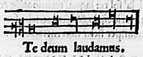Title: Thoscanello de la musica
Author: Pietro Aaron
Publication: Bernardino & Mattheo de Vitali (Venezia, 1523)
Bibliothèque nationale de France, Paris, FranceTitle: Toscanello in musica
Author: Pietro Aaron
Publication: Bernardino & Mattheo de Vitali (Venezia, 1529)
Bibliothèque Royale Albert Ier, Brussels, BelgiumTitle: Toscanello in musica
Author: Pietro Aaron
Publication: Marchio Sessa (Venezia, 1539)
Bibliotheca Riccardiana, Florence, ItalyTitle: Toscanello
Author: Pietro Aaron
Publication: Domenico Nicolino (Venezia, 1562)
Bibliothèque nationale de France, Paris, France First edition, 1523: Bibliothèque nationale de France, Paris, France Second edition, 1529: Bibliothèque Royale Albert Ier, Brussels, Belgium Third edition, 1539: Bibliotheca Riccardiana, Florence, Italy Fourth edition, 1562: Bibliothèque nationale de France, Paris, FrancePrincipal editor: Anne-Emmanuelle Ceulemans
Funder: Université catholique de Louvain F.N.R.S.
Edition: 2002
Department of Information and Computing Sciences Utrecht University P.O. Box 80.089 3508 TB Utrecht Netherlands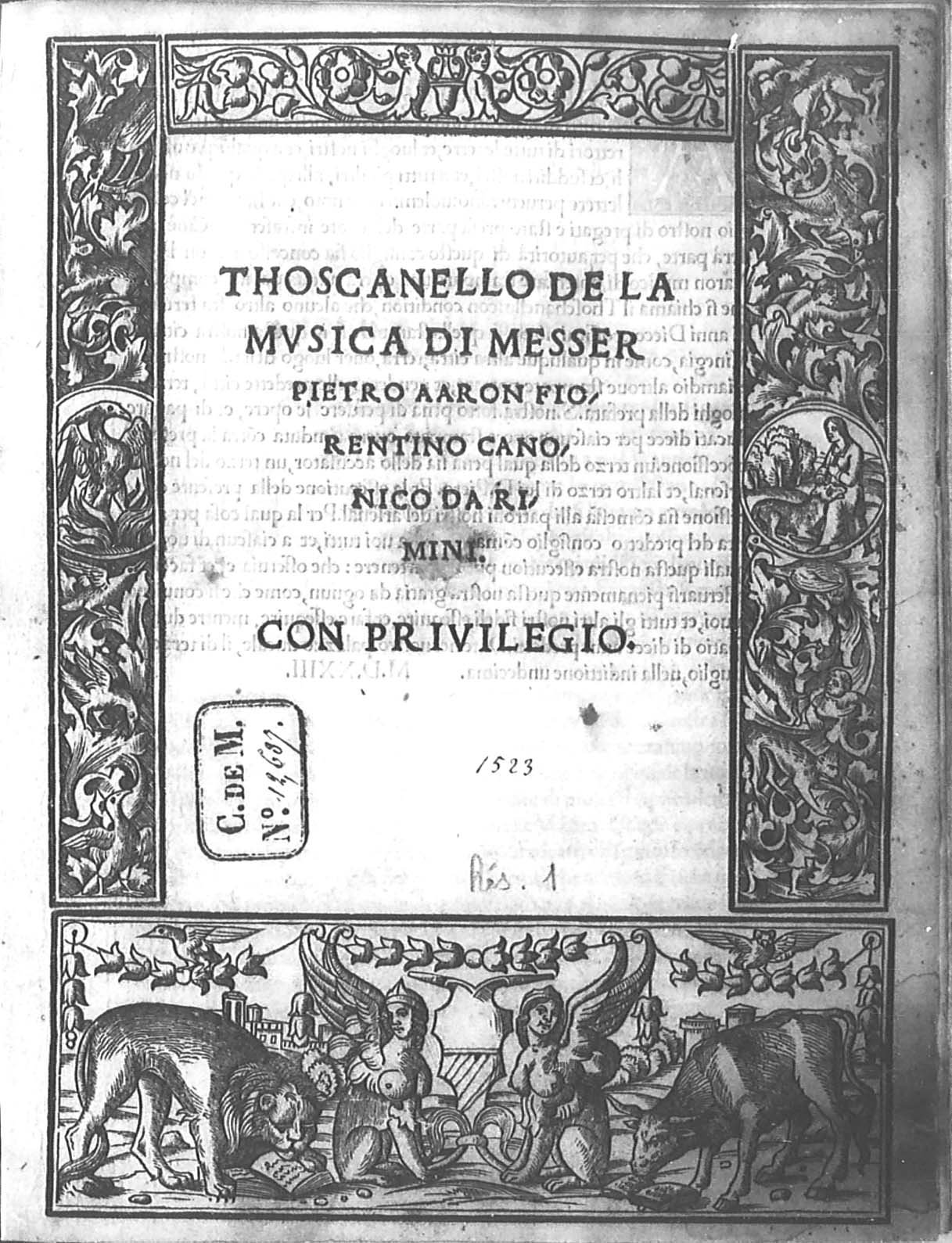
Si uvis scire modum generosa iuuventa candendi
Petrus Aron clarus Mmusicus arte docet.
Edocet ut coelum numeris mouveatur, & alta
Organa pulsentur, voceq faxa mouvet.
Attrahit hic syluvas, labentia flumina sistit,
Threiicius vates cedere iure potest.
Si uvis scire modum generosa iuuenta canendi
Petrus Aron clarus Mmusicus arte docet.
Edocet ut coelum numeris mouveatur, & alta
Organa pulsentur, uvoceq saxa mouvet.
Attrahit hic syluvas, labentia flumina sistit,
Threiicius uvates cedere iure potest.

 In Venetia,
APPRESSO DOMENICO NICOLINO.
MDLXII. [s1523: page 2]
In Venetia,
APPRESSO DOMENICO NICOLINO.
MDLXII. [s1523: page 2]AL REVERENDO, ET MAGNIFICO MONSI-GNORE SEBASTIANO MICHELE, PATRITIO VENETO, CAVALLIERE HIEROSOLYMITANO, ET PRIORE DI SAN GIOVANNI DAL TEMPIO DIGNISSIMO, PIERO AARON FIORENTINO, CA-NONICO RIMINESE.For further information on this preface, see Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 81 sqq.
AL MOLTO REVERENDO, ET MAGNIFICO MONSIGNORE SEBASTIANO MICHELE, GENTILHVUOMO VENETIANO, CAVALIERE HIEROSOLIMITANO, ET PRIORE DI S. GIOVANNI DAL TEMPIO DIGNISSIMO., PIERO ARON FIORENTINO.
[#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: TABVULA] [#s1562: TAVOLA DEI CAPITOLI, CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO]
| [#s1523: LOoda] [#s1529: LAaude] [#s1539: LAaude] [#s1562: Laude] della musica. | Cap. I. |
| Delli inuventori della musica. | Cap. II. |
| Diffinitione, et deriuvatione della musica. | Cap. III. |
| Della musica mondana:, humana: et istromentale. | Cap. IIII. |
| Cognitione di uvoci: et suoni: et uvarii istromenti. | Cap. V. |
| Della intelligenza del modo. | Cap. VI. |
| Cognitione del modo minor perfetto. | Cap. VII. |
| Che cosa sia tempo. | Cap. VIII. |
| Che cosa sia prolatione. | Cap. IX. |
| Quato sia il uvalore delle note nel modo maggiore perfetto: et imperfetto:, modo minor perfetto: et imperfetto. | Cap. X. |
Del uvalore di ciaschedua nota nel modo maggior perfetto posto con il segno sequente,  . .
|
Cap. XI. |
Valore del modo maggior perfetto nel tepo imp-fetto: et prolatione perfetta:, come qui,  . .
|
Cap. XII. |
| Per il secondo [#s1523: modo] [#s1529: segno] [#s1539: segno] [#s1562: segno] del maggior perfetto. | Cap. XIII. |
| Per il modo maggiore imperfetto. | Cap. XIIII. |
| Per il modo minor perfetto. | Cap. XV. |
| Per il modo minore imperfetto. | Cap. XVI. |
Valore del modo maggiore perfetto nel segno del tepo pfetto: et prolatione impfetta:, come qui,  . .
|
Cap. XVII. |
| Per il secondo segno del modo maggior perfetto. | Cap. XVIII. |
| Per il modo maggiore imperfetto. | Cap. XIX. |
| Per il modo minor perfetto. | Cap. XX. |
| Per il modo minore imperfetto. | Cap. XXI. |
Valore del modo maggior pfetto nel segno del te-po: et prolatione imperfetta:, come qui,  . .
|
Cap. XXII. |
| Per il secondo segno del modo maggior perfetto. | Cap. XXIII. |
| Per il modo maggiore imperfetto. | Cap. XXIIII. |
| Per il modo minore perfetto. | Cap. XXV. |
| Per il modo minore imperfetto. | Cap. XXVI. |
| Della intelligenza del modo maggior perfetto: et modo minore: et tepo p uvarii segni [#s1523: dimostrato] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] . | Cap. XXVII. |
| [s1523: page 6][s1529: page 6]Della cognitione del modo minor pfetto: et imperfetto:, tempo: et prolatione, p uvarii segni. | Cap. XXVIII. |
| Come siano intese le note: ouver figure perfette. | Cap. XXIX. |
| Dimostratione delle note imperfette. | Cap. XXX. |
| Come la lunga nel tempo pfetto non si può dire imperfetta. | Cap. XXXI. |
| Della cognitione: et natura del punto. | Cap. XXXII. |
| Delle note alterate: et sua intelligenza. | Cap. XXXIII. |
| Cognitione della maxima: et lunga di color pieno. | Cap. XXXIIII. |
| Della figura breuve piena. | Cap. XXXV. |
| Della figura semibreuve piena. | Cap. XXXVI. |
| Che cosa sia syncopa. | Cap. XXXVII. |
| Cognitione: et modo di cantar [#s1523: segno] [#s1529: segni] [#s1539: segni] [#s1562: segni] contra a [#s1523: se-gno] [#s1529: segni] [#s1539: segni] [#s1562: segni] necessarii. | Cap. XXXVIII. |
| Come li cantori habbiano a numerare li canti. | Cap. XXXIX. |
| Delle note in legatura. | Cap. XXXX. |
| CHhe cosa sia tuono. | Cap. I. |
| Del semituono minore: et maggiore. | Cap. II. |
| Del ditono. | Cap. III. |
| Del semiditono. | Cap. IIII. |
| Del tritono. | Cap. V. |
| Del diàa tessáaron. | Cap. VI. |
| Del diàa péente. | Cap. VII. |
| Del hexachordo maggiore. | Cap. VIII. |
| Del hexachordo minore. | Cap. IX. |
| Del diàa pasôon. | Cap. X. |
| Del genere chromatico. | Cap. XI. |
| Del genere enarmonico. | Cap. XII. |
| Dichiaratione del contrapunto. | Cap. XIII. |
| Delle consonanze perfette. | Cap. XIIII. |
| Delle cocordanze imperfette in cotrapunto usate. | Cap. XV. |
| Come il copositore [#s1523: debbia] [#s1529: debbe] [#s1539: debbe] [#s1562: debbe] dare principio al suo canto. | Cap. XVI. |
| [s1523: page 7]Se la consonanza: òo concordanza è necessaria al principio del canto. | Cap. XVII. |
| [s1529: page 7]Della terminatione: òo uvorrai dire cadenza ordinata nel soprano. | Cap. XVIII. |
| Modo di comporre psalmi: et mMagnificat.pricipiji, mezi, et fini de' tuoni | Cap. XIX. |
| Della natura del diesis. | Cap. XX. |
| Del modo del comporre il contrabasso: et alto dopo il tenore, et canto, Pprecetto primo. | Cap. XXI. |
| Precetto secondo. | Cap. XXII. |
| Precetto terzo. | Cap. XXIII. |
| Precetto quarto. | Cap. XXIIII. |
| Precetto quinto. | Cap. XXV. |
| Precetto sesto. | Cap. XXVI. |
| Precetto settimo. | Cap. XXVII. |
| Precetto ottauvo. | Cap. XXVIII. |
| Precetto nono. | Cap. XXIX. |
| Precetto decimo. | Cap. XXX. |
| Ordine di comporre a piuù di quatro uvoci. | Cap. XXXI. |
| Che cosa sia proportione. | Cap. XXXII. |
| Del superparticolare genere. | Cap. XXXIII. |
| Del superpartiente genere. | Cap. XXXIIII. |
| Del molteplice superparticolare genere. | Cap. XXXV. |
| Del molteplice superpartiente genere. | Cap. XXXVI. |
| Della proportionalità arithmetica. | Cap. XXXVII. |
| Della geometrica proportionalità. | Cap. XXXVIII. |
| Della armonica proportionalità. | Cap. XXXIX. |
| Diuvisione del monachordo per tuoni, et semituoni naturali, et accidentali. | Cap. XXXX. |
| Della partecipatione, et modo d'accordar l'istro-mento. | Cap. XXXXI. |
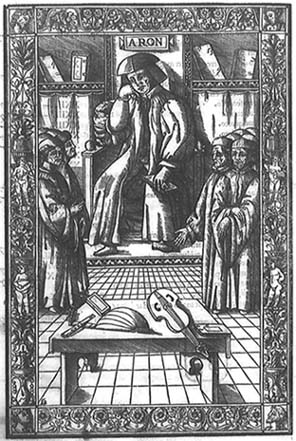
[#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: IL TOSCANELLO IN MVUSICA DI M. PIETRO ARON FIORENTINO, DELL'ORDINE GIEROSOLIMITANO, ET CANONICO IN RIMINI. ] LIBRO PRIMO.
[#s1523: LODA] [#s1529: LAVUDE] [#s1539: LAVUDE] [#s1562: DELLE LODI] DELLA MVUSICA. CAP. I.
sSe uvitio [s1523: page 11]alcuno (dice) saraà nelle mie opere, [#s1523: iscuselo [sic: iscusalo]] [#s1529: iscusalo] [#s1539: iscusalo] [#s1562: iscusalo] appresso te, o lettore, il suo tem-po. iIo era in essilio, et cercauva [s1529: page 11]riposo, et non fama, a ciocheé la mente non fusse sempre intenta alle sue calamitaà.eEt quanto seguita lungamente., per le qual cose appare, che non hanno mal parere quelli, che pensano la mu-sica a noi per dono dalla natura essere stata conceduta, a cioò che meglio si possino tolerare, et durare gli affanni di questa trauvagliata uvita. Non di meno di piuù sano giuditio sia, chi la crede esser grata alle menti humane, percioò che in essa riconoscono il lor principio, affirmando Platone nel Ti-meo, che l'anima nostra è composta di numeri musicali:, come anchora li pPythagorici affermano, che 'l mondo è composto di ragione musicale, del quale l'huomo sia imagine:, et per tanto uvenga detto microcosmo, che suo-na in nostra comune lingua "piccolo mondo":. oOuve risguardando i Romani, hauveano costume di celebrare l'essequie de' morti con suoni di trombe, et altri stormenti, i quali peroò funerali addimandauvano:, no per altra ragio-ne, se non che pensauvano le anime nella loro origine, cioè nel cielo ritor-nare:, al quale per mezzo del l'harmonia facile fusse il transito. eEt per simil cagione nel celebrar de gl'hymenei nottiali usauvono pur suoni per auspi-cio della creatione del l'anime, del quale effetto le nozze sono mezzano istromento. Prendi la confermatione nelli [#s1523: piccioli] [#s1529: piccoli] [#s1539: piccoli] [#s1562: piccoli] fanciulli,. nNon parlano anchora, non intendono, chi parla:; sono di quel puro intelletto da niu-na impressione [#s1523: segnato] [#s1529: segnati] [#s1539: segnati] [#s1562: segnati] , il quale il pPhilosopho assomiglia ad una tauvola rasa:, ouve [#s1523: niente] [#s1529: nulla] [#s1539: nulla] [#s1562: nulla] sia scritto:. nNon di meno, quado piangono, se per caso odo-no qualche uvoce soauve, tantosto s'acchetano, et stansi consolati:; quado so-no ben cheti et allegri, se aspro suono loro offende gli orecchi, subito a stridere, et star sconsolati:. pPercheé? pPercioò che se ben alcuna altra cognitione non è in loro, no manca peroò la natura, che di similitudine s'allegra, et ab-horrisce il cotrario. aAlla fine anchora gli [#s1523: animanti] [#s1529: animali] [#s1539: animali] [#s1562: animali] irrationali mirabilme-te si dillettano in musica, parte in udirla, come ceruvi, delphini, elephanti, et gran parte di augelli, parte in essercitarla, come cygni et lusignuoli. Segue all'infinito piacere et diletto, che della musica nasce, una inestima-bile utilitaà, che all'animo, et al corpo s'estende. Et che sia utile a l'animo, potrei adducere in mezzo molti essempi, come di Empedocle, che mutata una modulatione, teperò l'ira di un furioso giouvane tauromenitano ebrio, incitato dal suono phrygio a uvolere ardere la casa, ouve una sua amica col riuvale era rinchiusa: col sostituito spondeo lo placoò, et a miglior mente [#s1523: ] [#s1529: lo ] [#s1539: lo ] [#s1562: lo ] ri-dusse.; come [#s1523: di] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] tutti [#s1523: ] [#s1529: gli ] [#s1539: gli ] [#s1562: i ] Pythagorici, e quali commouveano, et acchetauvano gli [s1523: page 12]animi: et a' buoni costumi colla musica gl'indirizzauvano., et allor imitatione Theophrasto, che a tor uvia le passioni del l'animo commadauva apporsi le piuve. Ma fra' molti [s1529: page 12]memorabili essempi di uno del popolo di Arcadia mi uvoglio contentare, del qual Polybio, grauvissimo historico, è autore,:
[#s1523: èE' manifesto] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] (dice egli) la musica essere utile a tutti gli huomini, ma a gli Arcadici necessaria, siì per le continue fatiche di quella gente in lauvorare i campi, et durezza et asprezza di uvita:, siì per la austeritaà di costumi, che gli soprauviene per il freddo, et maluvagitaà del aere, al quale per necessitaà simili siamo prodotti., Ppercioò da principio gli lor fanciulli da pueritia s'u-sauvano nelli canti de gl'hynni peani, co' quali secodo l'usanza della patria soleuvano lodare i genii, heroi, et iddii. pPoi, instrutti nelle discipline di Philosseno et Timotheo, faceuvano giuochi annuali in honor del dio padre Baccho con balli, et canti:. iIfanciugli faceuvano giuochi chiamati puerili, i giouvani giouvenili. Tutta la lor uvita al fine è conuversa in tali canzoni, no tanto che si diletteno di udire modulationi, quanto per essercitarsi insie-me cantando. oOltra di cioò, se un huomo non sa qualche cosa nell'altre arti, no gli è uvergogna:, ma che uno huomo no sappia la musica, no è possibile, percheé è necessario impararla:, et cofessare di no la sapere si tiene per cosa uvituperosissima. VUltimamente e giouvanetti ogn'ano spettacoli et giuochi alli suoi cittadini fanno nelli theatri co balli et canti. cCosiì prima gli Arca-dici introdussero tutte le cose dette di sopra, di poi gli [s1539: page 7]comuni couventi, et [#s1523: moltissimi] [#s1529: moltissimi] [#s1539: moltissimi] [#s1562: molti] sacrificii, ne' quali si cogregauvano maschi et femine:; in ultimo gli chori di damigelle et fanciulli:, le quali cose tutte fecero a questo fine:, acciocheé quello, che era duro per natura ne gli animi loro, p cosuetudine si mitigasse, et [#s1523: diuvenisse] [#s1529: venissi] [#s1539: venissi] [#s1562: venissi] piaceuvole. Ma li Cynethesi in spacio di tepo hauvedo cominciato a sprezzar questa usanza, la quale a loro, piuù che ad altri, era necessaria, come habitati nella piuù fredda parte di Arcadia:, [s1562: page 7]uvoltati a cupiditaà, et ambitione, in breuve uvenero in tata fierezza, che in niuna cittaà di Grecia si faceano maggior sceleratezze, o piuù frequente crudeltà:. eEt p tal peruversitaà tutti gli altri popoli di Arcadia hauveuvano in odio la uvita et co-stumi loro.tTato et piuù recita Polybio nel quarto delle sue hHistorie dintor-no l'immenso frutto, che dalla musica al popolo arcadico uvene, cotra la falsa openione di Ephoro, che nel proemio del l'hHistorie diceuva la musica essere stata trouvata ad ingannare, et beffare gli huomini:. eEt a questa musica disciplina de gli aArcadici hauvere hauvuto riguardo Virgilio, si giudica dalli dotti, quado nell'eEgloga allo [sic: Galla] dice,:
uVoi Arcadi catarete alli uvostri monti, [s1523: page 13]Arcadi soli dotti a cantare.Che sia giouveuvole & salutifera all'infirmitaà corporali, queste memorie in fra l'altre [#s1523: n'] [#s1529: noi ] [#s1539: noi ] [#s1562: noi ] habbiamo. Xenocrate con orga-niche modulationi liberauva i spiritati,. [s1529: page 13]Asclepiade col canto delle trombe [#s1523: a' sordissimi] [#s1529: a' sordissimi] [#s1539: a' sordissimi] [#s1562: a i sordi] l'audito, co altra symphonia a' phrenetichi la mente restituiuva. Thaleta cCandiotto colla soauvitaà della cithara la pestilenza da Misithrà discaccioò:, et Terpandro il partiale tumulto ne remosse. Ismenia tThebano col canto della piuva a piuù Beotici sanoò le sciatiche:, la qual cosa se ad alcu pare impossibile, legga Aulo gGellio nel quinto delle nNotti attiche, et inten-deraà la ragione, pcheé puoò essere:, per modo che pareraà meno miracoloso, se Timotheo con modulatione [#s1523: orthia] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] concitoò Alessandro mMagno a pren-der l'arme in mano., come fusse presente il nimico, che a morte lo sfidasse:; et cocitato che l'hebbe, immantenete co altro tuono molle et quieto lo placoò:. eEt piuù credibile sia, se [#s1523: ] [#s1529: il ] [#s1539: dal ] [#s1562: dal ] citharizzate Dauvit (come si ha nel sacro vVecchio iIstrometo)'Istromento' i.e. 'Testamento'., il re Saul si recreauva dal furor della pazzia, dal qual spesso era occupato. Aggiunge che secondo Vitruuvio, l'architettore senza musica no saraà pfetto, la qual precipuamete è efficace alle teperature di baliste, catapulte, scorpioi, et machine hydrauliche:; secodo Hierophilo, et Erasistrato, il medico, per li polsi, che a coparatione di numeri si cosiderano:. eEt secodo Platone la musica è necessaria all'huomo ciuvile da lui detto politico. Da Platone no discorda Aristotele, il qual nelli pPolitici libri è autore la musi-ca essere collocata tra li studii liberali:, la qual insieme con le lettere, et con la lotta li giouvanetti alli tepi antichi usauvano imparare:. eEt se uvogliamo (dice il medesimo) uviuvere in quiete, dobbiamo hauvere con noi la musica, la quale è di natural piacere, procedente da cose giocondissime:, per il che et Museo dolcissima la disse essere alli mortali. Il gramatico senza musica no puoò esser copiuto, bisognadoli (come testimonia Quintiliano) che sappia cantare i uversi a tepo et misura:, di che la musica è maestra. eEt quel che del gramatico si dice, sia detto del poeta:, sia detto del oratore. eEssendo li numeri antichi mal coposti et quasi rustichi:, la poetica (dice Cesorino) usciì fuora piuù affettata, et piuù [#s1523: modulata] [#s1529: modulata] [#s1539: modulata] [#s1562: moderata] , quasi una legittima musica:, la quale con metrica [#s1523: modulatione] [#s1529: modulatione] [#s1539: modulatione] [#s1562: moderatione] polisse l'asprezza, et il tutto [#s1523: facessi] [#s1529: facessi] [#s1539: facessi] [#s1562: fa] bello:. mMa sopra tutti, quelli poeti abbracciaro li rhythmi, et numeri musichi, et piedi, che lyrici furo cognominati, pcheé li loro uversi attamente si catauvano alla lyra:, de' quali tata fu la copia, tato fu il numero appresso li atichi, che Cicerone niega douvergli bastare il tempo a leggere tutti li poeti lyrici:, anchora che l'etaà gli fussi duplicata. dDe' piedi et numeri, che segue l'oratore:, Diomede, et [s1523: page 14]Probo, gramatici, et Cicerone nell'oOratore, et altri copiosamete ne trattano:, appresso quelli il studioso lettore ne potraà leggere:. nNoi solo questo tocche-remo, che Gaio gGraccho, chiarissimo [s1529: page 14]oratore de' suoi tepi, quado orauva al popolo, teneuva un musico dopo le spalle, che con una fistola [#s1523: occultamete] [#s1529: occultamente] [#s1539: occultamente] [#s1562: nascostamente] gli dauva i modi della pronontia, hora remessi, hora concitati. Ma che piuù parole? cChe piuù essempi? iIl sopra citato Quintiliano afferma, che la musi-ca dà la perfettione a tutte l'altre sue sorelle dottissime:, et niuno può essere perfetto in qual [#s1523: uvuoi del l'arti] [#s1529: uvuoi del l'arti] [#s1539: uvuoi delle arti] [#s1562: si uvoglia arte] senza musica:. eEt Isidoro coferma, che niuno puoò essere senza musica, neé ancho cosa alcuna. Et questo basti per il uvalor della musica. Sarebbe anchora da dire del pregio, et in che riputatioe, et stima è stata di cotinuo, siì priuvata, siì [#s1523: publicamete] [#s1529: publicamente] [#s1539: publicamente] [#s1562: publica] , tanto in guerra, quato in pace:. eEt uveramente se in parte alcuna la musica è degna di [#s1523: loda] [#s1529: laude] [#s1539: laude] [#s1562: lode] , in questa è dignissima:, p modo che non se ne [s1539: page 8]potria predicare tanto, che [#s1523: uvia] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] piuù no ne restasse:. nNo di meno, percheé per le parti di sopra tocche si puoò molto bene conoscere, che in ogni secolo da persone eccelleti d'imperio, ouver di sapieza, appresso ogni popolo, et natione honorata si truouva sommamete et appregiata:, no m'estenderoò piuù in lungo,; et siì come si scriuve Pythagora dal pieè solo hauver giaà raccolto, quata fusse la gradezza di tutto il corpo di Hercole:, cosiì lascieroò io, che ogni suvegliato ingegno, se ben no è dotto in greco, o latino, no peroò neé dalle Muse, neé dalle gratie alieno, da una piccolissima particella in altro proposito mostrata faccia giudicio di tutto il resto:. eEt sapendo che la musica è nobilissima per antiquitaà, et per operatio-ne, et potentissima per diletto, et per utile:, pensesi certo, che anchora honoratissima sia:. eEt per tanto gradi honori, grandi priuvilegii, [#s1523: gradi dimostra-tioni] [#s1529: grandi dimostrationi] [#s1539: grandi dimostrationi] [#s1562: ] sempre habbia receuvuto:, li quali io no dichiaro, neé tengo che per humana uvoce si possino mai dichiarare appieno:; et solo le sacre Muse, che il reuverendo nome gli ha dato, a tanto ufficio douver essere sufficieti riputo.
DELLI INVENTORI DELLA MVUSICA. CA. II.
cCompose anchora Alcmane, et ritrouvoò la modula-tione, mettendo insieme il modulato nome delle perdici.Non dimeno noi, siì come habbiamo il tTestamento uVecchio per fondamento della chri-stiana nostra uvera fede [#s1523: nel l'altre cose] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] , cosiì anchora [#s1523: habbianlo [sic: habbiamlo]] [#s1529: habbianlo [sic: habbiamlo]] [#s1539: habbiamolo] [#s1562: l'habbiamo] in questa, et crediamo esser la uverità quel, che dice Moyse nel gGenesi, che Tubal fu trouvatore della scienza musica, il qual fu della stirpe di Cain [#s1523: nanzi] [#s1529: nanzi] [#s1539: nanzi] [#s1562: innanzi] il diluuvio. [s1523: page 16][s1529: page 16]
DIFFINITIONE, ET DERIVATIONE DELLA MVUSICA. CAP. III.
Noi diremo la musa di Damone et d'Al-phesibeo pastori.Si potrebbe anchora dire dalle Muse, per una di due cause, o uvero percheé le Muse seguitorno Dionysio, figliuolo di Giouve, et di Proserpina, dandogli (come testifica Diodoro nel quinto) delettatione con la suauvitaà del lor canto, nel qual erano dottissime, come anchora in tutte l'altre ottime arti/, o uvero pcheé (siì come si legge nel primo de l'iIliade di Homero) cantauvano alla mensa di Giouve. Aggiunge l'altra causa, la qual è piuù uvera. Musica [#s1523: è] [#s1529: è] [#s1539: eè] [#s1562: ] detta dalle Muse, percheé per il numero nouvenario di tali dee, li antichi Ttheologi uvolsero denotarsi li concenti delle otto sphere celesti, [#s1523: et] [#s1529: et] [#s1539: &] [#s1562: ] una maxima concordanza, la qual si fàa di tutti gli altri concenti, che fu chiamata harmonia. Da musa dunque, ouver dalle Muse è detta la Mmusica, et non da altrouve, come si hanno imaginato alcuni poco diligenti [#s1523: inquisitori] [#s1529: inquisitori] [#s1539: inquisitori] [#s1562: cercatori] di tal [#s1523: originatione] [#s1529: originatione] [#s1539: originatione] [#s1562: originati] , li quali da quello fonte han scritto deriuvarsi la Mmusica, dal qual piuù presto questo nome mMusa si deriuva. Tale è l'essentia della Mmusica, come è detto, et indi è nominata. Qui di sotto di-remo in quante parti si diuvida, [#s1523: couveniente] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] riputando alla diffinitione do-uver seguir la diuvisione. lLa ragione è in pronto, per che (come dice Por-phyrio) il genere è primo, che le sue specie.
DELLA MVUSICA MONDANA, HVUMANA, ET ISTROMENTALE. CAP. IIII.
qQuale è questo cosiì grande, et cosiì soauve suono, che empie li orecchi miei?[#s1523: èE' manifesta] [#s1529: èE' manifesta] [#s1539: eE' manifesta ] [#s1562: Manifesta] cosa [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: è] , che non parla di altro suono, se non di quello, dal qual è causata questa musica, della qual hora parliamo. Questo medesimo conferma Boetio nel primo della sua mMusica, dicendo,:
cCome puoò essere, che una cosiì grande machina, come è quella di cieli, tacitamete, et senza suono si muouva?Ma percheé hauvemo detto, che essi circoli [#s1523: celesti] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] hanno proportione insieme, è da notare, che le proportioni loro sono di tuono, ouver di semituono, per modo che dal primo, et piuù basso, ch'è della luna, al supremo, et piuù alto, che eè delle stelle fisse, uviene ad essere una proportione di ottauva cosonaza, et fra li intermedii è proportione di terza, di quarta, di quinta, et di sesta. èE' anchora da sapere, che quanto li circoli, et pianeti sono piuù bassi, et piuù propinqui alla luna, piuù grauve suono causano, et quanto sono piuù alti, et piuù appropinquano al cielo supremo, piuù acutamete risuonano. Musica Humana.La musica humana è quella, che risulta per la congiuntione dell'anima, et del corpo nostro insieme, imperoò che alli sapienti non par cosa uverisimile, che il corpo, et l'anima tanto bene insieme si accordino a far le lor solite opera-tioni, che sono mirabili, et che tra loro non sia proportione alcuna.; onde per questo essendo necessario confessar, che tra il corpo, et l'anima sia pro-portione,. bBisogna anchora dire, che tra loro sia no aperta, ma occulta harmonia, et musica, la quale quanto dura, tanto sta l'anima nostra al suo corpo cogiunta, ma come si dissoluve, è guasta questa musica, [#s1523: ] [#s1529: & ] [#s1539: & ] [#s1562: & ] subito uviene la morte, cioeè la separatione dell'anima, et del corpo. pPer questo credeuvano gli antichi, quado alcuno era [#s1523: ouver] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] amazzato, ouver annegato, l'anima sua non potere mai andar al luoco suo diputato, per fin che non era compito il numero musicale, con il qual era dal nascimento al suo corpo stata con-giuta, onde disse Virg. nel. vi.:
cCopiroò il numero, et torneromi alle tenebre.[s1523: page 18]Musica Istromentale.La musica istromentale è quella, che solo da gli istromenti nasce, et di questa specialmente habbiamo noi atrattar. mMa è da [s1529: page 18]sapere, che li istromenti sono di due maniere,. aAlcuni sono naturali, alcui [s1539: page 10]artificiali. qQuegli naturali sono, come in questi tre uversi appare,:
Nouve son glistrometi naturali: Ggola, lingua, palato, Eet quatro denti, et dui labri al parlar insieme equali.dDi questi istrometi nascono le uvoci, et li suoni causatiuvi delle cosonanze, et della musica, la quale è chiamata uvocale, et è di molto piuù precio, che tutte l'al-tre musiche, impoò che la uvoce humana auvanza tutte l'altre uvoci. Gli istro-meti artificiali sono di piuù sorti, ma generalmete si truouvano esser triplici, cioeè da chorde, et da fiato, et da battimeto solo. gGli istromenti da chorde sono arpichordi, clauvichordi, monochordi, liuti, cithare, lyre, harpe, dolcemeli, et altri simili. Gli istromenti da fiato sono organi, [#s1523: ] [#s1529: pifferi, ] [#s1539: pifferi, ] [#s1562: Ppifferi, ] flauti, trobe, corni, et altri simili. Gli istromenti da battimeto solo sono, come tamburi, cym-bali, sistri, crotali, et altri simili. Hora, hauvendo cosiì dichiarato queste tre sorti di musica, cioè della mondana, humana, et istromentale, quanto alla cognitione della prattica pare necessario:, da qui inanzi cominciaremo [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: àa ] trattare delle cose [#s1523: pertinenti] [#s1529: pertinenti] [#s1539: ptineti] [#s1562: apartinenti] alla cognitione de' uvarii istromenti.
COGNITIONE DI VOCI, ET SVUONI, ET VARII ISTROMENTI. CAP. V. This chapter essentially consists of a translation of Isidore of Seville's section 'De musica'. See Anne-Emmanuelle Ceulemans, "Instruments real and imaginary: Aaron's interpretation of Isidore and an illustrated copy of the Toscanello", Early Music History 21 (2002), 1-35.
lLa uvoce della tromba fece fremito,et altrouve,:
lLe uvoci rotte nel lito,.iIl suono si domada uvoce impoò che questo è il proprio, come,
gGli scolgi [#s1523: litorali] [#s1529: del lito] [#s1539: del lito] [#s1562: del lito] suonano.Harmonia è modulatioe di uvoci, ouver coattatione di piuù suoni. sijymphonia coiè cosonaSymphonia eè temperamento di modulatione di grauve, et acuto, di suoni cocordanti, o nella uvoce, o [#s1523: in lo] [#s1529: nel] [#s1539: nel] [#s1562: nel] fiato. pP questa symphonia certamete [s1523: page 19]la uvoce piuù acuta, o piuù grauve si [#s1523: cocordano] [#s1529: concordano] [#s1539: cocordano] [#s1562: concorda] per tal modo, che ciascuno, il quale si discorda da [s1529: page 19]quella, offende il senso dello auditore., della quale è cotraria la Dijyasphonia, disona [#s1523: dysphonia] [#s1529: dyasphonia] [#s1539: dyasphonia] [#s1562: Ddiafonia] , cioè la uvoce discrepante, et dissonante. euphonia.Euphonia è suauvitaà di uvoce,; questa appresso altri autori si domanda melos. Diastema.Diastema è spacio di uvoce di dui, ouver piuù suoni., imperoò che la differetia della har-monia è quatitaà, la qual cosiste nello acceto, ouver tenore della uvoce, le ge-nerationi della quale li musici hano diuviso in quindeci parti, delle quali il primo si domada hyplydio, l'ultimo si domada hypodorio, di tutti grauvissimo. Canto è inflexione di uvoce, ma il suono è diretto, et il suono [#s1523: precede il] [#s1529: procede [sic: precede] il] [#s1539: procede [sic: precede] il] [#s1562: procede dal] canto. Arsis, et Thesis.Arsis è eleuvatione di uvoce. Thesis è positione di uvoce. Soauvi uvoci sono sottili, et spesse, chiare, et acute. Voci di più sorte cioè.
| Perspicue. | cieca. |
| sottile. | Vinola. |
| Pingue. | Perfetta, |
| Acuta. | alta, |
| Dura. | soauve, et |
| Aspra. | chiara. |

 troba prima fu ritrouvata da gli Tyrrheni, cioeè dagli tToscani, come Virgilio dice,:
troba prima fu ritrouvata da gli Tyrrheni, cioeè dagli tToscani, come Virgilio dice,: iIl suono della toscana trom-ba mugghiauva per l'aere.sSi usauva non solo nelle battaglie, ma in tutti li diì festiuvi, per [s1539: page 11]la chiarezza delle laudi et della allegrezza,. pP cioò nel pPsalterio si dice,:
cCatate nel principio del mese colla tromba nel diì nobile della uvostra [s1523: page 20]solenitaà,[#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciohe [sic: percioché]] era commandato agli Giudei, che in principio della luna nuouva sonassino con la tromba, la qual cosa fanno anchora fin qui. Le
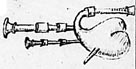 Piuéve piuve forno [s1529: page 20]ritrouvate in Phrygia. qQueste lungo tepo si usauvano solamete nelle sepolture de gli morti, et incotinente se usorno ne gli sacrificii de' getili.
TibiaTibie sono state nomiate, pcheé prima delle tibie, cioè de gli ossi del stinco
di ceruvi, o di grue si faceuvano. dDi poi abusiuve cosiì cominciorno ad essere
chiamate, et anchora al presente, bencheé no si facciano di quegli ossi,; non
di meno resta il nome, et di qui è deriuvato, tibicen, cioè colui, il quale suo-na la tibia.
Piuéve piuve forno [s1529: page 20]ritrouvate in Phrygia. qQueste lungo tepo si usauvano solamete nelle sepolture de gli morti, et incotinente se usorno ne gli sacrificii de' getili.
TibiaTibie sono state nomiate, pcheé prima delle tibie, cioè de gli ossi del stinco
di ceruvi, o di grue si faceuvano. dDi poi abusiuve cosiì cominciorno ad essere
chiamate, et anchora al presente, bencheé no si facciano di quegli ossi,; non
di meno resta il nome, et di qui è deriuvato, tibicen, cioè colui, il quale suo-na la tibia.  sapo-gnasampogna, òo CalamoCalamo è canna, la qual ha li spatii fra' nodi minuti, lunghi et
dritti., Iil qual essendo tutto cocauvo, neé hauvedo punto di charta, neé di car-ne, è utilissimo (come scriuve Plinio) alle sampogne, et percioò uvien detto in
greco syringa, che
sapo-gnasampogna, òo CalamoCalamo è canna, la qual ha li spatii fra' nodi minuti, lunghi et
dritti., Iil qual essendo tutto cocauvo, neé hauvedo punto di charta, neé di car-ne, è utilissimo (come scriuve Plinio) alle sampogne, et percioò uvien detto in
greco syringa, che  fistula Hieroni-mi.fistola significa in latino. fFu la sampogna inuvention di
Pan, dio de' pastori, il qual no potendo goder uviuva l'amata nympha Syringa, essendo quella (come canta Ouvidio) mutata in cane, p hauverla pur
in copagnia, sette calami dispari colla cera aggiuse, et syringa dalla nym-pha, cioè sampogna, chiamolla. Sabuca Sabuca in musica è specie di symphonia,
et è una generatioe di legno fragile, del quale si copongono anchora le tibie. Pandura Pandura secodo Giulio pPolluce è istromento trichordo ritrouvato dalli
popoli di Assyria. Martiano cCapella nel libro di mMusica l'attribuisce al dio
Pan. Choro
fistula Hieroni-mi.fistola significa in latino. fFu la sampogna inuvention di
Pan, dio de' pastori, il qual no potendo goder uviuva l'amata nympha Syringa, essendo quella (come canta Ouvidio) mutata in cane, p hauverla pur
in copagnia, sette calami dispari colla cera aggiuse, et syringa dalla nym-pha, cioè sampogna, chiamolla. Sabuca Sabuca in musica è specie di symphonia,
et è una generatioe di legno fragile, del quale si copongono anchora le tibie. Pandura Pandura secodo Giulio pPolluce è istromento trichordo ritrouvato dalli
popoli di Assyria. Martiano cCapella nel libro di mMusica l'attribuisce al dio
Pan. Choro


 . iIl numero delle chorde è
moltiplicato, et la generatioe è comutata. lL'atica cithara era di chorde set-te, come Virgilio dice,:
. iIl numero delle chorde è
moltiplicato, et la generatioe è comutata. lL'atica cithara era di chorde set-te, come Virgilio dice,: sette differenze di uvoci.,et imperoò dice differeti, per che niuna chorda rende simile suono alla chorda uvicina,. pP tanto dice set-[s1523: page 21]te chorde, ouver pcheé sette chorde adempiono tutta la uvoce, ouvero pcheé il cielo suona col mouvimeto de' sette pianeti. Chorde sono dette àa corde, per che cosiì come [s1529: page 21]il polso del cuore, è nel petto, cosiì il polso della chorda è nella cithara. Mercurio fu il primo inuventore delle chorde, et fu il primo, che strinse il suono nelle chorde, et neruvi. Psalterio
 Psalterio, il qle dal uvolgo si domanda
catico, è nominato da psallo, cioè canto, pcheé alla uvoce di quello il choro
cosonado rispode. La Lijyra
Psalterio, il qle dal uvolgo si domanda
catico, è nominato da psallo, cioè canto, pcheé alla uvoce di quello il choro
cosonado rispode. La Lijyra  lyra si chiama secodo alcuni apò tu lirin, cioè dalla
uvarietaà delle uvoci, pcheé fa diuversi suoni. sSecondo altri è detta da lyrin, cioè
cantare. lLi latini la chiamano fidicula ouver fide, percheé tanto consuonano
tra seé le chorde di quella, quanto ben si accordano gli huomini, tra i quali
è fede. lLa lyra prima fu trouvata da Mercurio in questo modo. rRitornando
il nNilo dentro dalle sue riuve, et hauvedo lasciato uvarii animali nelli campi,
lascioò anchora una testuggine, la quale essendo putrefatta, et li neruvi suoi
rimasti distesi tra il corio, percossa da Mercurio dette il suono, a similitudine della quale Mercurio fece la lyra, et dettela ad Orpheo. Timpanu Jheronimi
lyra si chiama secodo alcuni apò tu lirin, cioè dalla
uvarietaà delle uvoci, pcheé fa diuversi suoni. sSecondo altri è detta da lyrin, cioè
cantare. lLi latini la chiamano fidicula ouver fide, percheé tanto consuonano
tra seé le chorde di quella, quanto ben si accordano gli huomini, tra i quali
è fede. lLa lyra prima fu trouvata da Mercurio in questo modo. rRitornando
il nNilo dentro dalle sue riuve, et hauvedo lasciato uvarii animali nelli campi,
lascioò anchora una testuggine, la quale essendo putrefatta, et li neruvi suoi
rimasti distesi tra il corio, percossa da Mercurio dette il suono, a similitudine della quale Mercurio fece la lyra, et dettela ad Orpheo. Timpanu Jheronimi  TijympanoTympano,
cioè il taburo, è pelle ouver corio disteso, et appiccato a legno., et è mezza
parte di symphonia. tTympano è detto da typto, cioè percuoto, percheé [#s1523: co-me] [#s1529: la] [#s1539: la] [#s1562: la] symphonia si percuote co una bacchetta. Cijymbalo de Hieronimo
TijympanoTympano,
cioè il taburo, è pelle ouver corio disteso, et appiccato a legno., et è mezza
parte di symphonia. tTympano è detto da typto, cioè percuoto, percheé [#s1523: co-me] [#s1529: la] [#s1539: la] [#s1562: la] symphonia si percuote co una bacchetta. Cijymbalo de Hieronimo  Cymbali, et acettabuli sono
alcuni istromenti, li quali percossi insieme si toccano et fanno suono. sSono
detti cymbali, pcheé co balematia insieme si pcuotono. cCosiì li gGreci dicono
cymbali ballematia. Sistro
Cymbali, et acettabuli sono
alcuni istromenti, li quali percossi insieme si toccano et fanno suono. sSono
detti cymbali, pcheé co balematia insieme si pcuotono. cCosiì li gGreci dicono
cymbali ballematia. Sistro  Sistro è nominato da sio, cioè comuouvo. èE' sonaglio
di rame, per una stretta lama del quale, retorta a modo di cintura, alcune
girelle trapassate p mezzo, ogni uvolta che le braccia [#s1523: le] [#s1529: lo] [#s1539: lo] [#s1562: lo] scrollano, rendono
uno suono stridolo. pPensano alcuni, che no sia diuverso dal cymbalo, che le
fanciulle a Firenze usano negli loro balli. eEra usitato negli sacrificii d'Isis,
dea degli Egittii.
Sistro è nominato da sio, cioè comuouvo. èE' sonaglio
di rame, per una stretta lama del quale, retorta a modo di cintura, alcune
girelle trapassate p mezzo, ogni uvolta che le braccia [#s1523: le] [#s1529: lo] [#s1539: lo] [#s1562: lo] scrollano, rendono
uno suono stridolo. pPensano alcuni, che no sia diuverso dal cymbalo, che le
fanciulle a Firenze usano negli loro balli. eEra usitato negli sacrificii d'Isis,
dea degli Egittii.  Tintinabuli Tintinabulo [#s1523: ancho era] [#s1529: anchora éè] [#s1539: anchora eè] [#s1562: ancora è] [s1539: page 12]istromento di rame, col quale la
gente a hora di lauvare era chiamata al bagno. fFu detto dal suono, che fa
"tin tin", onde tintinire è uverbo, che [#s1523: ptiene] [#s1529: pertiene] [#s1539: pertiene] [#s1562: apartiene] al suono di tutti li metalli, et fa
coto, che era come la capanella, che chiama il popolo alla chiesia. Et pcheé
parlando del Tamburo
Tintinabuli Tintinabulo [#s1523: ancho era] [#s1529: anchora éè] [#s1539: anchora eè] [#s1562: ancora è] [s1539: page 12]istromento di rame, col quale la
gente a hora di lauvare era chiamata al bagno. fFu detto dal suono, che fa
"tin tin", onde tintinire è uverbo, che [#s1523: ptiene] [#s1529: pertiene] [#s1539: pertiene] [#s1562: apartiene] al suono di tutti li metalli, et fa
coto, che era come la capanella, che chiama il popolo alla chiesia. Et pcheé
parlando del Tamburo  tamburo, hauve fatto mentione della symphonia, quella no è
sorte di organo, come alcuni lLatini malamete pensano, ma un choro, che
catano insieme in laude d'iIddio, et questo [#s1523: si] [#s1529: si] [#s1539: si] [#s1562: ] significa per il uvocabolo, pcheé
sijymphonia quid sit. symphonia si exprime in latino cosonaza, deriuvata da syn, cioè insieme,
et phoni, uvoce,. nNodimeno al tepo nostro dal uvolgo Sijymphoniasymphonia si domada
un legno cauvo da tutte due le parti, co una pelle distesa, la qual li musici
percuotono di qua et di laà con le bacchette, et si fa in quella dalla cocor-danza del grauve, et dello acuto soauvissimo canto. Aliud Psalterium Decachordu
tamburo, hauve fatto mentione della symphonia, quella no è
sorte di organo, come alcuni lLatini malamete pensano, ma un choro, che
catano insieme in laude d'iIddio, et questo [#s1523: si] [#s1529: si] [#s1539: si] [#s1562: ] significa per il uvocabolo, pcheé
sijymphonia quid sit. symphonia si exprime in latino cosonaza, deriuvata da syn, cioè insieme,
et phoni, uvoce,. nNodimeno al tepo nostro dal uvolgo Sijymphoniasymphonia si domada
un legno cauvo da tutte due le parti, co una pelle distesa, la qual li musici
percuotono di qua et di laà con le bacchette, et si fa in quella dalla cocor-danza del grauve, et dello acuto soauvissimo canto. Aliud Psalterium Decachordu  [s1523: page 22][s1529: page 22]
[s1523: page 22][s1529: page 22]DELLA INTELLIGENZA DEL MODO. CAP. VI.Aaron's conception of the modes is discussed in a correspondence between Giovanni del Lago and Pietro Aaron, dated 1539-1540. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 712-727.
 le quali pause, o uvirgole, ouvuq serano preposte, notificano la maxima uvalere tre lunghe, le qual lunghe possono essere del uvalore
di tre breuvi, et di due, come p le pause appare.Modo maggre perfetto.
le quali pause, o uvirgole, ouvuq serano preposte, notificano la maxima uvalere tre lunghe, le qual lunghe possono essere del uvalore
di tre breuvi, et di due, come p le pause appare.Modo maggre perfetto.
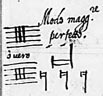
 ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562:
] [#s1562:  ] Modo maggre impfetto.
] Modo maggre impfetto.

COGNITIONE DEL MODO MINORE pfetto. CAP. VII.
 Modo minore impfetto
Modo minore impfetto  . Et nota, che li musici hano ordinato, che tal modo resti nel esser suo, auvega che le breuvi cotenute in quello fussino di qtitaà uvariate, siì come piuù apieno di poi si dichia-riraà. Et pcheé anchora no sia dubbio quado detto modo minore sia pfetto,
o ipfetto, si hano a cosiderare le pause, ouver uvirgole di sopra figurate, cioè
se quelle occupano dui, o tre spatii., poò che occupado tre spatii, dimostrano
il modo minore pfetto, et se dui, il minore impfetto. Questo medesimo mo
si usita dalli compositori dimostrare alcuna uvolta co una sola pausa
[#s1523: di] [#s1529: di] [#s1539: di] [#s1562: ] lunga di tre spatii, come qui.
. Et nota, che li musici hano ordinato, che tal modo resti nel esser suo, auvega che le breuvi cotenute in quello fussino di qtitaà uvariate, siì come piuù apieno di poi si dichia-riraà. Et pcheé anchora no sia dubbio quado detto modo minore sia pfetto,
o ipfetto, si hano a cosiderare le pause, ouver uvirgole di sopra figurate, cioè
se quelle occupano dui, o tre spatii., poò che occupado tre spatii, dimostrano
il modo minore pfetto, et se dui, il minore impfetto. Questo medesimo mo
si usita dalli compositori dimostrare alcuna uvolta co una sola pausa
[#s1523: di] [#s1529: di] [#s1539: di] [#s1562: ] lunga di tre spatii, come qui.  pP tato, ritrouvado detta pausa delli tre
spatii, farai il medesimo giuditio circa la pfettioe di detto mo mino(re.
pP tato, ritrouvado detta pausa delli tre
spatii, farai il medesimo giuditio circa la pfettioe di detto mo mino(re.
CHE COSA SIA TEMPO. CAP. VIII.
 , a di-notare, che ogni tepo, ouver breuve habbia a essere numerata impfetta, ouvero di quantitaà di semibreuvi due, come è detto. Ma il tepo, [s1529: page 24]che si considera
esser pfetto: è quado la breuve consiste del numero di tre semibreuvi, la qual
quatitaà, et numero si descriuve co il sequete segno,
, a di-notare, che ogni tepo, ouver breuve habbia a essere numerata impfetta, ouvero di quantitaà di semibreuvi due, come è detto. Ma il tepo, [s1529: page 24]che si considera
esser pfetto: è quado la breuve consiste del numero di tre semibreuvi, la qual
quatitaà, et numero si descriuve co il sequete segno,  ., p la qual cosa saraà
differete di una mezza parte della breuve, ouver tepo binario. Et pcheé alcui
dicono, che la semibreuve aggiuta alla breuve del tepo pfetto è parte terza
di essa breuve, si risponde che [#s1523: no [sic: no]] [#s1529: no] [#s1539: no] [#s1562: no] , pcheé il tepo (come è detto) p sua natura
fu costituito di uvalimeto di due semibreuvi. Essendo aduq tal quatitaà sta-bile, et ferma, ne segue, che l'augumeto di quella semibreuve non è la terza
parte del tepo, ma solo la mezza di essa breuve, quado tal nota sia aggiuta.
mMa quado tal breuve, o tepo p seé si dimostra pfetto, allhora la semibreuve saraà conumerata, et chiamata parte terza di quella breuve, o tepo. Per tato dico, che la semibreuve aggiuta alla figura breuve impfetta è mezza pte, et no
terza, et quella inchiusa nella pfetta breuve è parte terza della sua quatitaà.
., p la qual cosa saraà
differete di una mezza parte della breuve, ouver tepo binario. Et pcheé alcui
dicono, che la semibreuve aggiuta alla breuve del tepo pfetto è parte terza
di essa breuve, si risponde che [#s1523: no [sic: no]] [#s1529: no] [#s1539: no] [#s1562: no] , pcheé il tepo (come è detto) p sua natura
fu costituito di uvalimeto di due semibreuvi. Essendo aduq tal quatitaà sta-bile, et ferma, ne segue, che l'augumeto di quella semibreuve non è la terza
parte del tepo, ma solo la mezza di essa breuve, quado tal nota sia aggiuta.
mMa quado tal breuve, o tepo p seé si dimostra pfetto, allhora la semibreuve saraà conumerata, et chiamata parte terza di quella breuve, o tepo. Per tato dico, che la semibreuve aggiuta alla figura breuve impfetta è mezza pte, et no
terza, et quella inchiusa nella pfetta breuve è parte terza della sua quatitaà. puto mezza parte della breuve p ca del tepo ipfetto.
puto mezza parte della breuve p ca del tepo ipfetto.  puto 3a parte della breuve p causa del tepo pfetto.
puto 3a parte della breuve p causa del tepo pfetto.  [s1523: page 24]
[s1523: page 24]CHE COSA SIA PROLA-TIONE. CAP. VIII [sic: IX].
 .,
.,  . Hauvendo aduque li detti deputato, et ordinato
due sorti di prolatione, cioè perfetta, et imperfetta, ouvero maggiore, et minore, è da sapere, che douve detto punto saraà messo nella figura circolare, o
semicircolare, quella esser detta plation [s1562: page 13]maggiore, ouver pfetta, nella quale
prolatione si trouveraà la semibreuve di quantitaà, et numero di tre minime.,
Iimperoò che mancando il punto nelli sopradetti segni, resteraà diminuta,
et sol binaria, come nelli sequenti.,
. Hauvendo aduque li detti deputato, et ordinato
due sorti di prolatione, cioè perfetta, et imperfetta, ouvero maggiore, et minore, è da sapere, che douve detto punto saraà messo nella figura circolare, o
semicircolare, quella esser detta plation [s1562: page 13]maggiore, ouver pfetta, nella quale
prolatione si trouveraà la semibreuve di quantitaà, et numero di tre minime.,
Iimperoò che mancando il punto nelli sopradetti segni, resteraà diminuta,
et sol binaria, come nelli sequenti.,  .,
.,  .Prolatione pfetta òo uvero maggre
.Prolatione pfetta òo uvero maggre  Prolatione ipfa o uvero minorée
Prolatione ipfa o uvero minorée  Per tanto si può conchiudere,
che siì come p le pause di sopra dimostrate ne risulta il modo, et per il cir-colo, et semicircolo il tempo, cosiì per il punto la prolatione perfetta, come
per la sequente figura si dimostra. [s1529: page 25]
Per tanto si può conchiudere,
che siì come p le pause di sopra dimostrate ne risulta il modo, et per il cir-colo, et semicircolo il tempo, cosiì per il punto la prolatione perfetta, come
per la sequente figura si dimostra. [s1529: page 25]
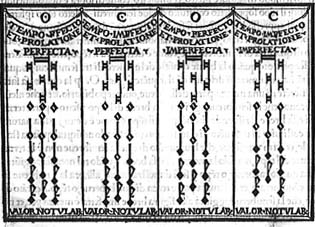
 /,
/,  .,
.,  . .,
. .,  ., congiunti a ciascuna pausa,
ouvero uvirgole inditiale, per li quali facilmete si haraà notitia di quello, che
necessariamete debbe ogni prattico esser capace. Et pcheé alcuo dubiteraà,
se ritrouvadosi un canto, nel principio del qual no fussi segno di tepo, o prolatione, ma solo le pause dimostrati li modi, se tal canto sia senza ragione
composto, Ssi risponde, che no, percheé le pause delli modi predetti farano
dui effetti uvarii in questo canto:. pPrima dimostrano la quantitaà, et uvalore
delle note, di poi sono in taciturnitaà numerate.
., congiunti a ciascuna pausa,
ouvero uvirgole inditiale, per li quali facilmete si haraà notitia di quello, che
necessariamete debbe ogni prattico esser capace. Et pcheé alcuo dubiteraà,
se ritrouvadosi un canto, nel principio del qual no fussi segno di tepo, o prolatione, ma solo le pause dimostrati li modi, se tal canto sia senza ragione
composto, Ssi risponde, che no, percheé le pause delli modi predetti farano
dui effetti uvarii in questo canto:. pPrima dimostrano la quantitaà, et uvalore
delle note, di poi sono in taciturnitaà numerate.  oOnde trouvado in una can-tilena le pause del modo maggiore, et minore perfetto, non solo sarano in
quello le maxime, et lunghe perfette, ma anchora si haranno a numerare
dette pause, et cosiì de glialtri. mMa quando fussino accompagnate con li
segni inanzi detti, et precedendo tal pause li segni, haranno forza solo di
dimostrare il uvalore di dette figure in esso canto. [s1529: page 26]
oOnde trouvado in una can-tilena le pause del modo maggiore, et minore perfetto, non solo sarano in
quello le maxime, et lunghe perfette, ma anchora si haranno a numerare
dette pause, et cosiì de glialtri. mMa quando fussino accompagnate con li
segni inanzi detti, et precedendo tal pause li segni, haranno forza solo di
dimostrare il uvalore di dette figure in esso canto. [s1529: page 26]Quanto sia il uvalore delle note nel modo maggiore perfetto, et impfetto, modo minor perfetto, et imperfetto. CAP. X.Parts of this chapter are criticised in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 19 September 1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 262-263.
 [#s1523: et] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ogni maxima è perfetta,
et uvaleraà tre lunghe., 9. breuvi, ouver tepi, semibreuvi. 18. et mini-me. 36.
[#s1523: et] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ogni maxima è perfetta,
et uvaleraà tre lunghe., 9. breuvi, ouver tepi, semibreuvi. 18. et mini-me. 36.
- Cosiì la lunga uvaleraà tre breuvi., 6. semi. [#s1523: et] [#s1529: et] [#s1539: ] [#s1562: ] minime. 12.
- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, et minime. 4. [s1562: page 14]
- La semibreuve uvaleraà. 2. minime.
 auvertisca, che in esso modo la
maxima uvaleraà. 3. lun-ghelunghe, breuvi. 6., semibreuvi. 12. [s1523: page 26]
auvertisca, che in esso modo la
maxima uvaleraà. 3. lun-ghelunghe, breuvi. 6., semibreuvi. 12. [s1523: page 26]- Cosiì la lunga uvaleraà. 2. breuvi., 4. semibreuvi, et minime. 8.
- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi., 4. minime, et semiminime. 8.
- La semibreuve uvaleraà. 2. minime, et. 4. semiminime.

- La lunga uvaleraà. 3. breuvi., semi-breuvi. 6. et minime. 12.
- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, et minime. 4.
- La semibreuve uvaleraà. 2. minime, et. 4. semiminime.

- Cosiì la lunga uvaleraà. 3. breuvi, semibreuvi. 6., minime. 12.
- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, minime. 4.
- La semibreuve uvaleraà minime. 2.
- Cosiì la lunga uvaleraà. 2. breuvi., semibreuvi. 4., minime. 8. [s1529: page 27]
- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, et minime. 4.
- La semibreuve uvaleraà. 2. minime, et. 4. semiminime,.
 ]
]
§ Del uvalore di ciascheduna nota nel modo maggior perfetto
inanzi posto il sequente segno/,  /. CAP. XI.
/. CAP. XI.
- Tre lunghe, percheé il modo maggiore è perfetto.;
- Nouve breuvi, percheé ciascuna lunga uval. 3. tempi.;
- Ventisette semibreuvi, percheé ciascuna breuve ne uval. 3.;
- Ottanta, et una minima, percheé ciascuna semibreuve uval. 3. minime.;
- Ttre lunghe, percheé la maxima è perfetta.;
- Ddue breuvi, percheé la lungha è imperfetta.;
- Ttre semibreuvi, percheé la breuve è perfetta.; [s1523: page 27]
- Ttre minime, percheé la semibreuve è perfetta.
- Ddue lunghe, percheé la maxima è imperfetta;
- Ssei breuvi, percheé la lunga uval. 3. breuvi,;
- Ddeciotto semibreuvi, percheé la breuve uval. 3. semibreuvi;
- Ccinquanta quatro minime, percheé la semibreuve uval. 3. minime.
- Ddue lunghe, percheé la maxima è imperfetta;
- Ssei breuvi, percheé la lungha ne uval. 3,;
- Ssemibreuvi. 18., percheé la breuve [#s1523: ne uval. 3] [#s1529: éè perfetta] [#s1539: eè perfetta] [#s1562: è perfetta] ,;
- Mminime. 54., percheé la semibreuve ne uval. 3.
- Ddue lunghe, percheé la maxima è imperfetta,;
- Bbreuvi. 4., percheé la lunga è imperfetta,;
- Ssemibreuvi. 12., percheé le breuvi son perfette,;
- Mminime. 36., percheé le semibreuvi son pfette, come la figura dimostra.
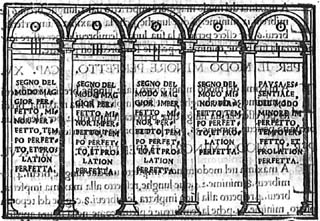
PRIMA DIMOSTRATIONE.
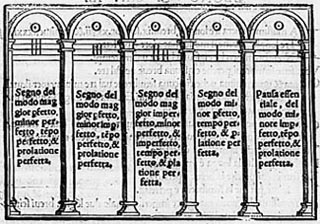
PRIMA DIMOSTRATIONE.
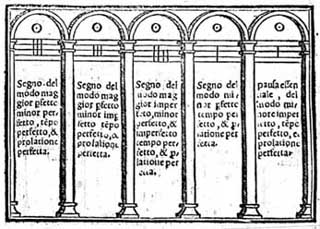
PRIMA DIMOSTRATIONE.
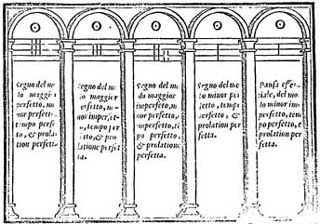
PRIMA DIMOSTRATIONE.
VALORE DEL MODO MAGGIOR PERFETTO
NEL TEMPO IMPERFETTO, ET PROLATION
PERFETTA, COME QVUI,  . CAP. XII.
. CAP. XII.
- tre lunghe, per essere la maxima perfetta.;
- breuvi. 9., per che la lunga è pfetta.;
- semibreuvi. 18., percheé la breuve uval. 2. semibreuvi.;
- minime. 54., percheé la semibreuve uval. 3. minime.
PER IL SECONDO MODO DEL MAGGIOR PERFETTO. CAP. XIII.
- Ttre lunghe, percheé la maxima è perfetta,;
- breuvi. 6., percheé la lunga è imperfetta,;
- semibreuvi. 12., percheé la breuve è imperfetta,;
- minime. 36., percheé la semibreuve è perfetta.
PER IL MODO MAGGIORE IMPER-FETTO. CAP. XIIII.
- due lunghe, pcheé la maxima eè imperfetta,;
- breuvi. 6., per essere perfetta la sua lunga,;
- semibreuvi. 12., per essere im-perfetta la sua breuve,;
- minime. 36., pcheé le semibreuvi son perfette.
PER IL MODO MINORE PERFETTO. CAP. XV.
- due lunghe, per essere impfetta la sua maxima,;
- breuvi sei, per essere la sua lunga [#s1523: qua] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] perfetta,;
- semibreuvi. 12, per esser la sua breuve no perfetta,;
- minime. [#s1523: 36] [#s1529: xxxvi] [#s1539: xxxv [sic: xxxvi]] [#s1562: xxxv [sic: xxxvi]] , pcheé la semibreuve [#s1523: uvien] [#s1529: è] [#s1539: eè] [#s1562: è] perfetta.
PER IL MODO MINORE IMPERFETTO. CAP. XVI.
- due lunghe., respetto alla maxima impfetta,;
- breuvi. 4., respetto alla luga impfetta,;
- semibreuvi. 8., cagioe del tepo impfetto,;
- minime. 24., pcheé la semibreuve è pfetta, come nella figure appare.
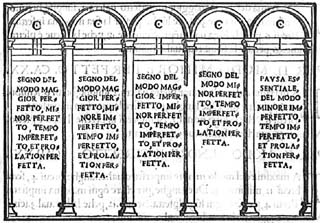
SECONDA DIMOSTRATIONE.
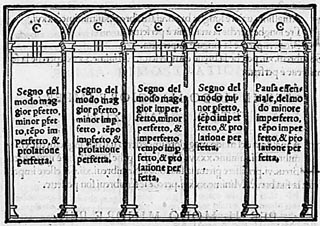
SECONDA DIMOSTRATIONE.
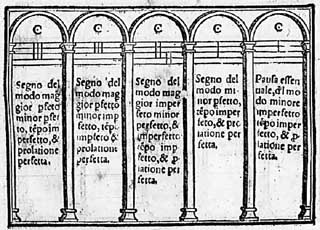
SECONDA DIMOSTRATIONE.
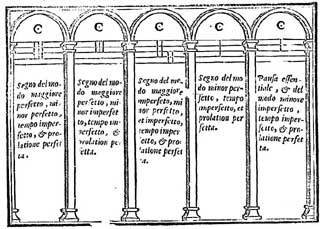
SECONDA DIMOSTRATIONE.
VALORE DEL MODO MAGGIOR PERFETTO
NEL SEGNO DEL TEMPO PERFETTO,
et prolatione impfetta, come qui,  . Cap. XVII.
. Cap. XVII.
- Ttre lughe, pcheé la maxima è pfetta.;
- Bbreuvi. 9., pcheé la luga ne uval. 3.;
- Ssemibreuvi. 27., percheé la breuve è perfetta.;
- Mminime. 54., percheé la semibreuve ne uval. [#s1523: 3 [sic: 2]] [#s1529: due minime] [#s1539: due minime] [#s1562: due Mminime] .
PER IL SECONDO SEGNO DEL MODO MAGGIOR PERFETTO. CAP. XVIII.
- Ttre lunghe, percheé la maxima è pfetta.;
- Bbreuve. 6, percheé la lunga uval due breuvi.;
- Ssemibreuvi. 18., percheé la breuve ne uval. 3.;
- Mminime. 36, percheé la semibreuve è imperfetta.
PER IL MODO MAGGIOR IMPERFETTO. CAP. XIX.
- Ddue lughe, p esser la sua maxima ipfetta.;
- Bbreuvi. 6, pcheé la luga uval. 3. tepi.;
- Ssemibre. 18, pcheé la breuve è pfetta.;
- Mminime. [#s1523: 36] [#s1529: xxxvi] [#s1539: xxx [sic: xxxvi]] [#s1562: xxx [sic: xxxvi]] , percheé la semibreuve uval. 2. minime.
PER IL MODO MINORE PERFETTO. CA. XX.
- Ddue lunghe, per essere la maxima imperfetta.;
- Bbreuvi 6, pcheé la luga ne uval. 3.;
- Ssemibreuvi 18, percheé il tepo è pfetto.;
- Mminime 36, percheé la semibreuve è imperfetta.
PER IL MODO MINORE IMPERFETTO. CAP. XXI.
- Ddue lunghe, per essere ogni maxima impfetta.;
- Bbreuvi 4, p essere ogni luga ipfetta.;
- Ssemib. 12, pcheé la bre. uval. 3. semi.;
- Mminime 24, percheé la semibreuve uval 2 minime.
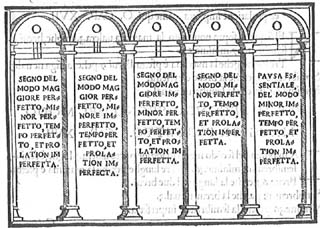
TERZA DIMOSTRATIONE.

TERZA DIMOSTRATIONE.
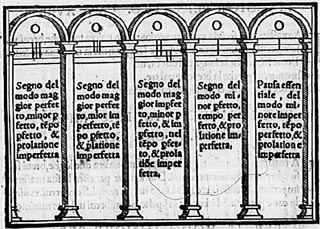
TERZA DIMOSTRATIONE.
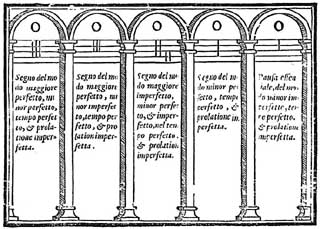
TERZA DIMOSTRATIONE.
VALORE DEL MODO MAGGIOR PERFETTO
NEL SEGNO DEL TEMPO, ET PROLATIONE
IMPERFETTA, COME QVUI,  . CAP. XXII.
. CAP. XXII.
- Ttre lunge [sic: lunghe], pcheé la maxima è pfetta,;
- breuvi. 9, pcheé la lun-ga ne uval. 3.;
- semibreuvi. 18., pcheé la breuve è impfetta,;
- minime. 36, pcheé la semibreuve no è perfetta.
PER IL SECONDO SEGNO DEL MODO MAGGIOR PERFETTO. CAP. XXIII.
- Ttre lunghe, percheé la maxima è perfetta.;
- breuvi. 6., per che la luga è imperfetta.;
- semibreuvi. 12, percheé li tepi sono imperfetti.;
- minime. 24, percheé la semibreuve è imperfetta.
PER IL MODO MAGGIOR IMPERFETTO. CAP. XXIIII.
- Ddue lughe, pcheé la maxima no è pfetta;
- breuvi. 6, pcheé la lunga è pfetta,;
- semibreuvi. 12, p esser il suo tempo imper-fetto.;
- minime. 24, pcheé la semibreuve è imperfetta.
PER IL MODO MINOR PER-FETTO. CAP. XXV.
- Ddue lunghe, pcheé la maxima è imperfetta,;
- breuvi 6, percheé la lunga ne uval. 3.;
- semibreuvi. 12, percheé la breuve è imper-fetta.;
- minime 24, percheé la semibreuve è imperfetta.
PER IL MODO MINORE IMPERFETTO. CAP. XXVI.
- Ddue lunghe, pcheé la maxima è imparf tta [sic: imparfetta].;
- bre-uvi 4, pcheé la lunga ne uval. 2.;
- semibreuvi. 8, pcheé la breuve è impfetta,;
- minime 16, percheé la semibreuve [#s1523: ne] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] uval. 2., come p la figura è chiaro.
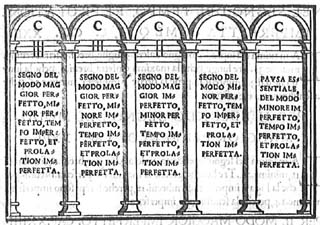
QVUARTA DIMOSTRATIONE.

QVUARTA DIMOSTRATIONE.

QVUARTA DIMOSTRATIONE.
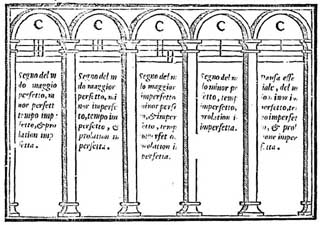
QVUARTA DIMOSTRATIONE.
DELLA INTELLIGENZA DEL MODO MAG-GIOR PERFETTO, ET IMPERFETTO:, modo minore, et tempo, per uvarii segni dimostrato. CAP. XXVII.For further information on the conception of the modes favoured by the Ancients, see also a letter written by Aaron to Giovanni Del Lago, dated 7 October 1539, in Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 715-725.
 33.Modo maggre pfo modo mire pfo Tempo pfo Il perfetto uveramete si conosceuva dallo impfetto p il circolo,
qual è figura [s1529: page 35]perfetta:, et l'imperfetto p il semicircolo:; et cosiì per la cifra ternaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: la ] perfettione, et per la binaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: l'] imperfettione. Per tanto il sopradetto
si dirà segno di modo maggior perfetto per rispetto del circolo, et per la
prima cifra di modo minor perfetto, et per la seconda di tempo anchor
perfetto. Cosiì ritrouvando il semicircolo, haraà natura del modo maggiore [s1523: page 33]impfetto, per esser forma imperfetta:; et se di poi seguiraà la binaria cifra,
modo minore imperfetto:. eEt se nel l'ultimo il simile trouverai, saraà indicio
di tempo imperfetto., come li presenti dimostrano.,
33.Modo maggre pfo modo mire pfo Tempo pfo Il perfetto uveramete si conosceuva dallo impfetto p il circolo,
qual è figura [s1529: page 35]perfetta:, et l'imperfetto p il semicircolo:; et cosiì per la cifra ternaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: la ] perfettione, et per la binaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: l'] imperfettione. Per tanto il sopradetto
si dirà segno di modo maggior perfetto per rispetto del circolo, et per la
prima cifra di modo minor perfetto, et per la seconda di tempo anchor
perfetto. Cosiì ritrouvando il semicircolo, haraà natura del modo maggiore [s1523: page 33]impfetto, per esser forma imperfetta:; et se di poi seguiraà la binaria cifra,
modo minore imperfetto:. eEt se nel l'ultimo il simile trouverai, saraà indicio
di tempo imperfetto., come li presenti dimostrano.,  22Modo maggre impfo
22Modo maggre impfo  22 minore impfo tepo ipfo .
22 minore impfo tepo ipfo .  3i1. mo magge ipfo minore pfetto tepo impfoAnchora se sa-raà prima la ternaria cifra, diremo modo minore perfetto,
3i1. mo magge ipfo minore pfetto tepo impfoAnchora se sa-raà prima la ternaria cifra, diremo modo minore perfetto,  32., et se
saraà ultima, tempo perfetto, come qui,
32., et se
saraà ultima, tempo perfetto, come qui,  23.Mo mag imp mi ip tempo per
23.Mo mag imp mi ip tempo per  23 Ma se saraà la prima, et la
seconda cifra ternaria, haremo modo minor perfetto, et tempo perfetto:,
come qui,
23 Ma se saraà la prima, et la
seconda cifra ternaria, haremo modo minor perfetto, et tempo perfetto:,
come qui,  33Mo ma imp mi p tepo pfetto.
33Mo ma imp mi p tepo pfetto.  33 . Se anchora saraà la prima, et secoda cifra binaria, saraà
modo minore imperfetto, et tepo impfetto:, come qui,
33 . Se anchora saraà la prima, et secoda cifra binaria, saraà
modo minore imperfetto, et tepo impfetto:, come qui,  22.Mo ma ip mi imp tempo imp
22.Mo ma ip mi imp tempo imp  22 Et pcheé tal
ordine dalli nostri copositori no è usitato, piuù di questo no mi extenderoò.
22 Et pcheé tal
ordine dalli nostri copositori no è usitato, piuù di questo no mi extenderoò.
DELLA COGNITIONE DEL MODO MINOR PERFETTO, ET IMPERFETTO, TEMPO, ET PROLATIONE, PER VARII SEGNI. CAP. XXVIII.
 3. Et quado tal circolo saraà con la
binaria, diremo modo minor perfetto, et tepo imperfetto, come qui,
3. Et quado tal circolo saraà con la
binaria, diremo modo minor perfetto, et tepo imperfetto, come qui,  2.
Se anchora saraà trouvato il semicircolo co la cifra ternaria, dimostreraà lo
imperfetto minore modo nel tepo perfetto, come qui,
2.
Se anchora saraà trouvato il semicircolo co la cifra ternaria, dimostreraà lo
imperfetto minore modo nel tepo perfetto, come qui,  3., et con la bi-naria, modo minore imperfetto, et tepo imperfetto, come qui,
3., et con la bi-naria, modo minore imperfetto, et tepo imperfetto, come qui,  2. Oltra
di questo, [s1529: page 36]uvolendo elli segnare la prolation pfetta, lo augumetano di uno
punto in mezzo del circolo, o semicircolo, come nelli segueti segni si uvede:
2. Oltra
di questo, [s1529: page 36]uvolendo elli segnare la prolation pfetta, lo augumetano di uno
punto in mezzo del circolo, o semicircolo, come nelli segueti segni si uvede:
 3.,
3.,  2.,
2.,  3.,
3.,  2., li quali al presente poco si usano. Non dimeno il tutto
sia in tuo arbitrio. [s1523: page 34]
2., li quali al presente poco si usano. Non dimeno il tutto
sia in tuo arbitrio. [s1523: page 34]COME SIANO INTESE LE NOTE, OVER FIGVURE PERFETTE. CAP. XXVIIII .
 cioè che una nota simile inanzi a una altra a seé [s1539: page 20]simile mai non puoò essere
imperfetta:, intendendo quelli la similitudine non secondo il colore, ma se-condo la forma:, bencheé alcuni impropriamente rompano tal regola, po-nendo inanzi due simili una minor con il punto inanzi posto:, pensando
che detto punto habbia forza di imperficere tal prima nota:. mMa quanto
siano lontani [s1562: page 20]dalla uveritaà, et dalla commune openione delli antichi musi-chi, [#s1523: in] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] questo lo dimostrano, peroò che sela impfettione ha luoco in tutte le
minori figure, no hauvendo la perfettione osseruvata [#s1523: nelle] [#s1529: in le] [#s1539: in le] [#s1562: nelle] simili, sarebbe da
meno, che detta imperfettione,. eEt in questa similitudine s'inchiudono an-chora le pause, le quali sarano nel secodo modo per noi inanzi detto:, per-cheé trouvando la maxima dauvanti alle tre pause dimostratiuve, [#s1523: del] [#s1529: il] [#s1539: il] [#s1562: il] modo
maggior perfetto:, o siano pause di tre tempi o dui, per esser dette pause la
quatitaà, et uvalore d'una figura maxima:, restano simili a essa figura:, et per
consequente detta maxima è perfetta,. cCosiì la lunga del modo minor per-fetto appresso la pausa delli tre tempi, o dui, sempre saraà perfetta., bencheé
alcuni a questo siano cotrarii:, cioè che essa lunga nanzi la pausa delli dui
tempi nel modo minor perfetto antedetto, [s1529: page 37]no sempre sia perfetta, p molte
cause, quali (per non essere prolisso) lascieremo.This sentence seems to be a response to a criticism contained in a letter sent to Aaron by Giovanni Spataro, dated February
1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 245. Nondimeno quello, che
a te piuù piace: osseruverai. Adunque la breuve, et semibreuve del tempo per-fetto, et prolation pfetta nanzi la sua simile figura, o sia pausa a seé equale: [s1523: page 35]sempre saraà pfetta. Il terzo modo è, che ogni maxima di esso modo mag-gior pfetto, hauvendo appresso a seé un punto, tal punto è la reintegratione,
et augumeto di una parte terza., laquale reintegratione dimostra, che essa
maxima è di quantitaà perfetta, ouver di tre lunghe, come fu detto di sopra.
Onde questo medesimo si concede alla lunga del modo minor perfetto:, et
il simile alla breuve, et semibreuve del tempo, et prolation perfetta:, come manifesta la figura presente:, nella quale non s'eè hauvuto riguardo al numero
delle note negre, ma solo alla breuvitaà:, come examinando uvederai.
cioè che una nota simile inanzi a una altra a seé [s1539: page 20]simile mai non puoò essere
imperfetta:, intendendo quelli la similitudine non secondo il colore, ma se-condo la forma:, bencheé alcuni impropriamente rompano tal regola, po-nendo inanzi due simili una minor con il punto inanzi posto:, pensando
che detto punto habbia forza di imperficere tal prima nota:. mMa quanto
siano lontani [s1562: page 20]dalla uveritaà, et dalla commune openione delli antichi musi-chi, [#s1523: in] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] questo lo dimostrano, peroò che sela impfettione ha luoco in tutte le
minori figure, no hauvendo la perfettione osseruvata [#s1523: nelle] [#s1529: in le] [#s1539: in le] [#s1562: nelle] simili, sarebbe da
meno, che detta imperfettione,. eEt in questa similitudine s'inchiudono an-chora le pause, le quali sarano nel secodo modo per noi inanzi detto:, per-cheé trouvando la maxima dauvanti alle tre pause dimostratiuve, [#s1523: del] [#s1529: il] [#s1539: il] [#s1562: il] modo
maggior perfetto:, o siano pause di tre tempi o dui, per esser dette pause la
quatitaà, et uvalore d'una figura maxima:, restano simili a essa figura:, et per
consequente detta maxima è perfetta,. cCosiì la lunga del modo minor per-fetto appresso la pausa delli tre tempi, o dui, sempre saraà perfetta., bencheé
alcuni a questo siano cotrarii:, cioè che essa lunga nanzi la pausa delli dui
tempi nel modo minor perfetto antedetto, [s1529: page 37]no sempre sia perfetta, p molte
cause, quali (per non essere prolisso) lascieremo.This sentence seems to be a response to a criticism contained in a letter sent to Aaron by Giovanni Spataro, dated February
1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 245. Nondimeno quello, che
a te piuù piace: osseruverai. Adunque la breuve, et semibreuve del tempo per-fetto, et prolation pfetta nanzi la sua simile figura, o sia pausa a seé equale: [s1523: page 35]sempre saraà pfetta. Il terzo modo è, che ogni maxima di esso modo mag-gior pfetto, hauvendo appresso a seé un punto, tal punto è la reintegratione,
et augumeto di una parte terza., laquale reintegratione dimostra, che essa
maxima è di quantitaà perfetta, ouver di tre lunghe, come fu detto di sopra.
Onde questo medesimo si concede alla lunga del modo minor perfetto:, et
il simile alla breuve, et semibreuve del tempo, et prolation perfetta:, come manifesta la figura presente:, nella quale non s'eè hauvuto riguardo al numero
delle note negre, ma solo alla breuvitaà:, come examinando uvederai.
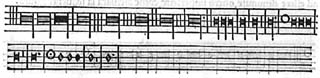
DIMOSTRATIONE DELLE NOTE PERFETTE.
[#s1523: DIMOSTRATIONE] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] DELLE NOTE IM-PERFETTE. CAP. XXX.
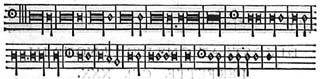
IMPERFETTIONE DELLE NOTE.
COME LA LVUNGA NEL TEMPO PERFETTO NON SI PVUO' DIRE IMPERFETTA. CAP. XXXI.
 ,
,  . Anchora accaderia della breuve posta in questo segno/,
. Anchora accaderia della breuve posta in questo segno/,  [#s1523:
[#s1523: 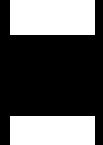 ] [#s1529:
] [#s1529: 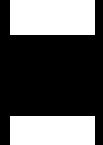 ] [#s1539:
] [#s1539: 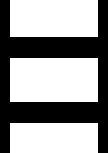 [sic: delete]] [#s1562:
[sic: delete]] [#s1562: 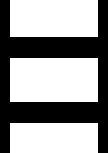 [sic: delete]] ,
la quale dimostra numero di due semibreuvi:, le quali sono numero di 6
minime:, che essa anchora si potesse dire breuve pfetta:, pcheé sei minime fano
la quatitaà di tre semibreuvi nella prolatione impfetta., et in molti altri modi
si potria dimostrare:, delli quali ne nascerebbe assai incouvenienti:, ma solo si
cosiderano le parti propinque a generare il pfetto numero, et lo impfetto.,
[sic: delete]] ,
la quale dimostra numero di due semibreuvi:, le quali sono numero di 6
minime:, che essa anchora si potesse dire breuve pfetta:, pcheé sei minime fano
la quatitaà di tre semibreuvi nella prolatione impfetta., et in molti altri modi
si potria dimostrare:, delli quali ne nascerebbe assai incouvenienti:, ma solo si
cosiderano le parti propinque a generare il pfetto numero, et lo impfetto., consideratione buona.
Ddel che diremo la lunga di sopra da noi assonta, quado a lei saraà tolto al-cuna parte:, lunga diminuta, et no impfetta:, percheé [#s1523: alcuna cosa] [#s1529: cosa alcuna] [#s1539: cosa alcuna] [#s1562: cosa alcuna] no si debbe
dire esser impfetta, se prima no è stata in lei pfettione.
consideratione buona.
Ddel che diremo la lunga di sopra da noi assonta, quado a lei saraà tolto al-cuna parte:, lunga diminuta, et no impfetta:, percheé [#s1523: alcuna cosa] [#s1529: cosa alcuna] [#s1539: cosa alcuna] [#s1562: cosa alcuna] no si debbe
dire esser impfetta, se prima no è stata in lei pfettione.
DELLA COGNITIONE, ET NATVURA DEL PVUNTO. CAP. XXXII. Much of this chapter is taken from a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 7 March 1521, published in Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 232-236.
 pcheé numerado queste
pcheé numerado queste  alla breuve,
si dice due:, et alla sequete semibreuve una:, che fanno insieme giunte tre., Mma
numerado questo
alla breuve,
si dice due:, et alla sequete semibreuve una:, che fanno insieme giunte tre., Mma
numerado questo  alla breuve, no si diraà due, et al puto una:, ma si nomina essa breuve con il punto, dicendo tre:, come se fusse una breuve, la quale
senza alcuno segno [s1539: page 22]accidetale p seé fusse [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta, come qui.
alla breuve, no si diraà due, et al puto una:, ma si nomina essa breuve con il punto, dicendo tre:, come se fusse una breuve, la quale
senza alcuno segno [s1539: page 22]accidetale p seé fusse [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta, come qui.  pP tato esso punto è detto di pfettione:, pcheé dimostra, che tal figura dal co-positore è pserata [sic: preservata] [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta:, percheé senza il puto forse sarebbe da
una sequete semibreuve fatta impfetta, come comada il precetto della imp-fettione. Sogliono alcuni intedere tal punto essere il uvalimeto di una semi-[s1523: page 38]
breuve cantabile:, et forse anchor si pensano, che siano catabili li punti dopo
tal note, a li quali si risponde, che se tal punto fusse inteso essere una semi-breuve, come qui,
pP tato esso punto è detto di pfettione:, pcheé dimostra, che tal figura dal co-positore è pserata [sic: preservata] [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta:, percheé senza il puto forse sarebbe da
una sequete semibreuve fatta impfetta, come comada il precetto della imp-fettione. Sogliono alcuni intedere tal punto essere il uvalimeto di una semi-[s1523: page 38]
breuve cantabile:, et forse anchor si pensano, che siano catabili li punti dopo
tal note, a li quali si risponde, che se tal punto fusse inteso essere una semi-breuve, come qui,  la breuve restaria pfetta: et la secoda semibreuve no sarebbe alterata, come si dimostreraà nel sequen-te cap., pcheé resteria in tal processo, et figura.
la breuve restaria pfetta: et la secoda semibreuve no sarebbe alterata, come si dimostreraà nel sequen-te cap., pcheé resteria in tal processo, et figura.  Ma dico, che
quel punto in tale essempio è supfluo, essendo dallui posto
p punto di pfettione., pcheé il punto della pfettione è quello, il quale senza
tal puto, la nota, alla quale esso puto è di poi posto, resta impfetta:. pP tato, se
in tal figura saraà leuvato quel punto:, la breuve resteraà cosiì pfetta senza puto,
come si faccia col punto. Dico adunque che il punto della perfettione no è
quatitaà, neé parte del tepo:, ma solamete è segno, accioò che il catore copreda
che la nota, che ha il puto dopo seé è coseruvata dalla iperfettioe. eEt p tal causa
la secoda semibreuve saraà in questo essempio alterata,
Ma dico, che
quel punto in tale essempio è supfluo, essendo dallui posto
p punto di pfettione., pcheé il punto della pfettione è quello, il quale senza
tal puto, la nota, alla quale esso puto è di poi posto, resta impfetta:. pP tato, se
in tal figura saraà leuvato quel punto:, la breuve resteraà cosiì pfetta senza puto,
come si faccia col punto. Dico adunque che il punto della perfettione no è
quatitaà, neé parte del tepo:, ma solamete è segno, accioò che il catore copreda
che la nota, che ha il puto dopo seé è coseruvata dalla iperfettioe. eEt p tal causa
la secoda semibreuve saraà in questo essempio alterata,  et no in
questo.
et no in
questo.  aAduque tal puto mai no è catato, neé anchora
è uvalore di semib., ma (come ho detto) sta come segno dimostrate la [s1562: page 22]pfettione alla breuve:, la quale forse saria diminuta, et imperfetta di una semibreuve
sequete, o suo uvalore. La cosideratione del Punto de la diuvisioneputo della diuvisione si manifesta
nelle copositioni del modo maggiore, et minor pfetto, anchora nel tepo, et
prolatione pfetta., pcheé trouvadosi il modo, tepo, et prolatioe diminuti della
sua terza parte, et bisognado il fauvore a tale reintegratione, è stato necessa-rio hauvere stabilito tal segno a riducere la qtitaà ternaria secodo la natura,
et forma delle note,. eEt pcheé il puto molte uvolte uvaria nella sua diuvisione, ti
auvertisco, che il punto di sopra detto dopo la sua diuvisione puoò impficere,
et alterare., pcheé [s1529: page 41]trouvado la presente figuratione,
aAduque tal puto mai no è catato, neé anchora
è uvalore di semib., ma (come ho detto) sta come segno dimostrate la [s1562: page 22]pfettione alla breuve:, la quale forse saria diminuta, et imperfetta di una semibreuve
sequete, o suo uvalore. La cosideratione del Punto de la diuvisioneputo della diuvisione si manifesta
nelle copositioni del modo maggiore, et minor pfetto, anchora nel tepo, et
prolatione pfetta., pcheé trouvadosi il modo, tepo, et prolatioe diminuti della
sua terza parte, et bisognado il fauvore a tale reintegratione, è stato necessa-rio hauvere stabilito tal segno a riducere la qtitaà ternaria secodo la natura,
et forma delle note,. eEt pcheé il puto molte uvolte uvaria nella sua diuvisione, ti
auvertisco, che il punto di sopra detto dopo la sua diuvisione puoò impficere,
et alterare., pcheé [s1529: page 41]trouvado la presente figuratione,  questo punto
uviene a generare dui effetti.: prima diuvide, da poi impfice., pcheé
no si trouvado il punto fra le due semib., uverebbe ad essere la prima breuve di
quatitaà perfetta, et per consequente la seconda semibreuve sarebbe alterata,
no essendo tal puto di diuvisione. Suole anchora alcune uvolte opare diuvisione, et alteratione (come è detto) in questo modo,
questo punto
uviene a generare dui effetti.: prima diuvide, da poi impfice., pcheé
no si trouvado il punto fra le due semib., uverebbe ad essere la prima breuve di
quatitaà perfetta, et per consequente la seconda semibreuve sarebbe alterata,
no essendo tal puto di diuvisione. Suole anchora alcune uvolte opare diuvisione, et alteratione (come è detto) in questo modo,  ma non
essendo punto [#s1523: infra] [#s1529: infra] [#s1539: in fra] [#s1562: fra] loro, la prima breuve resteraà intiera, et perfetta, come
qui,
ma non
essendo punto [#s1523: infra] [#s1529: infra] [#s1539: in fra] [#s1562: fra] loro, la prima breuve resteraà intiera, et perfetta, come
qui,  percheé si uvede dopo la prima breuve un tempo intiero,
et perfetto diuviso in parti propinque., per il qual modo è manifesto, che la
prima breuve è pfetta.; della qual dimostratione il puto della diuvisione può
essere chiamato di impfettione, et di alteratione, come si coprede. Per tato,
se nel modo maggior pfetto infra due lughe trouverai puto, diremo punto
di diuvisione:; se infra due breuvi nel modo minor pfetto, puto di diuvisione:; se
infra due semibreuvi del tepo pfetto, il simile.; Ccosiì anchora nella prolation
perfetta infra due minime. uUltimamete il punto di augumetatione [sic: augmentatione] è sem-[s1523: page 39]pre mai quello, che è posto dopo ciascuna nota del modo, tepo, et prolatione impfetta:, come la sequente figura dimostra.
[#s1523:
percheé si uvede dopo la prima breuve un tempo intiero,
et perfetto diuviso in parti propinque., per il qual modo è manifesto, che la
prima breuve è pfetta.; della qual dimostratione il puto della diuvisione può
essere chiamato di impfettione, et di alteratione, come si coprede. Per tato,
se nel modo maggior pfetto infra due lughe trouverai puto, diremo punto
di diuvisione:; se infra due breuvi nel modo minor pfetto, puto di diuvisione:; se
infra due semibreuvi del tepo pfetto, il simile.; Ccosiì anchora nella prolation
perfetta infra due minime. uUltimamete il punto di augumetatione [sic: augmentatione] è sem-[s1523: page 39]pre mai quello, che è posto dopo ciascuna nota del modo, tepo, et prolatione impfetta:, come la sequente figura dimostra.
[#s1523:
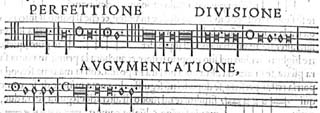
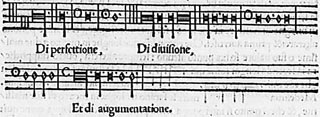
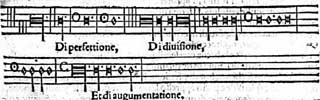

DELLE NOTE ALTERATE, Et sua intelligeza. CA. XXXIII.
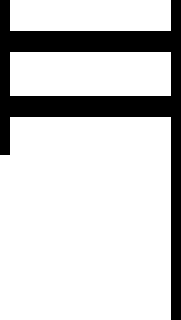
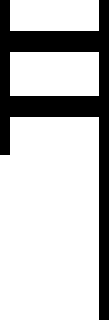
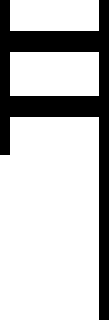
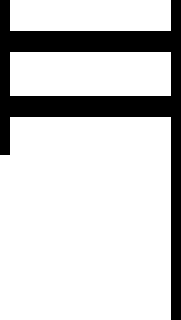 . Ma se il puto saraà tra le due lughe, come qui/,
. Ma se il puto saraà tra le due lughe, come qui/, 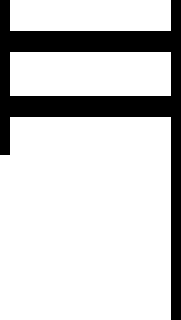
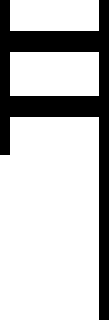 .
.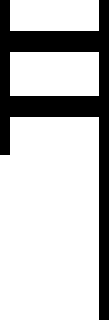
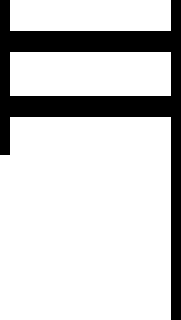 /,
no saraà piuù alcuna alteratione. Medesimamete, se [s1562: page 23]sarano tre lughe in mezzo di due maxime, et che il punto si interponga tra la prima, et secoda luga:, come qui/,
/,
no saraà piuù alcuna alteratione. Medesimamete, se [s1562: page 23]sarano tre lughe in mezzo di due maxime, et che il punto si interponga tra la prima, et secoda luga:, come qui/, 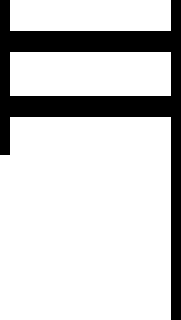
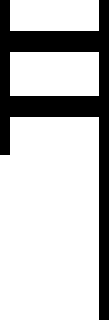 .
.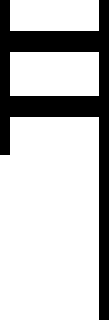
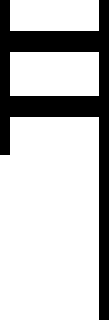
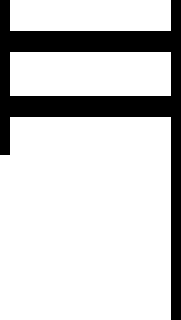 /, la terza lunga
saraà alterata. mMa no hauvendo il sopra detto puto, quelle
tre lughe resterano nel suo proprio uvalore. eEt anchora la prima maxima saraà pfetta, se inanzi da altra nota no saraà impedita. cCosiì la maxima seconda
potria restar perfetta, se dopo lei no seguisse altra nota minore di seé, come
qui/,
/, la terza lunga
saraà alterata. mMa no hauvendo il sopra detto puto, quelle
tre lughe resterano nel suo proprio uvalore. eEt anchora la prima maxima saraà pfetta, se inanzi da altra nota no saraà impedita. cCosiì la maxima seconda
potria restar perfetta, se dopo lei no seguisse altra nota minore di seé, come
qui/, 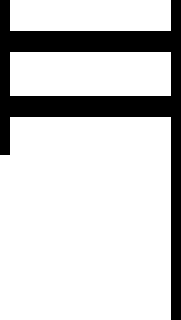
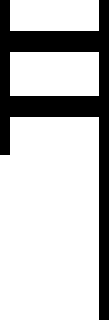
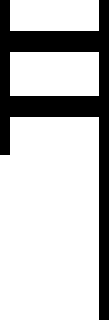
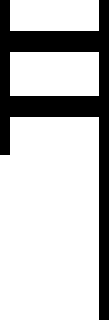
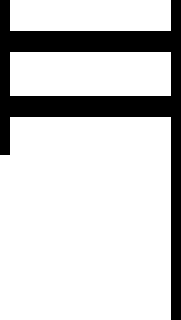 /. sSimilmete tal modo di alteratioe seguiraà, se tra due,
o piuù maxie sarano. 5. lughe, come q/,
/. sSimilmete tal modo di alteratioe seguiraà, se tra due,
o piuù maxie sarano. 5. lughe, come q/, 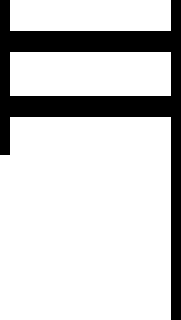
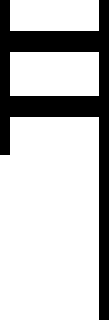
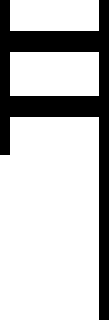
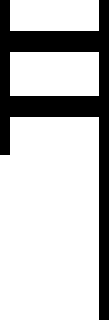
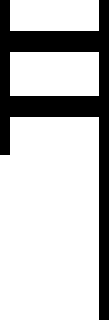
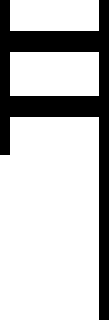
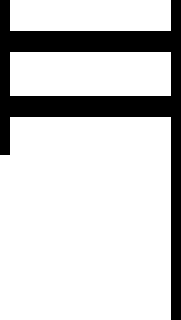 /,
[#s1523: douve] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] saraà necessario, che la quinta luga sia alterata,
per esser diminuto il modo maggiore di una luga. nNo altera aduque la lunga per altro, se no per reintegratione, et copimeto di detto modo maggior
perfetto:; la breuve, p adepire il ternario numero [s1529: page 43]del modo minor pfetto,; la
semibreuve, p cosequire la numerositaà ternaria del tepo pfetto:; et la minima
altera p pficere la diuvisione della prolatione pfetta.; Ddel che da tutti li mu-sici è concesso che la seconda, o uvero [#s1523: l'] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ultima, et no la prima figura minore
debbia alterare., pcheé ogni pfettioe in tutte le cose eè cocessa nella fine, et no
nel principio. Et nota che il puto, il quale è tra la prima, et secoda luga: del
l'essempio posto di sopra:, fàa dui effetti,. iIl primo è, che fa impfetta la sua an-tecedete maxima dalla luga sequete:; l'altro, fa impfetta la secoda maxima
dalla luga precedete:. eEt questo anchora intederai delle breuvi, et semibreuvi,
et minime:, dato che li fussino poste pause dinazi in luoco di note:, come nella sequete figura appare:, ma no p l'opposito, [#s1523: peroò che] [#s1529: peroò che] [#s1539: peroò che] [#s1562: perciocheé] le pause et note di co-lor pieno mai no possono essere alterate.
[#s1523:
/,
[#s1523: douve] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] saraà necessario, che la quinta luga sia alterata,
per esser diminuto il modo maggiore di una luga. nNo altera aduque la lunga per altro, se no per reintegratione, et copimeto di detto modo maggior
perfetto:; la breuve, p adepire il ternario numero [s1529: page 43]del modo minor pfetto,; la
semibreuve, p cosequire la numerositaà ternaria del tepo pfetto:; et la minima
altera p pficere la diuvisione della prolatione pfetta.; Ddel che da tutti li mu-sici è concesso che la seconda, o uvero [#s1523: l'] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ultima, et no la prima figura minore
debbia alterare., pcheé ogni pfettioe in tutte le cose eè cocessa nella fine, et no
nel principio. Et nota che il puto, il quale è tra la prima, et secoda luga: del
l'essempio posto di sopra:, fàa dui effetti,. iIl primo è, che fa impfetta la sua an-tecedete maxima dalla luga sequete:; l'altro, fa impfetta la secoda maxima
dalla luga precedete:. eEt questo anchora intederai delle breuvi, et semibreuvi,
et minime:, dato che li fussino poste pause dinazi in luoco di note:, come nella sequete figura appare:, ma no p l'opposito, [#s1523: peroò che] [#s1529: peroò che] [#s1539: peroò che] [#s1562: perciocheé] le pause et note di co-lor pieno mai no possono essere alterate.
[#s1523:
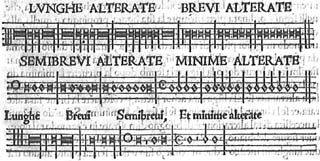
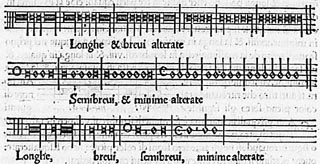
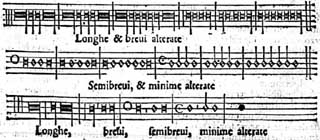

COGNITIONE DELLA MAXIMA, ET LVUN-GA DI COLORE PIENO. CAP. XXXIIII.This chapter is criticised in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 19 September 1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 263-266.
 ., nel qual segno la maxima, et lunga possono esser diuvise in tre
parti equali:, cioè la maxima in. 12. semibreuvi di tepo impfetto [sic: perfetto]: et la lunga
in sei.; cosiì in questo anchora,
., nel qual segno la maxima, et lunga possono esser diuvise in tre
parti equali:, cioè la maxima in. 12. semibreuvi di tepo impfetto [sic: perfetto]: et la lunga
in sei.; cosiì in questo anchora,  , nel quale si puoò trouvare diuvisa la maxima
in tre parti equali, cioè in minime 24, et la lunga in minime. 12. Togliendo
aduq nel primo segno il terzo [#s1523: alla] [#s1529: de la] [#s1539: de la] [#s1562: della] maxima, resta in semibre.
8, et la lunga
in. 4.; et nel secodo, diminuta del terzo, la maxima resta in minime. 16. et la
luga in minime. 8., come qui appare. semibreuvi. minime.
, nel quale si puoò trouvare diuvisa la maxima
in tre parti equali, cioè in minime 24, et la lunga in minime. 12. Togliendo
aduq nel primo segno il terzo [#s1523: alla] [#s1529: de la] [#s1539: de la] [#s1562: della] maxima, resta in semibre.
8, et la lunga
in. 4.; et nel secodo, diminuta del terzo, la maxima resta in minime. 16. et la
luga in minime. 8., come qui appare. semibreuvi. minime. Lro 2o co xi Frachino nella Pra Lro so co 6. et i Angelicu opus dice la metà
Lro 2o co xi Frachino nella Pra Lro so co 6. et i Angelicu opus dice la metà  Anchora ti auvertisco, che ritrouvado
tal note di color pieno sotto li segni
sequeti,
Anchora ti auvertisco, che ritrouvado
tal note di color pieno sotto li segni
sequeti,  ,
,  ., nelli quali la maxima è formata di semibreuvi 8:, pcheé tal
quatitaà di [s1562: page 24]otto non è diuvisibile in tre parti equali:, è necessario, che
tal note, o figure, trouvadosi nelli antedetti segni di color piene, siano sesqualterate:, ouvero [#s1523: pdono] [#s1529: perdino] [#s1539: perdino] [#s1562: perdino] il quarto, come nelli sequeti capitoli uvederai. [s1523: page 42]
., nelli quali la maxima è formata di semibreuvi 8:, pcheé tal
quatitaà di [s1562: page 24]otto non è diuvisibile in tre parti equali:, è necessario, che
tal note, o figure, trouvadosi nelli antedetti segni di color piene, siano sesqualterate:, ouvero [#s1523: pdono] [#s1529: perdino] [#s1539: perdino] [#s1562: perdino] il quarto, come nelli sequeti capitoli uvederai. [s1523: page 42]DELLA FIGVURA BREVE PIENA. CAP. XXXV.Parts of this chapter are criticised in two letters written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 1 and 6 November 1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 273-276 and 280-283.
 Il terzo modo è, quado nel tepo impfetto, et prolatione
imperfetta tu trouverai una sol breuve negra:. tTal breuve negra perde una sua
quarta parte, quale è una minima:, et tato resta, come se fusse una semibre-uve con un punto, o uvuoi dire una semibreuve, et una minima. Il quarto modo è quado [#s1523: tu] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] truouvi nel tepo impfetto, et prolatione pfetta una breuve ne-gra:, et pcheé essa breuve biaca è coposta di sei minime, essendo negra, pde la
terza sua parte:, [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] sei minime sono in tre parti equali diuvisibili:. eEt p co-sequente tal figura, et forma di colore pieno dimostra, che le sue due semi-breuvi in tal corpo formate restano diminute della sua terza parte, per la
negrezza apparente. Il quinto, et ultimo modo è, quado tu truouvi nel tepo
imperfetto, et prolation imperfetta alcune breuvi negre, senza alcun dubio
sarano sesqualterate, cioè tre di esse breuvi negre nella battuta di due breuvi
bianche:, come di poi al capitolo della sesqualtera intenderai.
Il terzo modo è, quado nel tepo impfetto, et prolatione
imperfetta tu trouverai una sol breuve negra:. tTal breuve negra perde una sua
quarta parte, quale è una minima:, et tato resta, come se fusse una semibre-uve con un punto, o uvuoi dire una semibreuve, et una minima. Il quarto modo è quado [#s1523: tu] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] truouvi nel tepo impfetto, et prolatione pfetta una breuve ne-gra:, et pcheé essa breuve biaca è coposta di sei minime, essendo negra, pde la
terza sua parte:, [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] sei minime sono in tre parti equali diuvisibili:. eEt p co-sequente tal figura, et forma di colore pieno dimostra, che le sue due semi-breuvi in tal corpo formate restano diminute della sua terza parte, per la
negrezza apparente. Il quinto, et ultimo modo è, quado tu truouvi nel tepo
imperfetto, et prolation imperfetta alcune breuvi negre, senza alcun dubio
sarano sesqualterate, cioè tre di esse breuvi negre nella battuta di due breuvi
bianche:, come di poi al capitolo della sesqualtera intenderai.
DELLA FIGVURA SEMIBREVE PIENA. CAP. XXXVI.Parts of this chapter are criticised in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 8 November 1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 286-287.
 ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562:
] [#s1562:  ]
] 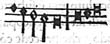 lLa prima chiaramete si uvede essere di quatitaà
di una minima [#s1523: con] [#s1529: col] [#s1539: col] [#s1562: col] punto, la secoda di una minima.
[#s1523: solo, p che] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] la breuve dinazi a lei è di uvalore di una semibreuve, et minima. lLa sequete semibreuve adunque è di uvalore di una sola
minima., bencheé alcuni dicono, che tal figure debbono essere sesqualterate:,
ma poco importa da un modo all'altro, [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] la quantitaà di esse note sono
sottoposte al seruvitio di un tepo. pPer tanto [#s1523: piglia] [#s1529: piglia] [#s1539: piglia] [#s1562: pigliarai] quello, che a te [#s1523: piace] [#s1529: piace] [#s1539: piace] [#s1562: piaceraà] :, per
che [#s1523: tutto] [#s1529: tutto] [#s1539: tutto] [#s1562: ogni cosa] torna a un solo fine. mMa ritrouvado prima la semibreuve dinanzi la
breuve, come qui,
lLa prima chiaramete si uvede essere di quatitaà
di una minima [#s1523: con] [#s1529: col] [#s1539: col] [#s1562: col] punto, la secoda di una minima.
[#s1523: solo, p che] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] la breuve dinazi a lei è di uvalore di una semibreuve, et minima. lLa sequete semibreuve adunque è di uvalore di una sola
minima., bencheé alcuni dicono, che tal figure debbono essere sesqualterate:,
ma poco importa da un modo all'altro, [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] la quantitaà di esse note sono
sottoposte al seruvitio di un tepo. pPer tanto [#s1523: piglia] [#s1529: piglia] [#s1539: piglia] [#s1562: pigliarai] quello, che a te [#s1523: piace] [#s1529: piace] [#s1539: piace] [#s1562: piaceraà] :, per
che [#s1523: tutto] [#s1529: tutto] [#s1539: tutto] [#s1562: ogni cosa] torna a un solo fine. mMa ritrouvado prima la semibreuve dinanzi la
breuve, come qui,  senza dubio saraà sottoposto tal quantitaà al seruvitio
sesqualtero:, ma per no essere tal modo troppo cosueto, et il piuù delle uvolte
trouvarsi nella figura sopradetta dalli compositori osseruvata, altro di questo
non diroò. Il quarto modo si ritruouva nella prolation perfetta, et tempo imperfetto:, la qual per essere di natura, et uvalore di tre minime:, essendo ne-gra, resta diminuta di una minima:, quale è sua terza parte:, pure che siano
piuù di una, o due insieme di tal colore, [#s1523: ouveramente] [#s1529: o uveramente] [#s1539: o uveramente] [#s1562: o] accompagnate co minime negre, come qui, [#s1523:
senza dubio saraà sottoposto tal quantitaà al seruvitio
sesqualtero:, ma per no essere tal modo troppo cosueto, et il piuù delle uvolte
trouvarsi nella figura sopradetta dalli compositori osseruvata, altro di questo
non diroò. Il quarto modo si ritruouva nella prolation perfetta, et tempo imperfetto:, la qual per essere di natura, et uvalore di tre minime:, essendo ne-gra, resta diminuta di una minima:, quale è sua terza parte:, pure che siano
piuù di una, o due insieme di tal colore, [#s1523: ouveramente] [#s1529: o uveramente] [#s1539: o uveramente] [#s1562: o] accompagnate co minime negre, come qui, [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562:
] [#s1562:  ] This example is unclear, both in the 1523 edition and in the revised version of the later editions. The 1539 edition, held
at the Bibliothèque Nationale in Paris, contains a corrected manuscript example which reads as follows.
] This example is unclear, both in the 1523 edition and in the revised version of the later editions. The 1539 edition, held
at the Bibliothèque Nationale in Paris, contains a corrected manuscript example which reads as follows.  ma ritrouvando tali note in questo
modo, la semibreuve negra resta di uvalore, et quatitaà di
una minima [#s1523: con] [#s1529: col] [#s1539: col] [#s1562: col] puto:, per la qual cosa uvolendo [#s1523: dritta-mente] [#s1529: sanamente] [#s1539: sanamente] [#s1562: sanamente] conoscere tal differenza, a te saraà necessario auvertire come, et in che
numero sono figurate. [s1562: page 25]Il quinto modo saraà, che quando trouverai tre semi-breuvi negre nel tempo et prolatione imperfetta, dette semibreuvi debbono
sesqualterare, come è detto delle breuvi nel capitolo di sopra. [s1523: page 44]
ma ritrouvando tali note in questo
modo, la semibreuve negra resta di uvalore, et quatitaà di
una minima [#s1523: con] [#s1529: col] [#s1539: col] [#s1562: col] puto:, per la qual cosa uvolendo [#s1523: dritta-mente] [#s1529: sanamente] [#s1539: sanamente] [#s1562: sanamente] conoscere tal differenza, a te saraà necessario auvertire come, et in che
numero sono figurate. [s1562: page 25]Il quinto modo saraà, che quando trouverai tre semi-breuvi negre nel tempo et prolatione imperfetta, dette semibreuvi debbono
sesqualterare, come è detto delle breuvi nel capitolo di sopra. [s1523: page 44]CHE COSA SIA SYNCOPA. CAP. XXXVII.
 et altri [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che son ] simili, cantado la breuve, no è poco faticoso. eEt pcheé tal pausa di breuve (come ho
detto [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: di sopra] ) nulla circa la harmonia importa:, hanno costituito,
et per precetto regulare ordinato, che a [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: piuù ] maggiore dichiaratione, et facilitaà,
[#s1523: tal] [#s1529: tal] [#s1539: tal] [#s1562: simile] pausa sia in due pause di semibreuvi diuvisa, non [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già ] parimente poste:, come
qui
et altri [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che son ] simili, cantado la breuve, no è poco faticoso. eEt pcheé tal pausa di breuve (come ho
detto [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: di sopra] ) nulla circa la harmonia importa:, hanno costituito,
et per precetto regulare ordinato, che a [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: piuù ] maggiore dichiaratione, et facilitaà,
[#s1523: tal] [#s1529: tal] [#s1539: tal] [#s1562: simile] pausa sia in due pause di semibreuvi diuvisa, non [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già ] parimente poste:, come
qui  per il qual modo saraà copreso, et co [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: molta ] facilitaà cantato., [#s1523: p-cheé chiaramete] [#s1529: percheé chiaramente] [#s1539: percheé chiaramente] [#s1562: perciocheé chiarissimamente] appareraà, che la [#s1523: prima] [#s1529: prima] [#s1539: prima] [#s1562: principale] semibreuve, et la [#s1523: prima] [#s1529: prima] [#s1539: prima] [#s1562: principale] pausa di semibrei [sic: semibreve] [#s1523: adempiono] [#s1529: empiono] [#s1539: empiono] [#s1562: empiono] uno tepo:, et che la secoda pausa di semibrei [sic: semibreve] colla sequete catabile semibreuve reintegrano uno altro tepo. Ma essendo posto, come qui,
per il qual modo saraà copreso, et co [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: molta ] facilitaà cantato., [#s1523: p-cheé chiaramete] [#s1529: percheé chiaramente] [#s1539: percheé chiaramente] [#s1562: perciocheé chiarissimamente] appareraà, che la [#s1523: prima] [#s1529: prima] [#s1539: prima] [#s1562: principale] semibreuve, et la [#s1523: prima] [#s1529: prima] [#s1539: prima] [#s1562: principale] pausa di semibrei [sic: semibreve] [#s1523: adempiono] [#s1529: empiono] [#s1539: empiono] [#s1562: empiono] uno tepo:, et che la secoda pausa di semibrei [sic: semibreve] colla sequete catabile semibreuve reintegrano uno altro tepo. Ma essendo posto, come qui,  tale syncopa saraà sup-flua, et [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ancho ] frustratoria, et come termine da sophista, et litigioso
inteso., [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] q appare la itegritaà del tepo unita, et no è., Iimperoò che la misura [#s1523: di esso] [#s1529: di esso] [#s1539: di esso] [#s1562: del sopradetto] tepo diuvide la pausa in due parti, la quale, pcheé (come ho detto)
no frutta altro, che taciturnitaà, et no harmonia:, la musical diligeza, p [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: voler ] tenere
ordine, et facilitaà in cantando:, no uvuole [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già] , che sia produtta integra, ma sia in [s1523: page 45]due pause di semibreuvi, no in una sola riga, ma in diuverse discritte. Per tanto si cosidera, che la nota syncopata no debbe ritrouvare la pausa maggiore
di seé:, ma debbe trouvare la figura catabile. eEt p tal causa diremo essere una
syncopa in nota, et una in misura, come di sopra è manifesto.
tale syncopa saraà sup-flua, et [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ancho ] frustratoria, et come termine da sophista, et litigioso
inteso., [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] q appare la itegritaà del tepo unita, et no è., Iimperoò che la misura [#s1523: di esso] [#s1529: di esso] [#s1539: di esso] [#s1562: del sopradetto] tepo diuvide la pausa in due parti, la quale, pcheé (come ho detto)
no frutta altro, che taciturnitaà, et no harmonia:, la musical diligeza, p [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: voler ] tenere
ordine, et facilitaà in cantando:, no uvuole [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già] , che sia produtta integra, ma sia in [s1523: page 45]due pause di semibreuvi, no in una sola riga, ma in diuverse discritte. Per tanto si cosidera, che la nota syncopata no debbe ritrouvare la pausa maggiore
di seé:, ma debbe trouvare la figura catabile. eEt p tal causa diremo essere una
syncopa in nota, et una in misura, come di sopra è manifesto.
COGNITIONE, ET MODO DI CANTAR SEGNO CONTRA A SEGNO NECESSARII. CAP. XXXVIII.
 , coparato a questo [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: segno] ,
, coparato a questo [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: segno] ,  , non ha alcuna differeza, ma son
simili nella battuta, et nel circolo puntato harai le breuvi perfette, et le se-mibreuvi, et nell'altro le semibreuvi [#s1523: solo] [#s1529: solo] [#s1539: solo] [#s1562: sole] . Ma questo,
, non ha alcuna differeza, ma son
simili nella battuta, et nel circolo puntato harai le breuvi perfette, et le se-mibreuvi, et nell'altro le semibreuvi [#s1523: solo] [#s1529: solo] [#s1539: solo] [#s1562: sole] . Ma questo,  , contra a questo,
, contra a questo,  ,
saraà di una altra natura, [#s1523: cioè che] [#s1529: cioè che] [#s1539: cheé] [#s1562: cheé] questo,
,
saraà di una altra natura, [#s1523: cioè che] [#s1529: cioè che] [#s1539: cheé] [#s1562: cheé] questo,  , faraà ogni sua minima equale
in quatitaà di una semibreuve di questo,
, faraà ogni sua minima equale
in quatitaà di una semibreuve di questo,  , pur osseruvando sempre la per-fettione, et alteratione occorrente a' detti segni. Anchora questo,
, pur osseruvando sempre la per-fettione, et alteratione occorrente a' detti segni. Anchora questo,  , coparato a questo,
, coparato a questo,  , è simile a quello di sopra, excettuado la pfettione del te-po, et della prolatione. Di poi questo,
, è simile a quello di sopra, excettuado la pfettione del te-po, et della prolatione. Di poi questo,  , coparato con questo,
, coparato con questo,  , harai
nella battuta della breuve di questo,
, harai
nella battuta della breuve di questo,  , una sol minima del precedete. Cosiì
questo,
, una sol minima del precedete. Cosiì
questo,  , con questo coparato,
, con questo coparato,  2, faraà il simile di quel di sopra.,L'
2, faraà il simile di quel di sopra.,L' dimostra il modo mi-nore pfetto, et la cifera 2 il tempo. ma solamete auvertirai in questo segno,
dimostra il modo mi-nore pfetto, et la cifera 2 il tempo. ma solamete auvertirai in questo segno,  2, che le lunghe son pfette, et le breuvi
impfette. Ma questo/,
2, che le lunghe son pfette, et le breuvi
impfette. Ma questo/,  /, con questo,
/, con questo,  , o uvero con questo altro,
, o uvero con questo altro,  ,
saraà dissimile nella battuta, cioè che ogni minima di questo,
,
saraà dissimile nella battuta, cioè che ogni minima di questo,  , saraà in quatitaà di una semib. delli dui sequeti,
, saraà in quatitaà di una semib. delli dui sequeti,  ,
,  ,. dDi poi questo,
,. dDi poi questo,  , co questo,
, co questo,  ,
faraà nella battuta ciascuna minima del primo in quatitaà di una breuve del
secodo, et anchora di questo,
,
faraà nella battuta ciascuna minima del primo in quatitaà di una breuve del
secodo, et anchora di questo,  2. Et se questo,
2. Et se questo,  , saraà coparato co que-sto,
, saraà coparato co que-sto,  , saraà simile nella battuta, becheé dissimile sia nella [s1562: page 26]pfettione del tepo.
Ma di questi,
, saraà simile nella battuta, becheé dissimile sia nella [s1562: page 26]pfettione del tepo.
Ma di questi,  , [#s1523:
, [#s1523:  ,] [#s1529:
,] [#s1529:  [sic: delete]] [#s1539:
[sic: delete]] [#s1539:  [sic: delete]] [#s1562:
[sic: delete]] [#s1562:  [sic: delete]] sarano duplicate le note, cioè che questo,
[sic: delete]] sarano duplicate le note, cioè che questo,  , haraà ogni
sua semibre. nella battuta di due semibr. di questo,
, haraà ogni
sua semibre. nella battuta di due semibr. di questo,  . dDa poi in questo,
. dDa poi in questo,  ,
con questo,
,
con questo,  2,
2, Tempo di Quadru-pla sarano le semibre. del primo in quatitaà, et battuta di quatro semibreuvi del sequete,
Tempo di Quadru-pla sarano le semibre. del primo in quatitaà, et battuta di quatro semibreuvi del sequete,  2. Anchor in questo, [#s1523:
2. Anchor in questo, [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  [sic: delete]] [#s1539:
[sic: delete]] [#s1539:  [sic: delete]] [#s1562:
[sic: delete]] [#s1562:  [sic: delete]] , con questo,
[sic: delete]] , con questo,  2, sarano le note sue duplicate, pcheé due semibreuvi di questo,
2, sarano le note sue duplicate, pcheé due semibreuvi di questo,  2, uvano nella battuta di una di questo,
2, uvano nella battuta di una di questo,  . Questi,
. Questi,  ,
,  , sarano dissimili nella battuta, cioè
che di questo,
, sarano dissimili nella battuta, cioè
che di questo,  , saraà cantata una semibreuve in quantitaà, et spacio di una
breuve di questo,
, saraà cantata una semibreuve in quantitaà, et spacio di una
breuve di questo,  . iIn questo,
. iIn questo,  , co questo,
, co questo,  2, sarano le figure moltiplicate in [#s1523: quadruplo] [#s1529: quadro] [#s1539: quadro] [#s1562: quadro] , cioè che ogni lunga di questo,
2, sarano le figure moltiplicate in [#s1523: quadruplo] [#s1529: quadro] [#s1539: quadro] [#s1562: quadro] , cioè che ogni lunga di questo,  2, saraà in quatitaà di una [s1523: page 46]semibreuve dello apparente
2, saraà in quatitaà di una [s1523: page 46]semibreuve dello apparente  . aAnchora questo,
. aAnchora questo,  , con questo,
, con questo,  , saranno
nella battuta dissimili, pcheé in questo,
, saranno
nella battuta dissimili, pcheé in questo,  , passeraà ogni breuve in quantitaà di
una semibreuve di questo,
, passeraà ogni breuve in quantitaà di
una semibreuve di questo,  . qQuesto,
. qQuesto,  2, co questo,
2, co questo,  , faraà ogni sua semi-breuve in quatitaà di una lunga [s1529: page 49]del precedente. Questo,
, faraà ogni sua semi-breuve in quatitaà di una lunga [s1529: page 49]del precedente. Questo,  , con questo,
, con questo,  2,
faraà di ogni sua breuve una battuta, la quale passeraà in quatitaà di due breuvi
di questo,
2,
faraà di ogni sua breuve una battuta, la quale passeraà in quatitaà di due breuvi
di questo,  2. qQuesto,
2. qQuesto,  2, con questo,
2, con questo,  , son simili in misura. Sogliono anchora li copositori dimostrare questo segno,
, son simili in misura. Sogliono anchora li copositori dimostrare questo segno,  , nel quale ogni sua nota re-sta diminuta della sua mezza parte coparato a questo,
, nel quale ogni sua nota re-sta diminuta della sua mezza parte coparato a questo,  , come essaminado trouverai nelli canti. Alcuni altri hano dimostrato tal segno,
, come essaminado trouverai nelli canti. Alcuni altri hano dimostrato tal segno,  , coparato
a questo,
, coparato
a questo,  , essere ogni due breuvi di questo,
, essere ogni due breuvi di questo,  , in quatitaà di tre semibreuvi
di questo,
, in quatitaà di tre semibreuvi
di questo,  ,
, et in [s1539: page 27]molti altri modi, come fare si potrebbe. mMa pcheé alcuni
confabulando dicono qual sia la cagione, che li copositori nostri antichi et
moderni hano osseruvato nelli segni di sopra mostrati il uvalore alle note con
uvarii modi, et misure, facendo la differenza del circolo al semicircolo comparato solamete nella breuve, laqual resta di quatitaà di tre semibreuvi nel presente segno,
et in [s1539: page 27]molti altri modi, come fare si potrebbe. mMa pcheé alcuni
confabulando dicono qual sia la cagione, che li copositori nostri antichi et
moderni hano osseruvato nelli segni di sopra mostrati il uvalore alle note con
uvarii modi, et misure, facendo la differenza del circolo al semicircolo comparato solamete nella breuve, laqual resta di quatitaà di tre semibreuvi nel presente segno,  , et di due in questo,
, et di due in questo,  , et ogni altra figura cantabile resta
in una equal misura., di poi considerado dicono, che in questi segni mede-simi puntati in mezzo, fanno, che in questo,
, et ogni altra figura cantabile resta
in una equal misura., di poi considerado dicono, che in questi segni mede-simi puntati in mezzo, fanno, che in questo,  , ogni sua minima resta nel
uvalore, et misura di una semibreuve di questo,
, ogni sua minima resta nel
uvalore, et misura di una semibreuve di questo,  , la qual differeza uviene p
forza di quel punto. - et cosiì non pare, che sia da esser tal modo concesso: -
la cagione di qui uviene. sSe fra li dui segni presenti,
, la qual differeza uviene p
forza di quel punto. - et cosiì non pare, che sia da esser tal modo concesso: -
la cagione di qui uviene. sSe fra li dui segni presenti,  ,
,  , non si fa diffe-renza di altro, che dalla breuve pfetta alla imperfetta, et ogni altra sua nota
sia con equal misura pronontiata, et connumerata, per consequente resta,
che qua non habbia ad essere alcuna differenza, excetto della semibreuve,
qual uviene pfetta per uvigore del punto, et la breuve uviene augumetata delle
tre minime, come qui, [#s1523:
, non si fa diffe-renza di altro, che dalla breuve pfetta alla imperfetta, et ogni altra sua nota
sia con equal misura pronontiata, et connumerata, per consequente resta,
che qua non habbia ad essere alcuna differenza, excetto della semibreuve,
qual uviene pfetta per uvigore del punto, et la breuve uviene augumetata delle
tre minime, come qui, [#s1523:  ,
,  ] [#s1529:
] [#s1529:  .,
.,  ] [#s1539:
] [#s1539:  .,
.,  ] [#s1562:
] [#s1562:  .,
.,  ] . Ma piuù dubbiosi restano nelli sequenti, cioè
che in questo segno,
] . Ma piuù dubbiosi restano nelli sequenti, cioè
che in questo segno,  , sia ogni sua semib. [#s1523: duplicata] [#s1529: dupplichera] [#s1539: dupplichera] [#s1562: dupplicherà [sic: duplicata]] coparato a questo,
, sia ogni sua semib. [#s1523: duplicata] [#s1529: dupplichera] [#s1539: dupplichera] [#s1562: dupplicherà [sic: duplicata]] coparato a questo,  :.
eEt ritrouvando di poi che questo segno,
:.
eEt ritrouvando di poi che questo segno,  , coparato a questo,
, coparato a questo,  , resti ciascu-na minima di questo,
, resti ciascu-na minima di questo,  , nella quatitaà, et misura di una breuve di questo,
, nella quatitaà, et misura di una breuve di questo,  .,
qua la ragione, et [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: la ] intelligeza alloro manca, et quasi non sanno, che dire. Si
risponde che se da Iosquino, et da Obreth è stato usitato ponere la misura
nella minima in questi segni.,
.,
qua la ragione, et [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: la ] intelligeza alloro manca, et quasi non sanno, che dire. Si
risponde che se da Iosquino, et da Obreth è stato usitato ponere la misura
nella minima in questi segni.,  .,
.,  , credo che dalloro tale cosa sia piuù
presto stata fatta p autoritaà, che p ragione alcuna., Iimperoò che li loro pre-decessori, et maestri, come Busnois, Ocheghen, et Duffai, et altri assai, alli
quali, p essere alli tepi loro stati huomini famosi, hano prestato grade fede:,
et per tanto hano sequitato tal modo, il quale modo, cioè di dare la misura [s1523: page 47]nella minima:, no è da uvitupare:, pcheé Bartholomeo rRami dice, che tal modo
di dare la misura nella minima delli segni puntati è stato (come ho detto [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: di
sopra] )
osseruvato da Ocheghen, Busnois, et Duffai, et da Giouvani di mMote, suo precettore, et anchora da altri huomini in questa facoltaà famosissimi:. eEt aggiuge il [s1529: page 50]medesimo Bartholomeo rRami, che questo si puoò ragioneuvolmete fare,
[#s1523: pcheé dice, che] [#s1529: pcheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] Busnois, et li altri pnominati, liquali erano huomini magni
in questa facoltaà:, si fondauvano nella atiquitaà, cioè in mathematica ragioe:,
la qual tratta di cotinua, et discreta quatitaà:, della qual quatitaà siì come la discreta, la qual tratta di numeri:, augumeta in crescedo:, cosiì la cotinua in di-videdo minuisce. Aduq, cosiì come li antiqui poneuvano la retta misura nella
breuve, et [#s1523: nella] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] lunga, et alcuna uvolta nella maxima, [#s1523: le quali] [#s1529: laqual] [#s1539: laqual] [#s1562: laqual] lunga et maxima nascono dalla breuve molte uvolte presa:, cosiì noi, diuvidedo il tepo, ouvero
la breuve in parti, poteremo ponere essa misura no solo nella breuve, ma an-chora nella semibre. et [#s1523: alcuna uvolta] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] nella minima:, le quali son figure, che diuvidono il tepo, ouvero la breuve in parti., la qual diuvisione dimostra, che la cotinua quatitaà no è di minor efficacia in canto misurato, che sia la discreta.
Per tato, cosiì come li antichi hano [#s1523: usitato] [#s1529: usato] [#s1539: usato] [#s1562: usato] dare [#s1523: alcuna] [#s1529:
alcuna] [#s1539: alcuna] [#s1562: qualche] uvolta la misura nella
lugha, et nella maxima, le quali son figure, che [#s1523: nascono] [#s1529: nascono] [#s1539: nascono] [#s1562: vengono a nascere] dalla aggregatioe
del tepo:, cosiì p tal ragioe essa misura (dice) che si potraà [#s1523: locare] [#s1529: locare] [#s1539: locare] [#s1562: allocare] nella semib.
et nella minima:, le quali son cosiderate come parti del tepo. Ma circa [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: a ] qllo,
che di sopra s'eè opposto:, cioè che siì come tra questi segni,
, credo che dalloro tale cosa sia piuù
presto stata fatta p autoritaà, che p ragione alcuna., Iimperoò che li loro pre-decessori, et maestri, come Busnois, Ocheghen, et Duffai, et altri assai, alli
quali, p essere alli tepi loro stati huomini famosi, hano prestato grade fede:,
et per tanto hano sequitato tal modo, il quale modo, cioè di dare la misura [s1523: page 47]nella minima:, no è da uvitupare:, pcheé Bartholomeo rRami dice, che tal modo
di dare la misura nella minima delli segni puntati è stato (come ho detto [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: di
sopra] )
osseruvato da Ocheghen, Busnois, et Duffai, et da Giouvani di mMote, suo precettore, et anchora da altri huomini in questa facoltaà famosissimi:. eEt aggiuge il [s1529: page 50]medesimo Bartholomeo rRami, che questo si puoò ragioneuvolmete fare,
[#s1523: pcheé dice, che] [#s1529: pcheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] Busnois, et li altri pnominati, liquali erano huomini magni
in questa facoltaà:, si fondauvano nella atiquitaà, cioè in mathematica ragioe:,
la qual tratta di cotinua, et discreta quatitaà:, della qual quatitaà siì come la discreta, la qual tratta di numeri:, augumeta in crescedo:, cosiì la cotinua in di-videdo minuisce. Aduq, cosiì come li antiqui poneuvano la retta misura nella
breuve, et [#s1523: nella] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] lunga, et alcuna uvolta nella maxima, [#s1523: le quali] [#s1529: laqual] [#s1539: laqual] [#s1562: laqual] lunga et maxima nascono dalla breuve molte uvolte presa:, cosiì noi, diuvidedo il tepo, ouvero
la breuve in parti, poteremo ponere essa misura no solo nella breuve, ma an-chora nella semibre. et [#s1523: alcuna uvolta] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] nella minima:, le quali son figure, che diuvidono il tepo, ouvero la breuve in parti., la qual diuvisione dimostra, che la cotinua quatitaà no è di minor efficacia in canto misurato, che sia la discreta.
Per tato, cosiì come li antichi hano [#s1523: usitato] [#s1529: usato] [#s1539: usato] [#s1562: usato] dare [#s1523: alcuna] [#s1529:
alcuna] [#s1539: alcuna] [#s1562: qualche] uvolta la misura nella
lugha, et nella maxima, le quali son figure, che [#s1523: nascono] [#s1529: nascono] [#s1539: nascono] [#s1562: vengono a nascere] dalla aggregatioe
del tepo:, cosiì p tal ragioe essa misura (dice) che si potraà [#s1523: locare] [#s1529: locare] [#s1539: locare] [#s1562: allocare] nella semib.
et nella minima:, le quali son cosiderate come parti del tepo. Ma circa [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: a ] qllo,
che di sopra s'eè opposto:, cioè che siì come tra questi segni,  ,
,  , no cade altra
differeza circa la battuta, ma siì nella quantitaà della breuve, che anchora in
qsti., [#s1523:
, no cade altra
differeza circa la battuta, ma siì nella quantitaà della breuve, che anchora in
qsti., [#s1523:  .,
.,  ] [#s1529:
] [#s1529:  .,
.,  ] [#s1539:
] [#s1539:  ,
,  ] [#s1562:
] [#s1562:  ,
,  ] ., non douvesse essere altra differeza, che solo della semib., et simil-mete tra qsti.,
] ., non douvesse essere altra differeza, che solo della semib., et simil-mete tra qsti.,  .,
.,  ., si responde, che [#s1523: qlli] [#s1529: quegli] [#s1539: quegli] [#s1562: coloro iquali] , che uvorrano [#s1523: tendere] [#s1529: tendere] [#s1539: tendere] [#s1562: attendere] a qsto: trouve-rano, che nella musica misurata uno solo segno basteraà., pcheé [#s1523: ciascuno] [#s1529: ciascuno] [#s1539: ciascuno] [#s1562: ciascheduno] delli
altri, come son questi,
., si responde, che [#s1523: qlli] [#s1529: quegli] [#s1539: quegli] [#s1562: coloro iquali] , che uvorrano [#s1523: tendere] [#s1529: tendere] [#s1539: tendere] [#s1562: attendere] a qsto: trouve-rano, che nella musica misurata uno solo segno basteraà., pcheé [#s1523: ciascuno] [#s1529: ciascuno] [#s1539: ciascuno] [#s1562: ciascheduno] delli
altri, come son questi,  ,
,  .,
.,  , si potrebbono exeplare: et pronotiare sotto
qsto,
, si potrebbono exeplare: et pronotiare sotto
qsto,  , [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] altro no saraà una breuve pfetta di qsto segno.,
, [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] altro no saraà una breuve pfetta di qsto segno.,  ., che una lu-ga, et una mini. di qsto,
., che una lu-ga, et una mini. di qsto,  ,
, 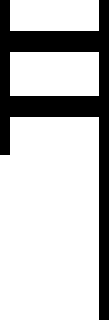 .
.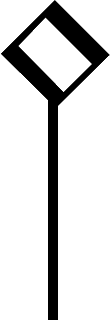 , o uvero cosiì
, o uvero cosiì 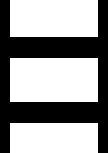
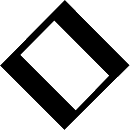
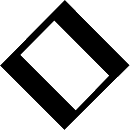 , o uvero [#s1523: cosiì] [#s1529: cosiì] [#s1539: cosiì] [#s1562: a questo modo]
, o uvero [#s1523: cosiì] [#s1529: cosiì] [#s1539: cosiì] [#s1562: a questo modo] 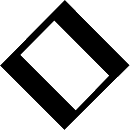 .
.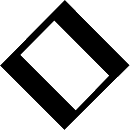 .
.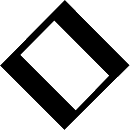
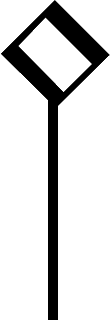 ,
et i molti altri modi, li quali possono accadere. [s1562: page 27]sSimilmente altro non
saraà una semibreuve pfetta di qsto segno.,
,
et i molti altri modi, li quali possono accadere. [s1562: page 27]sSimilmente altro non
saraà una semibreuve pfetta di qsto segno.,  ., che una semibreuve di questo
posta cosiì/,
., che una semibreuve di questo
posta cosiì/,  /,
/,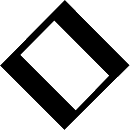 .,
.,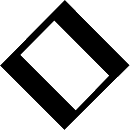
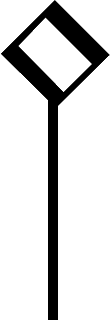 , et il simile accaderaà di altri segni predetti., per la
qual cosa appareria, che li nostri antichi si sarebbono in uvano affaticati:,
percheé harrebbono dimostrato per molti segni quello, che per uno solo
segno si puoò dimostrare, et intendere. Onde si debbe credere, che dalloro
tali segni son stati intesi, come p la senteza del predetto Bartholomeo eè di-mostrato:, douve egli dice, che dalli antichi in questi segni.,
, et il simile accaderaà di altri segni predetti., per la
qual cosa appareria, che li nostri antichi si sarebbono in uvano affaticati:,
percheé harrebbono dimostrato per molti segni quello, che per uno solo
segno si puoò dimostrare, et intendere. Onde si debbe credere, che dalloro
tali segni son stati intesi, come p la senteza del predetto Bartholomeo eè di-mostrato:, douve egli dice, che dalli antichi in questi segni.,  .,
.,  ., la misura [s1523: page 48]era posta nella semibreuve, et che in tal segni la breuve uvaleuva tre misure:. eEt
dice, che in questi,
., la misura [s1523: page 48]era posta nella semibreuve, et che in tal segni la breuve uvaleuva tre misure:. eEt
dice, che in questi,  ,
,  , similmente la misura era [s1539: page 28]locata sopra la semibre.
et che la breuve uvaleuva due misure:. eEt dice, che p tal modo la misura alcuna
uvolta restauva diuvisa in tre minime, come in qsti segni accade,
, similmente la misura era [s1539: page 28]locata sopra la semibre.
et che la breuve uvaleuva due misure:. eEt dice, che p tal modo la misura alcuna
uvolta restauva diuvisa in tre minime, come in qsti segni accade,  .,
.,  ., et al-cuna uvolta in due, come per questi segni,
., et al-cuna uvolta in due, come per questi segni,  ,
,  , era dimostrato:. [s1529: page 51]eEt dice, che
questo tale ordine era frequetemete osseruvato, et che secodo la antica exercitatione, le semibreuvi, et le minime di questi dui segni,
, era dimostrato:. [s1529: page 51]eEt dice, che
questo tale ordine era frequetemete osseruvato, et che secodo la antica exercitatione, le semibreuvi, et le minime di questi dui segni,  ,
,  , erano intese
equali in quatitaà, et pronontiatioe:, et affirma, che le minime, et semibreuvi
di questi dui,
, erano intese
equali in quatitaà, et pronontiatioe:, et affirma, che le minime, et semibreuvi
di questi dui,  ,
,  , erano intra loro equali:. mMa da noi, et esso no è affermato, che una semibreuve pfetta di ciascu di questi segni,
, erano intra loro equali:. mMa da noi, et esso no è affermato, che una semibreuve pfetta di ciascu di questi segni,  ,
,  , sia equale alla
semibreuve di questi,
, sia equale alla
semibreuve di questi,  ,
,  , percheé (come egli testifica) se in questi dui.,
, percheé (come egli testifica) se in questi dui.,  ,
,  ,
una semibreuve pfetta, ouver tre minime, ouver sei semiminime erano cantate
per la pfetta misura, il qual modo di catare era chiamato dalli antichi Cantare p maggiorée.
,
una semibreuve pfetta, ouver tre minime, ouver sei semiminime erano cantate
per la pfetta misura, il qual modo di catare era chiamato dalli antichi Cantare p maggiorée.cantare p maggiore, -et anchora tal modo di cantare è frequetato dalli cotra-puntati nelle capelle delli signori, maximamete quado sopra canto piano fanno cotraputo. - et pcheé tal modo di cantare (come pruouvano li canti antichi) era molto grato ad essi antichi:, quasi tutti li loro coceti, et harmonice copositioni erano di tali segni puntati exercitati., p la qual cosa si [#s1523: existima] [#s1529: esistima] [#s1539: esistima] [#s1562: stima] , che da Busnois fusse trouvato quel canto chiamato lL'ome armèé, notato co il segno puntato:, et che dallui fussi tolto il tenore:, et pcheé esso era brieuve, che dallui, p hauver capo piuù largo senza mutar segno, fussi trasmutata la misu-ra, la qual cadeuva sopra la pfetta semibre., nella minima., la qual cosa a lui, che era grade huomo, et ottimo musico: no fu attribuita ad errore. aAnchora il simile ad Ocheghe, et [#s1523: ad] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] altri antichi, et ad Obreth, et a Iosquino no saraà uvitupio hauver sequito le [#s1523: estigia [sic: vestigie]] [#s1529: uvestigie] [#s1539: uvestigie] [#s1562: uvestigie] delli suoi pdecessori. Ma a coloro, li quali ponerano la misura nella semibreuve in questi segni,
 ,
,  , saraà no poco uvituperio:, pcheé harriano addotto in luce quello, che mai no fu pensato da alcuno dotto.
, saraà no poco uvituperio:, pcheé harriano addotto in luce quello, che mai no fu pensato da alcuno dotto.  Per tato cochiudemo, che in tali segni putati cade la misura nella
minima, quado in uno canto solo fusse una sola partita di esso canto, come
il tenore:. mMa se tutte le parti del canto sarano per segno puntato segnate, si
teneraà altro ordine, pcheé allhora per una misura, ouver battuta passeraà una
semibreuve perfetta, ouvero tre minime:, come da Ocheghe è stato osseruvato
in una parte del pPatre della sua mMessa di lL'ome armèé.
Per tato cochiudemo, che in tali segni putati cade la misura nella
minima, quado in uno canto solo fusse una sola partita di esso canto, come
il tenore:. mMa se tutte le parti del canto sarano per segno puntato segnate, si
teneraà altro ordine, pcheé allhora per una misura, ouver battuta passeraà una
semibreuve perfetta, ouvero tre minime:, come da Ocheghe è stato osseruvato
in una parte del pPatre della sua mMessa di lL'ome armèé.
COME LI CANTORI [#s1523: HABBIANO] [#s1529: HANNO] [#s1539: HANNO] [#s1562: HANNO] A NVU-MERARE LI CANTI CAP. XXXVIIII.
DELLE NOTE IN LEGATVURA. CAP. XXXX.
 obliqua rispetto alla lunghezza sua, come la
presente dimostra,
obliqua rispetto alla lunghezza sua, come la
presente dimostra,  del che auvertirai, che nelle qdrate note, ogni qdrato dimostra un corpo di una sola nota:, ma la figura obliqua è di cotrario effetto, cioè che d'ogni corpo apparente il principio, et l'extremo suo
fanno due note, come esse fussino distinte, et separate. Legatura quel che siaEt no eè altro la legatura, che una certa qtitaà di note semplici in seé raccolte., p la qual cosa è stato [s1523: page 50]necessario, che sia uvariato il nome, et la sua forma., Iimpoò che è ordinato. [s1529: page 53]4.
figure, ouver note potersi colligare:, le quali sono maxima, luga, breuve, et se-mibr., o siano ascedenti, o discedenti. La ligatura aduque ascedete è quella,
nella quale la secoda nota sopra auvanza, et è superiore alla prima:, dato che
sia con uvirgola, o senza [#s1523: uvirgola] [#s1529: uvirgola] [#s1539: uvirgola] [#s1562: ] , come qui,
del che auvertirai, che nelle qdrate note, ogni qdrato dimostra un corpo di una sola nota:, ma la figura obliqua è di cotrario effetto, cioè che d'ogni corpo apparente il principio, et l'extremo suo
fanno due note, come esse fussino distinte, et separate. Legatura quel che siaEt no eè altro la legatura, che una certa qtitaà di note semplici in seé raccolte., p la qual cosa è stato [s1523: page 50]necessario, che sia uvariato il nome, et la sua forma., Iimpoò che è ordinato. [s1529: page 53]4.
figure, ouver note potersi colligare:, le quali sono maxima, luga, breuve, et se-mibr., o siano ascedenti, o discedenti. La ligatura aduque ascedete è quella,
nella quale la secoda nota sopra auvanza, et è superiore alla prima:, dato che
sia con uvirgola, o senza [#s1523: uvirgola] [#s1529: uvirgola] [#s1539: uvirgola] [#s1562: ] , come qui,  ma la discedete ligatu-ra è quella, nella quale la secoda nota appare inferiore alla pri-ma, coe qui/,
ma la discedete ligatu-ra è quella, nella quale la secoda nota appare inferiore alla pri-ma, coe qui/,  / se bene ascedono, o discendono, co uvirgola, o senza
uvirgola, di cotraria quatitaà et nome., pcheé trouvando piuù figure, o
note oblique, o quadre, senza uvirgola ascedenti, se esse fussino be mille, sempre sarano breuvi:, et p il cotrario, la prima, et ultima sarano lughe di forma
quadra. Ma pcheé sempre in questo mio Thoscanello mi sono affaticato co
modi facili, p li quali a te no sia di fastidio:, no uvoglio meno opare nel pre-sente capi. la dimostratione, et prattica necessaria a questo. Et prima notanota,
che ogni uvirgola ascedente dalla parte sinistra, ataccata alla nota quadra,
et obliqua, sempre dimostra la prima, et secoda nota semibreuve, o sia asce-dente, o discendente. mMa quelle del mezzo, oblique, et quadre, senza alcun
dubbio sarano breuvi:, saluvo che l'ultima discedente quadra, la quale eè luga.
Et se la uvirgola appariraà dal cato sinistro discedente co due note sole, la prima saraà breuve, et la secoda lunga:. mMa se sarano piuù di due, la prima, et la secoda sarano breuvi, et se ascederano tutte, co uvirgola, o senza uvirgola, sarano
breuvi:. dDi poi, se la uvirgola saraà dal canto destro discedete, o ascedete, questo
no maca, che saraà maxia, ouvero luga. Oltra [#s1523: ] [#s1529: di ] [#s1539: di ] [#s1562: di ] cioò si truouva achora la psente
figura,
/ se bene ascedono, o discendono, co uvirgola, o senza
uvirgola, di cotraria quatitaà et nome., pcheé trouvando piuù figure, o
note oblique, o quadre, senza uvirgola ascedenti, se esse fussino be mille, sempre sarano breuvi:, et p il cotrario, la prima, et ultima sarano lughe di forma
quadra. Ma pcheé sempre in questo mio Thoscanello mi sono affaticato co
modi facili, p li quali a te no sia di fastidio:, no uvoglio meno opare nel pre-sente capi. la dimostratione, et prattica necessaria a questo. Et prima notanota,
che ogni uvirgola ascedente dalla parte sinistra, ataccata alla nota quadra,
et obliqua, sempre dimostra la prima, et secoda nota semibreuve, o sia asce-dente, o discendente. mMa quelle del mezzo, oblique, et quadre, senza alcun
dubbio sarano breuvi:, saluvo che l'ultima discedente quadra, la quale eè luga.
Et se la uvirgola appariraà dal cato sinistro discedente co due note sole, la prima saraà breuve, et la secoda lunga:. mMa se sarano piuù di due, la prima, et la secoda sarano breuvi, et se ascederano tutte, co uvirgola, o senza uvirgola, sarano
breuvi:. dDi poi, se la uvirgola saraà dal canto destro discedete, o ascedete, questo
no maca, che saraà maxia, ouvero luga. Oltra [#s1523: ] [#s1529: di ] [#s1539: di ] [#s1562: di ] cioò si truouva achora la psente
figura,  della qle secodo la generale opinioe si dice, che la prima è luga,
et la secoda breuve:, ma ascedete, come qui,
della qle secodo la generale opinioe si dice, che la prima è luga,
et la secoda breuve:, ma ascedete, come qui,  si dice breuve, et breuve.,
della qual cosideratioe si adduce i cotrario, pcheé tali figure discedeti, et ascedeti, come qui,
si dice breuve, et breuve.,
della qual cosideratioe si adduce i cotrario, pcheé tali figure discedeti, et ascedeti, come qui,  , non si dicono altro, che breuvi, et le se-queti, come q,
, non si dicono altro, che breuvi, et le se-queti, come q,  , semibreuvi., p la qual cosa si risponde, che nel primo
essempio di sopra mostrato, per il fondamento delle presenti,
esse figure debbono essere simili di nome, et quatitaà., Iimperoò che no uvaria-do le dette dinanzi ascedenti, et discedenti, esse no debbono anchora esser
uvariate. nNo di meno quello, che a te piace, osseruverai. VUltimamete nel prin-cipio della figura sequete sono alcue note in mezzo co la uvirgola appresso
di alcuni chiamate lunghe, nelle quali appare un punto in ultimo della sua
uvirgola:, et pcheé sono alcuni altri di contraria opinione, [#s1523: li quali dicono tali
note, che sono in mezzo:, chiamarsi breuvi, et senza uvirgola, et altri lughe co
la uvirgola] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] :, io ti pongo l'uno, et l'altro essempio, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: hora ] fa' come a te [#s1523: pare] [#s1529: piace] [#s1539: piace] [#s1562: piace] . [s1523: page 51][s1529: page 54][s1539: page 30][s1562: page 29]
, semibreuvi., p la qual cosa si risponde, che nel primo
essempio di sopra mostrato, per il fondamento delle presenti,
esse figure debbono essere simili di nome, et quatitaà., Iimperoò che no uvaria-do le dette dinanzi ascedenti, et discedenti, esse no debbono anchora esser
uvariate. nNo di meno quello, che a te piace, osseruverai. VUltimamete nel prin-cipio della figura sequete sono alcue note in mezzo co la uvirgola appresso
di alcuni chiamate lunghe, nelle quali appare un punto in ultimo della sua
uvirgola:, et pcheé sono alcuni altri di contraria opinione, [#s1523: li quali dicono tali
note, che sono in mezzo:, chiamarsi breuvi, et senza uvirgola, et altri lughe co
la uvirgola] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] :, io ti pongo l'uno, et l'altro essempio, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: hora ] fa' come a te [#s1523: pare] [#s1529: piace] [#s1539: piace] [#s1562: piace] . [s1523: page 51][s1529: page 54][s1539: page 30][s1562: page 29]
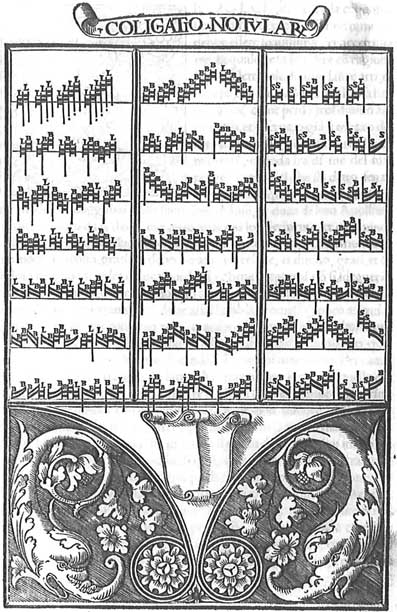
COLIGATIO NOTVULAR
[#s1523: LIBRO] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: IL TOSCANELLO IN MVUSICA DI M. PIETRO ARON FIORETNINO [sic: FIORENTINO]. LIBRO] SECONDO.
CHE COSA SIA TVUONO. CAP. I.
 mi, ouvero secodo li gGreci da proslambanóomenos a hypáate hypatôon, le qli chorde rispondono appresso di noi queste syllabe, [#s1523: ] [#s1529: ut-re, & ] [#s1539: ut-re & ] [#s1562: Vut-re & ] re,-mi, cosiì
in ascedere, come in discedere, secodo l'ordine naturale.,
et è diuviso in due parti differenti, delle quali l'una saraà
maggiore, et l'altra minore. lLa parte maggiore è detta da' gGreci Apotomèe parte maggre del tuono apotomèe,
qual no importa altro, che semituono maggiore. lLa minor parte è chiama-ta Lima parte minorelima, che tato è, come semituono minore., la qual diuvisioe resta stabile in
tutti li segueti tuoni. Il terzo luoco, douve è causato il tuono, è da parhypáate
hypatôon a licanòos hypatôon, cioè da C fa ut a D sol re, co queste note, fa-sol,
et sol-fa. Il qrto tuono nasce da lichanòos [#s1523: hypatôon] [#s1529: hypatôon] [#s1539: hypaton] [#s1562: hypatonia] a hypáate mesôon, cioè D
sol re, et E la mi, co qste uvoci, re-mi, et mi-re. Il qnto tuono appare da parhypáate mesôon a lichanòos mesôon, cioè da F fa ut a G sol re ut, cosiì dicendo, fa-
sol, et sol-fa, ut-re, et re-ut, in ascedere, et discedere. Il sesto tuono cade da li-chanòos mesôon a méese, cioè G sol re ut, et A la mi re, dicedo sol-la, et la-sol,
re-mi, et mi-re, ut-re, et re-ut. Il settimo tuono si cosidera da méese a paraméese, cioè A la mi re, et
mi, ouvero secodo li gGreci da proslambanóomenos a hypáate hypatôon, le qli chorde rispondono appresso di noi queste syllabe, [#s1523: ] [#s1529: ut-re, & ] [#s1539: ut-re & ] [#s1562: Vut-re & ] re,-mi, cosiì
in ascedere, come in discedere, secodo l'ordine naturale.,
et è diuviso in due parti differenti, delle quali l'una saraà
maggiore, et l'altra minore. lLa parte maggiore è detta da' gGreci Apotomèe parte maggre del tuono apotomèe,
qual no importa altro, che semituono maggiore. lLa minor parte è chiama-ta Lima parte minorelima, che tato è, come semituono minore., la qual diuvisioe resta stabile in
tutti li segueti tuoni. Il terzo luoco, douve è causato il tuono, è da parhypáate
hypatôon a licanòos hypatôon, cioè da C fa ut a D sol re, co queste note, fa-sol,
et sol-fa. Il qrto tuono nasce da lichanòos [#s1523: hypatôon] [#s1529: hypatôon] [#s1539: hypaton] [#s1562: hypatonia] a hypáate mesôon, cioè D
sol re, et E la mi, co qste uvoci, re-mi, et mi-re. Il qnto tuono appare da parhypáate mesôon a lichanòos mesôon, cioè da F fa ut a G sol re ut, cosiì dicendo, fa-
sol, et sol-fa, ut-re, et re-ut, in ascedere, et discedere. Il sesto tuono cade da li-chanòos mesôon a méese, cioè G sol re ut, et A la mi re, dicedo sol-la, et la-sol,
re-mi, et mi-re, ut-re, et re-ut. Il settimo tuono si cosidera da méese a paraméese, cioè A la mi re, et  mi, co qste note, re-mi, et mi-re. L'ottauvo tuono è da
tríite synemenôon, a paranéete synemenôon, cioè B
mi, co qste note, re-mi, et mi-re. L'ottauvo tuono è da
tríite synemenôon, a paranéete synemenôon, cioè B fa, et C sol fa ut, co qste no-te, fa-sol, et sol-fa. Il nono tuono si ritruouva da tríite diezeugmenôon a paranéete diezeugmenôon, cioè C sol fa ut, et D la sol re, co qste syllabe, fa-sol, et sol-
fa, ut-re, et re-ut. Il decimo tuono è dimostrato da paranéete diezeugmenôon
a néete diezeugmenôon, cioè [#s1523: D ] [#s1529: dD ] [#s1539: dD ] [#s1562: D ] Lla sol re, et E la mi, cosiì dicedo, sol-la, et la-sol, re-
mi, et mi-re. L'undecio tuono è da tríite hypboléeon a paranéete hypboléeon,
cioè da F fa ut, et G sol re ut, co qste note, fa-sol, et sol-fa, ut-re, et re-ut. Il duodecimo tuono è da paranéete hypboléeon a néete hyperboléeon, cioè da G sol
re ut ad A la mi re, co tal processo, sol-la, et la-sol, re-mi, et mi-re, ut-re, et re-ut.
Il terzodecimo tuono è da néete hyperboléeon a
fa, et C sol fa ut, co qste no-te, fa-sol, et sol-fa. Il nono tuono si ritruouva da tríite diezeugmenôon a paranéete diezeugmenôon, cioè C sol fa ut, et D la sol re, co qste syllabe, fa-sol, et sol-
fa, ut-re, et re-ut. Il decimo tuono è dimostrato da paranéete diezeugmenôon
a néete diezeugmenôon, cioè [#s1523: D ] [#s1529: dD ] [#s1539: dD ] [#s1562: D ] Lla sol re, et E la mi, cosiì dicedo, sol-la, et la-sol, re-
mi, et mi-re. L'undecio tuono è da tríite hypboléeon a paranéete hypboléeon,
cioè da F fa ut, et G sol re ut, co qste note, fa-sol, et sol-fa, ut-re, et re-ut. Il duodecimo tuono è da paranéete hypboléeon a néete hyperboléeon, cioè da G sol
re ut ad A la mi re, co tal processo, sol-la, et la-sol, re-mi, et mi-re, ut-re, et re-ut.
Il terzodecimo tuono è da néete hyperboléeon a  mi, cioè A la mi re, et B
mi, cioè A la mi re, et B fa
fa  mi, con queste note, re-mi, et mi-re. Il quarto decimo tuono nasce dal
fa di B
mi, con queste note, re-mi, et mi-re. Il quarto decimo tuono nasce dal
fa di B fa
fa  [s1539: page 32]mi a C sol fa, dicedo fa-sol, [#s1523: et sol-] [#s1529: & sol-] [#s1539: & sol-] [#s1562: ] fa.; Iil qntodecimo tuono da C
sol fa a D la sol con tal discorso, fa-sol, et sol-fa, o uvero sol-la, et la-sol. Il decio
sesto, et ultimo tuono è da D la sol ad E la, co qste note, sol-la, et la-sol, come
nella figura diatonica piuù facilmete intederai:, il qual tuono cade nella proportione sesquiottauva posta in qsti numeri, otto a nouve, ouvero altri simili. [s1523: page 55][s1529: page 57][s1562: page 31]
[s1539: page 32]mi a C sol fa, dicedo fa-sol, [#s1523: et sol-] [#s1529: & sol-] [#s1539: & sol-] [#s1562: ] fa.; Iil qntodecimo tuono da C
sol fa a D la sol con tal discorso, fa-sol, et sol-fa, o uvero sol-la, et la-sol. Il decio
sesto, et ultimo tuono è da D la sol ad E la, co qste note, sol-la, et la-sol, come
nella figura diatonica piuù facilmete intederai:, il qual tuono cade nella proportione sesquiottauva posta in qsti numeri, otto a nouve, ouvero altri simili. [s1523: page 55][s1529: page 57][s1562: page 31]DEL SEMITVUONO MINORE, ET MAGGIORE. CAP. II.
 mi, et C fa
ut, in qsto modo, mi-fa, et fa-mi, cosiì in ascedere, come in discedere. Il secodo
semituono si ritruouva tra hypáate mesôon, et parhypáate mesôon, cioè E la mi,
et F fa ut, cosiì dicedo achora mi-fa, et fa-mi. Il terzo semituono è da méese a
tríite synemenôon, cioè A la mi re, et B
mi, et C fa
ut, in qsto modo, mi-fa, et fa-mi, cosiì in ascedere, come in discedere. Il secodo
semituono si ritruouva tra hypáate mesôon, et parhypáate mesôon, cioè E la mi,
et F fa ut, cosiì dicedo achora mi-fa, et fa-mi. Il terzo semituono è da méese a
tríite synemenôon, cioè A la mi re, et B fa. Il qrto da paraméese a tríite diezeu-gmenôon, cioè [#s1523:
fa. Il qrto da paraméese a tríite diezeu-gmenôon, cioè [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et C sol fa ut. Il qnto è da néete diezeugmenôon a tríite hypboléeon [#s1523: co il supiore interuvallo] [#s1529: cioeè eE la mi, & fF fa ut] [#s1539: cioeè eE la mi, & fF fa ut] [#s1562: cioeè eE la mi, & fF fa ut] . Il sesto da néete hypboléeon, cioè aA la mi re,
et b
] [#s1562: ] mi, et C sol fa ut. Il qnto è da néete diezeugmenôon a tríite hypboléeon [#s1523: co il supiore interuvallo] [#s1529: cioeè eE la mi, & fF fa ut] [#s1539: cioeè eE la mi, & fF fa ut] [#s1562: cioeè eE la mi, & fF fa ut] . Il sesto da néete hypboléeon, cioè aA la mi re,
et b fa. Il settimo, et ultimo semituono nasce tra [#s1523:
fa. Il settimo, et ultimo semituono nasce tra [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et C sol fa. Restano
dui semituoni differeti da qsti, secodo il genere diatoico chiamati maggiori,
appareti tra la syllaba fa, et mi della positione chiamata B
] [#s1562: ] mi, et C sol fa. Restano
dui semituoni differeti da qsti, secodo il genere diatoico chiamati maggiori,
appareti tra la syllaba fa, et mi della positione chiamata B fa [#s1523:
fa [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, la qual
uvoce mi è piuù acuta di essa uvoce fa di detto semituono maggiore, il quale
supa di [#s1523: uno] [#s1529: uno] [#s1539: una] [#s1562: una] coma il miore semituono. pP tato il minore semituono cade nella
pportione 256, et 243., Iil qual numero 256 soprauvaza 13 al numero 243.
] [#s1562: ] mi, la qual
uvoce mi è piuù acuta di essa uvoce fa di detto semituono maggiore, il quale
supa di [#s1523: uno] [#s1529: uno] [#s1539: una] [#s1562: una] coma il miore semituono. pP tato il minore semituono cade nella
pportione 256, et 243., Iil qual numero 256 soprauvaza 13 al numero 243.
DEL DITONO. CAP. III.
 ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi., Iil secodo da parhypáate hypatôon a hypáate mesôon, cioè C fa ut, et E la mi., Iil terzo
da parhypáate mesôon a méese, che significa F fa ut, et A la mi re., Iil qrto da lichanòos mesôon a paraméese, cioeè G sol re ut, et [#s1523:
] [#s1562: ] mi., Iil secodo da parhypáate hypatôon a hypáate mesôon, cioè C fa ut, et E la mi., Iil terzo
da parhypáate mesôon a méese, che significa F fa ut, et A la mi re., Iil qrto da lichanòos mesôon a paraméese, cioeè G sol re ut, et [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi., Iil qnto da tríite synem-menôon a néete synemenôon, cioè B
] [#s1562: ] mi., Iil qnto da tríite synem-menôon a néete synemenôon, cioè B fa, et D la sol re., Iil sesto da tríite diezeug-menôon a néete diezeugmenôon, cioè C sol fa ut, et E la mi., Iil settio da tríite hypboléeo a néete hypboléeo, cioè F fa ut, et A la mi re., Ll'ottauvo da G sol re ut,
et [#s1523:
fa, et D la sol re., Iil sesto da tríite diezeug-menôon a néete diezeugmenôon, cioè C sol fa ut, et E la mi., Iil settio da tríite hypboléeo a néete hypboléeo, cioè F fa ut, et A la mi re., Ll'ottauvo da G sol re ut,
et [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi., Iil nono da B
] [#s1562: ] mi., Iil nono da B fa a D la sol., Iil decimo, et ultio da C sol fa ad E la. Et
pcheé tal discorso genera dui nomi, et forme uvarie, in questo modo, Vut-mi, et
Ffa-la, tali nomi, et forme no sarano dette due specie, dato che siano in [s1529: page 58]uva-rii luochi ordinati, et differenti di nomi, percheé non è intra loro semituono
mediato alcuno,, et per questa cagion no si dirà, che siano due specie, ma p
seé solo:, [#s1523: impoò che] [#s1529: imperoò che] [#s1539: imperoò che] [#s1562: imperciocheé] li semituoni son quelli, che fano uvariare le specie, come se-quedo intenderai. pPer tato tal ditono cade nella proportione 81, et 64., nella
quale il numero 81 auvanza il numero 64 la quatitaà presente, cioè 17. [s1523: page 56]
fa a D la sol., Iil decimo, et ultio da C sol fa ad E la. Et
pcheé tal discorso genera dui nomi, et forme uvarie, in questo modo, Vut-mi, et
Ffa-la, tali nomi, et forme no sarano dette due specie, dato che siano in [s1529: page 58]uva-rii luochi ordinati, et differenti di nomi, percheé non è intra loro semituono
mediato alcuno,, et per questa cagion no si dirà, che siano due specie, ma p
seé solo:, [#s1523: impoò che] [#s1529: imperoò che] [#s1539: imperoò che] [#s1562: imperciocheé] li semituoni son quelli, che fano uvariare le specie, come se-quedo intenderai. pPer tato tal ditono cade nella proportione 81, et 64., nella
quale il numero 81 auvanza il numero 64 la quatitaà presente, cioè 17. [s1523: page 56]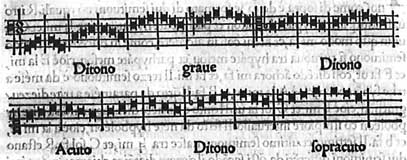
Dimostratione del ditono.
DEL SEMIDITONO. CAP. IIII.
 ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et [s1539: page 33]D sol re. eEt cosiì examinado tal
discorso, ritrouverai due specie differeti di nome, et copositioe, in qsto modo,
Rre-fa, et Mmi-sol., douve chiaro si uvede essere differeti di detto nome, et copositione rispetto alli semituoni, che hano uvarii luochi. Il semiditono è detto
imperfetto ditono, et no mezzo, [#s1523: imperoò che] [#s1529: impoò che] [#s1539: imperoò che] [#s1562: imperciocheé] semis in questo luoco no significa mezzo, ma imperfetto. Il semituono della prima specie è nel secondo
interuvallo, et il secondo semituono nel primo resta, et da alcuni sono chia-mati terza minore, cadente nella proportione 32 a 27. sSimilmente, pcededo
si ritruouva da lichanòos hypatôon a parhypáate mesôon, cioè D sol re, et F fa
ut, et da hypáate mesôon a lichanòos mesôon, che significano E la mi, et G sol
re ut, come la figura ti dimostra.
] [#s1562: ] mi, et [s1539: page 33]D sol re. eEt cosiì examinado tal
discorso, ritrouverai due specie differeti di nome, et copositioe, in qsto modo,
Rre-fa, et Mmi-sol., douve chiaro si uvede essere differeti di detto nome, et copositione rispetto alli semituoni, che hano uvarii luochi. Il semiditono è detto
imperfetto ditono, et no mezzo, [#s1523: imperoò che] [#s1529: impoò che] [#s1539: imperoò che] [#s1562: imperciocheé] semis in questo luoco no significa mezzo, ma imperfetto. Il semituono della prima specie è nel secondo
interuvallo, et il secondo semituono nel primo resta, et da alcuni sono chia-mati terza minore, cadente nella proportione 32 a 27. sSimilmente, pcededo
si ritruouva da lichanòos hypatôon a parhypáate mesôon, cioè D sol re, et F fa
ut, et da hypáate mesôon a lichanòos mesôon, che significano E la mi, et G sol
re ut, come la figura ti dimostra.
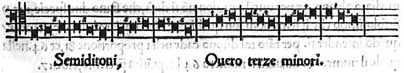
Dimostratione del semiditono.
DEL TRITONO. CAP. V.
 fa [#s1523:
fa [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, in qsto modo, fa-sol-re-mi. cCosiì ancho-ra da tríite hypboléeon, qual è F fa ut acuto, a B
] [#s1562: ] mi, in qsto modo, fa-sol-re-mi. cCosiì ancho-ra da tríite hypboléeon, qual è F fa ut acuto, a B fa [#s1523:
fa [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi secodo, il simile trouverai. No dimeno, pcheé esso tritono è cosa dura, et aspra, è stato di bisogno
che sempre mai sia mitigato, et indolcito co la figura, òo segno sequente, b
] [#s1562: ] mi secodo, il simile trouverai. No dimeno, pcheé esso tritono è cosa dura, et aspra, è stato di bisogno
che sempre mai sia mitigato, et indolcito co la figura, òo segno sequente, b ,
quado il canto no passerà il luogo di detto B
,
quado il canto no passerà il luogo di detto B fa [#s1523:
fa [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et qsto intedi cosiì in
ascedere, come i discedere:. mMa ritornato al [#s1523: primo suo] [#s1529: primo suo] [#s1539: primo suo] [#s1562: suo primo] luoco, subito tal figura, òo segno debbe essere rimossa. Appare detto tritono naturalmete et ac-cidetalmete in sette luochi della mano, delli qli li dui sopradetti sono natu-rali. Il primo aduq accidetale nasce dalla positioe hypáate hypatôon, cioè [#s1523:
] [#s1562: ] mi, et qsto intedi cosiì in
ascedere, come i discedere:. mMa ritornato al [#s1523: primo suo] [#s1529: primo suo] [#s1539: primo suo] [#s1562: suo primo] luoco, subito tal figura, òo segno debbe essere rimossa. Appare detto tritono naturalmete et ac-cidetalmete in sette luochi della mano, delli qli li dui sopradetti sono natu-rali. Il primo aduq accidetale nasce dalla positioe hypáate hypatôon, cioè [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ]
mi, a qlla di hypáate mesôon, qle è E la mi grauve, essendo in esso hypáate hy-patôon il segno di b
] [#s1562: ]
mi, a qlla di hypáate mesôon, qle è E la mi grauve, essendo in esso hypáate hy-patôon il segno di b molle, nel quale sarà mutata la syllaba, o uvoce mi nella
syllaba fa, et p cosequente la uvoce mi di E la mi, o uvero hypáate mesôon sarà
mutata nella uvoce fa, [#s1523: p] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] qllo, che di sopra è stato detto. Et qsto sempre nelli
sequeti itederai, pcheé dicedo fa in hypáate mesôon, chiamato E la mi grauve,
et discorredo insino al luoco méese, chiamato A la mi re, è di bisogno porre
in esso méese il segno di b
molle, nel quale sarà mutata la syllaba, o uvoce mi nella
syllaba fa, et p cosequente la uvoce mi di E la mi, o uvero hypáate mesôon sarà
mutata nella uvoce fa, [#s1523: p] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] qllo, che di sopra è stato detto. Et qsto sempre nelli
sequeti itederai, pcheé dicedo fa in hypáate mesôon, chiamato E la mi grauve,
et discorredo insino al luoco méese, chiamato A la mi re, è di bisogno porre
in esso méese il segno di b molle.; Ccosiì anchora da tríite synemmenôon, quale
è b
molle.; Ccosiì anchora da tríite synemmenôon, quale
è b fa acuto, a néete diezeugmenôon, chiamato E la mi secodo, nel quale, la
sua nota è mutata nella uvoce fa. Similmete saraà da néete diezeugmenôon a
néete hypboléeon, cioè aA la mi re sopracuto, Eet da b
fa acuto, a néete diezeugmenôon, chiamato E la mi secodo, nel quale, la
sua nota è mutata nella uvoce fa. Similmete saraà da néete diezeugmenôon a
néete hypboléeon, cioè aA la mi re sopracuto, Eet da b fa ultimo insino ad E la.,
come nella sequete figura, secodo che nella mano si cotiene, trouverai,. Cade
il tritono nella proportione 729, et 512.
fa ultimo insino ad E la.,
come nella sequete figura, secodo che nella mano si cotiene, trouverai,. Cade
il tritono nella proportione 729, et 512.
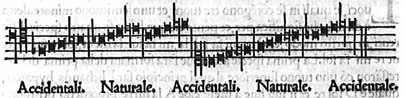
Dimostratione del Ttritono.
DEL DIATESSARON. CAP. VI.
 eEt in qualuque
luoco trouverai tal discorso, sempre sarà la prima figura, òo specie del diàa [s1539: page 34]tessáaron detto,. lLa seconda figura harraà principio da hypáate hypatôon a hy-páate mesôon, cioè [#s1523:
eEt in qualuque
luoco trouverai tal discorso, sempre sarà la prima figura, òo specie del diàa [s1539: page 34]tessáaron detto,. lLa seconda figura harraà principio da hypáate hypatôon a hy-páate mesôon, cioè [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et E la mi, co queste note, mi-fa-sol-la, differete dalla
prima forma di nome, et copositione, pcheé procede per semituono, tuono,
et tuono, ouvero per semiditono, et tuono. eEt similmete questa sarà chiama-ta in ogni luoco seconda specie del diàa tessaron. lLa terza, et ultima figura
harrà principio da parhypáate hypatôon, a parhypáate mesôon, cioeè C fa ut, et
F fa ut, co queste syllabe, ut-re-mi-fa, procedendo per tuono, tuono, et semituono minore, ouvero p ditono, et semituono, differente dalla prima, et secoda specie, percioò che il primo diàa tessáaron hàa il semituono nel secodo inter-uvallo, il secodo nel primo,; il terzo nel l'ultimo [#s1523: interuvallo si truouva] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ., come la
sequente figura. cCade il diàa tessáaron nella pportione sesquiterza psente, 4/3. [s1562: page 33]
] [#s1562: ] mi, et E la mi, co queste note, mi-fa-sol-la, differete dalla
prima forma di nome, et copositione, pcheé procede per semituono, tuono,
et tuono, ouvero per semiditono, et tuono. eEt similmete questa sarà chiama-ta in ogni luoco seconda specie del diàa tessaron. lLa terza, et ultima figura
harrà principio da parhypáate hypatôon, a parhypáate mesôon, cioeè C fa ut, et
F fa ut, co queste syllabe, ut-re-mi-fa, procedendo per tuono, tuono, et semituono minore, ouvero p ditono, et semituono, differente dalla prima, et secoda specie, percioò che il primo diàa tessáaron hàa il semituono nel secodo inter-uvallo, il secodo nel primo,; il terzo nel l'ultimo [#s1523: interuvallo si truouva] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ., come la
sequente figura. cCade il diàa tessáaron nella pportione sesquiterza psente, 4/3. [s1562: page 33]
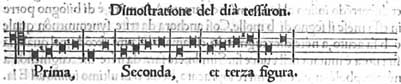
Dimostratione del diàa tessáaron.
DEL DIA PENTE. CAP. VII.
 mi acuto, ascendendo per semituono [s1523: page 59]minore, et tre tuoni. La terza specie si cosidera da parhypáate mesôon a tríite
diezeugmenôon, che sono F fa ut, et C sol fa ut, formata della terza specie
del diàa tessáaron, couversa in tritono, et uno semituono minore. La quarta, et
ultima specie si manifesta da lichanòos mesôon a paranéete diezeugmenôon,
cioè G sol re ut et D la sol re, [#s1523: formata della] [#s1529: formata de la] [#s1539: formata de la] [#s1562: forma tuono [sic: formata della]] terza figura del diàa tessáaron, et
uno tuono supiore., laqual procede per tuono, tuono, [#s1523: semituono] [#s1529: semituono] [#s1539: semituono] [#s1562: semi ta de la [sic: semituono]] , et tuono.
cCade il diàa péente nella proportione sequente detta sesqualtera, cioè 3 àa 2.
[#s1523:
mi acuto, ascendendo per semituono [s1523: page 59]minore, et tre tuoni. La terza specie si cosidera da parhypáate mesôon a tríite
diezeugmenôon, che sono F fa ut, et C sol fa ut, formata della terza specie
del diàa tessáaron, couversa in tritono, et uno semituono minore. La quarta, et
ultima specie si manifesta da lichanòos mesôon a paranéete diezeugmenôon,
cioè G sol re ut et D la sol re, [#s1523: formata della] [#s1529: formata de la] [#s1539: formata de la] [#s1562: forma tuono [sic: formata della]] terza figura del diàa tessáaron, et
uno tuono supiore., laqual procede per tuono, tuono, [#s1523: semituono] [#s1529: semituono] [#s1539: semituono] [#s1562: semi ta de la [sic: semituono]] , et tuono.
cCade il diàa péente nella proportione sequente detta sesqualtera, cioè 3 àa 2.
[#s1523:
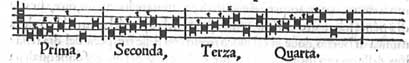
Dimostratione del diàa péente.
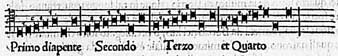
Dimostratione del diàa péente.

Dimostratione del dia pente.

Dimostratione del dia pente.
 ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] , fF-gG-aA-
] [#s1562: ] , fF-gG-aA- -cC, et gG-aA- [#s1523:
-cC, et gG-aA- [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] -cC- [#s1523: dD, li ] [#s1529: dD, gli ] [#s1539: di [sic: D, i] ] [#s1562: di [sic: D, i] ] termini medii locati tra li extremi della
predetta sesqualtera, ouvero diàa péente dal musico exercitata sono in quatro
modi differeti uvariati., però il musico, senza mutare li extremi, dice, che [#s1523: essa] [#s1529: esso] [#s1539: esso] [#s1562: esso]
diàa péente hàa quatro uvarietaà, come appare nel cap. 3. del quarto libro della
mMusica di Boetio, douve in tal luoco trouverano delle tre specie del diàa tessáa-ron, delle quatro [#s1523: specie] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] del diàa péente, et delle sette [s1562: page 34]del diàa pasôon:, le quali uvarietà da Boetio nel luogo preallegato sono chiamate specie:, le quali nasco-no, pcheé il semituono, il quale è dissimile dalli altri tre interuvalli:, hora cade
nel secondo interuvallo, hora nel primo, hora nel quarto, et hora nel terzo.
Et pcheé le predette quatro uvarietà siano meglio intese, et conosciute, li musici hano loro assegnato ordine, cioè prima, secoda, terza, et quarta:, il quale
ordine nasce dalla sua locatione, cioè quella, che prima è ritrouvata, ouvero
nasce prima nel monachordo, è detta prima:; di poi, secoda, terza, et quar-ta. oOnde tal ordine è osseruvato da tutti li dotti musici, et per tal modo tali
quatro uvarietà, ouvero specie di diàa péente, òo di sesqualtera, nascono dalla
uvariatione, che fanno li medii in quatro modi fra li extremi, et no dal mi-nuire, et accrescere li extremi:, li quali sono sempre immutabili diàa péente,
ouvero sesqualtere, et non, come li predetti, li quali senza consideratione, et
fondamento intendono. cCosiì seguitando dicono, che per adempire, et perfi-cere quelli quatro autentici tuoni, è stato necessario, che siano aiutati da
quelli quatro interuvalli di quella unità, òo sola specie di diàa péente. qQui dimostrano essere inauvertenti, per che, per formare li quatro tuoni autentici, no
si togliono una sola uvolta li quatro interuvalli di uno solo diàa péente, màa tali
interuvalli si togliono differentemente quatro uvolte, come di sopra è stato
essemplato da D grauve a G acuto. eEt per tal modo alla forma delli quatro
tuoni autentici conuvengono 16 interuvalli di diàa péente:, come nel tTrattato
nostro delli tuoni habbiamo dimostrato., per che solamente li quatro in-teruvalli del diàa péente [#s1523: solo] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] non possono dare la forma, se non ad uno solo
tuono. eEt per tal modo no si farebbono quatro tuoni differenti, màa sarebbe [s1523: page 61]solo uno. Che questo sia il uvero, si uvede apertamente, [#s1523: cheé] [#s1529: in che] [#s1539: in che] [#s1562: in che] [s1529: page 63]ciascheduno tuo-no si fàa di otto suoni, chiamati diàa pasôon, produtta dalla dupla proportio-ne, la qual dupla solo è una, et non molte. Adunque, secondo la openione
di essi, tante specie di diàa pasôon, ouvero tuoni saranno, quante sono le specie
della dupla:, et per consequente non potranno essere quatro tuoni autetici,
ma solo ne saraà uno:, la qual sentenza da noi non è conceduta.
] [#s1562: ] -cC- [#s1523: dD, li ] [#s1529: dD, gli ] [#s1539: di [sic: D, i] ] [#s1562: di [sic: D, i] ] termini medii locati tra li extremi della
predetta sesqualtera, ouvero diàa péente dal musico exercitata sono in quatro
modi differeti uvariati., però il musico, senza mutare li extremi, dice, che [#s1523: essa] [#s1529: esso] [#s1539: esso] [#s1562: esso]
diàa péente hàa quatro uvarietaà, come appare nel cap. 3. del quarto libro della
mMusica di Boetio, douve in tal luoco trouverano delle tre specie del diàa tessáa-ron, delle quatro [#s1523: specie] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] del diàa péente, et delle sette [s1562: page 34]del diàa pasôon:, le quali uvarietà da Boetio nel luogo preallegato sono chiamate specie:, le quali nasco-no, pcheé il semituono, il quale è dissimile dalli altri tre interuvalli:, hora cade
nel secondo interuvallo, hora nel primo, hora nel quarto, et hora nel terzo.
Et pcheé le predette quatro uvarietà siano meglio intese, et conosciute, li musici hano loro assegnato ordine, cioè prima, secoda, terza, et quarta:, il quale
ordine nasce dalla sua locatione, cioè quella, che prima è ritrouvata, ouvero
nasce prima nel monachordo, è detta prima:; di poi, secoda, terza, et quar-ta. oOnde tal ordine è osseruvato da tutti li dotti musici, et per tal modo tali
quatro uvarietà, ouvero specie di diàa péente, òo di sesqualtera, nascono dalla
uvariatione, che fanno li medii in quatro modi fra li extremi, et no dal mi-nuire, et accrescere li extremi:, li quali sono sempre immutabili diàa péente,
ouvero sesqualtere, et non, come li predetti, li quali senza consideratione, et
fondamento intendono. cCosiì seguitando dicono, che per adempire, et perfi-cere quelli quatro autentici tuoni, è stato necessario, che siano aiutati da
quelli quatro interuvalli di quella unità, òo sola specie di diàa péente. qQui dimostrano essere inauvertenti, per che, per formare li quatro tuoni autentici, no
si togliono una sola uvolta li quatro interuvalli di uno solo diàa péente, màa tali
interuvalli si togliono differentemente quatro uvolte, come di sopra è stato
essemplato da D grauve a G acuto. eEt per tal modo alla forma delli quatro
tuoni autentici conuvengono 16 interuvalli di diàa péente:, come nel tTrattato
nostro delli tuoni habbiamo dimostrato., per che solamente li quatro in-teruvalli del diàa péente [#s1523: solo] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] non possono dare la forma, se non ad uno solo
tuono. eEt per tal modo no si farebbono quatro tuoni differenti, màa sarebbe [s1523: page 61]solo uno. Che questo sia il uvero, si uvede apertamente, [#s1523: cheé] [#s1529: in che] [#s1539: in che] [#s1562: in che] [s1529: page 63]ciascheduno tuo-no si fàa di otto suoni, chiamati diàa pasôon, produtta dalla dupla proportio-ne, la qual dupla solo è una, et non molte. Adunque, secondo la openione
di essi, tante specie di diàa pasôon, ouvero tuoni saranno, quante sono le specie
della dupla:, et per consequente non potranno essere quatro tuoni autetici,
ma solo ne saraà uno:, la qual sentenza da noi non è conceduta.
DEL HEXACHORDO. MAGGIORE. CAP. VIII.
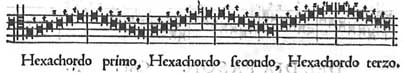
Dimostratione del hexachordo maggiore.

Dimostratione del hexacordo maggiore.

Dimostratione del hexacordo maggiore.
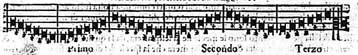
Dimostratione del hexacordo maggiore.
DEL HEXACHORDO MINORE. CAP. VIIII.
 ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et G sol re ut., Iil terzo da hypáate mesôon a tríite diezeugmenôon, che
sono E la mi, et C sol fa ut., Iil quarto da méese a tríite hyperboléeon, cioè
A la mi re, et F fa ut acuto., Iil quinto da paraméese a paranéete hyper-boléeon, liquali sono [#s1523:
] [#s1562: ] mi, et G sol re ut., Iil terzo da hypáate mesôon a tríite diezeugmenôon, che
sono E la mi, et C sol fa ut., Iil quarto da méese a tríite hyperboléeon, cioè
A la mi re, et F fa ut acuto., Iil quinto da paraméese a paranéete hyper-boléeon, liquali sono [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto, et G sol re ut sopracuto., Iil sesto, et ultimo da néete diezeugmenôon, cioè E la mi acuto, a C sol fa., delli quali tre ne
restano differenti di nome, et copositione, come qui, Rre-mi-fa-re-mi-fa,
Mmi-fa-re-mi-fa-sol, et Mmi-fa-sol-re-mi-fa. pPer tato il primo è diuverso dal
secondo, et terzo p causa del semituono, il qual si dimostra nel secondo in-teruvallo:. iIl secodo dal primo, et terzo è incotrario, pcheé il semituono resta
in grauve nel primo interuvallo:. cCosiì il terzo dal primo, et secondo non cocorda, pcheé il semituono nasce in acuto all'ultimo interuvallo., Pper la qual cosa li
seguenti saranno detti anchor replicati, percheé son simili di nome, et compositione., come per li quatro accidentali si comprende per il segno di b
] [#s1562: ] mi acuto, et G sol re ut sopracuto., Iil sesto, et ultimo da néete diezeugmenôon, cioè E la mi acuto, a C sol fa., delli quali tre ne
restano differenti di nome, et copositione, come qui, Rre-mi-fa-re-mi-fa,
Mmi-fa-re-mi-fa-sol, et Mmi-fa-sol-re-mi-fa. pPer tato il primo è diuverso dal
secondo, et terzo p causa del semituono, il qual si dimostra nel secondo in-teruvallo:. iIl secodo dal primo, et terzo è incotrario, pcheé il semituono resta
in grauve nel primo interuvallo:. cCosiì il terzo dal primo, et secondo non cocorda, pcheé il semituono nasce in acuto all'ultimo interuvallo., Pper la qual cosa li
seguenti saranno detti anchor replicati, percheé son simili di nome, et compositione., come per li quatro accidentali si comprende per il segno di b molle posto in b
molle posto in b fa [#s1523:
fa [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi., delli quali il primo harrà principio in lichanòos
hypatôon, qual è D sol re:, la fine [s1562: page 35]in tríite synemmenôon, cioè b
] [#s1562: ] mi., delli quali il primo harrà principio in lichanòos
hypatôon, qual è D sol re:, la fine [s1562: page 35]in tríite synemmenôon, cioè b fa acuto, con
questi nomi, re-mi-fa-re-mi-fa. Il secondo harrà principio da hypáate me-sôon a tríite diezeugmenôon, cioè E la mi grauve, et C sol fa ut., come qui, Mmi-
fa-re-mi-fa-sol. Il terzo, et quarto il simile nelle sue ottauve trouverai. Cade l'hexachordo minore in questi numeri, 128, et 81.
[#s1523:
fa acuto, con
questi nomi, re-mi-fa-re-mi-fa. Il secondo harrà principio da hypáate me-sôon a tríite diezeugmenôon, cioè E la mi grauve, et C sol fa ut., come qui, Mmi-
fa-re-mi-fa-sol. Il terzo, et quarto il simile nelle sue ottauve trouverai. Cade l'hexachordo minore in questi numeri, 128, et 81.
[#s1523:

Dimostratione del hexachordo minore.

Dimostratione del hexacordo minore.

DIMOSTRATIONE DELL'EXACORDO MINORE.
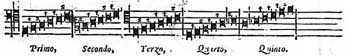
DIMOSTRATIONE DELL'EXACORDO MINORE.
DEL DIA PASON. CAP. X.
 mi
in grauve, et
mi
in grauve, et  mi in acuto, fatta della seconda figura del diàa tessáaron, et seconda diàa péente, dissimile dalla prima, terza, quarta, qnta, sesta, et settima.
La terza specie harrà principio da parhypáate hypatôon ad tríite diezeugmenôon, cioè C fa ut, et C sol [s1539: page 37]fa ut, fatta dalla terza [#s1523: figura del] [#s1529: figura del] [#s1539: figura del] [#s1562: ] diàa tessáaron, et
terza diàa péente, et p il semituono diuverso resta dalla prima, secoda, quarta,
qnta, sesta, et settima uvariata. La quarta specie harrà principio da lichanòos
hypatôon a paranéete diezeugmenôon, cioè D sol re, et D la sol re, fatta della
prima figura del diàa péente, et prima diàa tessáaron, diuversa dalla prima, secoda, terza, quinta, sesta, et settima. La quinta specie harrà principio da hy-páate mesôon a néete diezeugmenôon, cioè E la mi grauve, et E la mi acuto,
fatta della seconda figura del diàa péente, et seconda diàa tessáaron, dissimile
dalla prima, seconda, terza, quarta, sesta, et settima dimostratione. La sesta
specie harrà principio da parhypáate mesôon a tríite hyperboléeon, cioè F fa
ut grauve, et F fa ut acuto, fatta della terza figura del diàa péente, et terza diàa
tessáaron, diuversa dalla prima, secoda, terza, quarta, qnta, et settima. La settima specie harrà principio da lichanòos mesôon a paranéete hyperboléeon,
cioè G sol re ut grauve, [#s1523: ouver primo] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] , et G sol re ut secodo, fatta della quarta
figura del diàa péente, et prima diàa tessáaron, dissimile dalla prima, seconda,
terza, quarta, quinta, et sesta dimostratione, come si manifesta nel seguete
essempio.
mi in acuto, fatta della seconda figura del diàa tessáaron, et seconda diàa péente, dissimile dalla prima, terza, quarta, qnta, sesta, et settima.
La terza specie harrà principio da parhypáate hypatôon ad tríite diezeugmenôon, cioè C fa ut, et C sol [s1539: page 37]fa ut, fatta dalla terza [#s1523: figura del] [#s1529: figura del] [#s1539: figura del] [#s1562: ] diàa tessáaron, et
terza diàa péente, et p il semituono diuverso resta dalla prima, secoda, quarta,
qnta, sesta, et settima uvariata. La quarta specie harrà principio da lichanòos
hypatôon a paranéete diezeugmenôon, cioè D sol re, et D la sol re, fatta della
prima figura del diàa péente, et prima diàa tessáaron, diuversa dalla prima, secoda, terza, quinta, sesta, et settima. La quinta specie harrà principio da hy-páate mesôon a néete diezeugmenôon, cioè E la mi grauve, et E la mi acuto,
fatta della seconda figura del diàa péente, et seconda diàa tessáaron, dissimile
dalla prima, seconda, terza, quarta, sesta, et settima dimostratione. La sesta
specie harrà principio da parhypáate mesôon a tríite hyperboléeon, cioè F fa
ut grauve, et F fa ut acuto, fatta della terza figura del diàa péente, et terza diàa
tessáaron, diuversa dalla prima, secoda, terza, quarta, qnta, et settima. La settima specie harrà principio da lichanòos mesôon a paranéete hyperboléeon,
cioè G sol re ut grauve, [#s1523: ouver primo] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] , et G sol re ut secodo, fatta della quarta
figura del diàa péente, et prima diàa tessáaron, dissimile dalla prima, seconda,
terza, quarta, quinta, et sesta dimostratione, come si manifesta nel seguete
essempio.
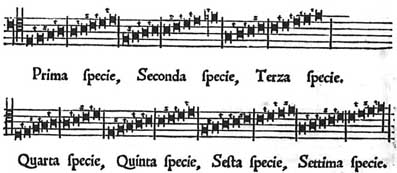
Dimostratione del diàa pasôon.
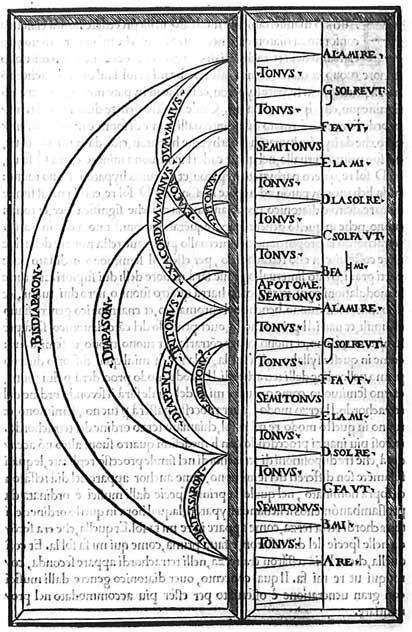
[#s1523: ] [#s1529: Dimostratione del genere diatonico.] [#s1539: Dimostratione del genere diatonico.] [#s1562: DIMOSTRATIONE DEL GENERE DIATONICO.]
 mi, et E la mi. Onde in qsto genere diatonico il tetra-chordo sempre è formato di tre interuvalli, come di sopra è manifesto., Iim-peroò che da hypáate hypatôon a parhypáate hypatôon, cioè da
mi, et E la mi. Onde in qsto genere diatonico il tetra-chordo sempre è formato di tre interuvalli, come di sopra è manifesto., Iim-peroò che da hypáate hypatôon a parhypáate hypatôon, cioè da  mi a C fa ut,
è il suo primo iteruvallo, nel quale cadeil semituono minore,; et tra C fa ut,
et D sol re, o uvero parhypáate hypatôon, et lichanòos hypatôon, è uno tuono:;
et da lichanòos hypatôon ad hypáate mesôon, cioè D sol re, et E la mi, il simile
appare. dDetto è diatonico propriamente da diàa, che significa per, et tonus,
tuono, pcheé in questo genere sono frequetati li tuoni. Et nota che in questo
tetrachordo, la proportione dell'interuvallo piuù grauve resta minore delle due
altre costituite in esso tetrachordo, per essere il semituono ordinato nelle
parti grauvi,. pP tato l'interuvallo grauve sarà minore delli dui supiori. Et i tutte
le modulationi, ogni tetrachordo harrà quatro suoni, o uvero dui tuoni, et
uno minor semituono., bencheé nel chromatico, et enarmonico genere siano
dissimili, et uvarii. Il primo modo, ouver processo del cato diatonico satà [sic: sarà] per
semituono, tuono, et tuono, et per cotrario per tuono, tuono, et semituono:,
come in queste syllabe, mi-fa-sol-la, et la-sol-fa-mi., il qual discorso diremo [#s1523: ] [#s1529: il ] [#s1539: il ] [#s1562: il ]
primo nell'ordine delli tetrachordi. Il secodo modo procederà p dui tuoni,
et uno semituono, come qui, ut-re-mi-fa., del quale sarà il secondo ordine del
tetrachordo. Il terzo modo, ouver processo passerà p tuono, semituono, et
tuono, in questo modo, re-mi-fa-sol, chiamato terzo ordine del tetrachordo.
eEt cosiì piuù inanzi procedendo con li medesimi quatro suoni, altro no acca-derà, che tre dispositioni di tetrachordi nel simile processo replicate, lequali
solamete son differeti del semituono, come anchor appare nel diàa tessáaron
di sopra nominato, nel quale la prima specie dalli musici è ordinata da
proslambanóomenos a lichanòos hypatôon, laqual hora in questo ordine delli
tetrachordi resta terza, come appare in re-mi-fa-sol. Et quella, che era seco-da nelle specie del diàa tessáaron, è fatta prima, come qui, mi-fa-sol-la. Et cosiì
quella, che nel diàa tessáaron era terza, nelli tetrachordi appare seconda, co-me qui, ut-re-mi-fa.; Iil qual concento, ouver diatonico genere dalli musici
con gran uveneratione è osseruvato, per esser piuù accommodato nel pro-nontiare. [s1523: page 67][s1529: page 69]
mi a C fa ut,
è il suo primo iteruvallo, nel quale cadeil semituono minore,; et tra C fa ut,
et D sol re, o uvero parhypáate hypatôon, et lichanòos hypatôon, è uno tuono:;
et da lichanòos hypatôon ad hypáate mesôon, cioè D sol re, et E la mi, il simile
appare. dDetto è diatonico propriamente da diàa, che significa per, et tonus,
tuono, pcheé in questo genere sono frequetati li tuoni. Et nota che in questo
tetrachordo, la proportione dell'interuvallo piuù grauve resta minore delle due
altre costituite in esso tetrachordo, per essere il semituono ordinato nelle
parti grauvi,. pP tato l'interuvallo grauve sarà minore delli dui supiori. Et i tutte
le modulationi, ogni tetrachordo harrà quatro suoni, o uvero dui tuoni, et
uno minor semituono., bencheé nel chromatico, et enarmonico genere siano
dissimili, et uvarii. Il primo modo, ouver processo del cato diatonico satà [sic: sarà] per
semituono, tuono, et tuono, et per cotrario per tuono, tuono, et semituono:,
come in queste syllabe, mi-fa-sol-la, et la-sol-fa-mi., il qual discorso diremo [#s1523: ] [#s1529: il ] [#s1539: il ] [#s1562: il ]
primo nell'ordine delli tetrachordi. Il secodo modo procederà p dui tuoni,
et uno semituono, come qui, ut-re-mi-fa., del quale sarà il secondo ordine del
tetrachordo. Il terzo modo, ouver processo passerà p tuono, semituono, et
tuono, in questo modo, re-mi-fa-sol, chiamato terzo ordine del tetrachordo.
eEt cosiì piuù inanzi procedendo con li medesimi quatro suoni, altro no acca-derà, che tre dispositioni di tetrachordi nel simile processo replicate, lequali
solamete son differeti del semituono, come anchor appare nel diàa tessáaron
di sopra nominato, nel quale la prima specie dalli musici è ordinata da
proslambanóomenos a lichanòos hypatôon, laqual hora in questo ordine delli
tetrachordi resta terza, come appare in re-mi-fa-sol. Et quella, che era seco-da nelle specie del diàa tessáaron, è fatta prima, come qui, mi-fa-sol-la. Et cosiì
quella, che nel diàa tessáaron era terza, nelli tetrachordi appare seconda, co-me qui, ut-re-mi-fa.; Iil qual concento, ouver diatonico genere dalli musici
con gran uveneratione è osseruvato, per esser piuù accommodato nel pro-nontiare. [s1523: page 67][s1529: page 69]DEL GENERE CHROMATICO. CAP. XI.
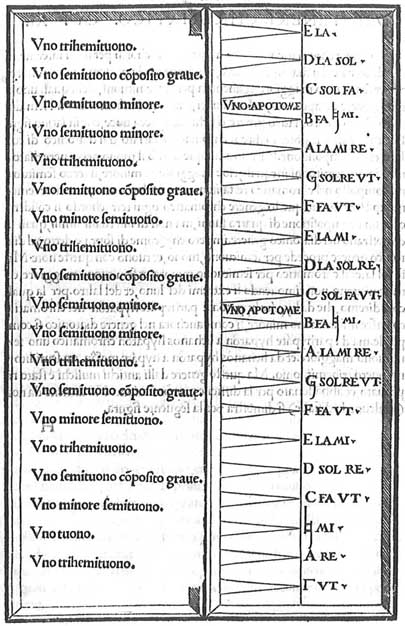
Dimostratione del genere chromatico.
DEL GENERE ENARMONI-CO. CAP. XII.
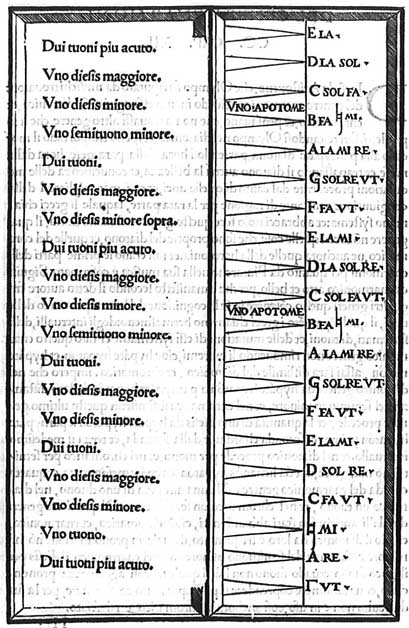
Dimostratione del genere enarmonico.
DICHIARATIONE DEL CONTRA-PVUNTO. CAP. XIII.
lLa conso-nanza, la qual regge tutta la modulatione della musica, no si puoò far sanza suono:; il suono non si rende senza certo battimento,; il battimento non [s1529: page 74]puoò esser per modo alcuno (come [#s1523: è di sopra] [#s1529: è di sopra] [#s1539: di sopra] [#s1562: di sopra è] detto) se no precede il mouvimeto.sSono alcune altre differenze dintorno [#s1523: tal] [#s1529: al] [#s1539: al] [#s1562: al] suono, pcussione, et moto da Boetio addotte, ma p no uvenire al proposito nostro, le taceremo. [#s1523: Sappi che di [s1523: page 72]sopra nelle cosonanze non habbiamo fatto mentione del diàa tessáaron, ouver quarta, percheé tal diàa tessáaron per seé solo è dissonante, et uvolendo exerci-tare una compositione a due uvoci, esso diàa tessáaron, senza esser tramezzato, assai discorderebbe, come la esperienza dimostra. Per tanto del detto diàa tessáaron nel capitolo, douve di più di due uvoci si parla: intenderai, come si debba usare.] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ]
DELLE CONSONANZE PER-FETTE. CAP. XIIII.
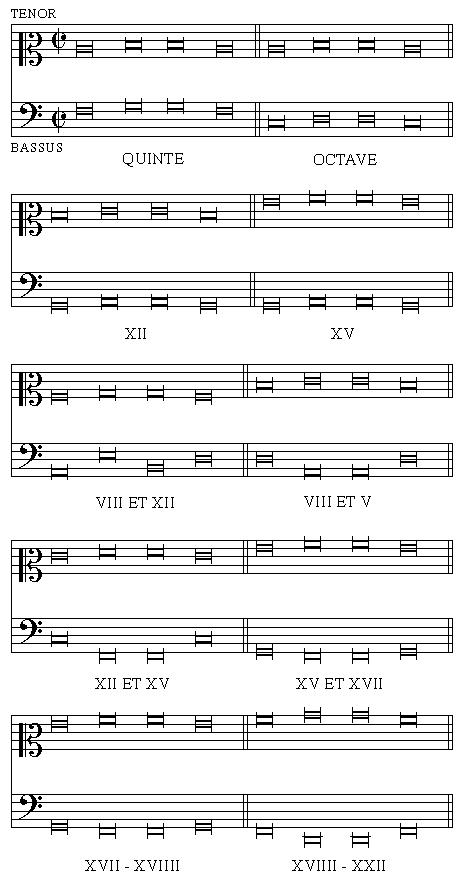
Dimostratione delle consonanze perfette.
[s1523: page 74][s1529: page 76][s1539: page 45][s1562: page 43]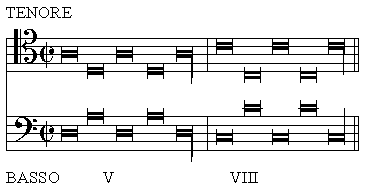
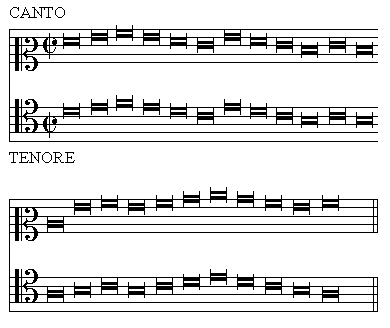
 et cosiì discorrendo per il medesimo modo intenderai. [s1523: page 75][s1529: page 77]
et cosiì discorrendo per il medesimo modo intenderai. [s1523: page 75][s1529: page 77]DELLE CONCORDANZE IMPERFETTE IN CONTRAPVUNTO VUSATE. CAP. XV.
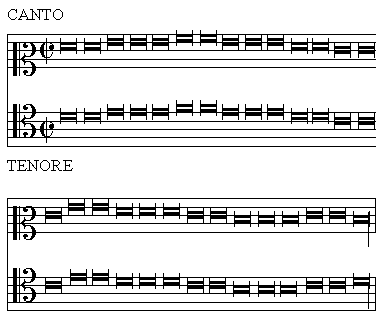 ] [#s1529:
] [#s1529: 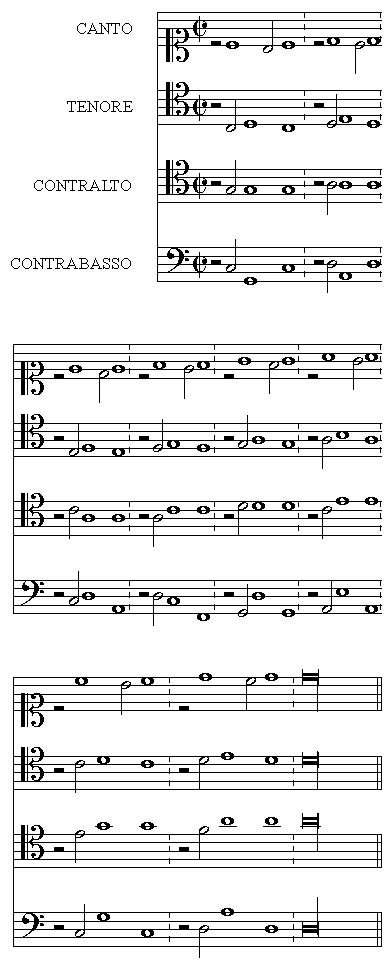 ] [#s1539:
] [#s1539: 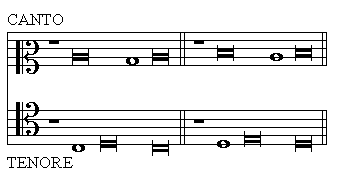 ] [#s1562:
] [#s1562: 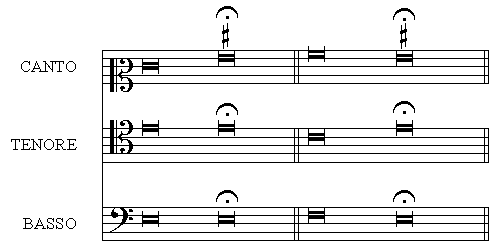 ]
]
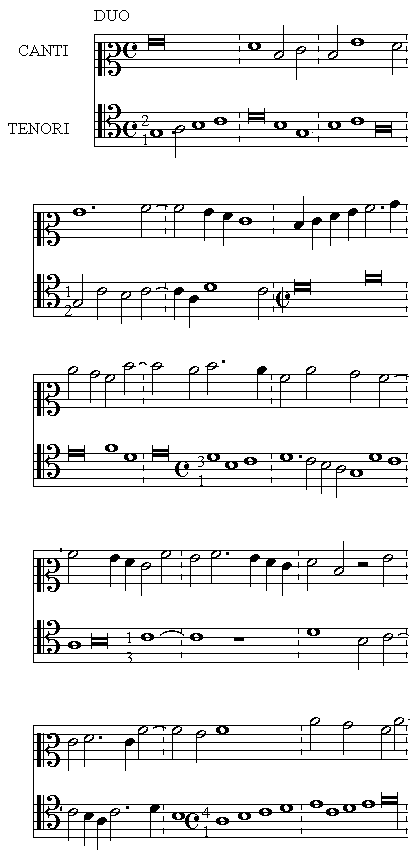 ] [#s1529:
] [#s1529: 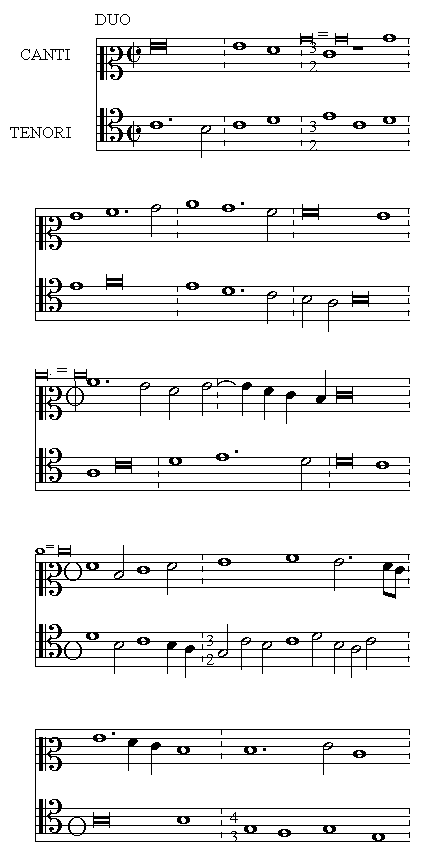 ] [#s1539:
] [#s1539: 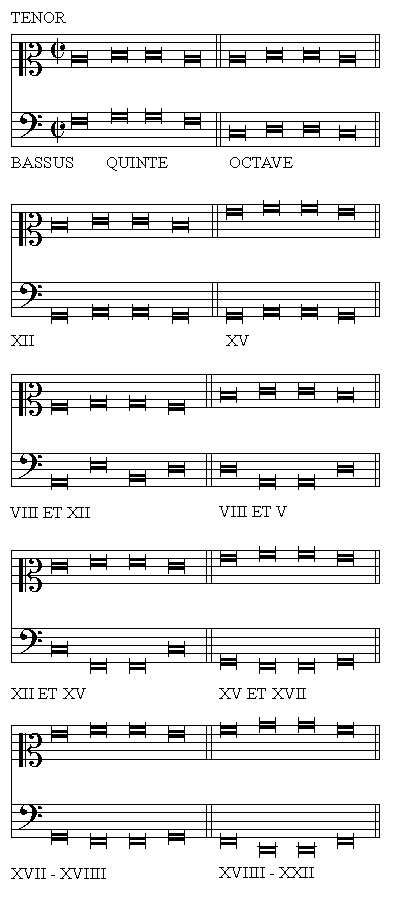 ] [#s1562:
] [#s1562: 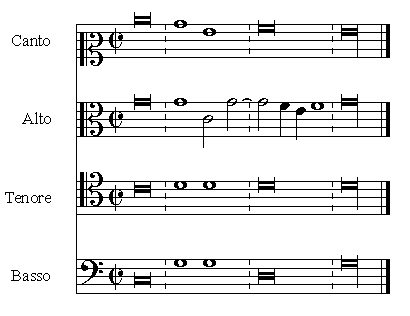 ] [s1523: page 76][s1529: page 78]
] [s1523: page 76][s1529: page 78]COME IL COMPOSITORE [#s1523: DEBBIA] [#s1529: POSSI] [#s1539: POSSI] [#s1562: POSSI] DARE PRENCIPIO AL SVUO CANTO. CAP. XVI.
SE LA CONSONANZA, O CONCORDANZA E' NECESSARIA AL PRINCIPIO DEL CANTO. CAP. XVII.This chapter is discussed in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 6 May 1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 103 and 291-296.
DELLA TERMINATIONE, O [#s1523: VORAI] [#s1529: VVUOI] [#s1539: VVUOI] [#s1562: VVUOI] DIRE CADENZA ORDINATA NEL SOPRANO. CAP. XVIII.
 fa
fa  mi, E la mi, et C sol fa,] [#s1529: & del secodo in aA la mi re primo/, cC sol fa ut/, dD la sol re/, fF fa ut/, gG sol [s1529: page 80]re ut/ & aA la mi re secondo:, ma essendo incotrario] [#s1539: & del secodo in aA la mi re primo, cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, gG sol [s1539: page 47]re ut, & aA la mi re secondo, ma essendo incontrario] [#s1562: & del secondo in aA la mi re primo, cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, gG sol re ut, & aA la mi re secondo, ma essendo in contrario] il canto no sarebbe grato, màa fuora di ogni
sua intonatione, come si uvede in alcune copositioni con poco fondamento
fatte. Cosiì il terzo, et quarto tuono, p esser coposto di mi-mi, et mi-la, secoda
specie del diàa péente, et diàa tessáaron, le sue cadenze saranno in E la mi, [#s1523: A la
mi re, et G sol re ut, màa raro] [#s1529: fF fa ut/, gG sol re ut/, aA la mi re/, b
mi, E la mi, et C sol fa,] [#s1529: & del secodo in aA la mi re primo/, cC sol fa ut/, dD la sol re/, fF fa ut/, gG sol [s1529: page 80]re ut/ & aA la mi re secondo:, ma essendo incotrario] [#s1539: & del secodo in aA la mi re primo, cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, gG sol [s1539: page 47]re ut, & aA la mi re secondo, ma essendo incontrario] [#s1562: & del secondo in aA la mi re primo, cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, gG sol re ut, & aA la mi re secondo, ma essendo in contrario] il canto no sarebbe grato, màa fuora di ogni
sua intonatione, come si uvede in alcune copositioni con poco fondamento
fatte. Cosiì il terzo, et quarto tuono, p esser coposto di mi-mi, et mi-la, secoda
specie del diàa péente, et diàa tessáaron, le sue cadenze saranno in E la mi, [#s1523: A la
mi re, et G sol re ut, màa raro] [#s1529: fF fa ut/, gG sol re ut/, aA la mi re/, b fa
fa  mi/ & cC sol fa:, & del quarto/ in cC sol fa/, dD la sol re/, eE la mi/, fF fa ut/, gG sol re ut/ & aA la mi re] [#s1539: fF fa ut, gG sol re ut, aA la mi re, b
mi/ & cC sol fa:, & del quarto/ in cC sol fa/, dD la sol re/, eE la mi/, fF fa ut/, gG sol re ut/ & aA la mi re] [#s1539: fF fa ut, gG sol re ut, aA la mi re, b fa
fa  mi, & cC sol fa, & del quarto, in cC sol fa, dD la sol re, eE la mi, fF fa ut, gG sol re ut, & aA la mi re] [#s1562: fF fa ut, gG sol re ut, aA la mi re, b
mi, & cC sol fa, & del quarto, in cC sol fa, dD la sol re, eE la mi, fF fa ut, gG sol re ut, & aA la mi re] [#s1562: fF fa ut, gG sol re ut, aA la mi re, b fa
fa  mi, & cC sol fa, & del quarto, in cC sol fa, dD la sol re, eE la mi, fF fa ut, gG sol re ut, & aA la mi re] ,. Il qnto, et sesto tuono sarà formato di Ffa-fa, et
Vut-fa, terza specie del diàa péente, et diàa tessáaron,. lLe sue cadenze saranno in F
fa ut, A la mi re, [#s1523: ] [#s1529: & ] [#s1539: & ] [#s1562: & ] C sol fa, [#s1523: et qualche uvolta i G sol re ut] [#s1529: il sesto in cC sol fa ut/, dD la sol re/, fF fa ut/, aA la mi re/ & cC sol fa] [#s1539: Iil sesto i cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, aA la mi re, & cC sol fa] [#s1562: Iil sesto in cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, aA la mi re, & cC sol fa] . Il settimo, et ottauvo
tuono, p esser formato di ut-sol, quarta specie del diàa péente, et re-sol, prima
del diàa tessáaron, le sue cadenze sono [#s1523: ] [#s1529: in ] [#s1539: in ] [#s1562: in ] G sol re ut, A la mire [#s1523: , et C sol fa] [#s1529: /, cC sol fa/ & dD la sol:, l'ottauvo i cC sol fa ut/, dD la sol re/, fF fa ut: & gG sol re ut] [#s1539:
mi, & cC sol fa, & del quarto, in cC sol fa, dD la sol re, eE la mi, fF fa ut, gG sol re ut, & aA la mi re] ,. Il qnto, et sesto tuono sarà formato di Ffa-fa, et
Vut-fa, terza specie del diàa péente, et diàa tessáaron,. lLe sue cadenze saranno in F
fa ut, A la mi re, [#s1523: ] [#s1529: & ] [#s1539: & ] [#s1562: & ] C sol fa, [#s1523: et qualche uvolta i G sol re ut] [#s1529: il sesto in cC sol fa ut/, dD la sol re/, fF fa ut/, aA la mi re/ & cC sol fa] [#s1539: Iil sesto i cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, aA la mi re, & cC sol fa] [#s1562: Iil sesto in cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, aA la mi re, & cC sol fa] . Il settimo, et ottauvo
tuono, p esser formato di ut-sol, quarta specie del diàa péente, et re-sol, prima
del diàa tessáaron, le sue cadenze sono [#s1523: ] [#s1529: in ] [#s1539: in ] [#s1562: in ] G sol re ut, A la mire [#s1523: , et C sol fa] [#s1529: /, cC sol fa/ & dD la sol:, l'ottauvo i cC sol fa ut/, dD la sol re/, fF fa ut: & gG sol re ut] [#s1539:  b fa
b fa  mi, cC sol fa, & dD la sol, l'ottauvo in cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, & gG sol re ut] [#s1562: b,
mi, cC sol fa, & dD la sol, l'ottauvo in cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, & gG sol re ut] [#s1562: b,  fa
fa  mi, cC sol fa, & dD la sol, l'ottauvo in cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, & gG sol re ut] ., Pper la
qual cosa, essaminando li sopradetti modi, faccio giudicio che in breuve te-po arriuverai alla intelligenza della retta compositione. [#s1523: Et questo a te sia a
sofficieza detto p messe, motetti, canzone, frottole, barzellette, madrigali,
strambotti, capitoli, et sonetti.] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] Et tutte le [#s1523: dette cadeze] [#s1529: cadenze dette] [#s1539:
cadenze dette] [#s1562: dette cadenze] si dichiarerano nella
figura seguente [#s1523: ] [#s1529: ne la quale manca la positioe di b
mi, cC sol fa, & dD la sol, l'ottauvo in cC sol fa ut, dD la sol re, fF fa ut, & gG sol re ut] ., Pper la
qual cosa, essaminando li sopradetti modi, faccio giudicio che in breuve te-po arriuverai alla intelligenza della retta compositione. [#s1523: Et questo a te sia a
sofficieza detto p messe, motetti, canzone, frottole, barzellette, madrigali,
strambotti, capitoli, et sonetti.] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] Et tutte le [#s1523: dette cadeze] [#s1529: cadenze dette] [#s1539:
cadenze dette] [#s1562: dette cadenze] si dichiarerano nella
figura seguente [#s1523: ] [#s1529: ne la quale manca la positioe di b fa
fa  mi/, cagioe & colpa de lo intagliatore] [#s1539: ne la quale manca la positione di b
mi/, cagioe & colpa de lo intagliatore] [#s1539: ne la quale manca la positione di b fa
fa  mi, cagione & colpa de lo intagliatore] [#s1562: nellaqual manca la positione di b
mi, cagione & colpa de lo intagliatore] [#s1562: nellaqual manca la positione di b fa
fa  mi, cagione & colpa dello intagliatore] . [s1562: page 45] [#s1523:
mi, cagione & colpa dello intagliatore] . [s1562: page 45] [#s1523: 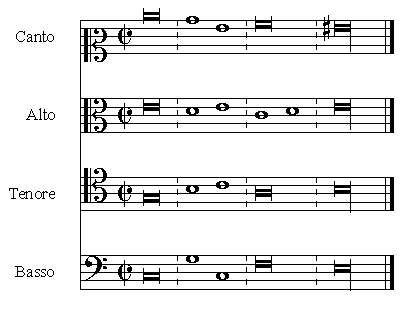 ] [#s1529:
] [#s1529: 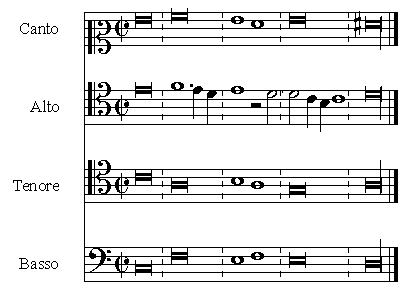 ] [#s1539:
] [#s1539: 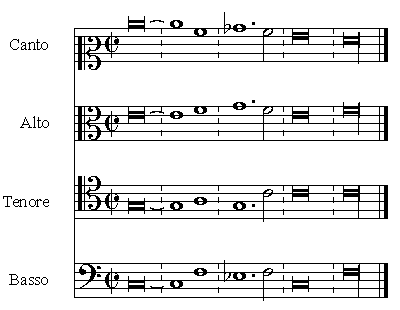 ] [#s1562:
] [#s1562: 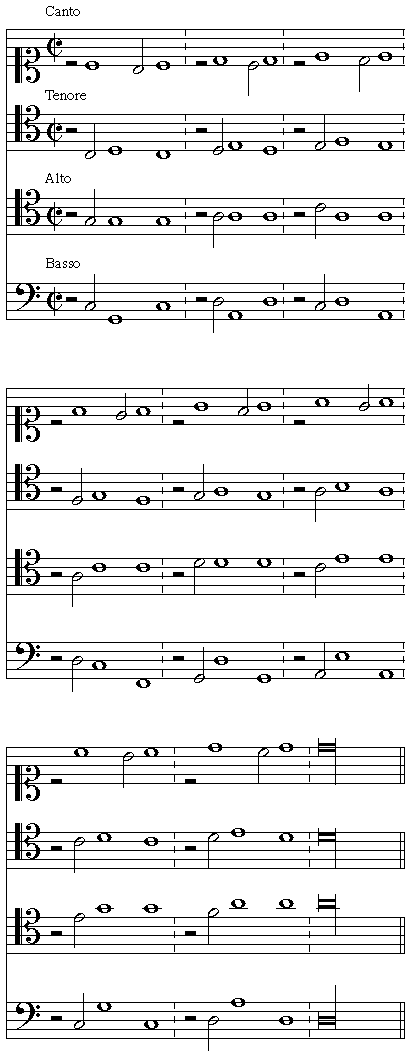 ]
]
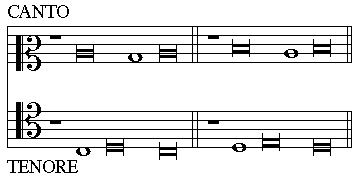 [s1523: page 79]
[s1523: page 79]MODO DI COMPORRE PSALMI, ET MAGNIFICAT. CAP. XVIIII.This chapter is discussed in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 23 May 1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 300-301.
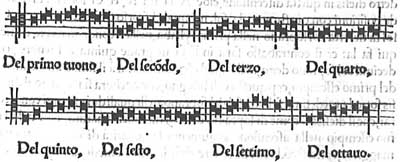
INTONATIONE DI TVUTTI LI TVUONI.
DELLA NATVURA DEL DIESIS. CAP. XX.This chapter is discussed in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 23 May 1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 301-305.
 ,
percheé appresso li theorici diesis è [#s1523: domandato la mezza parte] [#s1529: domandato la mezza parte] [#s1539: domandato
la mezza parte] [#s1562: detto la metà] di uno semituono minore, [#s1523: et in effetto] [#s1529: bencheé] [#s1539: bencheé] [#s1562: becheé] in prattica [#s1523: opera maggiore] [#s1529: operi maggiore] [#s1539: operi maggiore] [#s1562: operi in piuù] quantità, come p li
essempi intenderai. Et acciò che in questo no resti dubbioso, [s1562: page 46]sappi, che questo segno diuversamente [#s1523: significa, et] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] par che sia di natura contrario., percheé
nello ascenso accresce, et nel discenso diminuisce., come sarà nel seguente
discorso da E la mi acuto, a G sol re ut secondo con queste syllabe, mi-sol,
con il qual sol sarà il tenore in terza di sotto, et il contrabasso per una de-cima minore, per la qual congiuntione nascerà [#s1523: dispiaceuvole] [#s1529: non grata] [#s1539: non grata] [#s1562: non grata] harmonia, [#s1523: come per la esperienza udirai] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ., Ddel che è necessario segnare sotto a quella
syllaba sol del sopradetto soprano la figura diesis, acciò che quella decima
minore del contrabasso, quale era alquanto dissonante, per essere diminuta
di uno semituono maggiore, essendo solleuvata al luoco suo, si senta piuù soauve., Bbencheé tal segno appresso li dotti, et prattichi cantori [#s1523: no] [#s1529: manco] [#s1539: manco] [#s1562: manco] è di bisogno,
ma sol si pone, percheé forse il mal prattico, et non intelligente cantore non
darebbe pronontia perfetta a tal positione, ouver syllaba., percheé essendo naturalemente dal mi, et sol un semiditono, senza quel segno esso cantore non
canterebbe altro, che il suo proprio, se giaà l'orecchio non gli dessi aiuto., co-me si uvede in alcuni, che questo molto bene fanno. [#s1523: E' anchora] [#s1529: Anchora è] [#s1539: Anchora eè] [#s1562: Ancora è] necessario
detto diesis in questa discensione, cioè A la mi re, et G sol re ut, secon-de positioni, con queste note, la-sol., nel qual discorso si farrà il tenore in C
sol fa ut sesta col soprano nella prima syllaba, nella seconda in terza, come
qui, fa-la:, et il contrabasso sarà in F fa ut grauve, quinta col tenore [#s1523: ] [#s1529: & dapoi in ottauva] [#s1539: & da poi in ottauva] [#s1562: & dapoi in ottauva] , [#s1523: et] [#s1529: &] [#s1539: ] [#s1562: ]
decima [#s1523: ] [#s1529: minore ] [#s1539: minore ] [#s1562: minore ] col soprano [#s1523: detto] [#s1529: ] [#s1539:
] [#s1562: ] , nella qual cogiuntione sarà il simile incouveniete
del primo essempio, et p questo è di bisogno, che anchora sia segnato il die-sis sotto la medesima syllaba sol del soprano., nelli quali dui essempi conoscerai, che il diesis (siì come di sopra hòo detto) hàa diuversa natura, cioè nel primo essempio nella ascensione augumenta la quantità di uno semituono
maggiore, et nel secodo nel [#s1523: discendere] [#s1529: discendendo] [#s1539: discendendo] [#s1562: discendendo] disminuisce la medesima quantità. [s1523: page 81]Cosiì [#s1523: anchora] [#s1529: il simile] [#s1539: il simile] [#s1562: il simile] in altri luochi di quella natura, et compositione [s1529: page 83]intenderai,
percheé non sempre sotto a dette syllabe gli accade tal figura., perciò che al-cuna uvolta il copositore uvaria le cosonanze., come sarebbe, se esso facesse in
quel luoco proprio una quinta, duodecima, òo quintadecima, nelle quali
sentiresti discordia grande. Per tanto nelli sopradetti luochi è necessario tal
crescimento, et leuvamento:, massimamete in breuvi, semibreuvi, et coronate,
come qui di sotto è figurato.
,
percheé appresso li theorici diesis è [#s1523: domandato la mezza parte] [#s1529: domandato la mezza parte] [#s1539: domandato
la mezza parte] [#s1562: detto la metà] di uno semituono minore, [#s1523: et in effetto] [#s1529: bencheé] [#s1539: bencheé] [#s1562: becheé] in prattica [#s1523: opera maggiore] [#s1529: operi maggiore] [#s1539: operi maggiore] [#s1562: operi in piuù] quantità, come p li
essempi intenderai. Et acciò che in questo no resti dubbioso, [s1562: page 46]sappi, che questo segno diuversamente [#s1523: significa, et] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] par che sia di natura contrario., percheé
nello ascenso accresce, et nel discenso diminuisce., come sarà nel seguente
discorso da E la mi acuto, a G sol re ut secondo con queste syllabe, mi-sol,
con il qual sol sarà il tenore in terza di sotto, et il contrabasso per una de-cima minore, per la qual congiuntione nascerà [#s1523: dispiaceuvole] [#s1529: non grata] [#s1539: non grata] [#s1562: non grata] harmonia, [#s1523: come per la esperienza udirai] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ., Ddel che è necessario segnare sotto a quella
syllaba sol del sopradetto soprano la figura diesis, acciò che quella decima
minore del contrabasso, quale era alquanto dissonante, per essere diminuta
di uno semituono maggiore, essendo solleuvata al luoco suo, si senta piuù soauve., Bbencheé tal segno appresso li dotti, et prattichi cantori [#s1523: no] [#s1529: manco] [#s1539: manco] [#s1562: manco] è di bisogno,
ma sol si pone, percheé forse il mal prattico, et non intelligente cantore non
darebbe pronontia perfetta a tal positione, ouver syllaba., percheé essendo naturalemente dal mi, et sol un semiditono, senza quel segno esso cantore non
canterebbe altro, che il suo proprio, se giaà l'orecchio non gli dessi aiuto., co-me si uvede in alcuni, che questo molto bene fanno. [#s1523: E' anchora] [#s1529: Anchora è] [#s1539: Anchora eè] [#s1562: Ancora è] necessario
detto diesis in questa discensione, cioè A la mi re, et G sol re ut, secon-de positioni, con queste note, la-sol., nel qual discorso si farrà il tenore in C
sol fa ut sesta col soprano nella prima syllaba, nella seconda in terza, come
qui, fa-la:, et il contrabasso sarà in F fa ut grauve, quinta col tenore [#s1523: ] [#s1529: & dapoi in ottauva] [#s1539: & da poi in ottauva] [#s1562: & dapoi in ottauva] , [#s1523: et] [#s1529: &] [#s1539: ] [#s1562: ]
decima [#s1523: ] [#s1529: minore ] [#s1539: minore ] [#s1562: minore ] col soprano [#s1523: detto] [#s1529: ] [#s1539:
] [#s1562: ] , nella qual cogiuntione sarà il simile incouveniete
del primo essempio, et p questo è di bisogno, che anchora sia segnato il die-sis sotto la medesima syllaba sol del soprano., nelli quali dui essempi conoscerai, che il diesis (siì come di sopra hòo detto) hàa diuversa natura, cioè nel primo essempio nella ascensione augumenta la quantità di uno semituono
maggiore, et nel secodo nel [#s1523: discendere] [#s1529: discendendo] [#s1539: discendendo] [#s1562: discendendo] disminuisce la medesima quantità. [s1523: page 81]Cosiì [#s1523: anchora] [#s1529: il simile] [#s1539: il simile] [#s1562: il simile] in altri luochi di quella natura, et compositione [s1529: page 83]intenderai,
percheé non sempre sotto a dette syllabe gli accade tal figura., perciò che al-cuna uvolta il copositore uvaria le cosonanze., come sarebbe, se esso facesse in
quel luoco proprio una quinta, duodecima, òo quintadecima, nelle quali
sentiresti discordia grande. Per tanto nelli sopradetti luochi è necessario tal
crescimento, et leuvamento:, massimamete in breuvi, semibreuvi, et coronate,
come qui di sotto è figurato.
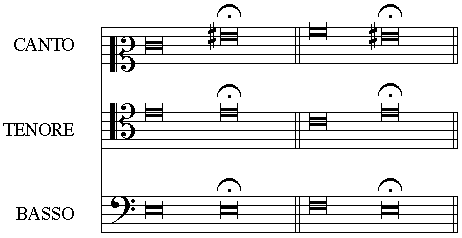
DEL MODO DEL COMPORRE IL CONTRA-BASSO, ET CONTRALTO DOPO IL TENORE ET CANTO. PRECETTO PRIMO CAP. XXI.This chapter is discussed in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 23 May 1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 305.
PRECETTO SECONDO. CAP. XXII.
PRECETTO TERZO. CAP. XXIII.
PRECETTO QVUARTO. CAP. XXIIII.
PRECETTO QVUINTO. CAP. XXV.
PRECETTO SESTO. CAP. XXVI.
PRECETTO SETTIMO. CAP XXVII.
PRECETTO OTTAVO. CAP. XXVIII.
PRECETTO NONO. CAP. XXVIIII.
PRECETTO DECIMO. CAP. XXX.
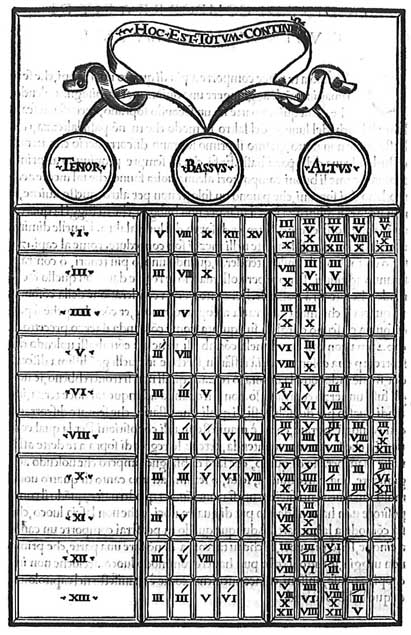
Tauvola del contrapunto.
ORDINE DI COMPORRE A PIVU' DI QVUATRO VOCI. CAP. XXXI.
CHE COSA SIA PROPORTIONE. CAP. XXXII.
cCioò che tu comadi, sarai breuve, acciocheé li animi docili intendino psto le cose dette:, et fidelmete le coseruvino., pcheé niuna cosa supuvacua si ritiene dal petto pie-no.Diremo aduque che la pportioe prima, et principalmete si ritruouva nella quatità, òo sia cotinouva, òo sia discreta:, cioè, quado essa si diffinisce p habitudine di due quatità di uno medesimo genere:, le quali habitudini si hano a cosiderare, secodo che una di dette qtità è maggiore et minore, ouvero eqle, et inequale al'altra., p la qual cosa diremo Proportione quello che siapportione, quado due quatità d'u medesimo genere, l'una a l'altra insieme sono coparate, co certa, et determi-nata habitudine, cioè che debbia essere fra' dui extremi, òo sieno equali, òo siano inequali., come appare i qsti numeri, 3 a 2, 2 a 3, 4 a 3, 5 a 4, et 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 etc., Pper la qual cosa si notifica, che tutte le quatità bisogna sieno eqli, ouvero inequali, siì che è necessario si faccia coparatione alcuna uvolta dall'u-na equale al'altra, laql coparatioe genera una specie detta pportione ronale di eqlità, la ql no cade in pposito al musico, et poò di qsta no ne parleremo. Ma facedo coparatione di inequale numero, ne nasce la secoda specie, detta pportioe rationale di inequalità, della quale si [#s1523: ordinano] [#s1529: ordina] [#s1539: ordina] [#s1562: ordina] cinque generi [#s1523: cosiì] [#s1529: cosiì] [#s1539: cosiì] [#s1562: ] chiamati:Cinque generi di Pportni molteplice, supparticolare, suppartiente, molteplice suppartico-lare, et molteplice suppartiete,. eEt di questi generi li tre primi sono [#s1523: chiamati] [#s1529: chiamati] [#s1539: chiamati] [#s1562: detti] semplici, et li dui seguenti composti. Onde uvenedo al pposito nostro, dire-mo del genere primo, chiamato molteplice, qual serà, quado il maggior numero harrà in seé il minore piuù uvolte:, come in qsti numeri si cotiene:, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. mMàa se il numero maggiore harrà aputo due uvolte il minore, come q, 2 a 1, diremo pportione dupla, pcheé 2 cotiene uno due uvolte,. eEt se harrà il [s1539: page 53]numero maggiore tre uvolte aputo i seé il minore, come q, 3 a 1, diremo, [s1529: page 90]pportione tripla, pcheé 3, maggior termino, cotiene tre uvolte il minore, qle è uno. [s1523: page 88]Et cosiì se il maggior numero cotenessi quatro uvolte i seé il minore, come q, 4 a 1, tale coparatioe, è detta pportione quadrupla, pcheé in esso termino maggiore, qual è 4:, se gli ritruouva qtro uvolte aputo il minore, qual è uno, et cosiì nelle altre simili intenderai. lLa specie prima del genere molteplice sarà chiamata dupla, la secoda tripla, la terza quadrupla, la quarta quincupla, et tal pcesso sarà ifinito. Per tato auvertirai, che da noi no sarà dimostrato i essempio [#s1523: in tal narratione] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] altro, che le pportioni usitate, necessarie, et catabili., p che qllo, che in ragione harmonica non sarà diuvisibile, neé in quatità riducibile, da noi non sarà p essempio addotto, pcheé allo impossibile nessuno [#s1523: no] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] è tenuto, et secodariamete p essere qsto in lugo stato addotto dal uvenerando molto dDon Frachino gGafurio, li essempi del quale (qto attiene [s1562: page 50]alla prattica) sono stati quasi frustratorii. pPer tato, uvoledo tu la dupla nelli cati coponere, dui modi a tal dimostratione da noi sara coceduti, il primo p cifre numerali, et il secodo p semicircoli tagliati, et no tagliati, come nel cap. delli segni [#s1523: cotra'] [#s1529: contro a'] [#s1539: cotro a'] [#s1562: contro a'] segni ti hòo mostrato. uVolendo adunque mostrare una dupla nella tua copositione p cifre numerali, poni la presente cifra 2 appresso 1 inferiore [#s1523: al dui] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] , come qui 2/1:; se una tripla, cosiì 3/1:; se una quadrupla, cosiì 4/1:; et in tutto qsto genere cosiì pcederai,. mMa nota, che tal coparatione è intesa in figure cata-bili, cioè in qsto modo: due lughe [#s1523: cotra] [#s1529: cotro a] [#s1539: cotro a] [#s1562: cotro ad] una, due breuvi cotra ad una, due semibr. [#s1523: cotra] [#s1529: cotro a] [#s1539: cotro a] [#s1562: contro ad] una, [#s1523: et Cc] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] . eEt cosiì a te sarà tal pcetto libero. Nel secodo modo, la dupla (come hòo detto) sarà da te dimostrata col semicircolo in qsta forma, cioè quado un tuo cato sarà in qsto segno,
 , et che [#s1523: di poi] [#s1529: di poi] [#s1539: di poi] [#s1562: dapoi] ne segua il psente,
, et che [#s1523: di poi] [#s1529: di poi] [#s1539: di poi] [#s1562: dapoi] ne segua il psente,
 ,. dDico, che douve tu [#s1523: dauvi] [#s1529: dauvi] [#s1539: dauvi] [#s1562: darai] la battuta tua nella semibreuve in qsto segno,
,. dDico, che douve tu [#s1523: dauvi] [#s1529: dauvi] [#s1539: dauvi] [#s1562: darai] la battuta tua nella semibreuve in qsto segno,  ,
debbi cantare le tue note seguendo questo,
,
debbi cantare le tue note seguendo questo,  , per il doppio piuù presto:, cioè
douve che passauva una semibreuve i una misura di questo,
, per il doppio piuù presto:, cioè
douve che passauva una semibreuve i una misura di questo,  , uvoglio che passi
una misura di una breuve di questo,
, uvoglio che passi
una misura di una breuve di questo,  . eEt in questo modo formerai, et osser-uverai il modo della pportione dupla, passando due semibreuvi nel termine
di una, et cosiì dell'altre figure. La tripla, et quadrupla anchora si dimostrano colli proprii sui numeri, osseruvado quello, che nella dupla si cotiene:, cioè
che passerano tre semibreuvi, breuvi, òo lunghe nello interuvallo di una sola:;
la quadrupla passeraà quatro semibreuvi [#s1523: contra] [#s1529: contro a] [#s1539: contro a] [#s1562: contro ad] una, le qual semibreuvi uve-niranno in forma, et quantità di quatro semiminime., delle qual propor-tioni in questo genere secondo la diuvisione cantabile altro in luce da noi
non sarà [s1529: page 91] [#s1523: dato] [#s1529: messo] [#s1539: messo] [#s1562: messo] , per esser questi più facili al pronontiante., li essempii delli
quali dopo il genere superparticolare seguente da noi saranno dimostrati.
Onde, paredo a te rimuouvere, et distruggere tal modo, et misura delle pre-[s1523: page 89]dette proportioni, è di bisogno segnare le cifre al contrario:, cioè quel nu-mero, che prima era maggiore:, sia il minore, et quello, che era minore:, sia
maggiore, come per li presenti s'intende, 1/2, 1/3, 1/4, per la qual prima fi-gura sarà chiamato sottodupla proportione., per il secondo sottotripla, et
per il terzo sotto quadrupla. Puoi anchora rimuouvere dallo inteto proportionato la misura con il segno antecedente, cioè che (come ate no pare, che
sia in tal dispositione proportionabile) metti dopo la tua proportione il se-gno, quale era inanzi, et cosiì sarà distrutta la tua proportione tante uvolte,
quante a te parerà, insino che si ritruouvi altra forma, òo segno.
. eEt in questo modo formerai, et osser-uverai il modo della pportione dupla, passando due semibreuvi nel termine
di una, et cosiì dell'altre figure. La tripla, et quadrupla anchora si dimostrano colli proprii sui numeri, osseruvado quello, che nella dupla si cotiene:, cioè
che passerano tre semibreuvi, breuvi, òo lunghe nello interuvallo di una sola:;
la quadrupla passeraà quatro semibreuvi [#s1523: contra] [#s1529: contro a] [#s1539: contro a] [#s1562: contro ad] una, le qual semibreuvi uve-niranno in forma, et quantità di quatro semiminime., delle qual propor-tioni in questo genere secondo la diuvisione cantabile altro in luce da noi
non sarà [s1529: page 91] [#s1523: dato] [#s1529: messo] [#s1539: messo] [#s1562: messo] , per esser questi più facili al pronontiante., li essempii delli
quali dopo il genere superparticolare seguente da noi saranno dimostrati.
Onde, paredo a te rimuouvere, et distruggere tal modo, et misura delle pre-[s1523: page 89]dette proportioni, è di bisogno segnare le cifre al contrario:, cioè quel nu-mero, che prima era maggiore:, sia il minore, et quello, che era minore:, sia
maggiore, come per li presenti s'intende, 1/2, 1/3, 1/4, per la qual prima fi-gura sarà chiamato sottodupla proportione., per il secondo sottotripla, et
per il terzo sotto quadrupla. Puoi anchora rimuouvere dallo inteto proportionato la misura con il segno antecedente, cioè che (come ate no pare, che
sia in tal dispositione proportionabile) metti dopo la tua proportione il se-gno, quale era inanzi, et cosiì sarà distrutta la tua proportione tante uvolte,
quante a te parerà, insino che si ritruouvi altra forma, òo segno.
DEL SVUPERPARTICOLARE GENERE. CAP. XXXIII.
 ,.
,. eEt alcuni altri dicono, che non può essere se-squaltera senza perfettione. aAltri uveramente dicono, che tale effetto no può
essere creato da tal ragione, [#s1523: impocheé] [#s1529: imperocheé] [#s1539: imperocheé] [#s1562: perciocheé] la breuve è stata ordinata, et costituita
dalli musici perfetta sotto al segno della circolare figura, come qui,
eEt alcuni altri dicono, che non può essere se-squaltera senza perfettione. aAltri uveramente dicono, che tale effetto no può
essere creato da tal ragione, [#s1523: impocheé] [#s1529: imperocheé] [#s1539: imperocheé] [#s1562: perciocheé] la breuve è stata ordinata, et costituita
dalli musici perfetta sotto al segno della circolare figura, come qui,  . pPer
tanto, rimosso tal segno, intendono no douversi osseruvare pfettione di breuvi,
neé alteratione alcuna, pcheé se tal cifra 3 fàa lo effetto di pfettione, in uvano
è stato il presente segno
. pPer
tanto, rimosso tal segno, intendono no douversi osseruvare pfettione di breuvi,
neé alteratione alcuna, pcheé se tal cifra 3 fàa lo effetto di pfettione, in uvano
è stato il presente segno  dalli musici trouvato. nNon dimeno [#s1523: qua] [#s1529: qua] [#s1539: qua] [#s1562: quiuvi] faremo
conclusione, che [#s1523: qui] [#s1529: qui] [#s1539: qui] [#s1562: quiuvi] al proposito sarà,. qQuando a te piace componere una
sesqualtera dopo il segno semicircolare tagliato, [s1562: page 51]auvertirai ponere la pre-detta sesqualtera co il presente segno
dalli musici trouvato. nNon dimeno [#s1523: qua] [#s1529: qua] [#s1539: qua] [#s1562: quiuvi] faremo
conclusione, che [#s1523: qui] [#s1529: qui] [#s1539: qui] [#s1562: quiuvi] al proposito sarà,. qQuando a te piace componere una
sesqualtera dopo il segno semicircolare tagliato, [s1562: page 51]auvertirai ponere la pre-detta sesqualtera co il presente segno  3/2la sesqualtera déueve esserée accompa-gnata co il tempo
3/2la sesqualtera déueve esserée accompa-gnata co il tempo  3/2:, nel quale ragioneuvolmete si trouverano le breuvi pfette, et semib. alterate. mMàa se in principio del tuo cato
si ponerà tal segno,
3/2:, nel quale ragioneuvolmete si trouverano le breuvi pfette, et semib. alterate. mMàa se in principio del tuo cato
si ponerà tal segno,  , et dopo alquate note tu formerai una sesqualtera,
fàa' che tal canto sia terminato in quatità senaria, aciò che si possa coniun-gere la battuta delle breuvi col termine et misura sesqualterata., pcheé tu sai,
che questo segno,
, et dopo alquate note tu formerai una sesqualtera,
fàa' che tal canto sia terminato in quatità senaria, aciò che si possa coniun-gere la battuta delle breuvi col termine et misura sesqualterata., pcheé tu sai,
che questo segno,  , quanto alla battuta debbe esser simile al presente,
, quanto alla battuta debbe esser simile al presente,  ,
et qui alcuna uvolta li copositori incosideratamente mancano. Sono alcuni
altri, che inanzi pongono in principio del suo canto il segno seguente,
,
et qui alcuna uvolta li copositori incosideratamente mancano. Sono alcuni
altri, che inanzi pongono in principio del suo canto il segno seguente,  ,
nel qual segno è diputato [#s1523: ciascuna] [#s1529: ciascuna] [#s1539: ciascuna] [#s1562: ogni] semibreuve passare per una misura, et co
poca auvertenza adducono la sesqualtera proportione con breuvi, et semi-breuvi, nel qual ordine, et forma accadono tre effetti: dui contrarii, et uno
difficile al pronontiate, ouver cantore,. Per il primo, hauvendo data la misura
nella semibreuve, et uvolendo creare la sesqualtera, ne risulta tripla., pcheé prima passauva per una battuta una semibreuve, [#s1523: di poi] [#s1529: di poi] [#s1539: di poi] [#s1562: dapoi] ne passa tre. Per il seco-do effetto cotrario auviene, che se pur tu uvuoi creare la sesqualtera propor-tione, a te è dibisogno mutarti dalla prima misura, quale era una semibreuve p battuta:, et entrare nella misura, qual si couviene a qsto segno,
,
nel qual segno è diputato [#s1523: ciascuna] [#s1529: ciascuna] [#s1539: ciascuna] [#s1562: ogni] semibreuve passare per una misura, et co
poca auvertenza adducono la sesqualtera proportione con breuvi, et semi-breuvi, nel qual ordine, et forma accadono tre effetti: dui contrarii, et uno
difficile al pronontiate, ouver cantore,. Per il primo, hauvendo data la misura
nella semibreuve, et uvolendo creare la sesqualtera, ne risulta tripla., pcheé prima passauva per una battuta una semibreuve, [#s1523: di poi] [#s1529: di poi] [#s1539: di poi] [#s1562: dapoi] ne passa tre. Per il seco-do effetto cotrario auviene, che se pur tu uvuoi creare la sesqualtera propor-tione, a te è dibisogno mutarti dalla prima misura, quale era una semibreuve p battuta:, et entrare nella misura, qual si couviene a qsto segno,  , [#s1523: quale] [#s1529: &] [#s1539: &] [#s1562: &]
è errore, pcheé tutte le proportioni drittamete si riferiscono al l'antecedente
segno. Il terzo effetto [#s1523: è] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] di difficoltaà [#s1523: ] [#s1529: è] [#s1539: eè] [#s1562: eè] , cheé ben puoi creare la sesqualtera proportione nelle figure, et forma medesima sanza rimuouvere la misura del
segno in questo modo, [#s1523: cioè] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] facendo che ciascuna nota sia syncopata, la
qual proportione [#s1523: resoluta nel segno tagliato, restano duplicate le note] [#s1529: resulteraà, che tutte le note resterano dupplicate] [#s1539: resulteraà, che tutte le note resterano dupplicate] [#s1562: risulteraà, che tutte le note resteranno dupplicate] , per
la qual cosa ne sarà la giusta, [s1529: page 93]et uvera sesqualtera. mMàa percheé questo modo [s1523: page 91]poco è usitato, auvertirai, quado sotto tal segno,
, [#s1523: quale] [#s1529: &] [#s1539: &] [#s1562: &]
è errore, pcheé tutte le proportioni drittamete si riferiscono al l'antecedente
segno. Il terzo effetto [#s1523: è] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] di difficoltaà [#s1523: ] [#s1529: è] [#s1539: eè] [#s1562: eè] , cheé ben puoi creare la sesqualtera proportione nelle figure, et forma medesima sanza rimuouvere la misura del
segno in questo modo, [#s1523: cioè] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] facendo che ciascuna nota sia syncopata, la
qual proportione [#s1523: resoluta nel segno tagliato, restano duplicate le note] [#s1529: resulteraà, che tutte le note resterano dupplicate] [#s1539: resulteraà, che tutte le note resterano dupplicate] [#s1562: risulteraà, che tutte le note resteranno dupplicate] , per
la qual cosa ne sarà la giusta, [s1529: page 93]et uvera sesqualtera. mMàa percheé questo modo [s1523: page 91]poco è usitato, auvertirai, quado sotto tal segno,  , tu penserai formare una
sesqualtera, fàa' le tue note [#s1523: con figura] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] di semibreuvi, et minime accopagnate,
et no di breuvi, et semibreuvi, nel qual pcesso uverano in battuta tre minime
cotra una semibreuve, quale è sesqualtera. eEt cosiì no incorrerai in tali [#s1523: effetti] [#s1529: errori] [#s1539: errori] [#s1562: errori]
da noi di sopra dimostrati. Per tanto ciascuna sesqualtera formata sotto la
battuta di una breuve éè di bisogno segnarsi co breuvi, et semibreuvi uvacue, òo
piene. mMàa quella, che si ritruouva nella battuta di semibreuvi, òo minime, fàa'
che la sua forma si mostri di semibreuvi, et minime. cCosiì a te sia maifesto della semibreuve sesqualterata nella prolatione perfetta, et impfetta. Hora diremo della secoda specie del supparticolare genere, quale è la sesquiterza:, la
qual pportione è, quado il termino maggiore cotiene in seé una uvolta tutto
il minore, et una parte terza, come appare nelli presenti numeri, 4 a 3, nella
qual coparatione manifestamete si uvede, che il numero maggiore, quale è
4:, hàa in seé il minore una uvolta, quale è 3:, et anchora una unità, quale è parte terza del 3. Et se farai coparatioe dal numero ottonario al senario, sarà il
simile., [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] nello ottonario numero si cotiene una sol uvolta il senario, et
due unità, che sono terza parte del senario numero. eEt cosiì seguendo per le
medesime coparationi, sarà il simile in quatità infinita, osseruvando [#s1523: che ciascu] [#s1529: che ciascun] [#s1539: che ciascun] [#s1562: ch'ogni] termino minore sia dal suo maggiore supato di una parte
terza. Cosiì
la sesquiquarta sarà, quado il termino maggiore [#s1523: cotiene] [#s1529: conteneraà] [#s1539: coteneraà] [#s1562: conteneraà] in seé il minore, et
una quarta parte, come qui, 5 a 4, la sesquiquinta uno quinto, come 6 a 5.,
et questo in [#s1523: tutto [sic: tutte]] [#s1529: tutte] [#s1539: tutte] [#s1562: tutte] le altre parti del genere superparticolare è necessario trouvarsi., perciò uvolendo formare tal [s1539: page 55]proportione nelli tuoi canti, harràai dui
modi, il primo in questa forma, 4/3 ouver 8/6, le quali comparationi sono intese
quatro note nello interuvallo di tre, et anchora otto note nel termino di sei.
pPer tato è a te di bisogno (se farai coparatioe di sequiterzo [sic: sesquiterza]) torre a ciascheduna nota la sua quarta parte, come sarano quatro lughe cotra tre., le quali
quatro lunghe del modo minore imperfetto, tepo, et prolatione imperfetta,
sono di quantità di semibreuvi quatro per ciascheduna, et comparate nella
sesquiterza, [#s1523: restano] [#s1529: resta] [#s1539: resta] [#s1562: resta] di numero tre ciascuna lunga, che sono in tutto 12
semibreuvi, che fanno la quatità delle tre lunghe a seé comparate. Cosiì anchora se
sarano breuvi, ciascuna breuve resta di una semibreuve, et minima. eEt per conseguente le semibreuvi restano di una minima, et semiminima per ciascheduna. Anchora apresso alcuni tal sesquiterza si ritruouva nelli canti cosiì segna-ta,
, tu penserai formare una
sesqualtera, fàa' le tue note [#s1523: con figura] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] di semibreuvi, et minime accopagnate,
et no di breuvi, et semibreuvi, nel qual pcesso uverano in battuta tre minime
cotra una semibreuve, quale è sesqualtera. eEt cosiì no incorrerai in tali [#s1523: effetti] [#s1529: errori] [#s1539: errori] [#s1562: errori]
da noi di sopra dimostrati. Per tanto ciascuna sesqualtera formata sotto la
battuta di una breuve éè di bisogno segnarsi co breuvi, et semibreuvi uvacue, òo
piene. mMàa quella, che si ritruouva nella battuta di semibreuvi, òo minime, fàa'
che la sua forma si mostri di semibreuvi, et minime. cCosiì a te sia maifesto della semibreuve sesqualterata nella prolatione perfetta, et impfetta. Hora diremo della secoda specie del supparticolare genere, quale è la sesquiterza:, la
qual pportione è, quado il termino maggiore cotiene in seé una uvolta tutto
il minore, et una parte terza, come appare nelli presenti numeri, 4 a 3, nella
qual coparatione manifestamete si uvede, che il numero maggiore, quale è
4:, hàa in seé il minore una uvolta, quale è 3:, et anchora una unità, quale è parte terza del 3. Et se farai coparatioe dal numero ottonario al senario, sarà il
simile., [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] nello ottonario numero si cotiene una sol uvolta il senario, et
due unità, che sono terza parte del senario numero. eEt cosiì seguendo per le
medesime coparationi, sarà il simile in quatità infinita, osseruvando [#s1523: che ciascu] [#s1529: che ciascun] [#s1539: che ciascun] [#s1562: ch'ogni] termino minore sia dal suo maggiore supato di una parte
terza. Cosiì
la sesquiquarta sarà, quado il termino maggiore [#s1523: cotiene] [#s1529: conteneraà] [#s1539: coteneraà] [#s1562: conteneraà] in seé il minore, et
una quarta parte, come qui, 5 a 4, la sesquiquinta uno quinto, come 6 a 5.,
et questo in [#s1523: tutto [sic: tutte]] [#s1529: tutte] [#s1539: tutte] [#s1562: tutte] le altre parti del genere superparticolare è necessario trouvarsi., perciò uvolendo formare tal [s1539: page 55]proportione nelli tuoi canti, harràai dui
modi, il primo in questa forma, 4/3 ouver 8/6, le quali comparationi sono intese
quatro note nello interuvallo di tre, et anchora otto note nel termino di sei.
pPer tato è a te di bisogno (se farai coparatioe di sequiterzo [sic: sesquiterza]) torre a ciascheduna nota la sua quarta parte, come sarano quatro lughe cotra tre., le quali
quatro lunghe del modo minore imperfetto, tepo, et prolatione imperfetta,
sono di quantità di semibreuvi quatro per ciascheduna, et comparate nella
sesquiterza, [#s1523: restano] [#s1529: resta] [#s1539: resta] [#s1562: resta] di numero tre ciascuna lunga, che sono in tutto 12
semibreuvi, che fanno la quatità delle tre lunghe a seé comparate. Cosiì anchora se
sarano breuvi, ciascuna breuve resta di una semibreuve, et minima. eEt per conseguente le semibreuvi restano di una minima, et semiminima per ciascheduna. Anchora apresso alcuni tal sesquiterza si ritruouva nelli canti cosiì segna-ta,  , quado il tempo è perfetto:.Tempo di dupla
, quado il tempo è perfetto:.Tempo di dupla 
 mMàa quado tal segno è nella quantità bina-ria, uvogliono allhora li copositori [#s1523: ] [#s1529: che ] [#s1539: che ] [#s1562: che ] sia inteso [s1529: page 94]p una pportione dupla:, come [s1523: page 92]dimostra il fine del pPatre della mMessa del l'oOmearmeé di Iosqno.Aaron is referring to Josquin's Missa L'homme armé sexti toni. eEt oltra qsto
se il medesimo farai in tutte le coparationi seguenti, sanza alcuno impedi-meto le specie del superparticolare trouverai:, come. 7 a 6, 8 a 7, le quali (uvoledo nelli cati usare) sono in tuo arbitrio. nNo dimeno (come di sopra habbia-mo detto), per no hauvere diuvisione equale, diremo no douversi nelli canti nostri [#s1523: essercitare, ma solo quelle, che nelle presenti figure si cotengono] [#s1529: esercitarsi, no derogando ad altri il suo uvolere, osseruverete quanto la figura mostra] [#s1539: esercitarsi, non derogando ad altri ilsuo uvolere, osseruverete quanto la figura mostra] [#s1562: esercitarsi, non derogando ad altri il suo volere, osseruverete quanto la figura mostra.] . [s1562: page 52]
mMàa quado tal segno è nella quantità bina-ria, uvogliono allhora li copositori [#s1523: ] [#s1529: che ] [#s1539: che ] [#s1562: che ] sia inteso [s1529: page 94]p una pportione dupla:, come [s1523: page 92]dimostra il fine del pPatre della mMessa del l'oOmearmeé di Iosqno.Aaron is referring to Josquin's Missa L'homme armé sexti toni. eEt oltra qsto
se il medesimo farai in tutte le coparationi seguenti, sanza alcuno impedi-meto le specie del superparticolare trouverai:, come. 7 a 6, 8 a 7, le quali (uvoledo nelli cati usare) sono in tuo arbitrio. nNo dimeno (come di sopra habbia-mo detto), per no hauvere diuvisione equale, diremo no douversi nelli canti nostri [#s1523: essercitare, ma solo quelle, che nelle presenti figure si cotengono] [#s1529: esercitarsi, no derogando ad altri il suo uvolere, osseruverete quanto la figura mostra] [#s1539: esercitarsi, non derogando ad altri ilsuo uvolere, osseruverete quanto la figura mostra] [#s1562: esercitarsi, non derogando ad altri il suo volere, osseruverete quanto la figura mostra.] . [s1562: page 52]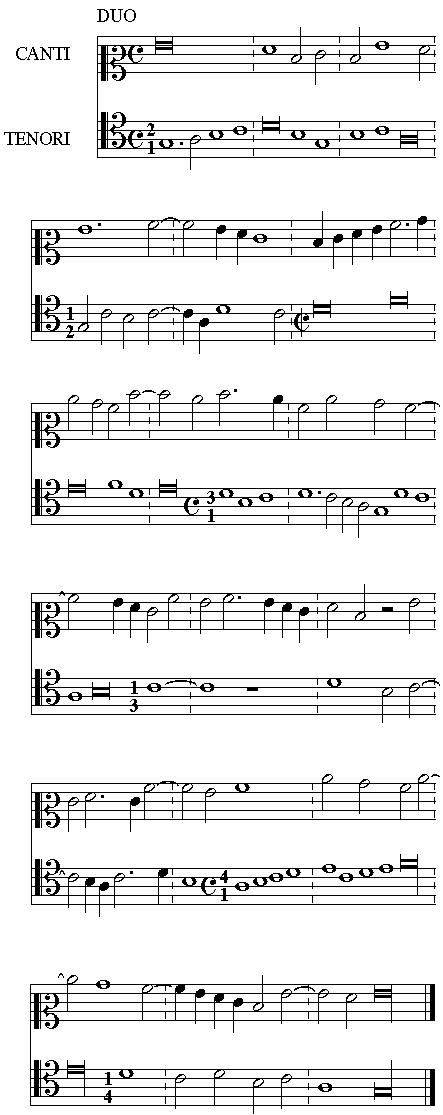
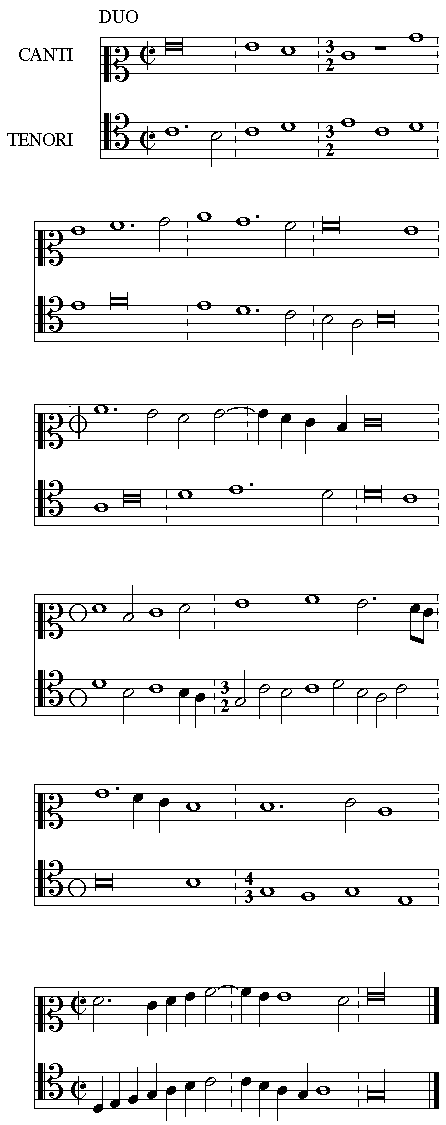 [s1523: page 93][s1529: page 95][s1539: page 56]
[s1523: page 93][s1529: page 95][s1539: page 56]DEL SVUPERPARTIENTE GE-NERE. CAP. XXXIIII.
DEL MOLTEPLICE SVUPERPARTICOLARE GENERE. CAP. XXXV.
DEL MOLTEPLICE SVUPERPARTIENTE [#s1523: GENERE] [#s1529: GENERE] [#s1539: GENERE] [#s1562: ] . CAP. XXXVI.
DELLA PROPORTIONALITA' ARITH-METICA. CAP. XXXVII.
DELLA GEOMETRICA PROPORTIO-NALITA'. CAP. XXXVIII.
DELLA HARMONICA PROPORTIONAlitaLITA'. CAP. XXXIX.
DIVISIONE DEL MONACHORDO PER TVUONI, ET SEMITVUONI NATVURALI, ET ACCIDENTALI. CAP. XXXX.Much of this chapter is taken from an anonymous letter copied by Aaron, published in Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 929-934. See also Commentary, ibid., p. 937-940.
 ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi:. mMa da [#s1523:
] [#s1562: ] mi:. mMa da [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et C fa ut, [#s1523: òo] [#s1529: òo] [#s1539: o] [#s1562: ouveramente] uvuoi hypáate
hypatôon, et parhypáate hypatôon, [#s1523: no] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] saraà [#s1523: un tuono, màa siì] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] un semituono minore, [#s1523: no mezza parte di tuono, come altrouve fùu detto] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] . Et pcheé da proslamba-nóomenos a hypáate hypatôon si dimostra un tasto [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] negro in mezzo, sappi che
tal tasto da quello bianco posto in proslambanóomenos è una distanza di
semituono minore, et da quello di hypáate hypatôon un semituono maggio-re, come chiaramente puoi uvedere per la quinta apparente da [#s1523:
] [#s1562: ] mi, et C fa ut, [#s1523: òo] [#s1529: òo] [#s1539: o] [#s1562: ouveramente] uvuoi hypáate
hypatôon, et parhypáate hypatôon, [#s1523: no] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] saraà [#s1523: un tuono, màa siì] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] un semituono minore, [#s1523: no mezza parte di tuono, come altrouve fùu detto] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] . Et pcheé da proslamba-nóomenos a hypáate hypatôon si dimostra un tasto [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] negro in mezzo, sappi che
tal tasto da quello bianco posto in proslambanóomenos è una distanza di
semituono minore, et da quello di hypáate hypatôon un semituono maggio-re, come chiaramente puoi uvedere per la quinta apparente da [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi a F fa
ut, òo uvuoi [s1562: page 55]da hypáate hypatôon a parhypáate mesôon, la quale è coposta di dui
tuoni, et dui semituoni minori:, del che resta diminuta [#s1523: di una] [#s1529: uno] [#s1539: uno] [#s1562: uno] apotomèe det-to semituono maggiore,. pPer tanto è stato di bisogno a tale reintegratione,
et pfettione stabilire il detto tasto negro, accioò che esso diàa péente, ouver qnta
sia soauve, et grata allo udito. Dal quarto luogo, chiamato parhypáate hypa-tôon, ouvero C fa ut, a lichanòos hypatôon, chiamato D sol re, sarà uno interuvallo di [#s1523: uno] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] tuono., fra li quali parhypáate hypatôon, et lichanòos hypatôon nasce
il tasto negro in mezzo, per il quale resta diuviso parhypáate hypatôon da li-chanòos hypatôon in dui semituoni, uno maggiore, et uno minore, delli quali
il maggiore sarà da C fa ut al tasto negro,; et dal tasto negro al biaco seguete, qual è D sol re:, sarà il semituono minore, come si uvede da A re, et C fa
ut, quale è terza minore:; et bisognado essa reintegrare, et augumetare alla
quatitaà [#s1523: della] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] maggiore, sarà necessario accrescere uno semituono maggio-re, qual sarà propriamete quella distanza, che è da C fa ut al tasto negro.
Da lichanòos hypatôon a hypáate mesôon, cioè D sol re, et E la mi (come hai
nel passato inteso), cade il tuono, et da detto D sol re al tasto negro cade un
semituono al quanto maggiore del suo bisogno.,Following the anonymous author on whom he bases this chapter, Aaron is describing a tempered interval. See Bonnie J. Blackburn,
Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 930, note 2. per il quale no si puoò dare
fauvore neé augumetatione alla terza minore, qual cade da [#s1523:
] [#s1562: ] mi a F fa
ut, òo uvuoi [s1562: page 55]da hypáate hypatôon a parhypáate mesôon, la quale è coposta di dui
tuoni, et dui semituoni minori:, del che resta diminuta [#s1523: di una] [#s1529: uno] [#s1539: uno] [#s1562: uno] apotomèe det-to semituono maggiore,. pPer tanto è stato di bisogno a tale reintegratione,
et pfettione stabilire il detto tasto negro, accioò che esso diàa péente, ouver qnta
sia soauve, et grata allo udito. Dal quarto luogo, chiamato parhypáate hypa-tôon, ouvero C fa ut, a lichanòos hypatôon, chiamato D sol re, sarà uno interuvallo di [#s1523: uno] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] tuono., fra li quali parhypáate hypatôon, et lichanòos hypatôon nasce
il tasto negro in mezzo, per il quale resta diuviso parhypáate hypatôon da li-chanòos hypatôon in dui semituoni, uno maggiore, et uno minore, delli quali
il maggiore sarà da C fa ut al tasto negro,; et dal tasto negro al biaco seguete, qual è D sol re:, sarà il semituono minore, come si uvede da A re, et C fa
ut, quale è terza minore:; et bisognado essa reintegrare, et augumetare alla
quatitaà [#s1523: della] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] maggiore, sarà necessario accrescere uno semituono maggio-re, qual sarà propriamete quella distanza, che è da C fa ut al tasto negro.
Da lichanòos hypatôon a hypáate mesôon, cioè D sol re, et E la mi (come hai
nel passato inteso), cade il tuono, et da detto D sol re al tasto negro cade un
semituono al quanto maggiore del suo bisogno.,Following the anonymous author on whom he bases this chapter, Aaron is describing a tempered interval. See Bonnie J. Blackburn,
Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 930, note 2. per il quale no si puoò dare
fauvore neé augumetatione alla terza minore, qual cade da [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi a D sol re,
uvolendo che sia maggiore, siì come in tutti li altri tuoni diuvisi si couviene, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: & ] co-me la experienza del l'uno, et del l'altro [#s1523: ti] [#s1529: gli] [#s1539: gli] [#s1562: gli] dimostra. Voledo adunque in tal
luogo detto formare la terza maggiore, è di bisogno, che quel tal semituo-no, òo tasto negro sopra della chorda, òo uvoce D sol re, sia al quanto sbassato., [s1539: page 59]dal quale sbassameto sono impedite, et guaste le qnte, et ottauve corrispon-[s1523: page 101]denti al detto semituono, òo tasto negro, della qual cosa nascerebbe grande
incouveniente piuù di quello, che prima era. Questo [#s1523: solo] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] si truouva in tali positioni, cioè tra D sol re, et E la mi, et nelle ottauve, et qntedecime, percheé lo
acuto, et sopracuto corrispondono al grauve, qual è suo primo nascimento.
eEt non per altro tali incouvenienti in questi luochi accadono, se non p cagione [s1529: page 103]delli organisti, li quali piuù tosto uvogliono accommodare il C fa ut della
terza minore, che il
] [#s1562: ] mi a D sol re,
uvolendo che sia maggiore, siì come in tutti li altri tuoni diuvisi si couviene, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: & ] co-me la experienza del l'uno, et del l'altro [#s1523: ti] [#s1529: gli] [#s1539: gli] [#s1562: gli] dimostra. Voledo adunque in tal
luogo detto formare la terza maggiore, è di bisogno, che quel tal semituo-no, òo tasto negro sopra della chorda, òo uvoce D sol re, sia al quanto sbassato., [s1539: page 59]dal quale sbassameto sono impedite, et guaste le qnte, et ottauve corrispon-[s1523: page 101]denti al detto semituono, òo tasto negro, della qual cosa nascerebbe grande
incouveniente piuù di quello, che prima era. Questo [#s1523: solo] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] si truouva in tali positioni, cioè tra D sol re, et E la mi, et nelle ottauve, et qntedecime, percheé lo
acuto, et sopracuto corrispondono al grauve, qual è suo primo nascimento.
eEt non per altro tali incouvenienti in questi luochi accadono, se non p cagione [s1529: page 103]delli organisti, li quali piuù tosto uvogliono accommodare il C fa ut della
terza minore, che il  mi della maggiore, percheé [#s1523:
mi della maggiore, percheé [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi da essi poco è ope-rato, et per tal modo manca, che quella terza minore dinanzi detta non si
può fare maggiore, sanza tagliare il tasto di sopra detto negro, acciò che
una parte di esso renda la uvoce piuù bassa, che la prima. eEt cosiì saraà aiutata,
et reintegrata la terza di quel semituono maggiore, che allei manca. Et di-scorrendo col tasto negro al luoco di E la mi, òo pure hypáate mesôon, harrai
la quantità del semituono maggiore, il quale pfice la qnta, ouver diàa péente
posta dal detto E la mi a B
] [#s1562: ] mi da essi poco è ope-rato, et per tal modo manca, che quella terza minore dinanzi detta non si
può fare maggiore, sanza tagliare il tasto di sopra detto negro, acciò che
una parte di esso renda la uvoce piuù bassa, che la prima. eEt cosiì saraà aiutata,
et reintegrata la terza di quel semituono maggiore, che allei manca. Et di-scorrendo col tasto negro al luoco di E la mi, òo pure hypáate mesôon, harrai
la quantità del semituono maggiore, il quale pfice la qnta, ouver diàa péente
posta dal detto E la mi a B fa acuto, diminuta, et impfetta. Da hypáate me-sôon a parypte [sic: parhypate] mesôon, cioè E la mi, et F fa ut, naturalmete cade il semituon
minore, nelli quali non si couviene altra diuvisione di semituoni, [#s1523: òo] [#s1529: óo] [#s1539: o] [#s1562: ouver] tasti negri.
Màa da parhypáate mesôon a lichanòos mesôon, chiamati F fa ut, et G sol re ut,
cade naturalmente il tuono diuviso in dui semituoni per il tasto negro in
mezzo posto, il quale sarà distante da F fa ut un semituono maggiore, col
quale si accresce la sesta minore in maggiore posta da A re a F fa ut grauve,
uvolendo ritrouvare la sua ottauva,. mMàa da esso tasto negro al bianco posto in
lichanòos mesôon, quale è G sol re ut:, cade il semituono minore, come si uvede
da lichanòos hypatôon a lichanòos mesôon, dicedo ut in lichanòos hypatôon, chiamato D sol re, i sino al fa di lichanòos mesôon, chiamato G sol re ut. dDa G sol
re ut ad A la mi re, chiamato méese, similmente cade un tuono, nelli quali anchora si truouva il semituono, òo uvero tasto negro, dal qual tasto negro alla
positione di lichanòos mesôon, cioè G sol re ut, cade il semituono maggiore,
[#s1523: percheé] [#s1529: pcheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] da hypáate hypatôon a lichanòos mesôon, quali sono [#s1523:
fa acuto, diminuta, et impfetta. Da hypáate me-sôon a parypte [sic: parhypate] mesôon, cioè E la mi, et F fa ut, naturalmete cade il semituon
minore, nelli quali non si couviene altra diuvisione di semituoni, [#s1523: òo] [#s1529: óo] [#s1539: o] [#s1562: ouver] tasti negri.
Màa da parhypáate mesôon a lichanòos mesôon, chiamati F fa ut, et G sol re ut,
cade naturalmente il tuono diuviso in dui semituoni per il tasto negro in
mezzo posto, il quale sarà distante da F fa ut un semituono maggiore, col
quale si accresce la sesta minore in maggiore posta da A re a F fa ut grauve,
uvolendo ritrouvare la sua ottauva,. mMàa da esso tasto negro al bianco posto in
lichanòos mesôon, quale è G sol re ut:, cade il semituono minore, come si uvede
da lichanòos hypatôon a lichanòos mesôon, dicedo ut in lichanòos hypatôon, chiamato D sol re, i sino al fa di lichanòos mesôon, chiamato G sol re ut. dDa G sol
re ut ad A la mi re, chiamato méese, similmente cade un tuono, nelli quali anchora si truouva il semituono, òo uvero tasto negro, dal qual tasto negro alla
positione di lichanòos mesôon, cioè G sol re ut, cade il semituono maggiore,
[#s1523: percheé] [#s1529: pcheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] da hypáate hypatôon a lichanòos mesôon, quali sono [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, et G sol re
ut:, è una distanza di sesta minore, et aggiungendo al detto tasto negro, si
augumeta del psente semituon maggiore, et di minor sesta resta maggiore.
Da esso semituono, òo tasto negro in sino ad A la mi re, chiamato méese, cade
la quantità del minor semituono, come facilmente uvedrai, dicendo ut in E
la mi grauve, et il re al quarto tasto negro, la uvoce mi al quinto tasto negro,
che son dui tuoni:, et il semituono minore seguita da esso quinto tasto negro
al seguente bianco, quale è A la mi re., la qual compositione, et discorso ge-nera un diàa tessáaron. Da méese, et trte synemmenn [sic: paramese],This error stems from the anonymous letter from which Aaron copied most of this chapter. See Bonnie J. Blackburn, Edward E.
Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 931. quali sono A la mi re,
et [#s1523:
] [#s1562: ] mi, et G sol re
ut:, è una distanza di sesta minore, et aggiungendo al detto tasto negro, si
augumeta del psente semituon maggiore, et di minor sesta resta maggiore.
Da esso semituono, òo tasto negro in sino ad A la mi re, chiamato méese, cade
la quantità del minor semituono, come facilmente uvedrai, dicendo ut in E
la mi grauve, et il re al quarto tasto negro, la uvoce mi al quinto tasto negro,
che son dui tuoni:, et il semituono minore seguita da esso quinto tasto negro
al seguente bianco, quale è A la mi re., la qual compositione, et discorso ge-nera un diàa tessáaron. Da méese, et trte synemmenn [sic: paramese],This error stems from the anonymous letter from which Aaron copied most of this chapter. See Bonnie J. Blackburn, Edward E.
Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 931. quali sono A la mi re,
et [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto:, cade il tuono naturale diuviso dal tasto negro, il qual tasto ne-[s1523: page 102]
gro sarà distante da méese, cioè A la mi re, l'interuvallo di uno semituono mi-nore,. mMàa da esso tasto negro al luoco di detto
] [#s1562: ] mi acuto:, cade il tuono naturale diuviso dal tasto negro, il qual tasto ne-[s1523: page 102]
gro sarà distante da méese, cioè A la mi re, l'interuvallo di uno semituono mi-nore,. mMàa da esso tasto negro al luoco di detto  mi acuto cade il semituo-no maggiore, come [#s1523: chiaramete tutti li autori i tal luoco] [#s1529: chiaramete tutti gli autori in tal luogo] [#s1539:
chiaramete tutti gli autori in tal luogo] [#s1562: chiarissimamente ciascheduno auttore in luogo simile] dimostrano, massimamente quando delle mutationi parlano. Da paraméese a tríite diezeug-menôon, che sono [#s1523:
mi acuto cade il semituo-no maggiore, come [#s1523: chiaramete tutti li autori i tal luoco] [#s1529: chiaramete tutti gli autori in tal luogo] [#s1539:
chiaramete tutti gli autori in tal luogo] [#s1562: chiarissimamente ciascheduno auttore in luogo simile] dimostrano, massimamente quando delle mutationi parlano. Da paraméese a tríite diezeug-menôon, che sono [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto et C sol fa ut, cade naturalmente il minor se-mituono., nelli qualli [sic: quali] interuvalli no è mezzo alcuno. Da tríite diezeugmenôon
a [s1529: page 104]paranéete diezeugmenôon, cioè C sol fa ut, et D la sol re, cade un tuono naturale diuviso dal tasto negro, il qual tasto negro è sopra di C sol fa ut la quatità del semituono maggiore, et da esso tasto negro al sequente bianco, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] chiamato paranéete diezeugmenôon, cade il semituono minore. Il maggiore se-mituono detto è in quel luoco, p cagione della sesta minore, formata da E
la mi a C sol fa ut,. uVolendo adunque farla [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: piuù ] maggiore, è dibisogno toccare il
sopradetto tasto,. eEt (come è [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già ] detto) da esso tasto negro a quello di D la sol re,
altro no è, che semituono minore., [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] formado il diàa tessáaron terzo, quale
è ut-fa:, no trouverai se no un semituono minore nel l'ultimo interuvallo, dice-do ut in A la mi re, re in B
] [#s1562: ] mi acuto et C sol fa ut, cade naturalmente il minor se-mituono., nelli qualli [sic: quali] interuvalli no è mezzo alcuno. Da tríite diezeugmenôon
a [s1529: page 104]paranéete diezeugmenôon, cioè C sol fa ut, et D la sol re, cade un tuono naturale diuviso dal tasto negro, il qual tasto negro è sopra di C sol fa ut la quatità del semituono maggiore, et da esso tasto negro al sequente bianco, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] chiamato paranéete diezeugmenôon, cade il semituono minore. Il maggiore se-mituono detto è in quel luoco, p cagione della sesta minore, formata da E
la mi a C sol fa ut,. uVolendo adunque farla [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: piuù ] maggiore, è dibisogno toccare il
sopradetto tasto,. eEt (come è [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già ] detto) da esso tasto negro a quello di D la sol re,
altro no è, che semituono minore., [#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] formado il diàa tessáaron terzo, quale
è ut-fa:, no trouverai se no un semituono minore nel l'ultimo interuvallo, dice-do ut in A la mi re, re in B fa [#s1523:
fa [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, mi al settimo tasto negro, qual son dui
tuoni,. iIl semituono per cosequente sarà da detto settimo tasto negro al bia-co sequente, che è D la sol re. Da paranéete diezeugmenôon a néete diezeug-menôon, cioè D la sol re, et E la mi, cade un tuono naturale, [s1562: page 56]diuviso dal semi-tuono, ouver tasto negro, il quale tasto negro sarà distante di altezza, quato
fùu quello (se ben ti ricordi) che [#s1523: ] [#s1529: fùu ] [#s1539: fu ] [#s1562: fu ] da
] [#s1562: ] mi, mi al settimo tasto negro, qual son dui
tuoni,. iIl semituono per cosequente sarà da detto settimo tasto negro al bia-co sequente, che è D la sol re. Da paranéete diezeugmenôon a néete diezeug-menôon, cioè D la sol re, et E la mi, cade un tuono naturale, [s1562: page 56]diuviso dal semi-tuono, ouver tasto negro, il quale tasto negro sarà distante di altezza, quato
fùu quello (se ben ti ricordi) che [#s1523: ] [#s1529: fùu ] [#s1539: fu ] [#s1562: fu ] da  mi, et D sol re [#s1523: fùu dichiarato, percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé]
si uvede manifestamete, dicendo il fa di B
mi, et D sol re [#s1523: fùu dichiarato, percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé]
si uvede manifestamete, dicendo il fa di B fa
fa  mi posto al sesto tasto negro
in sino all'ottauvo negro, sarà un diàa tessarôon, del quale uverrà fa-mi, semituo-no minore, da detto ottauvo tasto negro allo antecedente biaco, et dal sequete bianco sarà la quantità del semituon maggiore., come alla dichiaratione
delli tasti negri per seé soli [#s1523: coparato] [#s1529: comparati] [#s1539: coparati] [#s1562: comparati] l'uno all'altro si coprenderà. Da néete diezeugmenôon a tríite hyperboléeon, detti E la mi, et F fa ut, cade il semituono [s1539: page 60]minore senza altra diuvisione infra di loro. mMàa da tríite hypboléeon, detto F
fa ut, a paranéete hyperboléeon, chiamato G sol re ut secondo, cade natural-mente l'interuvallo di uno tuono, li quali positioni sono tramezzate dal semituono, ouver tasto negro, il qual semituono sarà distante da tríite hypboléeon
la quatità del semituono maggiore, come per la sesta cadete da méese, detto
A la mi re primo, a quella positione detta tríite hyperboléeon, cioè F fa ut, la
qual sesta naturalmente si dimostra minore. pPer tato bisognando, col detto
tasto negro si augumenta al luoco della maggiore, et cosiì la terza minore,
qual cade da D la sol re a quella di F fa ut secondo: si augumenta in mag-giore, il quale augumento è anchora al proposito alla decima minore ca-[s1523: page 103]dente da lichanòos hypatôon a tríite hypboléeon, cioè D sol re, et F fa ut acu-to. Essendo aduque il semituono maggiore in detto luoco, di necessitaà resta
il suo minore [#s1523: ] [#s1529: semituono ] [#s1539: semituono ] [#s1562: semituono ] dal tasto negro al seguente bianco, [#s1523: chiamato] [#s1529: chiamato] [#s1539: chiamato] [#s1562: detto] paranéete hyperboléeon, cioè G sol re ut. Da paranéete hyperboléeon a néete hypboléeon, cioè
G sol re ut, et A la mi re, naturalmente cade il tuono, nel quale si dimostra
il semituono in mezzo, ouver tasto negro, [#s1523: il quale] [#s1529: &] [#s1539: &] [#s1562: &] è distante per uno [s1529: page 105]inter-uvallo superiore da paranéete hyperboléeon di uno semituono maggiore, il
qual semituono augumenta la sesta cadente da [#s1523:
mi posto al sesto tasto negro
in sino all'ottauvo negro, sarà un diàa tessarôon, del quale uverrà fa-mi, semituo-no minore, da detto ottauvo tasto negro allo antecedente biaco, et dal sequete bianco sarà la quantità del semituon maggiore., come alla dichiaratione
delli tasti negri per seé soli [#s1523: coparato] [#s1529: comparati] [#s1539: coparati] [#s1562: comparati] l'uno all'altro si coprenderà. Da néete diezeugmenôon a tríite hyperboléeon, detti E la mi, et F fa ut, cade il semituono [s1539: page 60]minore senza altra diuvisione infra di loro. mMàa da tríite hypboléeon, detto F
fa ut, a paranéete hyperboléeon, chiamato G sol re ut secondo, cade natural-mente l'interuvallo di uno tuono, li quali positioni sono tramezzate dal semituono, ouver tasto negro, il qual semituono sarà distante da tríite hypboléeon
la quatità del semituono maggiore, come per la sesta cadete da méese, detto
A la mi re primo, a quella positione detta tríite hyperboléeon, cioè F fa ut, la
qual sesta naturalmente si dimostra minore. pPer tato bisognando, col detto
tasto negro si augumenta al luoco della maggiore, et cosiì la terza minore,
qual cade da D la sol re a quella di F fa ut secondo: si augumenta in mag-giore, il quale augumento è anchora al proposito alla decima minore ca-[s1523: page 103]dente da lichanòos hypatôon a tríite hypboléeon, cioè D sol re, et F fa ut acu-to. Essendo aduque il semituono maggiore in detto luoco, di necessitaà resta
il suo minore [#s1523: ] [#s1529: semituono ] [#s1539: semituono ] [#s1562: semituono ] dal tasto negro al seguente bianco, [#s1523: chiamato] [#s1529: chiamato] [#s1539: chiamato] [#s1562: detto] paranéete hyperboléeon, cioè G sol re ut. Da paranéete hyperboléeon a néete hypboléeon, cioè
G sol re ut, et A la mi re, naturalmente cade il tuono, nel quale si dimostra
il semituono in mezzo, ouver tasto negro, [#s1523: il quale] [#s1529: &] [#s1539: &] [#s1562: &] è distante per uno [s1529: page 105]inter-uvallo superiore da paranéete hyperboléeon di uno semituono maggiore, il
qual semituono augumenta la sesta cadente da [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto a G sol re ut
secondo, et la terza posta da néete diezeugmenôon, [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: nominato] E la mi acuto, a pa-ranéete hyperboléeon, chiamato G sol re ut secondo, et cosiì la decima cade-te da hypáate mesôon a paranéete hyperboléeon, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che sono ] detti E la mi grauve et G sol
re ut acuto,. sSegue adunque che il semituono minore sarà da néete hyperbo-léeon, [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: che eè chiamato] A la mi re, al tasto negro [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] di sopra ordinato, [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] uvolendo [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: noi ] for-mare il diàa pasôon da poi la sesta, et essendo in quel luoco minore, per [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: uvolere ] osser-uvare il precetto, [#s1523: conuvien] [#s1529: conuvien] [#s1539: conuvien] [#s1562: s'acconuviene] che sia [#s1523: tocco] [#s1529: tocco] [#s1539: tocco] [#s1562: toccato] il predetto tasto negro. Da néete hy-perboléeon, quale è A la mi re, a
] [#s1562: ] mi acuto a G sol re ut
secondo, et la terza posta da néete diezeugmenôon, [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: nominato] E la mi acuto, a pa-ranéete hyperboléeon, chiamato G sol re ut secondo, et cosiì la decima cade-te da hypáate mesôon a paranéete hyperboléeon, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che sono ] detti E la mi grauve et G sol
re ut acuto,. sSegue adunque che il semituono minore sarà da néete hyperbo-léeon, [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: che eè chiamato] A la mi re, al tasto negro [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] di sopra ordinato, [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] uvolendo [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: noi ] for-mare il diàa pasôon da poi la sesta, et essendo in quel luoco minore, per [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: uvolere ] osser-uvare il precetto, [#s1523: conuvien] [#s1529: conuvien] [#s1539: conuvien] [#s1562: s'acconuviene] che sia [#s1523: tocco] [#s1529: tocco] [#s1539: tocco] [#s1562: toccato] il predetto tasto negro. Da néete hy-perboléeon, quale è A la mi re, a  mi [#s1523: secondo [sic: terzo]] [#s1529: terzo] [#s1539: terzo] [#s1562: terzo] naturalmente [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562:
uviene a cadere] il tuono,
nel quale nasce il semituono ouver [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: il ] tasto negro, dal qual [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562:
predetto ] tasto negro a néete
hyperboléeon, cade il semituono minore, et nello ascenso [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] il maggiore,
[#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] trouvandosi secondo il discorso accidentale la quinta imperfetta da
detto
mi [#s1523: secondo [sic: terzo]] [#s1529: terzo] [#s1539: terzo] [#s1562: terzo] naturalmente [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562:
uviene a cadere] il tuono,
nel quale nasce il semituono ouver [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: il ] tasto negro, dal qual [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562:
predetto ] tasto negro a néete
hyperboléeon, cade il semituono minore, et nello ascenso [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] il maggiore,
[#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] trouvandosi secondo il discorso accidentale la quinta imperfetta da
detto  mi [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ch'eè ] sopra detto al fa, quale è di sopra alla positioe di E la, la quale
uvolendo che sia intiera et [#s1523: perfetta] [#s1529: perfetta] [#s1539: perfetta] [#s1562: perfettissima] , bisogna [#s1523: che] [#s1529: che] [#s1539: che] [#s1562: ch'essa] sia reintegrata da quel semi-tuono ouver tasto negro di sopra [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: narrato] , siì come fu nello antecedente [#s1523:
mi [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ch'eè ] sopra detto al fa, quale è di sopra alla positioe di E la, la quale
uvolendo che sia intiera et [#s1523: perfetta] [#s1529: perfetta] [#s1539: perfetta] [#s1562: perfettissima] , bisogna [#s1523: che] [#s1529: che] [#s1539: che] [#s1562: ch'essa] sia reintegrata da quel semi-tuono ouver tasto negro di sopra [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: narrato] , siì come fu nello antecedente [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi
acuto. [#s1523: Seguendo] [#s1529: Seguendo] [#s1539: Seguendo] [#s1562: Dapoi seguendo] piuù inanzi alla positione di C sol fa, sanza alcun dubbio
naturalmente cade il semituono minore de [sic: da]
] [#s1562: ] mi
acuto. [#s1523: Seguendo] [#s1529: Seguendo] [#s1539: Seguendo] [#s1562: Dapoi seguendo] piuù inanzi alla positione di C sol fa, sanza alcun dubbio
naturalmente cade il semituono minore de [sic: da]  mi sopracuto al fa di C sol
fa, fra li quali non si ritruouva mezzo alcuno. dDa C sol fa a D la sol simil-mente [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] lo interuvallo del tuono, nel qual si uvede diuviso dal semituono
ouver tasto negro, del che diremo che saraà da C sol fa al seguente semituono
negro la quantità di uno semituono maggiore, et dal seguente tasto biaco
quella del minore,. cChe sia maggiore il semituono detto, si uvede per la sesta
minore che nasce da néete diezeugmenôon, [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: chiamato] E la mi, alla positione di C
sol fa, et cosiì per la terza minore formata da néete hyperboléeon, quale è A
la mi re, a C sol fa. èE' necessario il tasto negro, come hàa di bisogno anchor la
decima inferiore a esso tasto negro, che sanza quello resterebbe minore. dDa
D la sol ad E la, ultima positione, cade il tuono diuviso [#s1523: anchora] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] per il suo tasto negro, distante dal detto E la, la quantità del semituono dinanzi detto,
cadete tra lichanòos hypatôon ad hypáate mesôon, et da paranéete diezeugme-[s1523: page 104]
nôon a néete diezeugmenôon. eEt da esso tasto negro alla position detta E la [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] il maggior semituono, et [#s1523: tal] [#s1529: tal] [#s1539: tal] [#s1562: simile] positione rettamente
si può chiamare quel-lo, che nella ottauva inferiore risponde:, qual si domanda E la mi [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] replicato,
[#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] passando sopra di E la, bisogna rinouvare [#s1523: ciascuna] [#s1529: ciascuna] [#s1539: ciascuna] [#s1562: ciascheduna] positione, et luoco
co quella dimostratione, ordine, et [#s1523: modo] [#s1529: modo] [#s1539: modo] [#s1562: maniera] che [#s1523: feceno] [#s1529: fu fatto] [#s1539:
fu fatto] [#s1562: fu fatto] le prime, [#s1523: chiamate] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] grauvi, et quelle che [#s1523: era] [#s1529: erano] [#s1539: erano] [#s1562: erano] nello acuto, et sopracuto,. iIl simile nelle sequeti trouverai,
seguendo l'ordine un'altra uvolta sopra di E la mi secondo che nella mano si
truouva [s1529: page 106]ordinato. Adunque diremo che da E la al seguente tasto non cade
altro, che il semituono minore, come [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già ] manifestamete si uvede, sanza altra di-uvisione di semituono, [#s1523: òo] [#s1529: o] [#s1539: o] [#s1562: ouvero] tasto negro. Ma dal seguente F fa ut replicato insi-no a G sol re ut [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] un tuono, il quale anchora resta diuviso dal tasto ne-gro, ilqual tasto negro è d'interuvallo superiore al tasto bianco inanzi posto
di quantità di uno semituono maggiore, come si dimostrano in tali positioni dinanzi dette, et come la experienza piuù chiaro dimostra:. eEt il contrario
dalla parte di sopra auviene, [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] da esso tasto negro al superiore bianco
non è altro che il semituono minore. dDal terzo G sol re ut replicato ad A
la mi re, altro non è, che quantità di tuono, nel qual si mostra il semituono
negro distate da detto G sol re ut per uno semituono maggiore, cosiì come
nel grauve fùu chiarito,. eEt dalla parte di [s1539: page 61]sopra da detto semituono negro al
tasto bianco cade il semituon minore. Da A la mi re [#s1523: a] [#s1529: a ] [#s1539: a] [#s1562: ]
mi sopracuto al fa di C sol
fa, fra li quali non si ritruouva mezzo alcuno. dDa C sol fa a D la sol simil-mente [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] lo interuvallo del tuono, nel qual si uvede diuviso dal semituono
ouver tasto negro, del che diremo che saraà da C sol fa al seguente semituono
negro la quantità di uno semituono maggiore, et dal seguente tasto biaco
quella del minore,. cChe sia maggiore il semituono detto, si uvede per la sesta
minore che nasce da néete diezeugmenôon, [#s1523: detto] [#s1529: detto] [#s1539: detto] [#s1562: chiamato] E la mi, alla positione di C
sol fa, et cosiì per la terza minore formata da néete hyperboléeon, quale è A
la mi re, a C sol fa. èE' necessario il tasto negro, come hàa di bisogno anchor la
decima inferiore a esso tasto negro, che sanza quello resterebbe minore. dDa
D la sol ad E la, ultima positione, cade il tuono diuviso [#s1523: anchora] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] per il suo tasto negro, distante dal detto E la, la quantità del semituono dinanzi detto,
cadete tra lichanòos hypatôon ad hypáate mesôon, et da paranéete diezeugme-[s1523: page 104]
nôon a néete diezeugmenôon. eEt da esso tasto negro alla position detta E la [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] il maggior semituono, et [#s1523: tal] [#s1529: tal] [#s1539: tal] [#s1562: simile] positione rettamente
si può chiamare quel-lo, che nella ottauva inferiore risponde:, qual si domanda E la mi [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: che eè ] replicato,
[#s1523: pcheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] passando sopra di E la, bisogna rinouvare [#s1523: ciascuna] [#s1529: ciascuna] [#s1539: ciascuna] [#s1562: ciascheduna] positione, et luoco
co quella dimostratione, ordine, et [#s1523: modo] [#s1529: modo] [#s1539: modo] [#s1562: maniera] che [#s1523: feceno] [#s1529: fu fatto] [#s1539:
fu fatto] [#s1562: fu fatto] le prime, [#s1523: chiamate] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] grauvi, et quelle che [#s1523: era] [#s1529: erano] [#s1539: erano] [#s1562: erano] nello acuto, et sopracuto,. iIl simile nelle sequeti trouverai,
seguendo l'ordine un'altra uvolta sopra di E la mi secondo che nella mano si
truouva [s1529: page 106]ordinato. Adunque diremo che da E la al seguente tasto non cade
altro, che il semituono minore, come [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: già ] manifestamete si uvede, sanza altra di-uvisione di semituono, [#s1523: òo] [#s1529: o] [#s1539: o] [#s1562: ouvero] tasto negro. Ma dal seguente F fa ut replicato insi-no a G sol re ut [#s1523: cade] [#s1529: cade] [#s1539: cade] [#s1562: uviene a cadere] un tuono, il quale anchora resta diuviso dal tasto ne-gro, ilqual tasto negro è d'interuvallo superiore al tasto bianco inanzi posto
di quantità di uno semituono maggiore, come si dimostrano in tali positioni dinanzi dette, et come la experienza piuù chiaro dimostra:. eEt il contrario
dalla parte di sopra auviene, [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] da esso tasto negro al superiore bianco
non è altro che il semituono minore. dDal terzo G sol re ut replicato ad A
la mi re, altro non è, che quantità di tuono, nel qual si mostra il semituono
negro distate da detto G sol re ut per uno semituono maggiore, cosiì come
nel grauve fùu chiarito,. eEt dalla parte di [s1539: page 61]sopra da detto semituono negro al
tasto bianco cade il semituon minore. Da A la mi re [#s1523: a] [#s1529: a ] [#s1539: a] [#s1562: ]  mi replicato sen-za alcun dubbio cade la quatità d'un tuono, màa da detto A la mi re al ta-sto negro, che è in mezzo: cade il semituono minore, et dal seguete [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: uviene a cadere ] il mag-giore. [s1562: page 57] [#s1523: Dal
mi replicato sen-za alcun dubbio cade la quatità d'un tuono, màa da detto A la mi re al ta-sto negro, che è in mezzo: cade il semituono minore, et dal seguete [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: uviene a cadere ] il mag-giore. [s1562: page 57] [#s1523: Dal  ] [#s1529: Da
] [#s1529: Da  ] [#s1539: Da
] [#s1539: Da  ] [#s1562: Da] mi detto al tasto seguente no altro cade, [#s1523: che el] [#s1529: del] [#s1539: del] [#s1562: del] semituon mi-nore, màa dal seguente replicato luoco, chiamato C sol fa ut, a D la sol re, no
cade altro, che la quatità di un tuono diuviso dal semituono negro, il qual
semituono negro resta distate dal biaco dinazi posto per quatità del semi-tuono maggiore, et dal seguete biaco resta minore. [#s1523: Di poi] [#s1529: Di poi] [#s1539: Dipoi] [#s1562: Poi] , seguendo a D la
sol re replicato al tasto seguete E la mi, altro no è, che la quatità di un tuo-no, diuviso anchora dal semituono negro, il qual semituono, è supiore al primo tasto biaco dinazi a seé posto la quatità del semituono, òo interuvallo, qual
si ritruouva per le ottauve inferiori a essa positione,. mMa dal seguente tasto biaco al detto negro è [#s1523: solo] [#s1529: solo] [#s1539: solo] [#s1562: solamente] distanza del semituon minore [sic: maggiore]. cCosiì nelli seguenti il
simile si truouva, cosiderando all'uniuversal modo, [#s1523: percheé] [#s1529: pcheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] ne sono alcuni altri,
che sono di maggiore numero di uvoci, chiamati istrometi doppi, la qual cosideratione, et intelligenza di esse chorde, ouver tasti aggiunti saraà intesa per
la compositione, et ordine di sopra mostrato., percheé secondo che le positio-[s1523: page 105]ni dinanzi dette hanno hauvuto ordine, cosiì le chorde aggiunte, et accresciute dalla parte grauve, ouver di sotto saranno corispondenti alle parti acute.
mMàa quelle, che nel superiore saranno messe: concorderanno con quello, che
in nanzi è stato detto. Màa hora intederai, che dalla prima chorda, òo uvoce,
[#s1523: òo] [#s1529: o] [#s1539: o] [#s1562: ouver] semituono, o uvuoi tasto negro nello istromento da noi ordinato, al secodo
seguente negro, sarà distaza di un tuono, et semituono maggiore, qual fan-no la compositione d'un semiditono, et comma., [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] da esso semituon
negro al sequente secondo, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: i ] detti accidentali, resta in mezzo il naturale mi-nore semituono., come dal terzo, al quarto, sesto, et settimo, ottauvo, et nono, [s1529: page 107]
undecimo, et duodecimo, terzodecimo, et quarto decimo, sesto decimo, et
decimo settimo il medesimo interuvallo trouverai. Per tanto dal detto secondo semituon negro al terzo seguente harrai la quantità del tuono al-quanto maggiore.Aaron is describing a tempered interval between C sharp and E flat. Dal terzo in nanzi detto al quarto occorrente acci-dentale è la distanza del semiditono quasi superfluo, et dal quarto al
quinto il tuono si uvede. Dal quinto al sesto [#s1523: cadono] [#s1529: cadono] [#s1539: cadono] [#s1562: uvengono a cadere] dui semituoni minori.
mMàa da detto sesto al settimo seguente cade un tuono col semituon mag-giore.; Ddal settimo al l'ottauvo il tuono alquanto superato. mMàa dall'ottauvo
al nono risponde uno interuvallo di trihemituono. Il nono, et decimo son
distanti d'uno interuvallo del semituon maggiore, et minore, come è stato
[#s1523: dal] [#s1529: del] [#s1539: del] [#s1562: del] quarto et quinto semituono negro. Dal decimo all'undecimo è la di-stanza, che fùu dal quinto al sesto per dui semituoni minori. L'undecimo,
et duodecimo harrà distanza del tuono, et semituon maggiore, come an-chora giace tra il sesto, et settimo. Dal duodecimo al terzo decimo è
quello, che sol si uvede tra 'l settimo, et ottauvo. Et [#s1523: precedendo [sic: procedendo]] [#s1529: seguitado] [#s1539: seguitado] [#s1562: seguitando] dal terzo de-cimo al quarto decimo seguente si trouveranno tre semituoni, siì come fùu
l'ottauvo, et nono tasto. Il quarto decimo, et qnto decimo tasto negro son ri-spodeti di quello, che fùu tra 'l nono tasto, et decimo., qual fùu il tuono. Ma dal
quinto decimo, et decimo sesto è la distanza, che fùu tra 'l decimo, et undeci-mo di dui semituoni minori. Cosiì piuù inanzi passando dal sesto decimo al
decimo settimo, harrai la quantità, che fùu tra l'undecimo, et duodecimo, et
anchor sesto, et settimo, quale è il tuono, et semituon maggiore. Et dal de-cimo settimo al decimo ottauvo, ultimo semituono, sarà [#s1523: sol] [#s1529: sol] [#s1539: sol] [#s1562: solamente] quello, che dal
duo decimo, et terzo decimo, settimo, et ottauvo nacque., qual fùu la quan-tità del tuono alquanto maggiore., delli quali comparati l'uno al l'altro
poca soauvità si sente, excetto che dal secondo, et quinto gli cade la conso-nanza diàa péente:; et il simile dal terzo al sesto si comprende. aAnchora dal [s1523: page 106]
quarto, et settimo il diàa péente nasce:, dal settimo, et decimo unaltro diàa péen-te. Dal primo al sesto il diàa pasôon nasce, et dal secondo al settimo il simile
trouverai. Cosiì dal terzo al l'ottauvo sarà, come dal quarto al nono si com-prende solo essere un diàa pasôon. Dall'ottauvo al l'undecimo nasce la quinta,
come dal nono al duodecimo si uvede. Màa dal l'ottauvo al terzo decimo è un
diàa pasôon, come dal nono al quarto decimo si uvede. cCosiì sarà dal decimo al
quintodecimo anchora, et il medesimo dal l'undecimo, et decimo sesto har-rai. Dal duodecimo al quintodecimo la quinta harrai, come dal terzo decimo al decimo sesto si uvede. Dal duodecimo al decimo settimo un diàa pasôon,
come dal terzo decimo, et ultimo si uvede. Dal quarto decimo, et decimo
settimo la quinta, come dimostra il qnto decimo a l'ultimo semituon detto.
eEt questo a te basti per la diuvisione et dichiaratione del monachordo.
] [#s1562: Da] mi detto al tasto seguente no altro cade, [#s1523: che el] [#s1529: del] [#s1539: del] [#s1562: del] semituon mi-nore, màa dal seguente replicato luoco, chiamato C sol fa ut, a D la sol re, no
cade altro, che la quatità di un tuono diuviso dal semituono negro, il qual
semituono negro resta distate dal biaco dinazi posto per quatità del semi-tuono maggiore, et dal seguete biaco resta minore. [#s1523: Di poi] [#s1529: Di poi] [#s1539: Dipoi] [#s1562: Poi] , seguendo a D la
sol re replicato al tasto seguete E la mi, altro no è, che la quatità di un tuo-no, diuviso anchora dal semituono negro, il qual semituono, è supiore al primo tasto biaco dinazi a seé posto la quatità del semituono, òo interuvallo, qual
si ritruouva per le ottauve inferiori a essa positione,. mMa dal seguente tasto biaco al detto negro è [#s1523: solo] [#s1529: solo] [#s1539: solo] [#s1562: solamente] distanza del semituon minore [sic: maggiore]. cCosiì nelli seguenti il
simile si truouva, cosiderando all'uniuversal modo, [#s1523: percheé] [#s1529: pcheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] ne sono alcuni altri,
che sono di maggiore numero di uvoci, chiamati istrometi doppi, la qual cosideratione, et intelligenza di esse chorde, ouver tasti aggiunti saraà intesa per
la compositione, et ordine di sopra mostrato., percheé secondo che le positio-[s1523: page 105]ni dinanzi dette hanno hauvuto ordine, cosiì le chorde aggiunte, et accresciute dalla parte grauve, ouver di sotto saranno corispondenti alle parti acute.
mMàa quelle, che nel superiore saranno messe: concorderanno con quello, che
in nanzi è stato detto. Màa hora intederai, che dalla prima chorda, òo uvoce,
[#s1523: òo] [#s1529: o] [#s1539: o] [#s1562: ouver] semituono, o uvuoi tasto negro nello istromento da noi ordinato, al secodo
seguente negro, sarà distaza di un tuono, et semituono maggiore, qual fan-no la compositione d'un semiditono, et comma., [#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciocheé] da esso semituon
negro al sequente secondo, [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: i ] detti accidentali, resta in mezzo il naturale mi-nore semituono., come dal terzo, al quarto, sesto, et settimo, ottauvo, et nono, [s1529: page 107]
undecimo, et duodecimo, terzodecimo, et quarto decimo, sesto decimo, et
decimo settimo il medesimo interuvallo trouverai. Per tanto dal detto secondo semituon negro al terzo seguente harrai la quantità del tuono al-quanto maggiore.Aaron is describing a tempered interval between C sharp and E flat. Dal terzo in nanzi detto al quarto occorrente acci-dentale è la distanza del semiditono quasi superfluo, et dal quarto al
quinto il tuono si uvede. Dal quinto al sesto [#s1523: cadono] [#s1529: cadono] [#s1539: cadono] [#s1562: uvengono a cadere] dui semituoni minori.
mMàa da detto sesto al settimo seguente cade un tuono col semituon mag-giore.; Ddal settimo al l'ottauvo il tuono alquanto superato. mMàa dall'ottauvo
al nono risponde uno interuvallo di trihemituono. Il nono, et decimo son
distanti d'uno interuvallo del semituon maggiore, et minore, come è stato
[#s1523: dal] [#s1529: del] [#s1539: del] [#s1562: del] quarto et quinto semituono negro. Dal decimo all'undecimo è la di-stanza, che fùu dal quinto al sesto per dui semituoni minori. L'undecimo,
et duodecimo harrà distanza del tuono, et semituon maggiore, come an-chora giace tra il sesto, et settimo. Dal duodecimo al terzo decimo è
quello, che sol si uvede tra 'l settimo, et ottauvo. Et [#s1523: precedendo [sic: procedendo]] [#s1529: seguitado] [#s1539: seguitado] [#s1562: seguitando] dal terzo de-cimo al quarto decimo seguente si trouveranno tre semituoni, siì come fùu
l'ottauvo, et nono tasto. Il quarto decimo, et qnto decimo tasto negro son ri-spodeti di quello, che fùu tra 'l nono tasto, et decimo., qual fùu il tuono. Ma dal
quinto decimo, et decimo sesto è la distanza, che fùu tra 'l decimo, et undeci-mo di dui semituoni minori. Cosiì piuù inanzi passando dal sesto decimo al
decimo settimo, harrai la quantità, che fùu tra l'undecimo, et duodecimo, et
anchor sesto, et settimo, quale è il tuono, et semituon maggiore. Et dal de-cimo settimo al decimo ottauvo, ultimo semituono, sarà [#s1523: sol] [#s1529: sol] [#s1539: sol] [#s1562: solamente] quello, che dal
duo decimo, et terzo decimo, settimo, et ottauvo nacque., qual fùu la quan-tità del tuono alquanto maggiore., delli quali comparati l'uno al l'altro
poca soauvità si sente, excetto che dal secondo, et quinto gli cade la conso-nanza diàa péente:; et il simile dal terzo al sesto si comprende. aAnchora dal [s1523: page 106]
quarto, et settimo il diàa péente nasce:, dal settimo, et decimo unaltro diàa péen-te. Dal primo al sesto il diàa pasôon nasce, et dal secondo al settimo il simile
trouverai. Cosiì dal terzo al l'ottauvo sarà, come dal quarto al nono si com-prende solo essere un diàa pasôon. Dall'ottauvo al l'undecimo nasce la quinta,
come dal nono al duodecimo si uvede. Màa dal l'ottauvo al terzo decimo è un
diàa pasôon, come dal nono al quarto decimo si uvede. cCosiì sarà dal decimo al
quintodecimo anchora, et il medesimo dal l'undecimo, et decimo sesto har-rai. Dal duodecimo al quintodecimo la quinta harrai, come dal terzo decimo al decimo sesto si uvede. Dal duodecimo al decimo settimo un diàa pasôon,
come dal terzo decimo, et ultimo si uvede. Dal quarto decimo, et decimo
settimo la quinta, come dimostra il qnto decimo a l'ultimo semituon detto.
eEt questo a te basti per la diuvisione et dichiaratione del monachordo.
DELLA PARTECIPATIONE ET MODO [#s1523: D'ACCORDARE] [#s1529: D'ACORDARE] [#s1539: DA CORDARE] [#s1562: DA CORDARE] L'ISTRO-MENTO. CAP. XXXXI.Much of this chapter is taken from an anonymous letter copied by Aaron, published in Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 929-934 (especially p. 933-934). See also Commentary, ibid., p. 937-940. For further information on Aaron's temperament, see Mark Lindley, "Early 16th Century Keyboard Temperaments", in Musica Disciplina, 28 (1974), p. 139-144.
 fa
fa  mi:, sempre discadono, et mancano della sua perfettione.
Per il secondo ordine, et modo è, che sempre a te bisogna sopra la chorda
di C sol fa ut, quale è unita, et giusta, accordare F fa ut, quinta di sotto., la
qual bisogna essere all'opposito delle altre dette di sopra, cioè che sia parte-cipata et alzato tanto, che passi alquanto del pfetto, et di qui nasce la par-tecipatione et accordo giusto et buono., per la qual partecipatione restano
spuntate, ouvero diminute le terze, et seste. Et cosiì accorderai il semituono di
B
mi:, sempre discadono, et mancano della sua perfettione.
Per il secondo ordine, et modo è, che sempre a te bisogna sopra la chorda
di C sol fa ut, quale è unita, et giusta, accordare F fa ut, quinta di sotto., la
qual bisogna essere all'opposito delle altre dette di sopra, cioè che sia parte-cipata et alzato tanto, che passi alquanto del pfetto, et di qui nasce la par-tecipatione et accordo giusto et buono., per la qual partecipatione restano
spuntate, ouvero diminute le terze, et seste. Et cosiì accorderai il semituono di
B fa
fa  mi sotto di F fa ut, et quello di E la mi sotto B
mi sotto di F fa ut, et quello di E la mi sotto B fa [#s1523:
fa [#s1523:  ] [#s1529:
] [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, il quale è
quinta, con quel medesimo ordine, et modo, che accordasti F fa ut con C
sol fa ut. Il terzo et ultimo modo auvertirai di accordare li semituoni mag-giori tra le sue terze, come è il semituono di C fa ut, toccado A re:. lLo accorderai insieme con E la mi quinta, tanto che resti in mezzo terza maggiore
con A re, et minore con E la mi. Et cosiì da D sol re ad A la mi re, la terza in
mezzo è il semituono di F fa ut, cioè il simile, che fùu la passata. eEt cosiì sequedo in sino al fine del tuo istromento, ciascuna ottauva accorderai, della qual
consideratione ne nasce la uvera partecipatione delle uvoci.
] [#s1562: ] mi, il quale è
quinta, con quel medesimo ordine, et modo, che accordasti F fa ut con C
sol fa ut. Il terzo et ultimo modo auvertirai di accordare li semituoni mag-giori tra le sue terze, come è il semituono di C fa ut, toccado A re:. lLo accorderai insieme con E la mi quinta, tanto che resti in mezzo terza maggiore
con A re, et minore con E la mi. Et cosiì da D sol re ad A la mi re, la terza in
mezzo è il semituono di F fa ut, cioè il simile, che fùu la passata. eEt cosiì sequedo in sino al fine del tuo istromento, ciascuna ottauva accorderai, della qual
consideratione ne nasce la uvera partecipatione delle uvoci.
AGGIVUNTA DEL TOSCANELLO, A COMPLACENZA DE GLI AMICI FATTA.A detailed analysis of this Aggiunta is given in Margaret Bent, "Accidentals, Counterpoint and Notation in Aaron's Aggiunta to the Toscanello in Musica", Journal of Musicology XII/3 (1994), p. 306-344.
 molle & diesis, utrum se de ne-cessitaà gli Ccompositori sono constretti
a segnare, ne gli canti da loro coposti,
dette figure, cioeè b
molle & diesis, utrum se de ne-cessitaà gli Ccompositori sono constretti
a segnare, ne gli canti da loro coposti,
dette figure, cioeè b molle & diesis:, ouve-ramente se il cantore è tenuto a douvere
intedere, & cognosere lo incognito se-creto di tutti gli luoghi douve tal figure
o segni bisognerano. Io che sempre fui,
& sono amatore di coloro, gli quali si
dilettono sapere la uvera intelligenza, &
piuù di quegli che di tal ragione non mancano, con quella breuvitaà che a me
saraà possibile, delibero trattarne alcune cosette, no dispiaceuvole uveramente a
te, desideroso, Bbencheé alcuni altri dicono che el segno del b
molle & diesis:, ouve-ramente se il cantore è tenuto a douvere
intedere, & cognosere lo incognito se-creto di tutti gli luoghi douve tal figure
o segni bisognerano. Io che sempre fui,
& sono amatore di coloro, gli quali si
dilettono sapere la uvera intelligenza, &
piuù di quegli che di tal ragione non mancano, con quella breuvitaà che a me
saraà possibile, delibero trattarne alcune cosette, no dispiaceuvole uveramente a
te, desideroso, Bbencheé alcuni altri dicono che el segno del b molle, &
molle, &  duro,
ouveramente b
duro,
ouveramente b rotondo, & quadro, sono segni appartenenti a' nuouvi scolari,
gli quali no hanno ragione alcuna. Si risponde che tal modo solo si intende
a la mitigatione & temperamento del tritono, al quale, bencheé non sia appa-rente el b
rotondo, & quadro, sono segni appartenenti a' nuouvi scolari,
gli quali no hanno ragione alcuna. Si risponde che tal modo solo si intende
a la mitigatione & temperamento del tritono, al quale, bencheé non sia appa-rente el b molle, appresso ogni dotto & no dotto, per ordinaria & spetial re-gola da gli musichi constituita, saraà inteso sempre non esser tal durezza tol-lerata:, la qual naturalmente nasce da parhypáate mesôon, & trite synemenon,
chiamati F fa ut grauve, &
molle, appresso ogni dotto & no dotto, per ordinaria & spetial re-gola da gli musichi constituita, saraà inteso sempre non esser tal durezza tol-lerata:, la qual naturalmente nasce da parhypáate mesôon, & trite synemenon,
chiamati F fa ut grauve, &  mi acuto, tanto ne lo ascendere, quanto nel di-scendere:; & per questa cagione fu aggiunto il segno del b
mi acuto, tanto ne lo ascendere, quanto nel di-scendere:; & per questa cagione fu aggiunto il segno del b molle, il quale ap-presso gli Greci, secodo la oppinioe di Guidone aAretino, è chiamato menon:,
cioeè una figura accidentale:, & come [#s1529: dice] [#s1539: disse] [#s1562: disse] esso Guidone, quello che è accidentale, no è proprio. Seguita aduque che quella cosa che no è propria, manco
è naturale:, per la quale autoritaà & ragione, cocludo che sempre debbe essere
mollificato, temperato, & annullato, sia come si uvuole, òo ascendenti, o discen-denti, nota per nota, òo per saltim [sic: saltum], non ritornando al fF, ouveramente al
molle, il quale ap-presso gli Greci, secodo la oppinioe di Guidone aAretino, è chiamato menon:,
cioeè una figura accidentale:, & come [#s1529: dice] [#s1539: disse] [#s1562: disse] esso Guidone, quello che è accidentale, no è proprio. Seguita aduque che quella cosa che no è propria, manco
è naturale:, per la quale autoritaà & ragione, cocludo che sempre debbe essere
mollificato, temperato, & annullato, sia come si uvuole, òo ascendenti, o discen-denti, nota per nota, òo per saltim [sic: saltum], non ritornando al fF, ouveramente al  . Cosiì
il simile ne gli luoghi douve non naturali si ritrouverrano:, come è stato dimo-strato nel capitolo uvigesimo del primo libro, de iInstitutione harmonica:, & [s1539: page 63]questo hano osseruvato molti copositori, gli quali, bencheé tal segno da loro sia [s1529: page 110]
stato inteso, no dimeno hano aduvertito a la inaduverteza del cantore:, la quale
facilmente nascerebbe. Onde, per tal cagione hano in luce messo, & in appa-renza dimostrato la presente figura b
. Cosiì
il simile ne gli luoghi douve non naturali si ritrouverrano:, come è stato dimo-strato nel capitolo uvigesimo del primo libro, de iInstitutione harmonica:, & [s1539: page 63]questo hano osseruvato molti copositori, gli quali, bencheé tal segno da loro sia [s1529: page 110]
stato inteso, no dimeno hano aduvertito a la inaduverteza del cantore:, la quale
facilmente nascerebbe. Onde, per tal cagione hano in luce messo, & in appa-renza dimostrato la presente figura b , come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: dice ] Giouvanni mMotone nel motetto.
Nos q uviuvimus, a la terza parte sopra il uverso.
, come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: dice ] Giouvanni mMotone nel motetto.
Nos q uviuvimus, a la terza parte sopra il uverso. Dominus memor fuit nostri.,
Ccosiì anchora nel controbasso al fine de la seconda riga sopra le parole, pla-cuisti rRegina Iesu cChristo:,From Mouton's motet Beata Dei genitrix. See Margaret Bent, "Accidentals, Counterpoint and Notation in Aaron's Aggiunta to the Toscanello in Musica", Journal of Musicology XII/3 (1994), p. 326. & similmente nel motetto chiamato, Benedicta es
celor rRegina, al fine de la terza riga sopra le parole Auve gratia plena. Ha anchora qsto medesimo segnato nel motetto chiamato, Cogregate sunt, al fine
de la secoda riga del canto sopra la parola ignoramus, & nel motetto sopra
detto Nos q uviuvimus, nel cotroalto a mezzo la terza riga de la prima parte,
sopra la parola retrorsu. Iosquino anchora lui questo coferma, come si uvede
nel motetto, Memor esto, nel quale ha segnato il b molle a la prima riga, in
fine nel cotroalto de la prima parte, sopra le parole,
molle a la prima riga, in
fine nel cotroalto de la prima parte, sopra le parole, Haec me consolata est in
humilitate mea, p ascenso solamete. Et nel pPatre omnipotente de la mMessa di
Gaudeamus, a mezzo la seconda riga del cotrobasso, è anchora segnato el b molle p il tritono ascedente, & al fine de la terza è segnato p lo ascedere & discendere. Cosiì al principio de la quarta riga, a la secoda parte del sopra detto
pPatre, è manifesto el b
molle p il tritono ascedente, & al fine de la terza è segnato p lo ascedere & discendere. Cosiì al principio de la quarta riga, a la secoda parte del sopra detto
pPatre, è manifesto el b molle p lo ascedere. Et nel pPleni sunt coeli, similmete si
uvede.; Ccosiì il medesimo nel primo Kyrie, al fine del canto,. Al primo kKyrie an-chora de la mMessa sSup [s1562: page 59]uvoces musicales, a la prima riga del cotroalto, & al principio del Sactus si uvede la figura detta segnata. In lLa sol fa re mi, sopra le parole.
molle p lo ascedere. Et nel pPleni sunt coeli, similmete si
uvede.; Ccosiì il medesimo nel primo Kyrie, al fine del canto,. Al primo kKyrie an-chora de la mMessa sSup [s1562: page 59]uvoces musicales, a la prima riga del cotroalto, & al principio del Sactus si uvede la figura detta segnata. In lLa sol fa re mi, sopra le parole. Et homo factus est, p discedere è segnato al tritono el b molle a la parte
del controalto. Antonio di fFeuvin, nel motetto, Bndictus dDns dDeus meus, sopra
le parole
molle a la parte
del controalto. Antonio di fFeuvin, nel motetto, Bndictus dDns dDeus meus, sopra
le parole deposuisti aduversarios meos, in sei luoghi rispetto al tritono lo ha segnato:, & al principio de la secoda parte in altri dui luoghi,. Lheéritier, al fine
de la seconda riga del motetto, Du coplerentur, sopra le parole dabat eloqui
illis, [#s1529: similemente] [#s1539: similmente] [#s1562: il simile] lo ha dimostrato, & al principio de la quarta riga, si feceritis,
per un salto si coprede,. [#s1529: VUltimamete] [#s1539: VUltimamete] [#s1562: Finalmente] , Carpetras, nel motetto Bonitate fecisti,
ne la prima parte del tenore, per uno altro salto:, sopra le parole ut discant [sic: discam]:, &
gradatim al fine de la secoda si truouva tal figura b segnata:, & per molti altri
copositori moderni & antichi esaminado si cognosce. Ma pcheé io a te ho mostrato che sempre questi tre tuoni, cotinuati l'uno dapoi l'altro, debbono essere
mollificati & tepati, pur che no tochino la qnta chorda, p due ragioni la nostra regola bisogneraà patire. La prima saraà p necessitaà, & comoditaà, & la se-conda p ragioe intesa. Voledo aduque pcedere da F grauve insino a [#s1529:
segnata:, & per molti altri
copositori moderni & antichi esaminado si cognosce. Ma pcheé io a te ho mostrato che sempre questi tre tuoni, cotinuati l'uno dapoi l'altro, debbono essere
mollificati & tepati, pur che no tochino la qnta chorda, p due ragioni la nostra regola bisogneraà patire. La prima saraà p necessitaà, & comoditaà, & la se-conda p ragioe intesa. Voledo aduque pcedere da F grauve insino a [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: mi] acuto,
& subito dapoi per un salto de uno diàa péente discendere, saraà dibisogno che 'l
cantore alhora cometta & pnuntii quella durezza del nominato tritono, p la [s1529: page 111]
comoditaà di quello interuvallo, ouveramente uvoce posta nel luogo di hypáate
mesôon, chiamato E la mi:, pcheé uvolendo satisfare al miglior comodo, è forza
a lui preterire la regola. Onde, osseruvado il precetto, accaderebbe gradissima
incomoditaà, con differenti processi:, come sarebbe dicendo fa nel [#s1529:
] [#s1562: mi] acuto,
& subito dapoi per un salto de uno diàa péente discendere, saraà dibisogno che 'l
cantore alhora cometta & pnuntii quella durezza del nominato tritono, p la [s1529: page 111]
comoditaà di quello interuvallo, ouveramente uvoce posta nel luogo di hypáate
mesôon, chiamato E la mi:, pcheé uvolendo satisfare al miglior comodo, è forza
a lui preterire la regola. Onde, osseruvado il precetto, accaderebbe gradissima
incomoditaà, con differenti processi:, come sarebbe dicendo fa nel [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto:,
con ilqual fa, no mai rettamente discenderaà al uvero suono di quella uvoce mi:,
come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: giaà ] si uvede nel terzo
] [#s1562: ] mi acuto:,
con ilqual fa, no mai rettamente discenderaà al uvero suono di quella uvoce mi:,
come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: giaà ] si uvede nel terzo Agnus dDei [#s1529: di] [#s1539: di] [#s1562: ] Clama ne cesses:, al [#s1529: fine] [#s1539: fine] [#s1562: finimento] del cotrobasso, la
psente figura da Iosquino coposta. 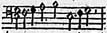 Et similmente tro-uverrai nel soprano de la mMessa di lLa sol fa re mi, so-pra le parole,
Et similmente tro-uverrai nel soprano de la mMessa di lLa sol fa re mi, so-pra le parole, Tu solus altissimus del canto, [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: siì ] come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: eè ] qui. 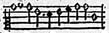 Nel pPatrem omnipotentem, medesimamente an-chora trouverrai un simile processo, sopra le parole,
Nel pPatrem omnipotentem, medesimamente an-chora trouverrai un simile processo, sopra le parole, & sepultus est, [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: siì ] come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: eè ] qui.
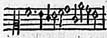 Dico che a forza tu sei astretto eleggere fra' dui mali
il manco incomodo, de gli quali saraà il dire del pro-prio mi, di detto [#s1529: bB
Dico che a forza tu sei astretto eleggere fra' dui mali
il manco incomodo, de gli quali saraà il dire del pro-prio mi, di detto [#s1529: bB  ] [#s1539: bB
] [#s1539: bB  ] [#s1562: b
] [#s1562: b mi] acuto:. Auverti il Trito, et il Diapete impfetto.qQuantunque sia manco
errore a cometere un diàa péente impfetto, che non è a comettere un tritono:,
pur non dimeno si concede in tali discorsi non comodi al cantore. Ritrouvasi
anchora ne le compositioni, uno altro modo di tritono no mitigato, neé tem-perato da la ragione di esso b
mi] acuto:. Auverti il Trito, et il Diapete impfetto.qQuantunque sia manco
errore a cometere un diàa péente impfetto, che non è a comettere un tritono:,
pur non dimeno si concede in tali discorsi non comodi al cantore. Ritrouvasi
anchora ne le compositioni, uno altro modo di tritono no mitigato, neé tem-perato da la ragione di esso b , siì come gli precedenti da la necessitaà concessi,
gli quali solamente discendendo, la sua natura mutano:; & ben che nel pro-nuntiare paiano tritoni non mitigati, per quella risonanza de la naturale
uvoce, òo syllaba mi:, non dimeno sono da la parte inferiore sospesi:, tanto che
restano di quella quatitaà che si ricerca a uno [#s1529: perfetto] [#s1539: perfetto] [#s1562: perfettissimo] diàa tessáaron, come qui.,
, siì come gli precedenti da la necessitaà concessi,
gli quali solamente discendendo, la sua natura mutano:; & ben che nel pro-nuntiare paiano tritoni non mitigati, per quella risonanza de la naturale
uvoce, òo syllaba mi:, non dimeno sono da la parte inferiore sospesi:, tanto che
restano di quella quatitaà che si ricerca a uno [#s1529: perfetto] [#s1539: perfetto] [#s1562: perfettissimo] diàa tessáaron, come qui.,
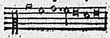 Ppercheé, essendo da la ragione del contrapunto ordi-nato che quella semibreuve ultima sia, p causa di una
sesta che nel tenore appariraà, come richiedono le naturali cadenze, sospesa, & accidentalmente pronuntiata, no è bisogno che la [s1539: page 64]secoda semibreuve sia dal b
Ppercheé, essendo da la ragione del contrapunto ordi-nato che quella semibreuve ultima sia, p causa di una
sesta che nel tenore appariraà, come richiedono le naturali cadenze, sospesa, & accidentalmente pronuntiata, no è bisogno che la [s1539: page 64]secoda semibreuve sia dal b molle soccorsa, neé aiutata:. lLa ragione è che da qlla
uvoce, ouvero semibreuve, posta nel luogo di [#s1529:
molle soccorsa, neé aiutata:. lLa ragione è che da qlla
uvoce, ouvero semibreuve, posta nel luogo di [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi sopracuto, a la sopra detta se-mibreuve ultima, è la distatia del suo diàa tessáaron:. mMa se uvolessimo cantare se-condo che gli altri tritoni appetiscono, ne resulterebbe no quatitaà di diàa tes-sáaron, ma una spetie di uno sol tuono, con duoi semituoni minori, come qui,.
] [#s1562: ] mi sopracuto, a la sopra detta se-mibreuve ultima, è la distatia del suo diàa tessáaron:. mMa se uvolessimo cantare se-condo che gli altri tritoni appetiscono, ne resulterebbe no quatitaà di diàa tes-sáaron, ma una spetie di uno sol tuono, con duoi semituoni minori, come qui,.
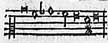 Pertanto dico che in questo modo, no sarebbe la spe-tie del tritono couvertita [#s1529: nel] [#s1539: nel] [#s1562: in lo] diàa tessáaron, neé dittono,
neé manco semidittono, neé altra spetie secondo il ge-nere diatonico da la uniuversale schola dimostrante. Onde, se per auventura tu
ritrouvassi che 'l compositore hauvessi una altra intentione sopra di quella nota
fa ultima, bisognerebbe [#s1529: bene] [#s1539: bene] [#s1562: ] alhora ti mutassi di proposito:, massimamente [s1529: page 112]
uvolendo detto Ccompositore dare una ottauva sopra del suo fine, come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: eè ] qui.
Pertanto dico che in questo modo, no sarebbe la spe-tie del tritono couvertita [#s1529: nel] [#s1539: nel] [#s1562: in lo] diàa tessáaron, neé dittono,
neé manco semidittono, neé altra spetie secondo il ge-nere diatonico da la uniuversale schola dimostrante. Onde, se per auventura tu
ritrouvassi che 'l compositore hauvessi una altra intentione sopra di quella nota
fa ultima, bisognerebbe [#s1529: bene] [#s1539: bene] [#s1562: ] alhora ti mutassi di proposito:, massimamente [s1529: page 112]
uvolendo detto Ccompositore dare una ottauva sopra del suo fine, come [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: eè ] qui.
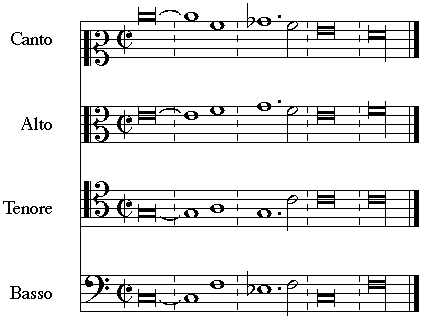 Cosiì il simile di tutte le altre cosonanze pfette intederai:, & osseruvado questa
regola, alhora saraà di necessitaà catare qlla semibreuve putata p la chiauve del b
Cosiì il simile di tutte le altre cosonanze pfette intederai:, & osseruvado questa
regola, alhora saraà di necessitaà catare qlla semibreuve putata p la chiauve del b rotodo:, il qual pcesso si couvertiraà ne la spetie terza del diàa tessáaron:, come co-mada la generale scienza. Ma ritrouvando il sopra detto tritono nel presente
modo,
rotodo:, il qual pcesso si couvertiraà ne la spetie terza del diàa tessáaron:, come co-mada la generale scienza. Ma ritrouvando il sopra detto tritono nel presente
modo, 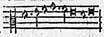 Ddico che senza dubbio per causa del tritono
ascen- denteascendente, cogiunto col discendente, patiraà: & dal
suo or- dineordine rimosso saraà, p cagione del primo moto,
che ascedente si oppone., Ddil che non osseruvado la comune regola, se incorre-rebbe in maggiore errore:, cocludedo aduq che ogni natura di tritono, òo sia
naturale, òo accidetale, òo torni, òo no ritorni al primo suo luogo, sia in che mo-do che a te piace, dico che il cantore ogni uvolta debbe mollificarlo, tempe-rarlo, & annullarlo:, òo sia il segno del b
Ddico che senza dubbio per causa del tritono
ascen- denteascendente, cogiunto col discendente, patiraà: & dal
suo or- dineordine rimosso saraà, p cagione del primo moto,
che ascedente si oppone., Ddil che non osseruvado la comune regola, se incorre-rebbe in maggiore errore:, cocludedo aduq che ogni natura di tritono, òo sia
naturale, òo accidetale, òo torni, òo no ritorni al primo suo luogo, sia in che mo-do che a te piace, dico che il cantore ogni uvolta debbe mollificarlo, tempe-rarlo, & annullarlo:, òo sia il segno del b molle, òo non sia:, eccettuando la forza
de lo incomodo, con le ragioni di sopra mostrate.
molle, òo non sia:, eccettuando la forza
de lo incomodo, con le ragioni di sopra mostrate.
 molle, douve naturalmete altro si uvede, cometterano no poco errore:, [#s1529: pcheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] .
molle, douve naturalmete altro si uvede, cometterano no poco errore:, [#s1529: pcheé] [#s1539: pcheé] [#s1562: perciocheé] . Propositu in mente retentu, nihil operat., Ssiì
come hano dimostrato alcuni degni copositori, ne gli suoi canti:, fra gli quali
uno è Iosquino, douve lui segna la figura b in fine del cotrobasso nel motetto,
Memor esto, p una qnta del tenor che naturalemete è impfetta:, la qual qnta [s1529: page 113]
si coprende sopra le parole
in fine del cotrobasso nel motetto,
Memor esto, p una qnta del tenor che naturalemete è impfetta:, la qual qnta [s1529: page 113]
si coprende sopra le parole spem dedisti. Et nel motetto Praeter rer, ne la proportione sesqualtera a la parte del controbasso, in fine di esso motetto, sopra
le parole, tua puerpia, ha medesimamete segnato in E lami el b molle, douve
procede p uno ordine proprio & naturale:, p il quale, se lui no hauvessi hauvuto
aduvertenza, pochi cantori harebbono inteso il suo intento:, il quale ha dimo-strato p la figura b
molle, douve
procede p uno ordine proprio & naturale:, p il quale, se lui no hauvessi hauvuto
aduvertenza, pochi cantori harebbono inteso il suo intento:, il quale ha dimo-strato p la figura b :, laquale batte sopra una qnta in quel luogo del cotroalto.
Nel motetto achora, Auve nobilissima, nel secodo cotrobasso, al fine de la secoda riga, sopra le parole,
:, laquale batte sopra una qnta in quel luogo del cotroalto.
Nel motetto achora, Auve nobilissima, nel secodo cotrobasso, al fine de la secoda riga, sopra le parole, ab omnibus malis & fraudibus, detto Iosqno in E la
mi, p una qnta ipfetta che farebbe in ql luogo el secodo cotroalto, ha segnato
detto b molle. Anchora nel motetto chiamato, Virgo salutiferi, Iosqno ha dimostrato co la figura b
molle. Anchora nel motetto chiamato, Virgo salutiferi, Iosqno ha dimostrato co la figura b coe in detto E la mi del basso, si [#s1529: pnunzi] [#s1539: pnuzia] [#s1562: pronuncia] fa:, p cagioe
di uno diàa pasôon posto ne la pma pte del cotroalto, in fine de la seconda riga,
sopra le parole,
coe in detto E la mi del basso, si [#s1529: pnunzi] [#s1539: pnuzia] [#s1562: pronuncia] fa:, p cagioe
di uno diàa pasôon posto ne la pma pte del cotroalto, in fine de la seconda riga,
sopra le parole, benigna maris. VUltimamente in una sua messa chiamata, [s1539: page 65]L'o-me armeé sup voces musicales, nel cotrobasso a mezzo del pmo Kzrie [sic: Kyrie], ha se-gnato in [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi grauve, el b
] [#s1562: ] mi grauve, el b molle, p cagione di uno diàa péente che era impfetto
con il tenore:, & piuù a l'ultimo kKyrie dapoi otto tepi, p una duodecima, & qn-tadecia, lequali erano impfette con esso cotrobasso. Et p maggiore autoritaà,
& cofirmatione di qsto, uvedemo anchora la oppenione di molti altri degni
copositori, come Giouvani mMotone, douve si uvede detto b
molle, p cagione di uno diàa péente che era impfetto
con il tenore:, & piuù a l'ultimo kKyrie dapoi otto tepi, p una duodecima, & qn-tadecia, lequali erano impfette con esso cotrobasso. Et p maggiore autoritaà,
& cofirmatione di qsto, uvedemo anchora la oppenione di molti altri degni
copositori, come Giouvani mMotone, douve si uvede detto b molle nel pncipio di
Gaude bBarbara, ne la parte del cotrobasso, de la positioe di [#s1529:
molle nel pncipio di
Gaude bBarbara, ne la parte del cotrobasso, de la positioe di [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto, laqle
uveniuva per quinta impfetta con il [#s1529: suo] [#s1539: ] [#s1562: ] tenore. Cosiì il simile ne la secoda parte,
sopra le parole,
] [#s1562: ] mi acuto, laqle
uveniuva per quinta impfetta con il [#s1529: suo] [#s1539: ] [#s1562: ] tenore. Cosiì il simile ne la secoda parte,
sopra le parole, & uvelata nobili:, & in Nos qui uviuvimus, sopra le parole, bene-dicimus dDno, nel cotrobasso è segnato il b molle in [#s1529:
molle in [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi grauve:, nelqual luo-go era prima qnta impfetta con il tenore. Seguita anchora a questa cofirmatione, Antonio di fFeuvin, ne la seconda pte di Bndictus dDns dDeus meus, nel controbasso si uvede p una breuve putata el b
] [#s1562: ] mi grauve:, nelqual luo-go era prima qnta impfetta con il tenore. Seguita anchora a questa cofirmatione, Antonio di fFeuvin, ne la seconda pte di Bndictus dDns dDeus meus, nel controbasso si uvede p una breuve putata el b molle, p cagione di una qnta, quale
era impfetta, sopra le parole,
molle, p cagione di una qnta, quale
era impfetta, sopra le parole, in uvoce exultationis. Ma p piuù chiarezza ti uvoglio adducere, Richafort, il quale no tato cosidera a le quinte, ottauve, duode-cime & quintedecime, quanto anchora a osseruvare la sesta maggiore [#s1529: nazi] [#s1539: nazi] [#s1562: innanzi] la
ottauva:, come dimostra il suo motetto, Miseremini mei,This is a misattribution. The motet was actually composed by Jean Mouton. See Howard Mayer Brown, "Jean Mouton", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie (London, 1980), vol. 12, p. 659. sopra le parole, quare
me psequimini:, laqle sesta appare nel cotrobasso con il cotroalto, & pcheé era
minore, ha uvoluto segnare la figura b . Constazo fFesta similmete lo dimostra
in dui luoghi nel suo cato, For seulemet, al principio del cotrobasso.; Loghe-uval, sopra le parole.
. Constazo fFesta similmete lo dimostra
in dui luoghi nel suo cato, For seulemet, al principio del cotrobasso.; Loghe-uval, sopra le parole. Diuvinitas custodiat nos,From Longueval's motet Benedicat nos imperialis maiestatis. See Margaret Bent, "Accidentals, Counterpoint and Notation in Aaron's Aggiunta to the Toscanello in Musica", Journal of Musicology XII/3 (1994), p. 332. p una qnta che faceuva il tenore
& basso impfetta. Verdeloth achora mette detta figura nel [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi grauve a la
parte del cotrobasso primo, al motetto Auve uVirgo gratiosa, p cagione di una
qnta del cotroalto, nel principio di esso motetto, qual si mostrauva impfetta,. [s1529: page 114]
Piero de lLarue, in una canzona chiamata. Il est bien, quasi nel principio a la
parte del cotrobasso, sopra una breuve, ha segnato el b
] [#s1562: ] mi grauve a la
parte del cotrobasso primo, al motetto Auve uVirgo gratiosa, p cagione di una
qnta del cotroalto, nel principio di esso motetto, qual si mostrauva impfetta,. [s1529: page 114]
Piero de lLarue, in una canzona chiamata. Il est bien, quasi nel principio a la
parte del cotrobasso, sopra una breuve, ha segnato el b molle in [#s1529:
molle in [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto, p
il diàa péente impfetto, ne la parte del suo cotroalto. Lheérithier, sopra le parole,
] [#s1562: ] mi acuto, p
il diàa péente impfetto, ne la parte del suo cotroalto. Lheérithier, sopra le parole,
oia ossa mea, del suo motetto Miserere mei dDeus., Ssimilemente nel cotrobasso
ha segnato il psente segno b nel [#s1529:
nel [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi grauve, p uno diàa péente impfetto, qual
faceuva il cotroalto. Constanzo fFesta [#s1529: il simile] [#s1539: il simile] [#s1562: medesimamente] ha segnato nel suo motetto. Ecce
dDeus saluvator meus, nel cotrobasso, sopra [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: de ] le parole
] [#s1562: ] mi grauve, p uno diàa péente impfetto, qual
faceuva il cotroalto. Constanzo fFesta [#s1529: il simile] [#s1539: il simile] [#s1562: medesimamente] ha segnato nel suo motetto. Ecce
dDeus saluvator meus, nel cotrobasso, sopra [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: de ] le parole fiducialiter aga:, de gli qli,
per esser moderni, forse no presterrai a loro indubitata fede:. mMa io, che questo
infra di me [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: medesimo] ho [#s1529: cosiderato] [#s1539: cosiderato] [#s1562: fatto consideratione]
, uvoglio p [#s1529: piuù] [#s1539: piuù] [#s1562: maggior] chiarezza, & satisfattione [#s1529: tuo [sic: tua]] [#s1539: tua] [#s1562: tua] , addu-cere alcuni altri al pposito nostro antichi, come Orto, Alessandro aAgricola,
Pierazzon de lLarue, Iapart, Copeère, Isach, & Obreth. Orto aduque, per una
quinta che fa il tenore co il cotroalto in una Auve maria, sopra le parole dDns
tecu, ha uvoluto dimostrare il b molle nel suo tenore. Et sappi che tutti gli so-pradetti canti & copositori, a uno per uno, gli trouverrai nel libro chiamato,
di cCento canti stampati per ordine, & [#s1529: qua] [#s1539: qua] [#s1562: quiuvi] mi sono alquanto affaticato, acioò
che tu piuù [#s1529: facilmete] [#s1539: facilmete] [#s1562: facilissimamente] ti possi ridurre alfine di questa intelligeza. Seguita an-chora Alesssandro aAgricola a la medesima confirmatione, nel canto C'est mal
charche, nel principio del cotrobasso, per una quinta impfetta del suo cotroalto:. dDapoi Pierazzon de lLarue, sopra del canto. Por quoy, ha segnato in A re
el b
molle nel suo tenore. Et sappi che tutti gli so-pradetti canti & copositori, a uno per uno, gli trouverrai nel libro chiamato,
di cCento canti stampati per ordine, & [#s1529: qua] [#s1539: qua] [#s1562: quiuvi] mi sono alquanto affaticato, acioò
che tu piuù [#s1529: facilmete] [#s1539: facilmete] [#s1562: facilissimamente] ti possi ridurre alfine di questa intelligeza. Seguita an-chora Alesssandro aAgricola a la medesima confirmatione, nel canto C'est mal
charche, nel principio del cotrobasso, per una quinta impfetta del suo cotroalto:. dDapoi Pierazzon de lLarue, sopra del canto. Por quoy, ha segnato in A re
el b , p una qnta col tenore impfetta, a mezzo la prima riga del [s1562: page 61]contro basso.
Iapart nel suo canto,I.e. Hélas qu'il est à mon gré. See Cristle Collins Judd, "Reading Aron Reading Petrucci: The Music Examples of the Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni (1525)", Early Music History 14 (1995), p. 147. in principio de la secoda parte nel controbasso, pone la
detta figura b
, p una qnta col tenore impfetta, a mezzo la prima riga del [s1562: page 61]contro basso.
Iapart nel suo canto,I.e. Hélas qu'il est à mon gré. See Cristle Collins Judd, "Reading Aron Reading Petrucci: The Music Examples of the Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni (1525)", Early Music History 14 (1995), p. 147. in principio de la secoda parte nel controbasso, pone la
detta figura b , p una duodecima del canto, & una quinta del suo cotroalto.
Compeère medesimamente nel canto suo. Nous son mens [sic: sommes], a mezzo la secoda
riga del cotrabasso, pone la figura detta, per una quinta impfetta, quale era
col tenore. Isach anchora segna per la medesima cagione, a mezzo la prima
riga del cotrobasso, un b
, p una duodecima del canto, & una quinta del suo cotroalto.
Compeère medesimamente nel canto suo. Nous son mens [sic: sommes], a mezzo la secoda
riga del cotrabasso, pone la figura detta, per una quinta impfetta, quale era
col tenore. Isach anchora segna per la medesima cagione, a mezzo la prima
riga del cotrobasso, un b molle nel cato chiamato, He logeron nous. Obreth
anchora al suo canto chiamato, Tader nahen [sic: Tandernaken], al principio de la secoda riga
del cotrobasso, p il tenore lo segna:, qual sarebbe quinta impfetta:, & in molti
altri luoghi, come esaminando si comprende:, a gli quali porremo fine. Ma siì
come Iddio a noi ha insegnato, & dipinto dinanzi a gli ochi nostri la uvia de
la saluvatione, & anchora de la dannatione, per la quale cognoscemo il bene
dal male, cheé forse senza questa facilmente haressimo potuto incorrere sem-pre al male operare, o al bene:, ouveramente alcuna uvolta al bene & quando al
male., Eessendo adunque la uvia buona & cattiuva, a lui è stato necessario ordi-nare gli suoi precetti, & modi, per gli quali habbiamo a cognoscere il ben uviuvere, da quello che è contrario. Et piuù si uvede in alcuni uviaggi, douve si truo-uvono uvarii segnali, & questo per essergli piuù strade da potere caminare:; onde, [s1529: page 115]
acioò che quegli che non sanno per quel paese andare, possino rettamente pi-gliare il buon camino, douve no essendo segno alcuno, senza dubbio potreb-bono pigliare la catiuva uvia:, alfin de laquale, nascerebbe un fiume, douve [s1539: page 66]biso-gnando passarlo, facilmente si potrebbono arenare, òo per il manco male tor-nare indrieto.; Il Musico è obligato segnare il suo intento.Ppertanto il Mmusico ouvero Ccompositore è ubbligato segnare lo
intento suo:, acioò che il cantore non incorraà in quello che dal detto copositore
no fu mai pensato. Cocludo aduque come ho detto, che tal segno éè cosiì couveniente a gli dotti, come a gli indotti, & dico che il cantore no éè tenuto nel primo moto, cantare le note ne gli luoghi douve tal segno puoò accadere, se tal segno no appare:, pcheé potrebbe errare:, imperoò che puoò stare, & no puoò stare.
Per tanto debbe apparere al tempo opportuno, & quado no bisogna, non si
debbe in luce adducere,.The two preceding sentences are taken almost word for word from a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 23 May
1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 305. Et questo si intende ne gli concenti no prouvisti:, cioeè
no prima cantati, ouveramente cosiderati.This sentence is taken almost word for word from a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 23 May 1524. See Bonnie
J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 305. Hauvendo di sopra a sufficieza di-mostrato circa il segno del b
molle nel cato chiamato, He logeron nous. Obreth
anchora al suo canto chiamato, Tader nahen [sic: Tandernaken], al principio de la secoda riga
del cotrobasso, p il tenore lo segna:, qual sarebbe quinta impfetta:, & in molti
altri luoghi, come esaminando si comprende:, a gli quali porremo fine. Ma siì
come Iddio a noi ha insegnato, & dipinto dinanzi a gli ochi nostri la uvia de
la saluvatione, & anchora de la dannatione, per la quale cognoscemo il bene
dal male, cheé forse senza questa facilmente haressimo potuto incorrere sem-pre al male operare, o al bene:, ouveramente alcuna uvolta al bene & quando al
male., Eessendo adunque la uvia buona & cattiuva, a lui è stato necessario ordi-nare gli suoi precetti, & modi, per gli quali habbiamo a cognoscere il ben uviuvere, da quello che è contrario. Et piuù si uvede in alcuni uviaggi, douve si truo-uvono uvarii segnali, & questo per essergli piuù strade da potere caminare:; onde, [s1529: page 115]
acioò che quegli che non sanno per quel paese andare, possino rettamente pi-gliare il buon camino, douve no essendo segno alcuno, senza dubbio potreb-bono pigliare la catiuva uvia:, alfin de laquale, nascerebbe un fiume, douve [s1539: page 66]biso-gnando passarlo, facilmente si potrebbono arenare, òo per il manco male tor-nare indrieto.; Il Musico è obligato segnare il suo intento.Ppertanto il Mmusico ouvero Ccompositore è ubbligato segnare lo
intento suo:, acioò che il cantore non incorraà in quello che dal detto copositore
no fu mai pensato. Cocludo aduque come ho detto, che tal segno éè cosiì couveniente a gli dotti, come a gli indotti, & dico che il cantore no éè tenuto nel primo moto, cantare le note ne gli luoghi douve tal segno puoò accadere, se tal segno no appare:, pcheé potrebbe errare:, imperoò che puoò stare, & no puoò stare.
Per tanto debbe apparere al tempo opportuno, & quado no bisogna, non si
debbe in luce adducere,.The two preceding sentences are taken almost word for word from a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 23 May
1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 305. Et questo si intende ne gli concenti no prouvisti:, cioeè
no prima cantati, ouveramente cosiderati.This sentence is taken almost word for word from a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 23 May 1524. See Bonnie
J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 305. Hauvendo di sopra a sufficieza di-mostrato circa il segno del b molle, & uvenendo al pposito retrattare qualche
particula de la figura apparente
molle, & uvenendo al pposito retrattare qualche
particula de la figura apparente  , dato che in nanzi al uvigesimo capitolo
del secondo libro ne sia alquanto parlato, no dimeno piuù diffusamente ne la
presente agiuta, a coloro che piuù di questo si delettono, si esponeraà. Hauvedo
io ricercato breuvitaà, facilitaà nel sopra detto Toscanello nostro, mi sono piuù
tosto in tal capitolo acomodato secodo il uvulgo, che altrimenti. Ma hora, percheé piuù si ricerca la uvera intelligeza, ti aduvertisco, quado da me éè stato detto
queste parole, nel sopra detto capitolo.:
, dato che in nanzi al uvigesimo capitolo
del secondo libro ne sia alquanto parlato, no dimeno piuù diffusamente ne la
presente agiuta, a coloro che piuù di questo si delettono, si esponeraà. Hauvedo
io ricercato breuvitaà, facilitaà nel sopra detto Toscanello nostro, mi sono piuù
tosto in tal capitolo acomodato secodo il uvulgo, che altrimenti. Ma hora, percheé piuù si ricerca la uvera intelligeza, ti aduvertisco, quado da me éè stato detto
queste parole, nel sopra detto capitolo.: Peroò éè stato necessario stabilire una figura o segno, p ilquale si habbia a dimostrare al cantore qual sia la nota au-gumentata o diminuta, ilqual segno p generale uso éè chiamato diesis,no in-tendere perocheé nessuna nota cresca di uvalore, neé diminuisca p forza di quel segno, ma solamete sano modo intendi, che tal segno dimostra lo augumeto & diminutione del spatio ouvero interuvallo, pcheé questo segno
 no acresce,
[#s1529: neé] [#s1539: &] [#s1562: &] disminuisce la nota oltra al suo uvalore:, ma bene acresce, & disminuisce il
spatio & interuvallo tra nota & nota apparente in quanto a la imaginatione
& operatioe, ma no in quanto a la sua apparente locatioe.The end of this sentence and the beginning of the next one are copied word for word from a letter written by Giovanni Spataro
to Aaron, dated 23 May 1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 301. Et questo aduviene
pcheé il spatio reale, & naturale, cosiderato mediante la apparenza del segno
preditto, resta pmutato, come di tuono in semituono: & di semituono in tuono:, & cosiì [#s1529: de'] [#s1539: da'] [#s1562: da'] altri simili. Ma la nota ne la sua teporale quantitaà cantata non
mai mediante tal segno, cresce, neé discresce intra il suono grauve & acuto:, ilqle
segno psente
no acresce,
[#s1529: neé] [#s1539: &] [#s1562: &] disminuisce la nota oltra al suo uvalore:, ma bene acresce, & disminuisce il
spatio & interuvallo tra nota & nota apparente in quanto a la imaginatione
& operatioe, ma no in quanto a la sua apparente locatioe.The end of this sentence and the beginning of the next one are copied word for word from a letter written by Giovanni Spataro
to Aaron, dated 23 May 1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 301. Et questo aduviene
pcheé il spatio reale, & naturale, cosiderato mediante la apparenza del segno
preditto, resta pmutato, come di tuono in semituono: & di semituono in tuono:, & cosiì [#s1529: de'] [#s1539: da'] [#s1562: da'] altri simili. Ma la nota ne la sua teporale quantitaà cantata non
mai mediante tal segno, cresce, neé discresce intra il suono grauve & acuto:, ilqle
segno psente  The ensuing argument and music example given by Aaron are taken almost word for word from a letter sent to him by Giovanni
Spataro, dated 23 May 1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 301-302. éè stato chiamato da Bartholomeo rRami, musico dignissimo,
uveramente da ogni dotto uvenerato, segno di b quadro:, & da frate Giouvanni
oOttobi éè stato chiamato segno di b quadro iacente:; & questo,
The ensuing argument and music example given by Aaron are taken almost word for word from a letter sent to him by Giovanni
Spataro, dated 23 May 1524. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 301-302. éè stato chiamato da Bartholomeo rRami, musico dignissimo,
uveramente da ogni dotto uvenerato, segno di b quadro:, & da frate Giouvanni
oOttobi éè stato chiamato segno di b quadro iacente:; & questo,  , da lui éè stato
chiamato segno di b quadro retto,
, da lui éè stato
chiamato segno di b quadro retto, b quadro iacente
b quadro iacente  b quadro retto gli qli nomi son piuù rettamete cosiderati., [s1529: page 116]
che no è chiamare tal segno
b quadro retto gli qli nomi son piuù rettamete cosiderati., [s1529: page 116]
che no è chiamare tal segno  diesis:, percheé il nome è piuù cosequente al suo
effetto:, come procedendo da méese a trite synemenon, cade interuvallo di semituono:, & dapoi ascendendo da la preditta chorda méese ad paraméese, al qual
pratico si atribuisce il b
diesis:, percheé il nome è piuù cosequente al suo
effetto:, come procedendo da méese a trite synemenon, cade interuvallo di semituono:, & dapoi ascendendo da la preditta chorda méese ad paraméese, al qual
pratico si atribuisce il b quadrato, el si procede per interuvallo di tuono:, el
quale paraméese, resta distante da trite synemenon, per semituono maggiore
intenso. Cosiì accaderaà di questo segno
quadrato, el si procede per interuvallo di tuono:, el
quale paraméese, resta distante da trite synemenon, per semituono maggiore
intenso. Cosiì accaderaà di questo segno  , che essendo al canto ascendente
dal spatio ne la riga, & de la riga al spatio, come qui
, che essendo al canto ascendente
dal spatio ne la riga, & de la riga al spatio, come qui 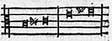 & altri simili, sempre conuvertiraà il spatio naturale
del semituono nel tuono. Per tanto, operado questo
segno come fa el b quadrato retto preditto, dico che ditto segno saraà piuù ra-gioneuvolmente chiamato b quadro, che diesis:, [#s1529: pcheé dicendo diesis, ] [#s1539: ] [#s1562: ] lo effetto
& il nome no hanno insieme conrispondenza:, ma siì bene essendo chiamato
b
& altri simili, sempre conuvertiraà il spatio naturale
del semituono nel tuono. Per tanto, operado questo
segno come fa el b quadrato retto preditto, dico che ditto segno saraà piuù ra-gioneuvolmente chiamato b quadro, che diesis:, [#s1529: pcheé dicendo diesis, ] [#s1539: ] [#s1562: ] lo effetto
& il nome no hanno insieme conrispondenza:, ma siì bene essendo chiamato
b quadro.
quadro.
§ Quale obbligo, òo necessitaà sia al compositore attribuita:, per ri-muouvere ogni pericolo & causa del cantore ne la quale potessi incorrere:
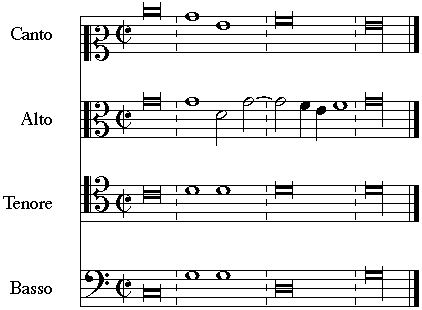 Nne la quale lo intento del compositore no ha considerato che quella ultima
bree [sic: longa], ouveramete interuvallo ultimo, habbia a essere sospeso, ouvero disminui-to:, percheé no appare segno dimostrante alcuna sospensione:, come è copreso
per la figura:; ma uvolendo sospendere detto interuvallo ultimo, sarebbe ottauva
imperfetta col basso, & no unisono col controalto. Ma quando saraà propo-sito a tal sospenso, lo segneraà, come seguitando si uvede. [s1539: page 67]
Nne la quale lo intento del compositore no ha considerato che quella ultima
bree [sic: longa], ouveramete interuvallo ultimo, habbia a essere sospeso, ouvero disminui-to:, percheé no appare segno dimostrante alcuna sospensione:, come è copreso
per la figura:; ma uvolendo sospendere detto interuvallo ultimo, sarebbe ottauva
imperfetta col basso, & no unisono col controalto. Ma quando saraà propo-sito a tal sospenso, lo segneraà, come seguitando si uvede. [s1539: page 67]
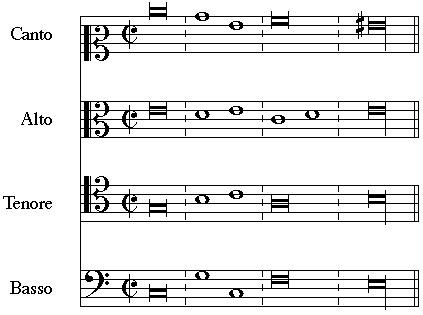 [s1529: page 117]
Et percheé lo intento suo è stato di rimuouvere la prima harmonia, bencheé sia
simile processo con il primo:, a lui è stato dibisogno con il segno presente ad-uvertire el cantore de la seconda sua consideratione:, acioò no pensassi al primo
modo da lui dimostrato:, come acaderaà se tal discorso trouverrai.
[s1529: page 117]
Et percheé lo intento suo è stato di rimuouvere la prima harmonia, bencheé sia
simile processo con il primo:, a lui è stato dibisogno con il segno presente ad-uvertire el cantore de la seconda sua consideratione:, acioò no pensassi al primo
modo da lui dimostrato:, come acaderaà se tal discorso trouverrai.
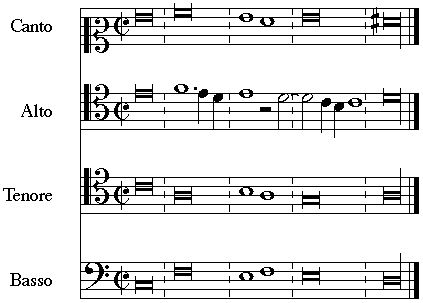
 molle, massimamente ne la parte grauve:. dDico che tal licenza è denegata & no cocessa, neé manco in cosideratione è al uvero musico.
Onde, uvolendo ristringersi al suo concetto & male pensamento, no altrimenti
credono essere scusati sol p il procedere molte uvolte, a la chorda del [#s1529:
molle, massimamente ne la parte grauve:. dDico che tal licenza è denegata & no cocessa, neé manco in cosideratione è al uvero musico.
Onde, uvolendo ristringersi al suo concetto & male pensamento, no altrimenti
credono essere scusati sol p il procedere molte uvolte, a la chorda del [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi grauve:, il quale rispode un diàa péente co il tenore impfetto:, laqual cosideratione è
frustratoria & uvana:, pcheé ne risulta & nasce dui incouvenienti,. iIl primo è, che
ciascheduna spetie uvien permutata & uvariata dal suo naturale:, come saraà da
Gama ut, a D sol re:, & quello che dittono si mostra, in terza minore o semi-dittono si truouva:, come discorredo dal D sol re al [#s1529:
] [#s1562: ] mi grauve:, il quale rispode un diàa péente co il tenore impfetto:, laqual cosideratione è
frustratoria & uvana:, pcheé ne risulta & nasce dui incouvenienti,. iIl primo è, che
ciascheduna spetie uvien permutata & uvariata dal suo naturale:, come saraà da
Gama ut, a D sol re:, & quello che dittono si mostra, in terza minore o semi-dittono si truouva:, come discorredo dal D sol re al [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi si uvede:, & similmete
da [#s1529:
] [#s1562: ] mi si uvede:, & similmete
da [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi al Gama ut:, le quali risonerano re-la, la-fa, & fa-re: (& prima erono,
ut-sol, sol-mi, & mi-ut:), spetie cotrarie a tutte le altre occorrenti nel soprano, tenore, & cotroalto:; & qsto è [#s1529: usitato] [#s1539: usitato] [#s1562: uvisitato] piuù da loro ne gli canti del settimo ouvero
ottauvo tuono. Per tanto, il secondo incouveniente saraà, che le ottauve & quinte
decime no corispoderano insieme giuste:, siì che a te è dibisogno prima consi-[s1529: page 118]derare di conseguire lo effetto con i processi simili & spetie:, & pur uvolendo
passare con la intentione tua per il detto [#s1529:
] [#s1562: ] mi al Gama ut:, le quali risonerano re-la, la-fa, & fa-re: (& prima erono,
ut-sol, sol-mi, & mi-ut:), spetie cotrarie a tutte le altre occorrenti nel soprano, tenore, & cotroalto:; & qsto è [#s1529: usitato] [#s1539: usitato] [#s1562: uvisitato] piuù da loro ne gli canti del settimo ouvero
ottauvo tuono. Per tanto, il secondo incouveniente saraà, che le ottauve & quinte
decime no corispoderano insieme giuste:, siì che a te è dibisogno prima consi-[s1529: page 118]derare di conseguire lo effetto con i processi simili & spetie:, & pur uvolendo
passare con la intentione tua per il detto [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, segna anchora a tutte le altri
parti la figura b
] [#s1562: ] mi, segna anchora a tutte le altri
parti la figura b , & senza errore alcuno, ogni processo & consonanze, si tro-uveranno concorde & sonore insieme:, douve primieramnete [sic: primieramente] alcuni discorda-uvano.
, & senza errore alcuno, ogni processo & consonanze, si tro-uveranno concorde & sonore insieme:, douve primieramnete [sic: primieramente] alcuni discorda-uvano.
DE LE DOMENICHE SEMIDVUPPLICATE.
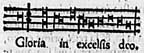
Be-nedicimus te, ne la chorda parhypáate hypatôon, chiamata C fa ut:, laqual ter-minatione, non è per cagione di alcun seculorum, neé cofinalitaà di diàa péenti,
ma per la forza del principio a lui in quella chorda concesso, come dimo-stra lo Iintroito del sabbato primo de lo aduvento., Veni & ostende nobis dDo-mine, & lo Iintroito da poi la quarta domenica di quadragesima, detto Si-tientes uvenite ad aquas. Da poi il uverso Glorificamus te, ha terminato ne la
positione hypáate mesôon, chiamato E la mi:. qQuesto uviene medesimamente per
cagione del principio:, come dimostra lo Ooffertorio del primo giorno di
quadragesima, Exaltabo te dDomine, con la irregulare terminatione:, & l'anti-phona. Domine dDeus rex omnipotens da poi la quarta domenica del mese
di settenbre., Dde la qual cosa discorrendo, ogni altro uverso regolarmente al
suo natural fine, si cognosce. Ma tal principio di E la mi, pochissime uvolte
in questo tuono si ritruouva.
DEL SANCTVUS, DOMINICALE.
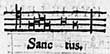
Sanctus termina ne la chorda parhypáate hypatôon, detto C fa ut:, laqual ter-minatione nasce da la libertaà del suo principio:, & tanto piuù per essere detto
luogo finalitaà del suo diàa tessáaron:, come lo Iintroito. Quasi modo geniti &c.,
il quale è ne la ottauva de la Pasqua, & lo Ooffertorio ultimo nanzi la sesta
de la Ascensione, detto Confitebor dDomino nimis in ore meo. Questi per il
principio aquistono la irregulare terminatione. Seguitando al Sanctus dDo-minus, dDeus sabbaoth, lui finisce regularmente, & alcuni altri ne la positione
& chorda, lichanòos mesôon, detto G sol re ut:, la qual si uvede nel presente con-cento., Tradiderut me in manus impiorum, primo Rrisponso del terzo not-turno de la sesta feria, ne la settimana santa:, per il che pochissimi di questi in
tal luogo se ne truouva:; & tutto il resto al suo buon fine si riduce.
DE GLI AGNVUS DEI, DOMENICALI.
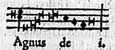
DEL GIORNO, DE LA VERGINE MARIA.
DEL KYRIE LEISON.
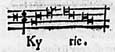
Christe leyson, ha la sua fine ne la positione méese, chiamato aA la
mi re:, & detto fine nasce dal seculorum, da la confinalitaà, da la irregularitaà,
& similmente dal principio. Dal seculor? cCome ne le differenze sue si com-prehende. Da la cofinalitaà? pPcheé da D sol re comincia il diàa péente, & il con-fine arriuva al detto luogo. Da la irregularitaà? pPercheé il primo, & secondo in
ditta chorda nasce. Et dal principio? cCome gli presenti introiti., Sapientiam
sanctorum narrent populi, & Salus autem iustor, nel comune di piuù mar-tiri si truouvano.
DE LA GLORIA IN EXCELSIS DEO.
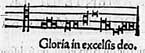
DEL SANCTUS.
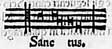
sSanctus, è solamente una equal terminatione:, ne la
chorda trite diezeugmenôon, chiamata cC sol fa ut:, & pcheé esso canto è quinto
tuono, detta terminatione è in quel luogo terminata:, per il seculorum, per
la cofinalitaà, & per il principio. Per il seculorum? pPercheé il quinto tuono ha
due differenze, de lequali una termina in aA la mi re, l'altra in ditta positione
cC sol fa ut. Per la cofinalitaà? pPercheé il principio del diàa péente è in F fa ut. Per
il principio? cCome appare ne gli presenti canti.: Ecce dDeus adiuuvat me, Iin-troito de la domenica nona dapoi la pPéentecoste:, & Deus in loco sancto suo,
de la domenica undecima:, & il Ggraduale, Anima nostra sicut passer, ne la
festa comune di piuù martiri. Onde, per non essere differenza ne gli Agnus
dDei, ma equale & regulare terminatione, non mi estenderoò in dichiara-tione alcuna.
DEL GIORNO DE GLI APPOSTOLI, OVERAMENTE DE LE FESTE DOPPIE MINORI.
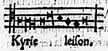
Kyrie si cognosce:, concioò sia
che il terzo, & quarto [s1539: page 70]kKyrie, non conrispondono regularmente al suo pro-prio fine:, ma douve la irregularitaà, & cofinalitaà si truouva:, & per la differenza
del seculorum amen. Queste ragioni nel passato chiare sono. Resta sola-mete dimostrare per il fine gli seguenti canti.: Scio cui credidi & certus sum,
Iintroito de la festa di sSan Paulo appostolo, & Meditatio cordis mei, ne la
sesta feria da poi la quarta domenica in quadragesima.
DE LA GLORIA IN EXCELSIS DEO.
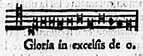
DE LE FESTE SEMPLICE SOLEMNE, ET INFRA TVUTTE LE OTTAVE.
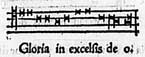
Laudamus te, Benedicimus te, & Gra-tias agimus tibi., Laudamus te, ha il suo fine ne la chorda méese, detto aA la mi
re.; Benedicimus te, ne la chorda paraméese, chiamato [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto,; &
] [#s1562: ] mi acuto,; & Gratias
agimus tibi, in lichanòos mesôon, detto G sol re ut. La terminatione adunque
di b fa [#s1529:
fa [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi, non è per causa di principio alcuno:, percheé tal tuono non ha
principio in detto luogo:, ma per cagione de la cofinalitaà, laqual procede da
E la mi, a quella chorda di b
] [#s1562: ] mi, non è per causa di principio alcuno:, percheé tal tuono non ha
principio in detto luogo:, ma per cagione de la cofinalitaà, laqual procede da
E la mi, a quella chorda di b fa [#s1529:
fa [#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi. La fine antecedente di aA la mi re, è per
il seculorum & non per il principio. Ma quella di G sol re ut, non tanto per
il seculorum, quanto anchora per gli principii suoi:, come gli presenti canti.:
Timete dDominum, omnes sancti eius, Iintroito del comune, ne le feste di piuù
martiri:, & Loquetur dDominus pacem.
] [#s1562: ] mi. La fine antecedente di aA la mi re, è per
il seculorum & non per il principio. Ma quella di G sol re ut, non tanto per
il seculorum, quanto anchora per gli principii suoi:, come gli presenti canti.:
Timete dDominum, omnes sancti eius, Iintroito del comune, ne le feste di piuù
martiri:, & Loquetur dDominus pacem.
DEL SANCTVUS.
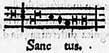
Sanctus constituito & terminato, ne la posi-tione méese, concesso è stato ad esso tuono ditta terminatione:, no per il prin-cipio, ma per la confinalitaà:, ne la qual chorda termina irregularmente il se-condo & primo tuono:, & per la differenza del seculorum amen. Onde per
essere gli Agnus dDei regularmente terminati, lasceremo questaa la comune intelligenza.
DE LE FESTE MAGGIORE DOPPIE.
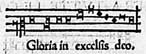
Domine dDeus rex coelestis, ha terminato in paraméese, chiamato
[#s1529:  ] [#s1539:
] [#s1539:  ] [#s1562: ] mi acuto.;
] [#s1562: ] mi acuto.; Domine dDeus aAgnus dDei, in trite diezeugmenôon, detto cC sol fa ut:;
& Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostra, in paranete die-zeugmenôon, chiamato dD la sol re:. pPer il primo Domine dDeus rex coelestis, la
terminatione è per la licenza del seculorum, qual termina in quel luogo, &
per il principio concesso al sopra ditto tuono:, come dimostra l'antiphona al
Magnificat infra l'ottauva de la Resurrettione, chiamata Tulerut dDominum
meum, & Exortum est in tenebris, al uvespro de la Natiuvitaà. La terminatione
del Domine dDeus aAgnus dDei, non è per altro, se non per il principio:, ilquale è
nel secodo Rrisponso, di sSanto Giouvani, appostolo & euvangelista., Hic est di-scipulus, & Omnes de sabba uvenient, nel secondo notturno, ne la uvigilia de
la Ephyfania. Ma la fine del Qui tollis peccata mundi, per tre cause finisce [s1539: page 71]
in dD la sol re.: Lla prima per la differenza del seculor., Lla seconda per la cofi-nalitaà. Eet la terza per il fine, come gli presente canti.: Veni dDomine & noli tardare, primo Rrisponso del terzo notturno de la terza domenica del Aduveto.,
& Ecce sacerdos magnus, con molti altri simili.
Il Sanctus & Agnus dDei [#s1529: appropriati] [#s1539: appropriati] [#s1562: propriati] a la di sopra scritta Mmessa, per non
essere in loro alcuna incognita differenza, sia dal comune ordine il resto
giudicato.
DE LE FESTE MAGGIORE, MEZZE DOPPIE.
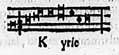
Kyrie ha il suo fine in paranéete die-zeugmenon, chiamato dD la sol re:, laqual terminatioe, come per il passato fu
detto, è per [#s1529: la] [#s1539: ] [#s1562: ] confinalitaà, principio, & seculor:. cChe sia per il principio, facil-mente piuù uvolte il trouverrai:, per ilche non metteremo altro essempio.
DE LA GLORIA IN EXCELSIS DEO.
Laudamus te, Benedicimus te, & Adoramus te, per l'ordine da noi di
sopra detto, senza altra nostra dichiaratione a te la rimettemo:, con tutto il
resto, ilqual irregularmente trouverrai.
DEL PATREM OMNIPOTENTEM CHIAMATO CARDINALESCO.
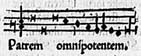
DEL TE DEVUM LAVUDAMVUS.