Title: Lucidario in musica
Author: Pietro Aaron
Publication: Girolamo Scotto (Venezia, 1545)
Principal editor: Anne-Emmanuelle Ceulemans
Funder: Université catholique de Louvain, Unité de musicologie F.N.R.S.
Edition: 2002
Department of Information and Computing Sciences Utrecht University P.O. Box 80.089 3508 TB Utrecht NetherlandsVIRGA ARON REFLORVUIT.

Viuvat Aron, saeclo sua uvirga refloreat omni,
Per quem oscura olim Mmusica, nunc rutilat.
Ergo pulchra ferat tantorum dona laborum.
Praemia quis tanto digna neget capiti?
Vos uviuvum uvates statua. & decorate corona,
Post obitum sydus Dii facite esse nouvum.
1545. Die. 30. Aaugusti in Rogatis.
La Ggratia, & Ppriuvilegio della Illustrissima Signoria di Vinegia.
TAVOLA DI TVUTTE LE COSE, CHE SI contengono nell'opera.
Intorno le chiauvi di natura, & di b , quadro,. , quadro,.
|
Ooppenione. 1 |
| Dell'ottauva corda, chiamata, G,. | oppenione 2 |
| Circa il procedere delle mutationi,. | oppenione 3 |
| Come il tropo si conosce p altra maniera, che p arsin, e tesinthesin. | op. 4 |
| Delle terminationi regolate, & non regolate,. | oppenione. 5 |
| Di alcuni Ttuoni da Marchetto non bene intesi,. | oppenione. 6 |
| Della medesima intelligenza,. | oppenione. 7 |
| Come le note sopra della sillaba la, si possano chiamare,. | opp. 8 |
| Di ut, -re, &, re, -mi, ascendenti. | oppenione. 9 |
| Sopra di alcuni processi ecclesiastici,. | oppenione. 10 |
| Nel proemio del secondo libro, cui uveramente si conuvenga questo nome di Mmusico. | |
| Delle due Ppause di tre tempi segnate,. | oppenione. 1 |
| Intorno la figura Ddiesi,. | oppenione. 2 |
Della conformitaà del Ddiesi, & del b , molle,. , molle,.
|
oppenione. 3 |
| Circa la sillaba sopra delle [sic: della] uvoce la,. | oppenione. 4 |
| Del Ppunto, & quantitaà di esso,. | oppenione. 5 |
| Del circolo, & semicircolo col punto,. | oppenione. 6 |
| Del mi, contro il fa nella perfetta Ssimphonia,. | oppenione. 7 |
| Delle due consonanze perfette nel contrapunto l'una dopo l'altra poste,. | oppenione. 8 |
| Come l'una di due note continouvate in spatio, o in riga da alcu-ni eè sospesa. | oppenione. 9 |
| Di alcuni progressi da molti falsamente chiamati fuga,. | oppe. 10 |
| Come i tre generi debbano incominciare dal tuono, & non dal semituono,. | oppenione. 11 |
| Del semicicolo [sic: semicircolo] incontrario posto,. | oppenione. 12 |
| Se il semicircolo tagliato, & non tagliato possono producere la doppia proportione,. | Ooppenione. 13 |
| Del tritono, ouvero tetracordo maggiore ne' coceti usato,. | op. 14 |
| Che il coporre della Mmusica, non eè altro che Ppratica,. | oppe. 15 |
| Del tempo Mmusico detto naturale, & accidentale. | Ccap. 1 |
| Risposta allo eccellente dDon Franchino intorno alcune sue oppenioni. | Ccap. 2 |
| Oppositione fatta dallo eccell. mMesser Giouvanni sSpadaro. | Ccap. 3 |
| Dichiaratione di alcuni segreti nel contrapunto. | Ccap. 4 |
| Come il punto non puoò fare imperfetta una nota simile. | Ccap. 5 |
| Come il catore dee osseruvare la misura ne' cocenti, & segni. | ca. 6 |
| Delle parti, & imperfettione delle note. | cap. 7 |
| Altre considerationi intorno la imperfettione. | cap. 8 |
| Qual sia stato il prio e 'l sedo segno da gli antichi dimostrato. | c. 9 |
| De' qttro modi da gli antichi, & moderni musici ordinati. | cap. 10 |
| Del tacito uvalore della Mmassima. | cap. 11 |
| Oppenione di alcuni intorno la breuve pfetta, & imperfetta. | c. 12 |
| Percheé la massima non ha pausa. | cap. 13 |
| Come il Mmusico non ha riguardo di fare imperfetta piuù l'una che l'altra di molte note in un corpo unite. | cap. 14 |
| Oppenione, & Rresolutione, circa i Mmandriali a Nnote nere. | ca. 15 |
| Oppenione, & resolutione, intorno le compositioni. | cap. 16 |
| Della Mmusica dorica, Llidia, & frigia. | cap. 1 |
| Per che cagione sia stato trouvata l'alteratione. | cap. 2 |
| Dubitationi necessarie intorno l'alteratione. | cap. 3 |
| Come si puoò formare ciascuna specie semplice, & composta nelle due congionte. | cap. 4 |
Delle sei sillabe considerate da, aA, a, fF, & da, b , a, [sic: G], & da, dD, a, bB, & da, eE, a, cC, & da, fF, a, dD. , a, [sic: G], & da, dD, a, bB, & da, eE, a, cC, & da, fF, a, dD.
|
cap. 5 |
| Del modo di procedere colle sei sillabe accidentali nello stor-mento detto Oorgano. | cap. 6 |
Domada del, b , molle, i, cC, & in, fF, cosiderato ouvero imaginato. , molle, i, cC, & in, fF, cosiderato ouvero imaginato.
|
c. 7 |
Del, b , in, fF, collocato. , in, fF, collocato.
|
cap. 8 |
| Del segno del Ddiesi in, bB, & in, eE, immaginato. | cap. 9 |
| Del Ddiesi in, eE, considerato. | cap. 10 |
Della congionta del, b , molle, & del, b , molle, & del, b , duro. , duro.
|
cap. 11 |
| Come in ciascun luogo della mano si possono trouvare. 30 mutationi. | cap. 12 |
ALL'ILLVUSTRE SIGNOR CONTE FORTVU-NATO MARTINENGO, PIETRO ARON, MVUSICO FIORENTINO.For a discussion of this dedication, see Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 87.
PIETRO ARON A' LETTORI
PIETRO ARON ALLI SPIRITI AR-MONICI, ET GENTILI.
PRECETTI DEL CANTO PIANO DA MOLTI NON BENE INTESI.
LIBRO PRIMO.
OPPENIONE. I.
 & la seconda seguente
& la seconda seguente  di C, sol, fa, ut, per lo qual ordine preteriscono il uvero modo, la qual cosa dannoi
non solamente non è conceduta, ma da
ogni mediocre Mmusico è riprouvata.
di C, sol, fa, ut, per lo qual ordine preteriscono il uvero modo, la qual cosa dannoi
non solamente non è conceduta, ma da
ogni mediocre Mmusico è riprouvata.
OPPOSITIONE.
 , quadro,. Et
bencheé nel detto capitolo da Franchino siano chiamate chiauvi delle corde, non è pe-roò da intendere che esse siano chiauvi delle propie corde, ma segni, che dimostrano le
positioni di F, & di C. page 10
, quadro,. Et
bencheé nel detto capitolo da Franchino siano chiamate chiauvi delle corde, non è pe-roò da intendere che esse siano chiauvi delle propie corde, ma segni, che dimostrano le
positioni di F, & di C. page 10RESOLVUTIONE.
OPPENIONE. II.
 quadro acuto, la qual cosa chiaramente in
contrario essere si uvede, percheé ouve la positione fosse detta grauve, per conseguente
anchora seguirebbe, chella propietaà fosse detta grauve, & non acuta, Iil che non puoò
star a modo alcuno, percheé due contrari in un istesso tempo non possono hauver luo-go nel medesimo subietto,; Aalla qual cosa rispondono, che tutto che la positione di G
sia grauve, che peroò la proprietaà è acuta, posto che essa sia nel luogo del detto G, percheé essa propietà non è altro, che un ricoglimento di sei sillabe, cioè di ut, -re, -mi, -fa, -
sol, -la, della qual aggregatione, o raccoglimento, la prima sillaba ut, è capo, & fondamento di tutte le seguenti allei, & per tanto, per essere piuù note nelle parti acute,
che nelle grauvi, dicono essa essere acuta, & non grauve.
quadro acuto, la qual cosa chiaramente in
contrario essere si uvede, percheé ouve la positione fosse detta grauve, per conseguente
anchora seguirebbe, chella propietaà fosse detta grauve, & non acuta, Iil che non puoò
star a modo alcuno, percheé due contrari in un istesso tempo non possono hauver luo-go nel medesimo subietto,; Aalla qual cosa rispondono, che tutto che la positione di G
sia grauve, che peroò la proprietaà è acuta, posto che essa sia nel luogo del detto G, percheé essa propietà non è altro, che un ricoglimento di sei sillabe, cioè di ut, -re, -mi, -fa, -
sol, -la, della qual aggregatione, o raccoglimento, la prima sillaba ut, è capo, & fondamento di tutte le seguenti allei, & per tanto, per essere piuù note nelle parti acute,
che nelle grauvi, dicono essa essere acuta, & non grauve.
OPPOSITIONE.
 quadro, al grauve, et una alle parti acute,. lLaà onde si uvede non po-ter essere quello, che dalloro è dimostrato, non ostante che maggior quantitaà di no-te siano nelle parti acute, per lo qual fondamento essa non saraà detta acuta, ma gra-uve, percheé ogni deriuvatiuvo tiene della natura del suo primitiuvo, o positiuvo.
quadro, al grauve, et una alle parti acute,. lLaà onde si uvede non po-ter essere quello, che dalloro è dimostrato, non ostante che maggior quantitaà di no-te siano nelle parti acute, per lo qual fondamento essa non saraà detta acuta, ma gra-uve, percheé ogni deriuvatiuvo tiene della natura del suo primitiuvo, o positiuvo.
RESOLVUTIONE.
 quadro acuta, & non grauve, per le ragioni disopra dimostra-te, ne risulteraà grande confusione, per lo qual modo saraà di necessitaà rimouvere la
proprietaà del b
quadro acuta, & non grauve, per le ragioni disopra dimostra-te, ne risulteraà grande confusione, per lo qual modo saraà di necessitaà rimouvere la
proprietaà del b molle, di grauve in acuto, conciosia cosa che la detta propietaà ten-ga maggior parte di sillabe, o note cantabili, nelle parti acute, che nelle grauvi,
nella qual cosa si uvede chiaro, chella oppenione di sopra allegata non ha conienza [sic: convenienza]
alcuna, neé fondamento ragioneuvole, percheé due propietaà del b
molle, di grauve in acuto, conciosia cosa che la detta propietaà ten-ga maggior parte di sillabe, o note cantabili, nelle parti acute, che nelle grauvi,
nella qual cosa si uvede chiaro, chella oppenione di sopra allegata non ha conienza [sic: convenienza]
alcuna, neé fondamento ragioneuvole, percheé due propietaà del b molle resterebbono
acute, & sopracute, douve primieramente era la prima grauve, la quale quiuvi ha il
suo nascimento,. Adunque, per rimouvere i dichiarati inconuvenienti, auvertirai te es-ser costretto diuvidere la tua mano in 8. grauvi, & 7. acute, & 5. sopracute, col prin-cipio in Gamma, prima corda, & la fine in ottauva detta G,; Eet per tal modo G, saraà grauve, con la propietaà grauve, per essere collocata nelle positioni, o luoghi gra-uvi, Eet cosiì essendo il b
molle resterebbono
acute, & sopracute, douve primieramente era la prima grauve, la quale quiuvi ha il
suo nascimento,. Adunque, per rimouvere i dichiarati inconuvenienti, auvertirai te es-ser costretto diuvidere la tua mano in 8. grauvi, & 7. acute, & 5. sopracute, col prin-cipio in Gamma, prima corda, & la fine in ottauva detta G,; Eet per tal modo G, saraà grauve, con la propietaà grauve, per essere collocata nelle positioni, o luoghi gra-uvi, Eet cosiì essendo il b quadro acuto, sarebbe detto in G, nascere la propietaà del b
quadro acuto, sarebbe detto in G, nascere la propietaà del b quadro acuto & in F primo la propietaà di b
quadro acuto & in F primo la propietaà di b molle acuto, & non grauve, & per te-ner retto ordine saraà detto cosiì,:
molle acuto, & non grauve, & per te-ner retto ordine saraà detto cosiì,:
- Lla propietaà di b
 quadro rispetto al luogo, grauve,;
quadro rispetto al luogo, grauve,;
- Lla proprietaà di natura, grauve,;
- Lla propietaà di b
 molle acuto, grauve,;
molle acuto, grauve,;
- Lla proprietaà di b
 quadro acuto, grauve,;
quadro acuto, grauve,;
- Lla propietaà di natura, acuta,;
- Lla proprietaà di b
 molle sopracuto, acuta,;
molle sopracuto, acuta,;
- Lla propietaà di b
 quadro sopracuto, acuta,.
quadro sopracuto, acuta,.
OPPENIONE. III.
 mi, positione. 2 [sic: 3].,
ad, A, positione, 9, dicendo mi, -fa, -re, -mi, -fa, -sol, -la, Eet discendendo, la, -sol, -fa, -la, -
sol, -fa, -mi, Iil quale ordine, o modo da noi non è concedutto [sic: conceduto], come quello che non eè commodo al canto piano, uvuoi dir fermo.
mi, positione. 2 [sic: 3].,
ad, A, positione, 9, dicendo mi, -fa, -re, -mi, -fa, -sol, -la, Eet discendendo, la, -sol, -fa, -la, -
sol, -fa, -mi, Iil quale ordine, o modo da noi non è concedutto [sic: conceduto], come quello che non eè commodo al canto piano, uvuoi dir fermo.
OPPOSITIONE.
 mi ad A, acuto, non si conuviene mutare in, D, la sil-laba sol, nella sillaba re, neé discendendo in E mutare il mi, nella sillaba la, percheé tal
modo non si osseruva nella Mmusica piana, ma è contro le institutioni di ogni scientia-to Mmusico.
mi ad A, acuto, non si conuviene mutare in, D, la sil-laba sol, nella sillaba re, neé discendendo in E mutare il mi, nella sillaba la, percheé tal
modo non si osseruva nella Mmusica piana, ma è contro le institutioni di ogni scientia-to Mmusico.
RESOLVUTIONE.
 , mi,
grauve ad A acuto, muterai la sillaba la, la quale è in E la, mi, nella sillaba mi, pure a un tempo medesimo, & discendendo come di sopra hai compreso,. Et questo modo, & ordine è necessario, & non come a te piace, percheé le mutationi mai non si
debbono fare, se prima la necessitaà non te costrigne, come afferma Guidone Areti-no dicendo.:
, mi,
grauve ad A acuto, muterai la sillaba la, la quale è in E la, mi, nella sillaba mi, pure a un tempo medesimo, & discendendo come di sopra hai compreso,. Et questo modo, & ordine è necessario, & non come a te piace, percheé le mutationi mai non si
debbono fare, se prima la necessitaà non te costrigne, come afferma Guidone Areti-no dicendo.: Mai non si dee fare la mutatione, se non astretto dalla necessitaà,.lLaà onde non saraà necessario mutare il sol nel re, del D grauve, ma la sillaba la, di E la, mi, nel mi, come da Marchetto (che che gli altri si habbiano creduto) Rrettamente è stato dimostrato, dicendo,:
La mutatione si è un uvariare del nome della uvoce in un'altra nel medesimo suono,.Et similmente Franchino al cap. 4. della sua pPratica dice, chella, uvoce non si cangia in un'altra uvoce per l'ascendere, neé per lo discendere, ma la sillaba siì bene in altra sillaba, & la propietaà, ouvero qualitaà in altra qualitaà, la quale intelligenza solo appartiene al canto figurato, & non al fermo, percheé le mutatio-page 13ni del canto figurato sono gouvernate dalla commoditaà, & quelle dal canto fermo dalla necessitaà, come la figura dimostra.
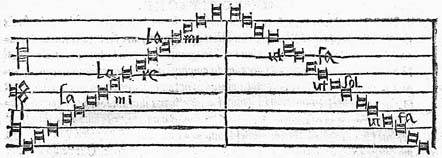
Essempio per cagione delle cose di sopra raccontate.
OPPENIONE. IIII.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
qQuello è detto Ttuono commisto, il quale essendo autentico, hauvraà altre spetiji che del suo plagale, & al contrario essen-do plagale, hauvraà altre spetiji che del suo autentico,per la sentenza del quale conchiudo che il terzo Ttuono non hauvraà mai luogo regolarmente per cagione delle spetiji in altra positione che in E grauve, ma in D, non mai.
OPPENIONE. V.
 , mi, C, D, acute, nelle quali ciascun di loro potraà
terminare, come per noi al cap. 32. del primo libro, de Institutione harmonica con alcuni precetti non s'eè tacciuto,. Et percheé molti hanno uvarie oppenioni di tale irregolaritaà, dicono tali terminationi non essere ragioneuvolmente considerate, per non trouvarsi in esse quella sorte di compositione, che a quelle si couviene,. oOnde dice Marchetto Padoano in quel suo tTrattatello della immisurabil Mmusica, al cap. 5 [sic: 4]., le seguenti parole, le quali, come ne gli altri luoghi ci è accaduto, habbiamo fatte uvolgari,:
, mi, C, D, acute, nelle quali ciascun di loro potraà
terminare, come per noi al cap. 32. del primo libro, de Institutione harmonica con alcuni precetti non s'eè tacciuto,. Et percheé molti hanno uvarie oppenioni di tale irregolaritaà, dicono tali terminationi non essere ragioneuvolmente considerate, per non trouvarsi in esse quella sorte di compositione, che a quelle si couviene,. oOnde dice Marchetto Padoano in quel suo tTrattatello della immisurabil Mmusica, al cap. 5 [sic: 4]., le seguenti parole, le quali, come ne gli altri luoghi ci è accaduto, habbiamo fatte uvolgari,: Ma potrebbe dire alcuno, percheé la prima spetie del Ddiapente non è constituita in A re grauve, la quale è composta del tuono, & del semituono, et di duoi tuoni, Eet appresso percheé non finisce nel medesimo luogo il primo tuono, e 'l secondo, & seguentemente le altre spetiji, dallequali alcuni altri tuoni sono ordinati,. Rispondiamo con piuù ra-page 15gioni, Eet la prima si è, che possiamo, ascendendo da A re grauve, incominciare la prima spetie del Ddiapente, sopra la quale nondimeno la prima spetie del Ddiatessaron a niuna guisa si ritrouva,; Lla seconda, che 'l suo plagale non hauvrebbe il suo discenso,; Lla terza, che procedendo all'ascendere non potremmo hauvere la seconda spetie del Ddiapente, perciocheé da Bmi grauve ad F, grauve niuna spetie si ritrouva,. oOltre di ciò, se tal primo tuono finiraà nella sua confinalità, sopra la detta prima spetie del Ddia-pente, non si harà la prima del Ddiatessaron, ma la seconda.
OPPOSITIONE.
 , mi, acuto nasceraà maggior discordia, percheé dal detto bB, ad F, acuto non saraà spetie di Ddiapente retto, ma scemato, & falso, & sopra il detto F, nasceraà un tetracordo superfluo, ouvero duro Ttritono., Eet in C acuto un pentacordo non atto al Qquinto neé al Ssesto Ttuono, ma al settimo, et a l'ottauvo; in D, appaiono le spetiji del primo, et del secondo Ttuono, delle qua-li dimostrationi pare, che ne nasca confusione grandissima. Et anchor che Marchetto dica chelle positioni non regolari, le quali da molti sono state concedute, siano uvane et di souverchio, nondimeno habbi mente, che non eè cosiì, ma sono atte alle spetiji,
& compositioni loro, secondo la irregolar natura, come seguitando intenderai.
, mi, acuto nasceraà maggior discordia, percheé dal detto bB, ad F, acuto non saraà spetie di Ddiapente retto, ma scemato, & falso, & sopra il detto F, nasceraà un tetracordo superfluo, ouvero duro Ttritono., Eet in C acuto un pentacordo non atto al Qquinto neé al Ssesto Ttuono, ma al settimo, et a l'ottauvo; in D, appaiono le spetiji del primo, et del secondo Ttuono, delle qua-li dimostrationi pare, che ne nasca confusione grandissima. Et anchor che Marchetto dica chelle positioni non regolari, le quali da molti sono state concedute, siano uvane et di souverchio, nondimeno habbi mente, che non eè cosiì, ma sono atte alle spetiji,
& compositioni loro, secondo la irregolar natura, come seguitando intenderai.
RESOLVUTIONE.
sSe qual-che Ttuono nasceraà nella sua confinalitaà, Ttal procedere saraà sempre accidente,;& possiam dire, che tal tuono, è acquisito, perciocheé egli uva acquistando le sue spetiji per la uvarietaà de' segni del b
 rotondo, & del b
rotondo, & del b quadro,; & in ogni altro luogo, douve propiamente esse spetiji termineranno, dico, che se 'l primo, & il secondo Ttuono
termineranno in A acuto, & il terzo, e 'l quarto in bB, & il quinto, e 'l sesto in C,
& il settimo, è [sic: e] l'ottauvo in D, tali terminationi non saranno nominate uvane, neé di
souverchio, ma sieno luoghi atti a conseruvare a ciascun Ttuono quello, che allui si con-page 16uveneraà,. Per tanto si risoluve, che se alcun canto termineraà nella corda, o positione
di A, acuto, saraà primo, o secondo tuono, & essendo la corda irregolare, conse-guetemente le spetiji loro saranno accidentali, come da A la, mi, re, acuto ad E la, mi,
& dal E la mi acuto, ad A sopra acuto, colla seguente figura,
quadro,; & in ogni altro luogo, douve propiamente esse spetiji termineranno, dico, che se 'l primo, & il secondo Ttuono
termineranno in A acuto, & il terzo, e 'l quarto in bB, & il quinto, e 'l sesto in C,
& il settimo, è [sic: e] l'ottauvo in D, tali terminationi non saranno nominate uvane, neé di
souverchio, ma sieno luoghi atti a conseruvare a ciascun Ttuono quello, che allui si con-page 16uveneraà,. Per tanto si risoluve, che se alcun canto termineraà nella corda, o positione
di A, acuto, saraà primo, o secondo tuono, & essendo la corda irregolare, conse-guetemente le spetiji loro saranno accidentali, come da A la, mi, re, acuto ad E la, mi,
& dal E la mi acuto, ad A sopra acuto, colla seguente figura,  , in F acuto. Se anchora terminerano in b
, in F acuto. Se anchora terminerano in b mi acuto, diremo essere del Tterzo, & del Qquarto tuono, percheé formando il presente segno
mi acuto, diremo essere del Tterzo, & del Qquarto tuono, percheé formando il presente segno  in F acuto, da esso F acuto a bB acuto, et da F acuto a B
sopra acuto non saraà altro che 'l secondo Ddiapente et il secondo Ddiatessaron. Et terminado in C acuto, saraà del Qquinto, et del Ssesto tuono, pur che paia la figura
in F acuto, da esso F acuto a bB acuto, et da F acuto a B
sopra acuto non saraà altro che 'l secondo Ddiapente et il secondo Ddiatessaron. Et terminado in C acuto, saraà del Qquinto, et del Ssesto tuono, pur che paia la figura  nel
detto F acuto, per cagion della quale ne nasceraà il terzo Ddiapente, & il terzo Ddiatessaron,. Et se finiraà in D, acuto, del settimo, & del ottauvo saraà giudicato, percheé
ponendo la figura come qui,
nel
detto F acuto, per cagion della quale ne nasceraà il terzo Ddiapente, & il terzo Ddiatessaron,. Et se finiraà in D, acuto, del settimo, & del ottauvo saraà giudicato, percheé
ponendo la figura come qui,  , in F acuto, laà douve prima era natural Ddiapente, cioè
re, -la, esso diuventa Qquarto, & sopra, il primo diatessaron, col qual modo, & ordi-ne saraà composto ciaschedun tuono irregolare, o uvuoi accidentale, come nella pre-sente figura intenderai.
, in F acuto, laà douve prima era natural Ddiapente, cioè
re, -la, esso diuventa Qquarto, & sopra, il primo diatessaron, col qual modo, & ordi-ne saraà composto ciaschedun tuono irregolare, o uvuoi accidentale, come nella pre-sente figura intenderai.
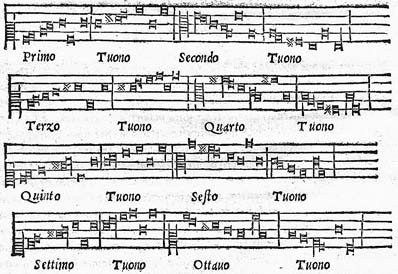
OPPENIONE. VI.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
puoò discendere,non è di necessitaà, ma in libertaà, & di licenza della Chiesa,. Laà onde si conchiude, che se un canto ascenderaà sopra del fine il suo Ddiapason, & non discenda il tuon sesquiottauvo, non saraà chiamato altro che perfetto, percheé tal perfettione sol si estende al numero di otto uvoci,. cCosiì ogni plagale, se non haraà sopra il fine uno Eessacordo maggiore, o minore, pur che ascenda al Ddiapente, & sotto il Ddiatessaron, saraà detto perfetto, & non imperfetto, come l'Eeccelente Franchino al cap. 11I.e. of the Tractatus secundus.. di quel suo Ttrattato uvolgare chiamato Angelico, & diuvino dice, che
ogni tuono, o cantico composto precisamente della sua intera Ddiapason è giudicato per-fetto.Et nota, che alcuni uvogliono, che i tuoni plagali per licenza, & autorità della Chiesa possano hauvere, sopra l'ascenso del loro Ddiapente, una sol nota eleuvata nel acuto per interuvallo di un minore semituono, ouvero di tuono, ma questo è ascritto a' tuoni soprabondanti & non a' perfetti, i quali sono considerati solamente nella pienezza del Ddiapasonico sistemma, come per gli tuoni, & modi antichi, è dimostra-to. Et a maggior confermatione, il medesimo al cap. 8. della sua Pratica in lingua latina replica tai parole.:
Ma noi, Ddiatonicamente procedendo, stimiamo, che non si debba sozopra riuvolgere la naturale dispositione delle uvoci della mano, conciosia cosa che esse otto uvoci della consonanza del Ddiapason stano distinte dalla misura della doppia proportione, la quale consiste di cinque sesquiottauvi tuoni con duoi mi-page 18nori semituoni, per la qual cosa non reputo necessario, chella detta uvoce discenda sotto il suo fine, come non conuveneuvole alla Ddiapasonica harmonia, per l'autoritaà della Chiesa, nondimeno da douver essere approuvata.Per tanto saraà conchiuso, che ogni tuono autentico, il quale haraà un Ddiapason sopra il fine, dato che non scenda altro [sic: oltre], saraà detto perfetto. Et se il plagale discenderaà sotto il suo fine per un Ttetracordo, & di sopra di esso fine non piuù oltre che per un Ppentacordo, saraà perfetto etian-dio chiamato.
OPPENIONE. VII .
 mi, non primiero, ma
secondo saraà detto, come dimostra la figura seguente.
mi, non primiero, ma
secondo saraà detto, come dimostra la figura seguente.
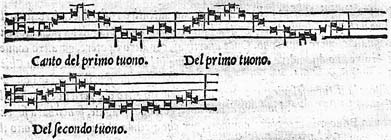
Il primo essempio dimostra il canto autentico, perciocheé egli ascende un tuono piuù oltre di quello, che fa il plagale, & non discende se non un semituono piuù basso di quello, che puoò discendere l'autentico. Nel secondo essempio appare il medesimo canto autentico, imperocheé tutto che egli discenda due uvolte al semituono, il che non è lecito all'autentico, tuttauvia i detti duo semituoni non aggiongono alla pienezza, & perfettione del tuono, allaquale non puoò arriuvare il plagale, perciocheé essi sono minori di quelli del genere Eenarmonico, & cantasi il detto canto per bquadro. Appresso diciamo, che tutto cioò che ascende sopra il primo bB acuto, è della sostan-za del primo tuono, & non del secondo, perciocheé siì come è detto, il secondo per lo b
rotondo necessariamente si dee cantare. Nel terzo essempio è contenuto il canto plagale, perciocheé i tre semituoni, da' quali discende il tuono, quello souverchia-page 19no di un Ddiesi, imperocheé tre semituoni contengono sei Ddiesi, & un tuono se non cin-que di essi contiene, Aalle quai regole è da douver essere hauvuto riguardo in tutti i canti.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
 mi grauve,
& dice, che 'l primo, e 'l secondo essempio sono autentici, Lla qual cosa adiuviene per
cagione del tuono, il qual si dimostra fra 'l bB , e 'l cC acuti, et appresso, per essere maggior del semituono nascente fra 'l C, e 'l B
mi grauve,
& dice, che 'l primo, e 'l secondo essempio sono autentici, Lla qual cosa adiuviene per
cagione del tuono, il qual si dimostra fra 'l bB , e 'l cC acuti, et appresso, per essere maggior del semituono nascente fra 'l C, e 'l B , mi grauvi, & per esser maggior parte nel
acuto, che nel grauve, gli appella autentici, la quale oppenione, se fosse al proposito,
sarebbe ragioneuvole, percheé tutto che sia maggior, o minor interuvallo dal tuono al
semituono, non si concede peroò tal oppenione a un processo simile, il qual si com-prende potersi per lo ascenso, & per lo discenso giudicare. Se ascende adunque alla
settima uvoce dal suo finale, & dal medesimo finale nel grauve al semidittono, non si
uvuole procaciare la quantitaà del tuono, neé del semituono, ma giudicargli per la lo-ro corda, per essere uguali di imperfettione, come dichiara Franchino al cap. 8. del
primo libro della sua Pratica, douve dice.:
, mi grauvi, & per esser maggior parte nel
acuto, che nel grauve, gli appella autentici, la quale oppenione, se fosse al proposito,
sarebbe ragioneuvole, percheé tutto che sia maggior, o minor interuvallo dal tuono al
semituono, non si concede peroò tal oppenione a un processo simile, il qual si com-prende potersi per lo ascenso, & per lo discenso giudicare. Se ascende adunque alla
settima uvoce dal suo finale, & dal medesimo finale nel grauve al semidittono, non si
uvuole procaciare la quantitaà del tuono, neé del semituono, ma giudicargli per la lo-ro corda, per essere uguali di imperfettione, come dichiara Franchino al cap. 8. del
primo libro della sua Pratica, douve dice.: Se un canto è autentico, & che nel grauve tocchi tutto 'l Ttetracordo del suo plagale, ouvero almanco due uvoci, tal canto saraà detto misto,.Per tanto diremo il detto canto essere del secondo tuono misto, & non del primo, per cagione del suo continouvare, il qual si conosce nelle parti grauvi, signoreggiando la corda, la qual sentenza è confermata da Guido Aretino in quel suo trattato chiamato Compendio di Mmusica, douve dice,:
Ma quelli autentici, che discenden-do si abbassano per un tuono, o per un semituono, o per un dittono, percioò che con loro plagali si mischiano, sono chiamati misti.page 20
OPPENIONE. VIII.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
 molle, & il mi del b
molle, & il mi del b duro. Per tanto eglino considerano esser meglio il dire
fa, sopra la uvoce la, che non è mi, percheé da aA, acuto a bB, si fa tal processo per lo semituono minore, il qual di natura è molle, Iil percheé non saraà di necessitaà in tai di-scorsi considerare il piuù soauve, neé il piuù duro, eccetto se non uvi nascesse la spetie Ttritonale, nel qual caso saresti costretto pronontiare la uvoce fa, sopra la sillaba la,. Onde, non procedendo il canto in tal durezza, ti sarebbe attribuito ad errore, percheé
nel canto piano non se canta per b
duro. Per tanto eglino considerano esser meglio il dire
fa, sopra la uvoce la, che non è mi, percheé da aA, acuto a bB, si fa tal processo per lo semituono minore, il qual di natura è molle, Iil percheé non saraà di necessitaà in tai di-scorsi considerare il piuù soauve, neé il piuù duro, eccetto se non uvi nascesse la spetie Ttritonale, nel qual caso saresti costretto pronontiare la uvoce fa, sopra la sillaba la,. Onde, non procedendo il canto in tal durezza, ti sarebbe attribuito ad errore, percheé
nel canto piano non se canta per b molle altrimenti, se non per addolcire il Ttritono,
come conferma Guido Monaco. Si conchiude adunque, che se un canto procederaà
da D, sol, re, ad A la, mi, re, & a b
molle altrimenti, se non per addolcire il Ttritono,
come conferma Guido Monaco. Si conchiude adunque, che se un canto procederaà
da D, sol, re, ad A la, mi, re, & a b , fa, b
, fa, b , mi, per un salto, o uveramente continouvate
note, non una uvolta, ma cento sempre saraà cantato per la propietaà del b
, mi, per un salto, o uveramente continouvate
note, non una uvolta, ma cento sempre saraà cantato per la propietaà del b quadro, come appare nel essempio dimostrato dallo eccelente Marchetto Padouvano, addotto in
un suo Ttrattato di canto fermo chiamato dDella Ccompositione de' tuoni per le loro
spetiji, al cap. 5 [sic: 4]., douve dice,:
quadro, come appare nel essempio dimostrato dallo eccelente Marchetto Padouvano, addotto in
un suo Ttrattato di canto fermo chiamato dDella Ccompositione de' tuoni per le loro
spetiji, al cap. 5 [sic: 4]., douve dice,: oOuvero alcuna uvolta al C acuto, & alhora doppiamente, page 21percheé ouvero ascende al predetto bB acuto piuù uvolte, & al C acuto, ouvero ascende dauvanti, che descenda al F grauve, & sempre si canta per bquadro, come qua.
 Dalle sopradette cose harai notitia, come, et in che modo,
ragioneuvolmente potrai procedere.
Dalle sopradette cose harai notitia, come, et in che modo,
ragioneuvolmente potrai procedere.
OPPENIONE. VIIII.
 quadro nel b
quadro nel b rotondo. Et similmente re -mi, di A acuto col medesi-mo processo ascende.
rotondo. Et similmente re -mi, di A acuto col medesi-mo processo ascende.
OPPOSITIONE.
 quadro nel b
quadro nel b rotondo., Ccertamente
non ne potraà nascere se non qualche confusione, imperocheé si uvede essere molto in contrario, dicendo che ut -re, & re -mi, ascendano dal b
rotondo., Ccertamente
non ne potraà nascere se non qualche confusione, imperocheé si uvede essere molto in contrario, dicendo che ut -re, & re -mi, ascendano dal b quadro nel b
quadro nel b rotondo, conciosia
cosa che la propietaà del b
rotondo, conciosia
cosa che la propietaà del b quadro sia superiore al b
quadro sia superiore al b rotondo. Essendo adunque essa
propietaà del b
rotondo. Essendo adunque essa
propietaà del b quadro nel G, & quella del b
quadro nel G, & quella del b rotondo nel F, seguiteraà quanto alla
propietaà, che siano domandate discendenti del b
rotondo nel F, seguiteraà quanto alla
propietaà, che siano domandate discendenti del b quadro nel b
quadro nel b rotondo, & non ascendenti, come dimostra l'eccelente Don Franchino al cap. 4. del primo libro della sua
Pratica. Et percheé egli ha solamente considerato la occorrenza, & necessitaà del
Ttritono, & il procedere con manco mutationi, ha biasimato l'arte, per accommo-darsi ad uno altro effetto, il qual cagioneraà nel G, & nel A, tre mutationi ascendenti, & tre discendenti, la quale oppenione non solamente annoi non piace, ma etian-dio è riprouvata dallo eccellentissimo, & dottissimo Mmusico mMesser Giouvan Spadaro
al cap. 10. della prima parte del suo tTrattato sopra i dubbiji del nominato Don Franchino., Eet similmente da noi al cap. 14. del primo libro de Institutione harmonica,
nel quale con ragioni, & efficaci argomenti habbiamo a questo contradetto, et mo-strato potersi conuvertire lo ascenso nel discenso, secondo che saranno i processi.
rotondo, & non ascendenti, come dimostra l'eccelente Don Franchino al cap. 4. del primo libro della sua
Pratica. Et percheé egli ha solamente considerato la occorrenza, & necessitaà del
Ttritono, & il procedere con manco mutationi, ha biasimato l'arte, per accommo-darsi ad uno altro effetto, il qual cagioneraà nel G, & nel A, tre mutationi ascendenti, & tre discendenti, la quale oppenione non solamente annoi non piace, ma etian-dio è riprouvata dallo eccellentissimo, & dottissimo Mmusico mMesser Giouvan Spadaro
al cap. 10. della prima parte del suo tTrattato sopra i dubbiji del nominato Don Franchino., Eet similmente da noi al cap. 14. del primo libro de Institutione harmonica,
nel quale con ragioni, & efficaci argomenti habbiamo a questo contradetto, et mo-strato potersi conuvertire lo ascenso nel discenso, secondo che saranno i processi.
RESOLVUTIONE.
 quadro nel b
quadro nel b rotondo, page 22par cosa di uvero molto contraria, percheé la propietaà del b
rotondo, page 22par cosa di uvero molto contraria, percheé la propietaà del b quadro è piuù intesa, ouvero alta della proprietaà del b
quadro è piuù intesa, ouvero alta della proprietaà del b rotondo., Eet per tal rispetto dicono chella detta muta-tione non ascende, ma discende. Et nota che questo dire ascende del b
rotondo., Eet per tal rispetto dicono chella detta muta-tione non ascende, ma discende. Et nota che questo dire ascende del b quadro nel b
quadro nel b rotondo non ha da essere da te considerato secondo la positione piuù alta, o piuù bassa, ma
secondo le propietaà, et note, ouvero sillabe poste nella detta positione dal Mmusico considerate. Onde, bisognando necessariamente mutare la sillaba ut, nella sillaba re, conciosia cosa che l'ut sia del b
rotondo non ha da essere da te considerato secondo la positione piuù alta, o piuù bassa, ma
secondo le propietaà, et note, ouvero sillabe poste nella detta positione dal Mmusico considerate. Onde, bisognando necessariamente mutare la sillaba ut, nella sillaba re, conciosia cosa che l'ut sia del b quadro, & il re del b
quadro, & il re del b rotondo, mostra, che non sia con-uveniente, che ella ascenda quanto alle proprietaà, ma come habbiamo detto, non si
attende alle proprietaà piuù alte, o piuù basse, ma al procedere delle note sopra la sillaba ut,. Lasciando adonque la sillaba ut, & cangiandola nella sillaba re, saraà rettamente detto, che ascenda del b
rotondo, mostra, che non sia con-uveniente, che ella ascenda quanto alle proprietaà, ma come habbiamo detto, non si
attende alle proprietaà piuù alte, o piuù basse, ma al procedere delle note sopra la sillaba ut,. Lasciando adonque la sillaba ut, & cangiandola nella sillaba re, saraà rettamente detto, che ascenda del b duro nel b
duro nel b molle., Ppercheé si lascia la nota del b
molle., Ppercheé si lascia la nota del b duro,
& si trasferisce in quelle [sic: quella] del b
duro,
& si trasferisce in quelle [sic: quella] del b molle,. Per tanto egli è di necessitaà, chella sillaba ut,
si cangi nel re, per ischifare il Ttritono interuvallo, come la seguente figura ti mostra,
la qual sillaba altramente ascenderebbe a qualche altra nota intensa,.
molle,. Per tanto egli è di necessitaà, chella sillaba ut,
si cangi nel re, per ischifare il Ttritono interuvallo, come la seguente figura ti mostra,
la qual sillaba altramente ascenderebbe a qualche altra nota intensa,.
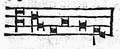
OPPENIONE. X.
 molle
segnato, senza altra consideratione dicono, che tale Kyrie no altrimenti che con esso
b
molle
segnato, senza altra consideratione dicono, che tale Kyrie no altrimenti che con esso
b molle dee essere cantato, come dimostra la seguente figura.
molle dee essere cantato, come dimostra la seguente figura.
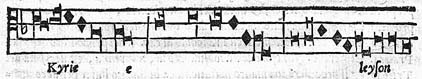
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
 molle, eccetto che nell'interuvallo del Ttritono, il quale opponendosi spes-se uvolte nel trapasso del Qquinto, & del Ssesto tuono, i Ccompositori hanno preso di segnar tali tuoni col segno del b
molle, eccetto che nell'interuvallo del Ttritono, il quale opponendosi spes-se uvolte nel trapasso del Qquinto, & del Ssesto tuono, i Ccompositori hanno preso di segnar tali tuoni col segno del b molle, per lo qual modo mutano il Ddiapente del quinto & del sesto tuono in quello del settimo, & del ottauvo,. oOnde la regola dice che per
niun modo si canta nel Ccanto fermo per b
molle, per lo qual modo mutano il Ddiapente del quinto & del sesto tuono in quello del settimo, & del ottauvo,. oOnde la regola dice che per
niun modo si canta nel Ccanto fermo per b molle, saluvo che per addolcire il Ttritono,.
Stando adunque questi fondamenti, non saraà necessario, che tal concento debba esse-re cantato per b
molle, saluvo che per addolcire il Ttritono,.
Stando adunque questi fondamenti, non saraà necessario, che tal concento debba esse-re cantato per b molle, per la qual cosa quello, che da noi è stato chiaramente di-mostrato al cap. 4. del Trattato nostro della natura, & cognitione di tutti i tuoni
di canto figurato, si potraà a tal proposito adducere, che essendo tal primo Kyrie, et
il seguente Christe del ottauvo tuono, non è cosa conuveneuvole mescolar seco il secon-do tuono,. Per tanto si domanda, se un concento a quattro uvoci hauvesse una sola parte col b
molle, per la qual cosa quello, che da noi è stato chiaramente di-mostrato al cap. 4. del Trattato nostro della natura, & cognitione di tutti i tuoni
di canto figurato, si potraà a tal proposito adducere, che essendo tal primo Kyrie, et
il seguente Christe del ottauvo tuono, non è cosa conuveneuvole mescolar seco il secon-do tuono,. Per tanto si domanda, se un concento a quattro uvoci hauvesse una sola parte col b molle segnata, come in alcuni canti si trouva, se sarebbe inconuveniente, o no.
Egli è cosa certa, che da ciascuno saraà riputato errore, percheé non è concesso can-tare parte per b
molle segnata, come in alcuni canti si trouva, se sarebbe inconuveniente, o no.
Egli è cosa certa, che da ciascuno saraà riputato errore, percheé non è concesso can-tare parte per b molle, & parte per natura, & parte per b
molle, & parte per natura, & parte per b quadro,; pur nondimeno
se dannoi questa tal oppenione ti saraà conceduta, risguarda quello, che ne seguiteraà,.
Prima, se tu darai il nome del mi, alla quarta nota legata nel principio del concento,
procedendo alle due in b
quadro,; pur nondimeno
se dannoi questa tal oppenione ti saraà conceduta, risguarda quello, che ne seguiteraà,.
Prima, se tu darai il nome del mi, alla quarta nota legata nel principio del concento,
procedendo alle due in b fa, b
fa, b mi, formate, per essere due uvolte continouvato il fa, sa-raà un uvalico del dissonante tritono, percheé il mi, seguente non è uvicino a quello di E la
mi intenso. pProcedendo con una sola nota nel detto b
mi, formate, per essere due uvolte continouvato il fa, sa-raà un uvalico del dissonante tritono, percheé il mi, seguente non è uvicino a quello di E la
mi intenso. pProcedendo con una sola nota nel detto b fa acuto, tal dissonanza me-glio seraà tollerata, perciocheé appare il Ddiapente secondo composto, o continouvato,.
Appresso un altro inconuveniente ne nasceraà, se tu dirai fa, alla sopradetta quarta nota,; uvenendo alla nona, la quale è mi, saraà processo certo non troppo grato, & questo
è per gli estremi del Ddiapente diminuto, per la qual cosa, se bene auvertirai, cantan-do per lo b
fa acuto, tal dissonanza me-glio seraà tollerata, perciocheé appare il Ddiapente secondo composto, o continouvato,.
Appresso un altro inconuveniente ne nasceraà, se tu dirai fa, alla sopradetta quarta nota,; uvenendo alla nona, la quale è mi, saraà processo certo non troppo grato, & questo
è per gli estremi del Ddiapente diminuto, per la qual cosa, se bene auvertirai, cantan-do per lo b quadro grauve, ne risulteraà processo naturale harmonioso, & grato,; &
qui si conchiude non ritrouvarsi mai nel Ccanto fermo concento alcuno, il qual si
cantasse per lo b
quadro grauve, ne risulteraà processo naturale harmonioso, & grato,; &
qui si conchiude non ritrouvarsi mai nel Ccanto fermo concento alcuno, il qual si
cantasse per lo b rotondo, essendo del primo, o del secondo, terzo, quarto, set-timo, & del ottauvo tuono,. Et percheé piuù fiate habbiamo considerato una no-uva oppenione di alcuni altri sopra il primo & il terzo Agnus dDei essercitati, &
dedicati alla solennitaà di Iesu Christo omnipotente, & anchora nelle solennitaà de' dodeci Aapostoli, per essere al fine del nostro canto fermo, inanzi che di quello ci espediamo, daremo risoluta decisione,. Molti dunque senza pensamento alcuno dicono, che
tali Agnus dDei nel loro principio debbono essere cantati per lo b
rotondo, essendo del primo, o del secondo, terzo, quarto, set-timo, & del ottauvo tuono,. Et percheé piuù fiate habbiamo considerato una no-uva oppenione di alcuni altri sopra il primo & il terzo Agnus dDei essercitati, &
dedicati alla solennitaà di Iesu Christo omnipotente, & anchora nelle solennitaà de' dodeci Aapostoli, per essere al fine del nostro canto fermo, inanzi che di quello ci espediamo, daremo risoluta decisione,. Molti dunque senza pensamento alcuno dicono, che
tali Agnus dDei nel loro principio debbono essere cantati per lo b molle, per cagione
del tritono, come qui,
molle, per cagione
del tritono, come qui,
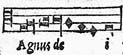
 molle dal cominciamento al fine,. Onde per le ragioni di so-pra allegate, giudicheremo da loro essere futo mal considerato, come fu anchora da
quel padre, ilquale uvolle racconciare il Ggraduale a penna di sSanta Maria delle gGratie di Bergamo, nel quale egli segnò gli Agnus dDei sopra la positione di F del segno
del b
molle dal cominciamento al fine,. Onde per le ragioni di so-pra allegate, giudicheremo da loro essere futo mal considerato, come fu anchora da
quel padre, ilquale uvolle racconciare il Ggraduale a penna di sSanta Maria delle gGratie di Bergamo, nel quale egli segnò gli Agnus dDei sopra la positione di F del segno
del b quadro, come è qui,
quadro, come è qui, 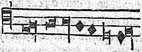 Iil qual segno certamente non
è conuveneuvole neé inteso dallui, conciosia cosa che sua
paternitaà solamete considerasse, che si douvesse procedere nel principio con le seguenti sillabe, cioè fa, -sol, -
sol, -la, -la, -sol, -fa, -mi, -fa, & non auvertiì, che il b
Iil qual segno certamente non
è conuveneuvole neé inteso dallui, conciosia cosa che sua
paternitaà solamete considerasse, che si douvesse procedere nel principio con le seguenti sillabe, cioè fa, -sol, -
sol, -la, -la, -sol, -fa, -mi, -fa, & non auvertiì, che il b quadro grauve non è conuveniente in
tal positione, come seguitando harai uvera notitia,; & questo è noto per la autoritaà
di tutti i Mmusici, i quali dicono, che ogni Ttritono annullato si conuvertisce nel Ttetracordo terzo, ordinariamente,. Si conchiude adunque, che l'uno, & l'altro modo è
di souverchio, & non concesso, percheé tal segno per seé è naturale, & essendo natu-rale, non puoò creare alcuno accidentale, neé lo accidentale alcuno naturale, come in
b
quadro grauve non è conuveniente in
tal positione, come seguitando harai uvera notitia,; & questo è noto per la autoritaà
di tutti i Mmusici, i quali dicono, che ogni Ttritono annullato si conuvertisce nel Ttetracordo terzo, ordinariamente,. Si conchiude adunque, che l'uno, & l'altro modo è
di souverchio, & non concesso, percheé tal segno per seé è naturale, & essendo natu-rale, non puoò creare alcuno accidentale, neé lo accidentale alcuno naturale, come in
b fa b
fa b mi si uvede,. Pertanto tal segno non haraà altro luogo, che nel b
mi si uvede,. Pertanto tal segno non haraà altro luogo, che nel b mi gra-uve & nel acuto, & nel sopracuto,; Oonde saraà necessario a tanti inconuvenienti che 'l
detto Agnus dDei resti formato come la figura, che segue dimostra.
mi gra-uve & nel acuto, & nel sopracuto,; Oonde saraà necessario a tanti inconuvenienti che 'l
detto Agnus dDei resti formato come la figura, che segue dimostra.
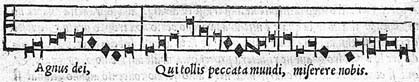
DICHIARATIONE DEL CAN-TO FIGVURATO.
LIBRO SECONDO.
iI cantori, & citharedi, & altri simili non debbono esser chiamati musici,perciocheé dice, che il musico è quegli, il quale con ragio-ne, & intelligenza ha facoltà di comporre la harmonia, Eet il cantore, & sem-plice citharedo è quegli, che publica, & fa manifesta l'opera harmonica compo-sta, & in luce prodotta dal musico, & compositore con ragione di dottrina, di maniera che esso cantore, & semplice citharedo saraà in comperatione del musico come è il banditore rispetto al podestaà, dal quale i comandamenti, & uvolontà di esso sono fatte note, & manifeste, & in publico addotte,. Et però da molti in-gegnosi, & ottimi cantori alcuna uvolta habbiamo inteso, che loro pareuva, che quelli cantori fossero da douver essere poco stimati, i quali non intendeuvano quel-lo, che da loro era cantato, & che non immeritamente si poteano rassomigliare a coloro, i quali leggendo qualche cosa, quella solamente intendono alla cortec-cia, & alla semplice struttura delle parole, senza alla midolla, & al uverace sentimento di quelle sotto esse nascosto penetrare, imperocheé il semplice cantore, per una certa sua pratica, esprime, & semplicemente conosce le note ouvero figure quantitatiuve ne' misurati moduli essercitate, lequali con ragione alcuna dallui non sono comprese, neé l'ordine di quelle, neé la forza del loro uvalore conosciuto, Iil che non aduviene del musico, dal quale non solamente è prodotto il tempo musico nella sua integritaà essercitato, ma etiandio è considerato esso tempo accozzato, ouvero mol-page 26te uvolte in una altra figura, ouvero nota preso, dal quale accozzamento nasce il modo minore, & il maggiore,. Appresso il detto musico tratta di esso tempo conuveneuvolmente in parte separato, & come di tal suo separamento nascono due uva-rietaà di prolationi, cioè minore, & maggiore, con molte altre sottilissime, & acutissime considerationi, & occorrenze da' dotti musici usate intorno l'ordine, & positione della regolare numerositaà constituita, & ordinata nel numero bina-rio, & ternario, i quali numeri da' musici ciascuno per seé sono intesi, & chia-mati perfetti & imperfetti, la quale intelligenza, & dimostrationi paiono a rozzi, oscure, & quasi impossibili a comprendere, & che per ragione alcuna non si possino dimostrare, neé essere intese.
OPPENIONE I.
 appresso di ogni musico significano tempo perfetto, per la qual similitudine
le pause di sopra nominate haranno forza del Mmodo maggior perfetto, la quale
oppenione, se fosse uvera, sarebbe al proposito.
appresso di ogni musico significano tempo perfetto, per la qual similitudine
le pause di sopra nominate haranno forza del Mmodo maggior perfetto, la quale
oppenione, se fosse uvera, sarebbe al proposito.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
OPPENIONE II.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
OPPENIONE III.
 mol-le siano conformi, & di niuna contrarietaà tra loro, conciosia cosa che essi
credano, che tal Ddiesi operi quello, che dal segno del b
mol-le siano conformi, & di niuna contrarietaà tra loro, conciosia cosa che essi
credano, che tal Ddiesi operi quello, che dal segno del b molle è operato, percio-cheé dal musico sempre è inteso, che la figura Ddiesi nel discenso diminuisce, & nel-l'ascenso accresca lo spatio dell'Aappotome, come da A, a G, & da D, a C, & appresso da D, a F, & da E, a G,. sSimilmente dicono, che il b
molle è operato, percio-cheé dal musico sempre è inteso, che la figura Ddiesi nel discenso diminuisce, & nel-l'ascenso accresca lo spatio dell'Aappotome, come da A, a G, & da D, a C, & appresso da D, a F, & da E, a G,. sSimilmente dicono, che il b molle opera, percheé
accresce, & toglie alla spetie lo spatio del detto Aappotome, come da C, acuto, a
b
molle opera, percheé
accresce, & toglie alla spetie lo spatio del detto Aappotome, come da C, acuto, a
b quadro acuto, & da C acuto ad E la mi acuto, come la figura, che segue dimo-stra.
quadro acuto, & da C acuto ad E la mi acuto, come la figura, che segue dimo-stra.
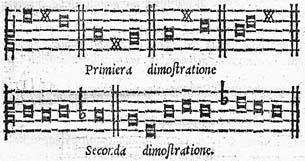
 molle sono conformi
nella operatione dello spatio maggiore detto Aappotome, non per tanto sono dissi-mili quanto all'effetto, conciosia che l'uno & l'altro toglia, & accresca alla spe-tie il semituon maggiore, non ostante che essi adoperino in contrario, ma percheé
essi sono differenti di forma, uvarieranno lo effetto dello spatio essercitato, & per
conseguente non haranno propia similitudine, come seguitando intenderai.
molle sono conformi
nella operatione dello spatio maggiore detto Aappotome, non per tanto sono dissi-mili quanto all'effetto, conciosia che l'uno & l'altro toglia, & accresca alla spe-tie il semituon maggiore, non ostante che essi adoperino in contrario, ma percheé
essi sono differenti di forma, uvarieranno lo effetto dello spatio essercitato, & per
conseguente non haranno propia similitudine, come seguitando intenderai.
OPPOSITIONE.
 mol-le non haranno fra loro conuvenenza, neé retta similitudine, percheé altro è l'ef-fetto & altro è la operatione,. Quanto all'operatione non ha dubbio, che l'u-no, & l'altro non toglia allo spatio Ssesquiottauvo lo Aappotome, & di minor se-page 30mituono non lo conuvertiscano in tuono, i quali effetti si conosceranno tra loro es-sere contrariji, & questo accaderaà quando il musico, per cagione di necessitaà, &
per far migliore consonanza, sostenteraà, & inalzeraà la nota dallui intesa, cosiì
nell'ascendere, come nel discendere, per laquale sostentagione, o inalzamento, si
uvolgeraà la spetie naturale nella accidentale, come appare nel principio della so-pra posta figura, nella quale si procede per dui tuoni continouvati, sotto i quali
appare in che maniera il musico intende, che tali tuoni siano conuvertiti in dua se-mitoni minori, & similmente, come il seguente tuono colle due spetiji semiditto-nali nella spetie, & forma del dittono sono da douver essere considerate, i quali se-midittoni, & tuoni, essendo pronontiati, conseruveranno il nome, ma in uvertuù mute-ranno la spetie,. oOnde quanto alla operatione hanno parte di similitudine,; tutta-uvia si uvede chiaro, che all'effetto, operano in contrario, & quinci nasce, che la
figura Ddiesi sempre nel discendere toglie, & nel ascendere accresce, alqual effet-to, & operatione il b
mol-le non haranno fra loro conuvenenza, neé retta similitudine, percheé altro è l'ef-fetto & altro è la operatione,. Quanto all'operatione non ha dubbio, che l'u-no, & l'altro non toglia allo spatio Ssesquiottauvo lo Aappotome, & di minor se-page 30mituono non lo conuvertiscano in tuono, i quali effetti si conosceranno tra loro es-sere contrariji, & questo accaderaà quando il musico, per cagione di necessitaà, &
per far migliore consonanza, sostenteraà, & inalzeraà la nota dallui intesa, cosiì
nell'ascendere, come nel discendere, per laquale sostentagione, o inalzamento, si
uvolgeraà la spetie naturale nella accidentale, come appare nel principio della so-pra posta figura, nella quale si procede per dui tuoni continouvati, sotto i quali
appare in che maniera il musico intende, che tali tuoni siano conuvertiti in dua se-mitoni minori, & similmente, come il seguente tuono colle due spetiji semiditto-nali nella spetie, & forma del dittono sono da douver essere considerate, i quali se-midittoni, & tuoni, essendo pronontiati, conseruveranno il nome, ma in uvertuù mute-ranno la spetie,. oOnde quanto alla operatione hanno parte di similitudine,; tutta-uvia si uvede chiaro, che all'effetto, operano in contrario, & quinci nasce, che la
figura Ddiesi sempre nel discendere toglie, & nel ascendere accresce, alqual effet-to, & operatione il b molle è contrario, perciocheé nel innalzare menoma, & aumenta nell'abbassare, come da F, a b
molle è contrario, perciocheé nel innalzare menoma, & aumenta nell'abbassare, come da F, a b mi quadro acuto, laquale è spetie tritonale,
per laqual cosa conchiuderemo, che il Ddiesi & il b
mi quadro acuto, laquale è spetie tritonale,
per laqual cosa conchiuderemo, che il Ddiesi & il b molle quanto alla operatione
sono conformi, ma quanto alla forma, & naturale effetto non hanno propia, neé
uvera similitudine, come anchora è manifesto alla mitigatione, & al dolcimento
del tritono, il quale sempre dal b
molle quanto alla operatione
sono conformi, ma quanto alla forma, & naturale effetto non hanno propia, neé
uvera similitudine, come anchora è manifesto alla mitigatione, & al dolcimento
del tritono, il quale sempre dal b molle è mitigato, & addolcito nell'estremitaà di
sopra, come da F, a b
molle è mitigato, & addolcito nell'estremitaà di
sopra, come da F, a b quadro acuto, la qual mitigatione è contraria a quella, che
dal Ddiesi è operata, percheé esso Ddiesi mitiga, & ammollisce la durezza del Ttri-tono nella parte di sotto, come da E acuto a b
quadro acuto, la qual mitigatione è contraria a quella, che
dal Ddiesi è operata, percheé esso Ddiesi mitiga, & ammollisce la durezza del Ttri-tono nella parte di sotto, come da E acuto a b quadro acuto, & da b
quadro acuto, & da b quadro acu-to a F grauve, come la figura mostra.
quadro acu-to a F grauve, come la figura mostra.
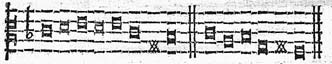
RESOLVUTIONE.
 quadro acuto per sostentare la
nota, la quale in essa si ritrouva, senza hauver riguardo alcuno al b
quadro acuto per sostentare la
nota, la quale in essa si ritrouva, senza hauver riguardo alcuno al b segnato in tal
canto, spetialmente trouvandosi il Ttenore nella terza, nella decima, & nell'altre
simili col Bbasso, ilquale in tal positione non haraà retto, neé douvuto luogo, concio-sia cosa che tal segno da Gioanni Othobi sia nominato b giacente, il qual non
richiede in tal positione, per esser figura accidentale, del che ne seguita dui segni
accidentali trouvarsi in un istesso luogo, cioè il b
segnato in tal
canto, spetialmente trouvandosi il Ttenore nella terza, nella decima, & nell'altre
simili col Bbasso, ilquale in tal positione non haraà retto, neé douvuto luogo, concio-sia cosa che tal segno da Gioanni Othobi sia nominato b giacente, il qual non
richiede in tal positione, per esser figura accidentale, del che ne seguita dui segni
accidentali trouvarsi in un istesso luogo, cioè il b , & il Ddiesi nomato, la qual
figura b
, & il Ddiesi nomato, la qual
figura b secondo Guidone è nomata Mmenon, che altro non uvien a dire, che acci-page 31dentale,. Restano adunque detti segni tra loro simili, per la qual similitudine, et
natura non potranno dimorare in una positione medesima, perciocheé non si con-cede un segno accidentale sopra un altro segno accidentale,. Onde saraà dibiso-gno al musico, & compositore, uvolendo sostentare, & solleuvare quella nota la, se-gnaruvi il b
secondo Guidone è nomata Mmenon, che altro non uvien a dire, che acci-page 31dentale,. Restano adunque detti segni tra loro simili, per la qual similitudine, et
natura non potranno dimorare in una positione medesima, perciocheé non si con-cede un segno accidentale sopra un altro segno accidentale,. Onde saraà dibiso-gno al musico, & compositore, uvolendo sostentare, & solleuvare quella nota la, se-gnaruvi il b quadro detto, il quale di quel luogo è naturale, per lo qual ordine la
sostentatione uverraà ad essere naturale, & per conseguente il Ddiesi solamente hauvraà
luogo nel C, nel F, & nel G, senza punto pregiudicare al b
quadro detto, il quale di quel luogo è naturale, per lo qual ordine la
sostentatione uverraà ad essere naturale, & per conseguente il Ddiesi solamente hauvraà
luogo nel C, nel F, & nel G, senza punto pregiudicare al b quadro, il quale quiuvi
ha la sua propia, & naturale stanza.
quadro, il quale quiuvi
ha la sua propia, & naturale stanza.
OPPENIONE IIII.
OPPOSITIONE.
 fa b
fa b mi quadro acuto,. mMa non es-sendo dalla necessitaà costretto, procederai per ordine naturale, secondo la forma, et
la dispositione del canto, & non come a te piace, il qual ordine, & modo osser-uva l'eccellente Marchetto Padouvano in un suo tTrattatello di canto immisurabile, da
noi allegato alla oppenione 8. del canto fermo.
mi quadro acuto,. mMa non es-sendo dalla necessitaà costretto, procederai per ordine naturale, secondo la forma, et
la dispositione del canto, & non come a te piace, il qual ordine, & modo osser-uva l'eccellente Marchetto Padouvano in un suo tTrattatello di canto immisurabile, da
noi allegato alla oppenione 8. del canto fermo.
RESOLVUTIONE.
 in b
in b fa b
fa b mi quadro posta, il qual processo non è da page 32te inteso, neé considerato, percheé tu pensi euvitare quel Ttritono, & non auvertisci,
che tutto è in contrario, perciocheé dicendo fa nel detto E la mi, & essendo il fa
sospeso di b
mi quadro posta, il qual processo non è da page 32te inteso, neé considerato, percheé tu pensi euvitare quel Ttritono, & non auvertisci,
che tutto è in contrario, perciocheé dicendo fa nel detto E la mi, & essendo il fa
sospeso di b fa b
fa b mi detto, non saraà spetie terza del Ttetracordo, ma spetie del
Ddittono menomato di un Ccomma, percheé procede per semituono, per tuono, &
per semituono. Per tanto dannoi (uvolendo seruvare ordine, & retto modo) saraà
conchiuso, che uvolendo ischifare tal Ttritono, saraà mestiere, essendo sospesa la sil-laba fa, dir mi nel detto E la mi, dato che gli estremi habbiano nome del Ttrito-no, ma in quantitaà, & forma del Ddiatessaron secondo, per laqual cosa, diuventando
il mi di E la mi la, & il fa sospeso conuvertendosi in mi, saraà distrutto il Ttritono
per lo segno del Ddiesi nello estremo inferiore, come piuù compitamente nel princi-pio della gGiunta del nostro Toscanello habbiamo detto, & con molte ragioni di-sputato.
mi detto, non saraà spetie terza del Ttetracordo, ma spetie del
Ddittono menomato di un Ccomma, percheé procede per semituono, per tuono, &
per semituono. Per tanto dannoi (uvolendo seruvare ordine, & retto modo) saraà
conchiuso, che uvolendo ischifare tal Ttritono, saraà mestiere, essendo sospesa la sil-laba fa, dir mi nel detto E la mi, dato che gli estremi habbiano nome del Ttrito-no, ma in quantitaà, & forma del Ddiatessaron secondo, per laqual cosa, diuventando
il mi di E la mi la, & il fa sospeso conuvertendosi in mi, saraà distrutto il Ttritono
per lo segno del Ddiesi nello estremo inferiore, come piuù compitamente nel princi-pio della gGiunta del nostro Toscanello habbiamo detto, & con molte ragioni di-sputato.
OPPENIONE V.
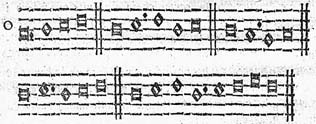
OPPOSITIONE.
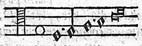 il qual punto in apparenza par bene, che sia semplice
per seé solo punto di riducimento, percheé non fa effet-to di niuno altro punto,. nNientedimeno, se tal punto non
appareraà, la prima semibreuve puntata, & la minima,
& la semibreuve seguenti saranno annouverate per un sol tempo, ouver breuve perfetta,
laà douve che senza tal punto la seguente semibreuve, per non poter far imperfetta la
prima breuve per la uniuversal regola della similitudine, saraà necessario sincoparla,
ouvero trasportarla, douve potraà hauver il suo luogo,. Et percheé tal misuramento na-sceraà da l'arte, & anchora dalla natura, la qual per seé, & senza altro fauvore
opera, & dimostra il suo effetto, & ordine, seguiteraà, che il punto messo da Franchino per punto di trasportamento otiosamente uvi saraà posto, neé potraà stare, senza
l'altrui aiuto, & fauvore, percheé senza tal punto si considera quello, che da Franchino per esso punto è stato inteso,. Et imperoò non saraà di necessitaà assegnare sei punti, ma solamente tre, come seguitando intenderai.
il qual punto in apparenza par bene, che sia semplice
per seé solo punto di riducimento, percheé non fa effet-to di niuno altro punto,. nNientedimeno, se tal punto non
appareraà, la prima semibreuve puntata, & la minima,
& la semibreuve seguenti saranno annouverate per un sol tempo, ouver breuve perfetta,
laà douve che senza tal punto la seguente semibreuve, per non poter far imperfetta la
prima breuve per la uniuversal regola della similitudine, saraà necessario sincoparla,
ouvero trasportarla, douve potraà hauver il suo luogo,. Et percheé tal misuramento na-sceraà da l'arte, & anchora dalla natura, la qual per seé, & senza altro fauvore
opera, & dimostra il suo effetto, & ordine, seguiteraà, che il punto messo da Franchino per punto di trasportamento otiosamente uvi saraà posto, neé potraà stare, senza
l'altrui aiuto, & fauvore, percheé senza tal punto si considera quello, che da Franchino per esso punto è stato inteso,. Et imperoò non saraà di necessitaà assegnare sei punti, ma solamente tre, come seguitando intenderai.
RESOLVUTIONE.
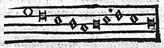 la qual al-teratione non nasceraà dal punto po- stoposto fra la
quarta, & la quinta semibreuve, ma dal mancamento, fanno che [sic: che fanno] le semibreuvi dopo il punto po-sto,. pPer tanto il detto punto non saraà di alteratione, ma di diuvisione, percheé fa,
che le figure annouverate a tre sono per altro modo diuvise, & considerate, che non
erano senza esso,. Et se alcuni dicessero, che tal punto saraà rettamente chiamato
di alteratione, percheé essa non puoò accadere senza l'apparenza di lui, Ssi rispon-de, che il propio della alteratione è, che il numero ternario sia scemato di una no-ta simile alle due innanzi annouverate, seguitando dopo una maggiore propinqua al-lei;. Adunque diremo, che il punto sopra detto non saraà causa di tale alteratione,
ma solo il scemamento ne saraà cagione, percheé esso punto solo diuvide, & rimouve le
figure dal primo loro essere, & l'alteratione attende a reintegrare il detto numero,
che secondo il regolar precetto, et ordine detto è dimostrato habile ad essere alterato.
la qual al-teratione non nasceraà dal punto po- stoposto fra la
quarta, & la quinta semibreuve, ma dal mancamento, fanno che [sic: che fanno] le semibreuvi dopo il punto po-sto,. pPer tanto il detto punto non saraà di alteratione, ma di diuvisione, percheé fa,
che le figure annouverate a tre sono per altro modo diuvise, & considerate, che non
erano senza esso,. Et se alcuni dicessero, che tal punto saraà rettamente chiamato
di alteratione, percheé essa non puoò accadere senza l'apparenza di lui, Ssi rispon-de, che il propio della alteratione è, che il numero ternario sia scemato di una no-ta simile alle due innanzi annouverate, seguitando dopo una maggiore propinqua al-lei;. Adunque diremo, che il punto sopra detto non saraà causa di tale alteratione,
ma solo il scemamento ne saraà cagione, percheé esso punto solo diuvide, & rimouve le
figure dal primo loro essere, & l'alteratione attende a reintegrare il detto numero,
che secondo il regolar precetto, et ordine detto è dimostrato habile ad essere alterato.
OPPENIONE VI.
cChi ha orecchi di udire, oda,.pPer tanto dicono, et dichiarano, che il circolo, et il semicircolo col punto sono chiamati maggior perfetto, & imperfetto, et senza 'l punto minor perfetto, & imperfetto, come ne' loro trattati manifestissimamente si uvede, le sentenze de' qua-li con euvidenti ragioni saranno dannoi riprouvate.
OPPOSITIONE.
 33,. Egli è certo, che tu nol domanderai altro che mo-do maggior perfetto, minor perfetto, tempo perfetto, et prolation perfetta, nome uveramente idoneo, & conuveneuvole et da ogni perito musico confermato;. Adunque il
circolo semplice puntato per te haraà equiuvalenza di nome àa quello, che si dimostra
con due cifre ternarie, la qual cosa non puoò star a modo alcuno, percheé il circolo
semplice puntato, & il semicircolo non possono acquistar nome di maggioranza
perfetta, & imperfetta, auvegna che egli hauvesse tal nome, per rispetto di quelle due
note perfette, perciocheé ouve cosiì fosse, saremmo costretti nominar questo
33,. Egli è certo, che tu nol domanderai altro che mo-do maggior perfetto, minor perfetto, tempo perfetto, et prolation perfetta, nome uveramente idoneo, & conuveneuvole et da ogni perito musico confermato;. Adunque il
circolo semplice puntato per te haraà equiuvalenza di nome àa quello, che si dimostra
con due cifre ternarie, la qual cosa non puoò star a modo alcuno, percheé il circolo
semplice puntato, & il semicircolo non possono acquistar nome di maggioranza
perfetta, & imperfetta, auvegna che egli hauvesse tal nome, per rispetto di quelle due
note perfette, perciocheé ouve cosiì fosse, saremmo costretti nominar questo  33. piuù
che maggior perfetto, percheé la massima, la lunga, la breuve, et la semibreuve sono
perfette, la qual oppenione sarebbe erronea, & falsa, & similmente ne nascerebbo-no altri disordinamenti, & manifeste confusioni, se da loro fosse detto questo segno,
33. piuù
che maggior perfetto, percheé la massima, la lunga, la breuve, et la semibreuve sono
perfette, la qual oppenione sarebbe erronea, & falsa, & similmente ne nascerebbo-no altri disordinamenti, & manifeste confusioni, se da loro fosse detto questo segno,
 , minor perfetto, & il seguente minor imperfetto, come qui,
, minor perfetto, & il seguente minor imperfetto, come qui,  , Iimperocheé se da
te è chiamato questo segno
, Iimperocheé se da
te è chiamato questo segno  maggiore imperfetto, percheé non chiami questo,
maggiore imperfetto, percheé non chiami questo,  ,
maggiore perfetto, per rispetto della sua forma circolare, & per la ugualezza, che
è fra loro di perfettione, conciosia cosa che in questo,
,
maggiore perfetto, per rispetto della sua forma circolare, & per la ugualezza, che
è fra loro di perfettione, conciosia cosa che in questo,  , sia una sola perfettione, et
nel seguente,
, sia una sola perfettione, et
nel seguente,  , un'altra,. oOnde considerato il fondamento, chiaro si uvede essere ogni
ordine confuso.
, un'altra,. oOnde considerato il fondamento, chiaro si uvede essere ogni
ordine confuso.
RESOLVUTIONE.
OPPENIONE VII.
 mi
grauve ad F grauve, & da E la mi a b
mi
grauve ad F grauve, & da E la mi a b fa acuto, lequali positioni sono di Ddiapenti diminuti, non atti, neé conuveneuvoli nella musica, come Franchino al 3. cap. del 3. lib.
della sua Pratica in lingua latina dice, che
fa acuto, lequali positioni sono di Ddiapenti diminuti, non atti, neé conuveneuvoli nella musica, come Franchino al 3. cap. del 3. lib.
della sua Pratica in lingua latina dice, che niuno non dubbita, chella quinta scema-ta di un semituono, per esser tal scemamento molto noto, non sia aspra, & nel canto poco conuveneuvole, & che per tal rispetto in musica non si patisce, chell'ordine delle spetiji Ddiapentiche da A grauve siano deriuvate,& per esser tal auttorità ordinaria, et comune, non si diranno altre sentenze sol per breuvitaà.
OPPOSITIONE.
Quelli, gli quali poneranno in uso due quinte l'una dopo l'altra, dato che l'una sia perfetta, & l'altra imperfetta, secondo il parer nostro incorrono in errore, percheé nella diuvisione Ddiatonica non si patisce tal spetie diminuta etc.,nel qual luogo auvertirai, che l'intendimento nostro non fu, che tal spetie, quando che sia, non potesse, ouve fosse in piacere del musico, essere to-lerata, percheé potraà per seé sola stare, & dal b
 molle essendo reintegrata, saraà per-fetta,. pPertanto due cose sono di douvere essere sanamete considerate;: l'una, se il compositore intenderaà far perfetta qualche figura o nota, che nello acuto, o nel grauve
sia distante da un'altra per uno Ddiapente diminuto; l'altra, se dallui saraà immaginato trascorrere in altre spetiji che de' Ppentacordi, le quali considerationi saranno page 37rettamente dall'arte ammesse, & concedute, come appresso intenderai.
molle essendo reintegrata, saraà per-fetta,. pPertanto due cose sono di douvere essere sanamete considerate;: l'una, se il compositore intenderaà far perfetta qualche figura o nota, che nello acuto, o nel grauve
sia distante da un'altra per uno Ddiapente diminuto; l'altra, se dallui saraà immaginato trascorrere in altre spetiji che de' Ppentacordi, le quali considerationi saranno page 37rettamente dall'arte ammesse, & concedute, come appresso intenderai.
DICHIARATIONE.


OPPENIONE VIII.
OPPOSITIONE.
 Iil qual modo piacendoti resta nel tuo arbitrio di seguirlo, & massimamente in
una necessità strema, non è dannoi uvituperato. page 39
Iil qual modo piacendoti resta nel tuo arbitrio di seguirlo, & massimamente in
una necessità strema, non è dannoi uvituperato. page 39RESSOLVUTIONE.
Spedite adunque queste cose, egli è da dire de' generi de' canti, iquali sono tre, Iil Ddiatonico, il Ccromatico, & l'Eenar-monico, fra' quali il Ddiatonico è alquanto duro, & naturale, ma il Ccromatico tiene quasi della natura del Ddiatonico, & piuù soauvemente procede,per le quai parole, il genere Ccromatico dallui è detto molle, percheé discorre per Ssemituoni,. oOn-de per tal mollezza, conciosia cosa che dallo audito fosse abominato, è futo rimosso dalla essercitatione, la qual cosa è stata dimostrata da Guido mMonaco, al capitolo quarto di quel suo tTrattato de' Ttuoni, douve dice, che i medesimi Ssemituoni non han-no luogo mai l'uno dopo l'altro, i quali sono stati ritrouvati per moderare, & rad-dolcire il canto, & che quando con men consideratione, & rispetto, che non si conuverebbe, sono posti, rendono durezza, & amarore in quella guisa, chi [sic: che] fanno le cose condite di souverchio sale, per la qual dimostratione si uvede, che assai piuù piace a gli ascoltanti il genere Ddiatonico usato, ilquale, come dice Boetio, è alquanto duro, & naturale, percheé nel suo ordine procede per un Ssemituono, & per dui spatiji di Ttuoni continouvati nel suo Ttetracordo, gli quali spatiji, o interuvalli di Ttuo-ni sono spatiji duri piuù che non sono quegli del genere Ccromatico, il qual procede per dui continouvati Ssemituoni, & per un Ttriemitonio in uno interuvallo, gli quali sono spatiji molli,. Et se alcuni argomentassero cosiì,:
Se due spetiji perfette simili ascendendo, & discendendo non sono grate, segue che due spetiji perfette dissimili, come la quinta dopo la ottauva, ascendendo, & discendendo, non debbano produce-re grata neé soauve armonia;,Aa tal loro ragione si risponde, che dato che la ottauva, & la quinta siano di natura perfette, esse peroò non sono di una medesima spetie,. Et siì come naturalmente suole interuvenire, che maggior diletto, & piacere sente il gusto in essendogli anzi due cose diuverse, che una sola porte, Ccosiì accade, che la quinta dopo la ottauva, & la ottauva dopo la quinta, percheé non sono simili in spe-tie, potranno stare insieme, cioè l'una dopo l'altra, ascendendo, & discendendo, senza impedire l'ascoltare;. Intorno adunque al parere di coloro, che non uvoglio-page 40no, che due consonanze perfette di un medesimo genere insieme ascendenti, & di-scendenti nel contrapunto siano concesse, conchiuderemo secondo Bartolomeo Rami, al precetto secondo del suo cContrapunto, che due quinte, o due ottauve, come è stato detto, insieme non si conuvengono, percheé quella continouvanza parrebbe una cosa medesima, per non esser in esse natura uvariabile, & appresso s'incorrerebbe qual-che uvolta nel Ddiapente diminuito, & percheé tali suoni sono tra loro equisonanti, per tal similitudine, & equalitaà, sono tralasciati dall'armonia, la quale non è al-tro, che mescolanza, & diuversitaà di uvoci concordi, le quali procedono per Aar-sim, & Tthesim, cioeè ascendendo, & discendendo;. Seguiteraà adunque, che la otta-uva posta dopo un'altra ottauva, & similmente la quinta dopo un'altra quinta non produceranno ottima harmonia, & appresso che per tale processi di suoni concor-di non nasceraà quel mescolamento di diuverse spetiji concordi, il quale dalla diffini-tione di sopra assegnata è dimostrato.
OPPENIONE IX.

OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
OPPENIONE X.

RESOLVUTIONE.

Fuga per Ddiapason
OPPENIONE II [sic: XI].
Qual sia la cagione, che essendo il Ccomma, co-me piace a Boetio, minimo, & insensibile all'udire, Pitagora, & gli altri philo-sophi non habbiano trouvato una diuvisione di Ttetracordi, i quali habbiano nel gra-uvissimo loro interuvallo la proportione, ouvero spatio di esso?,Lla qual questione nel 1516 fu da dDon Franchino proposta mentre l'eccellente mMesser Gioan Spada-ro, & io con lui, & con Nicolo Vulso erauvamo a musico litigio, nella quale il det-to dDon Franchino teneuva, che i tre generi hauvessono principio per Ttuono, & non per Ssemituono, neé per Ddiesi, allegando Boetio, Iilquale parlando de' detti generi, di-ce, che egli mai non adiuviene, che essi possano essere cangiati di grauvi in acuti;. Per tanto dal sopradetto mMesser Gioanni, & da noi fu data resoluta risposta, come di sotto appare.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
la uvo-ce procede,& anchora
si canta,.lLaà onde si comprende, che se la uvoce non potesse prononciare gli interuvalli de' detti generi, che tali interuvalli sarebbono uvani, & di souverchio posti, & trouvati,. Per tanto si dice che lo spatio del Ccomma non è futo considerato, neé posto per interuvallo di alcuno genere, percheé dato che egli sia com-preso dall'udire, dallo stormento naturale non puoò essere pronontiato,. Et come sa-rebbe fuor di proposito a colui che, douvendo essere in alcun luogo, facesse in giro il camino, ouve con men fatica, & piuù acconciamente a dirittura uvi potesse peruvenire, page 44cosiì se lo spatio del Ddiesi basta, piuù parti minute non si uvogliono ricercare,. Et ben che lo stormento artificiale (concioò sia cosa chell'arte sempre si sforzi di imitare la natura con tutto il suo potere) potesse per uventura pronontiarlo, non essendo il na-turale bastante, neé uvaleuvole a ciò fare, nientedimeno in tal diuvisione egli non si uve-de essere d'importanza alcuna;. Similmente da Franchino fu domandato,:
pPercheé il Ccromatico Ttetracordo dal Ddiatonico è deriuvato, piuù tosto procedendo dall'acuto nel grauve, che dal grauve nel acuto?.Si risponde, che niuna legge, neé ragione puoò sforzare il musico nella diuvisione di Ttetracordi a dar principio piuù nel grauve, che nel acuto, percheé quelli interuvalli, iquali si possono hauvere dallo acuto nel grauve, si potranno anchora hauvere dal grauve nello acuto;. Per tanto dico cioò essere a bene-placito di colui che fa tal diuvisione di grauve nel acuto, Iilche è stato osseruvato da Iacob Fabro nel diuvidere de' generi spessi, Eet somigliantemente da Guido nella partio ne [sic: partitione] del suo Mmonocordo secondo il genere Ddiatonico diuviso, cosiì anchora da Bartolomeo Rami nel Ddiatonico partimento, & anchora in quello, douve egli dimostra, che ogni Ttuono resta partito in dui Ssemituoni, Eet da Franchino al cap. 15. del primo libro dell'Armonia delli stormenti(.<space>cConchiuderemo adunque, che tal diuvisione co-minciata per lo grauve, o per lo acuto è in requisitione del musico, percheé il buon partitore faraà poca stima nel mediare dui estremi Ssesquitertiji, comunque si cominci, o nell'acuto, o nel grauve.
DEL SEMITVUONO NEL GRAVE.
OPPENIONE XII.
In questo pigliate errore, perciocheé il Ssemicircolo, comunque sia uvolto, sempre è segno di tempo imperfetto, come qua:& seguitando dice, che non trouvò mai dotto autore, che assegnasse ragione alcuna, che tal segno,,
, [[mus.TemImpDown]], [[mus.TemImpUp]], Iil qual Ssemicercolo, per non esser altro che un cerchio imperfetto, non pieno, o non intiero, o sia posto sopra, o sotto le figure, che di esso sono coronate, non è di uvalor uveruno,
 ., neé meno l'altra sua uguale parte, come qui.,
., neé meno l'altra sua uguale parte, come qui.,  .,
.,  ., fusse
proportione doppia, et che allui parea, chell'emispero [sic: hemisphero], ouvero Ssemicircolo fosse una
figura di Ggeometria, & la metà d'un circolo, appresso che il Mmusico giudicauva,
& assegnauva il circolo e 'l semicircolo al tempo ternario, & al binario, & che
non erano posti per caratteri di numeri da gli Aarithmetici,; & conchiudendo, dice,
che quello che dinota numero, è gouvernato dalla discreta quantitaà, & che tali numeri Mmusici debbono essere dimostrati per le zifre numerali, & non per,
., fusse
proportione doppia, et che allui parea, chell'emispero [sic: hemisphero], ouvero Ssemicircolo fosse una
figura di Ggeometria, & la metà d'un circolo, appresso che il Mmusico giudicauva,
& assegnauva il circolo e 'l semicircolo al tempo ternario, & al binario, & che
non erano posti per caratteri di numeri da gli Aarithmetici,; & conchiudendo, dice,
che quello che dinota numero, è gouvernato dalla discreta quantitaà, & che tali numeri Mmusici debbono essere dimostrati per le zifre numerali, & non per,  , neé per.
, neé per.  .,
le quali sono figure che s'appartengono alla continouva quantitaà;, Ttrallequali quantitaà, cioeè tralla continouva, èe la discreta, non è poca contrarietaà.
.,
le quali sono figure che s'appartengono alla continouva quantitaà;, Ttrallequali quantitaà, cioeè tralla continouva, èe la discreta, non è poca contrarietaà.
OPPOSITIONE.
 ., & quest'altro.,
., & quest'altro.,  ., faccia proportione doppia, Ddannoi è
risposto, che se egli non ha uveduto di cioò special regola, o trattato, che noi l'habbiamo trouvato nelle compositioni de' dotti musici nostri predecessori, & percheé egli dice, parlando Ggeometricamente, cioeè secondo la quantitaà apparente, che il Ssemicir-colo neé l'altra sua parte uguale non potranno fare doppia proportione, conciosia
che l'emispero [sic: hemisphero], o Ssemicircolo sia una figura Ggeometrica, & la metà d'un circolo,
Qquesto dannoi è conceduto parlando quanto alla Ggeometria, la qual consideratio-ne intorno la materia nostra è di souverchio, percheé essendo tal nostra consideratio-ne della musica, Ii Mmusici non giudicano il circolo, neé il semicircolo secondo la for-page 46ma, & la quantitaà apparente, Mma pigliono esso circolo, e 'l semicircolo, come egli
afferma, per tempo ternario, & binario,. aAppresso egli uvuole, che il Mmusico non
possa porre questo segno del ternario.
., faccia proportione doppia, Ddannoi è
risposto, che se egli non ha uveduto di cioò special regola, o trattato, che noi l'habbiamo trouvato nelle compositioni de' dotti musici nostri predecessori, & percheé egli dice, parlando Ggeometricamente, cioeè secondo la quantitaà apparente, che il Ssemicir-colo neé l'altra sua parte uguale non potranno fare doppia proportione, conciosia
che l'emispero [sic: hemisphero], o Ssemicircolo sia una figura Ggeometrica, & la metà d'un circolo,
Qquesto dannoi è conceduto parlando quanto alla Ggeometria, la qual consideratio-ne intorno la materia nostra è di souverchio, percheé essendo tal nostra consideratio-ne della musica, Ii Mmusici non giudicano il circolo, neé il semicircolo secondo la for-page 46ma, & la quantitaà apparente, Mma pigliono esso circolo, e 'l semicircolo, come egli
afferma, per tempo ternario, & binario,. aAppresso egli uvuole, che il Mmusico non
possa porre questo segno del ternario.  . contro a quest'altro del binario.
. contro a quest'altro del binario.  .
per crear la sesqualtera proportione, Mma ha oppenione che il Mmusico, quando uvor-raà dimostrare qualche proportione ne' suoi canti, debba adoperare le zifre, o figure
numerali da gli Aarithmetici usate, Iintorno al qual parere, dico, che l'usare i nume-ri eè in potestaà, & arbitrio del musico, neé percioò si fa pregiuditio alla Aarithmetica,
che bencheé sia lecito al Mmusico sapere Aarithmetica, egli non è peroò sforzato di usarla, se non quanto allui piace, & bisogna, Ppercheé se il Mmusico ne' suoi canti puoò di-mostrare per lo suo circolo, & per lo semicircolo la proportione cadente tra le sue
figure cantabili, non gli è dibisogno andar togliendo le zifre d'altrui.
.
per crear la sesqualtera proportione, Mma ha oppenione che il Mmusico, quando uvor-raà dimostrare qualche proportione ne' suoi canti, debba adoperare le zifre, o figure
numerali da gli Aarithmetici usate, Iintorno al qual parere, dico, che l'usare i nume-ri eè in potestaà, & arbitrio del musico, neé percioò si fa pregiuditio alla Aarithmetica,
che bencheé sia lecito al Mmusico sapere Aarithmetica, egli non è peroò sforzato di usarla, se non quanto allui piace, & bisogna, Ppercheé se il Mmusico ne' suoi canti puoò di-mostrare per lo suo circolo, & per lo semicircolo la proportione cadente tra le sue
figure cantabili, non gli è dibisogno andar togliendo le zifre d'altrui.
RESSOLVUTIONE.
 . &.
. &.  ., per dimo-strare il suo numero ternario, & il binario,. Ma egli ha creduto, che la uvertuù del-l'annouverare consista solamente nelle figure dello Aarithmetico, la qual cosa è falsa,
perciocheé noi uveggiamo che, tutto che l'arte dell'Aarithmetica sia una sola, et l'istes-sa, nondimeno appresso di molti con diuversi carratteri, &, segni ella, è significata,
et dimostrata, perciocheé uveggiamo i Greci hauvere le lor figure differenti da quelle
de' Latini, & similmente gli Hebrei, & altre nationi, le quali, tutto che con uvari caratteri, la ne dimostrino, et dichiarino, non dimeno tutte ugualmente la ne credono, et
tengono la medesima,. Similmente se il Mmusico dimostra il suo ternario per lo circolo, & il binario per lo semicircolo, dallui non è peroò stimato, che tali numeri siano
diuversi in uvertuù, & quantitaà da' numeri dalli Aarithmetici usati, & considerati,. Il
medesimo uveggiamo dalla forma delle lettere del nostro Aalphabeto, & di quelle de'
Greci, & di altre lingue, le quali quantunque di figura & di apparenza siano tra
seé differenti, & dissimili, esse peroò in uvertuù, & uvalore sono le istesse, & fanno il
medesimo effetto, & operatione, siì come si uvede in queste lettere, δ, γ, le quali,
come che con queste, d, g, non habbiano somiglianza de forma, nondimeno le pri-me l'istesso si uveggono operare appresso di Greci, che le seconde si facciano appres-so de' Latini, & de' nostri. Oltre di cioò, siì come la unitaà cosiì segnata., i1., senza mutar
la forma di essa altramente, alcuna uvolta è intesa per principio del numero, & al-page 47cuna uvolta dimostra numero, Ssimilmente il circolo, & il semicircolo del Mmusico è
alcuna uvolta inteso per tempo perfetto, & imperfetto, & alcuna per termine pro-portionato. Appresso dice il detto eccellente mM. Gioan Spadaro, che il Mmusico po-ne in due maniere la pausa occupante la metà dello spatio, cioè discendendo, &
ascendendo, come è la pausa della semibreuve, & la pausa della minima, & sottogiogne, che egli è manifesto che, quanto alla continouva quantitaà, tra le predette due pause non ha differenza alcuna apparente, ma quanto alla uvaluta, che dal musico è inteso che la pausa de la detta semibreuve comprenda in seé tre uvolte quella della mini-ma, & qualche uvolta due,. fFinalmente conchiude, che essendo la pausa della minima,
la quale è la metà di quella della semibreuve, seguiteraà, che la detta metà, che è la
medesima figura, saraà differente da seé stessa,. Inteso dannoi il fondamento, & le ragioni del sopradetto, si puoò conoscere, che questi duoi semicircoli.,
., per dimo-strare il suo numero ternario, & il binario,. Ma egli ha creduto, che la uvertuù del-l'annouverare consista solamente nelle figure dello Aarithmetico, la qual cosa è falsa,
perciocheé noi uveggiamo che, tutto che l'arte dell'Aarithmetica sia una sola, et l'istes-sa, nondimeno appresso di molti con diuversi carratteri, &, segni ella, è significata,
et dimostrata, perciocheé uveggiamo i Greci hauvere le lor figure differenti da quelle
de' Latini, & similmente gli Hebrei, & altre nationi, le quali, tutto che con uvari caratteri, la ne dimostrino, et dichiarino, non dimeno tutte ugualmente la ne credono, et
tengono la medesima,. Similmente se il Mmusico dimostra il suo ternario per lo circolo, & il binario per lo semicircolo, dallui non è peroò stimato, che tali numeri siano
diuversi in uvertuù, & quantitaà da' numeri dalli Aarithmetici usati, & considerati,. Il
medesimo uveggiamo dalla forma delle lettere del nostro Aalphabeto, & di quelle de'
Greci, & di altre lingue, le quali quantunque di figura & di apparenza siano tra
seé differenti, & dissimili, esse peroò in uvertuù, & uvalore sono le istesse, & fanno il
medesimo effetto, & operatione, siì come si uvede in queste lettere, δ, γ, le quali,
come che con queste, d, g, non habbiano somiglianza de forma, nondimeno le pri-me l'istesso si uveggono operare appresso di Greci, che le seconde si facciano appres-so de' Latini, & de' nostri. Oltre di cioò, siì come la unitaà cosiì segnata., i1., senza mutar
la forma di essa altramente, alcuna uvolta è intesa per principio del numero, & al-page 47cuna uvolta dimostra numero, Ssimilmente il circolo, & il semicircolo del Mmusico è
alcuna uvolta inteso per tempo perfetto, & imperfetto, & alcuna per termine pro-portionato. Appresso dice il detto eccellente mM. Gioan Spadaro, che il Mmusico po-ne in due maniere la pausa occupante la metà dello spatio, cioè discendendo, &
ascendendo, come è la pausa della semibreuve, & la pausa della minima, & sottogiogne, che egli è manifesto che, quanto alla continouva quantitaà, tra le predette due pause non ha differenza alcuna apparente, ma quanto alla uvaluta, che dal musico è inteso che la pausa de la detta semibreuve comprenda in seé tre uvolte quella della mini-ma, & qualche uvolta due,. fFinalmente conchiude, che essendo la pausa della minima,
la quale è la metà di quella della semibreuve, seguiteraà, che la detta metà, che è la
medesima figura, saraà differente da seé stessa,. Inteso dannoi il fondamento, & le ragioni del sopradetto, si puoò conoscere, che questi duoi semicircoli., 
 ., dato che se-condo la loro forma siano uguali, essi peroò per la loro diuversa apparenza, ouvero positione sono dal Mmusico considerati producere diuversi effetti intorno le figure loro
cantabili., Ddalle quai cose si raccoglie, che il semicircolo, secondo che egli si trouva
posto, è preso qualche uvolta da i Mmusici per assegnare il uvalore alle note cantabili,
& qualche altra per leuvare il detto uvalore loro, perciocheé questi segni.,
., dato che se-condo la loro forma siano uguali, essi peroò per la loro diuversa apparenza, ouvero positione sono dal Mmusico considerati producere diuversi effetti intorno le figure loro
cantabili., Ddalle quai cose si raccoglie, che il semicircolo, secondo che egli si trouva
posto, è preso qualche uvolta da i Mmusici per assegnare il uvalore alle note cantabili,
& qualche altra per leuvare il detto uvalore loro, perciocheé questi segni., 
 ., dan-no il numero alle figure, siì come al contrario questi
., dan-no il numero alle figure, siì come al contrario questi  le ne priuvano, imperocheé
recano la nota in un certo essere, & stato secondo il uvolere del cantore,. Et per
tanto egli è da dire, che questo semicircolo riuvolto.,
le ne priuvano, imperocheé
recano la nota in un certo essere, & stato secondo il uvolere del cantore,. Et per
tanto egli è da dire, che questo semicircolo riuvolto.,  ., dalli antichi sia stato inte-so per lo doppio di questo.:
., dalli antichi sia stato inte-so per lo doppio di questo.:  . Peroò, se tal ordine da loro rettamente è stato compre-so, non ha dubbio, che quello che dannoi a loro somiglianza, è futo trattato, conuve-neuvolemente non sia stato detto.
. Peroò, se tal ordine da loro rettamente è stato compre-so, non ha dubbio, che quello che dannoi a loro somiglianza, è futo trattato, conuve-neuvolemente non sia stato detto.
OPPENIONE XIII.
 , ta-gliato, & non tagliato., Lla quale era, che essi non potessono producere insie-me paragonati la doppia proportione, neé altra spetie, conciosia che essi non possano
far l'effetto di caratteri numerali in dimostrare alcuna proportione, & diceano,
che il semicircolo uvergolato, o tagliato, partorisce una diminutione simile alla pro-portione doppia nelle sue figure, & che comparando il detto semicircolo tagliato
al semicircolo non tagliato, le note, ouvero sillabe, di esso restano considerate nella di-minutione della metà del suo uvalore,. Appresso da loro era detto, che i seguenti se-gni non erano considerati nella proportione Ssesqualtera, come qui.,
, ta-gliato, & non tagliato., Lla quale era, che essi non potessono producere insie-me paragonati la doppia proportione, neé altra spetie, conciosia che essi non possano
far l'effetto di caratteri numerali in dimostrare alcuna proportione, & diceano,
che il semicircolo uvergolato, o tagliato, partorisce una diminutione simile alla pro-portione doppia nelle sue figure, & che comparando il detto semicircolo tagliato
al semicircolo non tagliato, le note, ouvero sillabe, di esso restano considerate nella di-minutione della metà del suo uvalore,. Appresso da loro era detto, che i seguenti se-gni non erano considerati nella proportione Ssesqualtera, come qui.,  .,
.,  ., percheé
il Ssemicircolo è segno di tempo imperfetto, & solamente diuvide la breuve in due semibreuvi, & tutto il rimanente del canto, Eet similmente, che la figura circolare è se-gno di tempo perfetto, & separa la breuve in tre semibreuvi, Eet in altre, che tali se-gni bene dimostrano la quantitaà loro, & il processo ternario, & il binario nelle semibreuvi, ma che non possono far diminutione, neé accrescimento alcuno apparte-page 48nente alla proportione, le sentenze, & fondamento de' quali dimostreremo non esse-re di momento niuno, perciocheé essi si fondano solamente nell'essercitatione.
., percheé
il Ssemicircolo è segno di tempo imperfetto, & solamente diuvide la breuve in due semibreuvi, & tutto il rimanente del canto, Eet similmente, che la figura circolare è se-gno di tempo perfetto, & separa la breuve in tre semibreuvi, Eet in altre, che tali se-gni bene dimostrano la quantitaà loro, & il processo ternario, & il binario nelle semibreuvi, ma che non possono far diminutione, neé accrescimento alcuno apparte-page 48nente alla proportione, le sentenze, & fondamento de' quali dimostreremo non esse-re di momento niuno, perciocheé essi si fondano solamente nell'essercitatione.
OPPOSITIONE.
 ., dimostra la proportione dop-pia, percheé come disopra habbiamo detto, essendo comparato al semicircolo non ta-gliato, le sue cantabili figure restano considerate la metà manco del loro uvalore,.
Appresso, la detta proportione si puoò dimostrare per gli numeri, come qui, 2/1, 4/2, Ppercheé ogni figura sotto tali termini numerali segnata, in comparatione delle poste
inanzi àa seé uvicine, resta con la metà del suo uvalore considerata.
., dimostra la proportione dop-pia, percheé come disopra habbiamo detto, essendo comparato al semicircolo non ta-gliato, le sue cantabili figure restano considerate la metà manco del loro uvalore,.
Appresso, la detta proportione si puoò dimostrare per gli numeri, come qui, 2/1, 4/2, Ppercheé ogni figura sotto tali termini numerali segnata, in comparatione delle poste
inanzi àa seé uvicine, resta con la metà del suo uvalore considerata.
RESOLVUTIONE.
 ., sono cantate ugualmente col-le semibreuvi di questo segno ,
., sono cantate ugualmente col-le semibreuvi di questo segno ,  ., Aa che rispondiamo, che gli è la uveritaà,. pPeroò il buon
Mmusico non dee dannare l'arte, per compiacere alla semplice essercitatione, percio-cheé egli puoò bene, scriuvendo in Mmusica, seruvare alla Ttheorica la propietaà, & tutto
quello che è suo, sanza derogare in cosa uveruna alla prattica, & per tal modo il detto potraà sodisfare all'una, & all'altra, & quello, che a ciascuna di esse si conuviene,
loro conseruvare,. oOnde per le ragioni addotte, gli antiche & dotti Mmusici sesquialte-rauvano le note di questo segno.,
., Aa che rispondiamo, che gli è la uveritaà,. pPeroò il buon
Mmusico non dee dannare l'arte, per compiacere alla semplice essercitatione, percio-cheé egli puoò bene, scriuvendo in Mmusica, seruvare alla Ttheorica la propietaà, & tutto
quello che è suo, sanza derogare in cosa uveruna alla prattica, & per tal modo il detto potraà sodisfare all'una, & all'altra, & quello, che a ciascuna di esse si conuviene,
loro conseruvare,. oOnde per le ragioni addotte, gli antiche & dotti Mmusici sesquialte-rauvano le note di questo segno.,  ., comparate al seguente.,
., comparate al seguente.,  ., percheé per un tempo
di questo.,
., percheé per un tempo
di questo.,  ., pronontiauvano due semibreuvi, & sotto questo.,
., pronontiauvano due semibreuvi, & sotto questo.,  ., ne passauvano tre, la
qual cosa è impossibile, uvolendo procedere per uvie ragioneuvoli, che altrimenti sia
considerata, non ostante che dannoi sia stato in contrario osseruvato, al cap. 38. del
primo libro del nostro Toscanello, non ad altro fine, che per osseruvare quello, che
molti innanti [sic: innanzi] noi hanno usato. For a discussion of the shift from equal minim to equal breve, see Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller,
A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 187.
., ne passauvano tre, la
qual cosa è impossibile, uvolendo procedere per uvie ragioneuvoli, che altrimenti sia
considerata, non ostante che dannoi sia stato in contrario osseruvato, al cap. 38. del
primo libro del nostro Toscanello, non ad altro fine, che per osseruvare quello, che
molti innanti [sic: innanzi] noi hanno usato. For a discussion of the shift from equal minim to equal breve, see Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller,
A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 187.
OPPENIONE XIIII.
OPPOSITIONE.
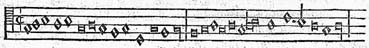
RESSOLVUTIONE.
 mi acuto, & per opposito, sempre si debba cantare per la figura del
b
mi acuto, & per opposito, sempre si debba cantare per la figura del
b molle,. nNulla dimeno ogni regola puoò patire eccettione, conciosia cosa che egli si
uvogliano uvariji effetti considerare,. pPer tanto diremo, che tali tritoni potranno ret-tamente dal cantore essere pronontiati et tollerati, percheé sono composti, & dimezzati da alcune note, le quali mettono tempo, per modo che la durezza, & dissonanza loro, la qual nasce da gli stremi, non è sentita, & poco offende gli uditori, per
laqual cosa, se dall'uno stremo all'altro saraà dimezzamento, ouvero compositione di
alcune note, per essere lontana la sillaba mi dal fa, potrai senza commettere errore
procedere all'uno, & all'altro modo, come saraà in tuo piacimento,. Ma se saranno
composti, o dimezzati per una sola sillaba, o nota, ouvero per uno solo interuvallo, senza dubbio essi non saranno tollerati, imperocheé gli stremi sono troppo prossimani,
& uvicini, nella qual cosa la regola non patiraà eccettione, come la figura seguente
dimostra.
molle,. nNulla dimeno ogni regola puoò patire eccettione, conciosia cosa che egli si
uvogliano uvariji effetti considerare,. pPer tanto diremo, che tali tritoni potranno ret-tamente dal cantore essere pronontiati et tollerati, percheé sono composti, & dimezzati da alcune note, le quali mettono tempo, per modo che la durezza, & dissonanza loro, la qual nasce da gli stremi, non è sentita, & poco offende gli uditori, per
laqual cosa, se dall'uno stremo all'altro saraà dimezzamento, ouvero compositione di
alcune note, per essere lontana la sillaba mi dal fa, potrai senza commettere errore
procedere all'uno, & all'altro modo, come saraà in tuo piacimento,. Ma se saranno
composti, o dimezzati per una sola sillaba, o nota, ouvero per uno solo interuvallo, senza dubbio essi non saranno tollerati, imperocheé gli stremi sono troppo prossimani,
& uvicini, nella qual cosa la regola non patiraà eccettione, come la figura seguente
dimostra.
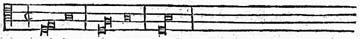

OPPENIONE XV.
OPPOSITIONE.
RESOLVUTIONE.
LIBRO TERZO
DICHIARATIONE DEL TEMPO MVUSICO DET-TO NATVURALE, ET ACCIDENTALE. CAP. I.
Risposta allo eccellente dDon Franchino intorno alcune sue oppe-nioni. Capitolo II.
diminute sesqualte-rate,.Et a questo modo secondo sua eEccellenza ci sarebbono due sorti di sesqualtera, cioè una propia, & l'altra per certa diminutione di una terza parte, Pper la qual cosa secondo lui la propria staraà per seé, & saraà chiaramente intesa per questi ter-mini comparati, 3/2, & altri simili,; Ll'altra nasceraà dal pieno alle figure assegnate disopra dette,. Et la prima dallui è chiamata propia, per non essere altro sesqual-tera ne' primi numeri, che quando tre figure si fanno equali a due, come i termini disopra dimostrano,. Et la seconda delle tre semibreuvi piene, saraà dallui detta impro-pria, Eet questo adiuviene, percheé ella non si dimostra in cifre numerali, ma dal pie-no delle figure cantabili, il quale leuva alle dette tre note piene tanto di uvirtuù, o uva-lore, che restano solamente in quantitaà di due uvacue,. Et dato che le dette due sesqualtere siano dimostrate per segni diuversi, non saranno peroò tra loro diuverse proprietaà, percheé per questi termini, 3/2, comparati, si conosce, che le tre note bianche, han-no solamente la uvertuù di due di quelle, che loro innanzi sono poste:; & per tal ra-gione i predetti termini comparati, & il nero alle figure assegnato non producono diuversi effetti,. Et peroò sarebbe errore a credere, chella forza consista nel segno, & non nella cosa segnata, percheé siì come il segno del merciaio, o d'altri non è cagione, chella merce sia uvenduta, ma quiuvi stàa per dar a conoscere qual sia di essa il signore, cosiì questi termini, 3/2, stanno per segno della sesqualtera, & non sono peroò essi se-squaltere, ma le figure nel loro sesqualtero uvalore pronontiate saranno essa sesqualte-ra,; & come il uvendere della merce puoò essere per uvari segni dimostrato, cosiì anchora la sesqualtera per uvariji segni puoò essere notata, Eet questi segni appresso i Mmusici si fanno in dui modi, cioè con cifre, & con note piene, bencheé da gli antichi essa se-squaltera era qualche uvolta dimostrata per lo circolo, & lo semicircolo tra loro comparati. dDalle sopradette ragioni conuvinto, sua Reuverenza non pote negare chel-la sesqualtera non si segnasse con le figure piene, imperocheé al cap. 5. del Qquarto libro della sua pPratica, conchiudendo, dice cosiì,:
Quello fra questo mezzo general-mente è da douver essere auvertito, chella sequaltera [sic: sesqualtera] di note nere non dee co' suoi nume-ri essere notata, acciocheé per sorte non incorressino, in questo inconuveniente di se-gnare due sesquialtere,Aalle quai parole dannoi fu auvertito, che se le figure piene non si debbono chiamare sesqualterate, ma diminute, ouve egli disopra ha detto se-squialtera di note nere, egli douvea dire sesquialtera di note diminute,. Ma questo egli non disse, percheé conuviene pur in fine, chella uveritaà stia disopra, Lla qual sentenza anchora è stata confermata da Gioan Tintori in quel suo tTrattato di proportione, laà douve trattando della sesqualtera, dice, Cchella sesqualtera ha altri segni che li so-pradetti, la qual cosa puoò ragioneuvolmente stare;. Conchiuderemo adunque, che siì page 57come le figure piene per seé non sono sesqualterate, similmente le figure uvacue in tal segno 3/2 non potranno essere per seé sesqualterate, ouve giaà ad altre figure non fossero comparate,. Et quello, che è proprio alle uvacue, saraà anchora proprio alle piene, & incontrario,. Alcuni studiosi sono stati a contentione, quale di dui segni predetti habbia piuù efficacia, & hanno conchiuso il pieno essere piuù efficace delle zifre cosiì po-ste, 3/2, & questo dicono auvenire, percheé il pieno è congionto col suo effetto, per essere nelle figure sesqualterate posto, Eet le cifre, le quali sono disgiunte dalle figu-re da loro dimostrate, potranno anche per seé stare altrouve senza quiuvi causare alcuno effetto, ma il pieno non mai. Medesimamente da sua Reuverenza fui ripreso, quando da noi fu detto, che ogni musico interuvallo per seé stesso nella corda sonora puoò essere misurato, dicendo, che pensauva che fusse la uveritaà parlando Ggeometrica-mente, ma che Aarithmeticamente, cioè secondo la proportione del numero intero, & manifesto, che egli non credea, che si potesse trouvare nella corda sonora la misu-ra del Ssemituono minore, neé del magiore [sic: maggiore], neé del Ddiesi, neé del Ccoma, neé del Ddittono, neé del Ssemidittono, cosiì a puntino, ma che bene le si potraà andar appresso al segno, al-laqual oppenione da noi fu risposto, che sua rReuverenza s'inganauva molto, creden-do, che gli interuvalli predetti solamente si potessono hauvere ciascuno per seé nella sonora corda Ggeometricamente & non Aarithmeticamente, conciosia cosa che egli faceuva del ragioneuvole irragioneuvole, & del lecito non lecito, percheé egli uvoleuva, che essi interuvalli si potessono dimostrare per ragioni Ggeometriche, le quali non hanno nome neé misura, & non per ragione Aarithmetica, la quale ha nome, & misura, Iintorno la qual cosa certamente sua rRiuverenza era fuori di ogni ragione, conside-rando che egli non uvoleuva che i sopradetti interuvalli, e quali ne' numeri hanno certa & denominata proportione, si potessono per seé numerare nella corda sonora, se non, per ragioni Ggeometriche, le quali appaiono, & non sono, percheé la musica non le riceuve,. Et cheé sia il uvero, egli si trouva per regola stabilissima, & ferma, che quan-do nella corda sonora uvogliamo hauvere l'interuvallo di qualche euvidente proportio-ne, che tutta la lunghezza della corda si parte per lo numero maggiore, & da poi si fa comparatione da esso al minore,. sSe nella corda uvogliamo introducere la sesqui-altera, la quale produce il Ddiapente, peroò egli eè di mestieri, chella corda sia diuvisa in tre parti uguali, & che dapoi il suono. 3. sia refferito al suono delle due parti, & per tal modo si potraà hauvere lo spatio del minor semituono per seé, il qual cade tra questi termini comparati., 256. ad. 243. Et se tutta la corda saraà diuvisa, ouvero partita in. 256. parti eguali, et dapoi il suono generato da quella saraà ref-ferto al suono. 243., haremo tal semituono minore per seé formato,. Et cosiì anchora accaderaà de gli altri interuvalli, iquali disopra sono nominati.
Oppositione fatta del eccellentissimo Messer Gioanni Spadaro, & da noi confermata. Cap. III
Egli non fu mai piuù udito, che una distanza, la quale habbia chiara, & denominata proportione, non si potesse per seé trouvare Ggeometrica, et Aarithmeticamete nella sonora corda, percheé quello, che per numeri è apparente, si puoò anchora trouvare nella con-tinouva quantitaà, laà douve tutto quello, che se puoò dimostrare nella continouva quantitaà non puoò giaà per numeri essere dimostrato, conciosia cosa che gli numeri siano infiniti, et l'altra manca di misura, et sia finita,come dimostra Iacopo fFabro dal detto Franchino allegato,. Et percheé sua rReuverenza allegauva Guido mMonaco dicendo, che 'l semituono e 'l semidittono, & il dittono non si poteuvano per seé formare nel Mmonacordo, ma che si poteuva bene loro andare appresso al segno, per laqual cosa concedeuva, che per seé tali distanze potessero hauvere diuvisione nel Mmonacordo, per-cheé niuno Sstormento essercitato colla mano non puoò arriuvare insino alla integritaà della perfettione di tali consonanze, ma che bene si potea tanto accostare alla per-fettione di quelle, che lo audito, come quello, che non puoò comprendere tal imperfet-tione, resterebbe contento,. A tal suo parere da noi si risponde in questo modo, che egli è la uveritaà, che Guido Monaco al cap. 6. nel Microcologo [sic: Micrologo] dice cosiì,:
Tutto che il semituono e 'l dittono, et il semidittono siano cantati, nondimeno non riceuvono niu-na diuvisione,per le quali parole Guido non dice, che tale distanze non possano esser condotte per seé nel Mmonacordo con nota, & certa misura, ma si iscusa, che per la diuvisione fatta nel quinto precedente capitolo, tali distanze tacitamente sono forma-te, & prodotte con piuù facilitaà, che non sarebbe auvenuto, se fossero state per seé essercitate, perciocheé nel predetto cap., egli partendo la corda solamente in due, in tre, in quattro, & in nouve parti, ha assegnato in essa corda tutti gli interuvalli nel Mmonacordo necessari, & con tal facile modo procedendo, leuva la faticosa diuvisione, la quale nascerebbe nel formare per seé nel Mmonacordo i predetti interuvalli, Ppercheé uvolendo hauvere nel Mmonacordo lo spatio intiero di duoi Ttoni sesquiottauvi, bisognereb-be diuvidere la corda in. 81. parti uguali, & dapoi refferire il suono. 81. al suo-no. 64., & all'opposito,. pPer tal modo sarebbe necessario essercitarsi circa gli altri interuvalli, cioè del minore & del maggiore semituono, del diesi, del coma, & del semidittono, le quali diuvisioni, dato che siano laboriose, pur nondimeno si possono trouvare, & per seé formare, percheé la loro proportione è chiara, & nota, & commensu-rabile, & ne' numeri constituita. oOnde Guido dice, che non possono per seé riceuvere diuvisione, percheé essa resta apparente dopo la facile diuvisione del Ddiapason, del Ddia-pente, del Ddiatessaron, et del Ttuono. lLe sopradette sentenze dello eccellente mMesser Gioanni non sono publicate, ma dallui ci furno scritte, & da noi considerate, & con-fermate.For a commentary on this passage, see Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 96.
Dichiaratione del Ccontrapunto. Cap. IIII.
il concento, ouvero modulatione è uno corpo, il quale ha in seé diuverse parti accommodate alla cantilena disposta tra uvoci distanti per interuvalli commensurabili,& che
questo è detto Ccontrapunto, percheé sempre si considera un punto contro a un altro, o uveramente una uvoce contro un'altra,Pper la qual cosa egli è da considerare che da Gioan tTin-tori, secondo la sua diffinitione, è stato inteso, che 'l Ccontrapunto occorra, ouvero sia, quando due uvoci, o note, o piuù, siano poste in modo che una simile nel cantare uvada, o risponda a un'altra sua simile in nome, ouvero in uvertuù, & uvalore, come breuve contro a breuve, ouvero altra nota, la quale per qualche accidente habbia il uvalore di es-sa breuve, Eet cosiì delle altre note, nella qual sentenza concorre Franchino, douve di-ce, che il Ccontrapunto è per tal modo nominato, percheé sempre si considera un punto contro a un'altro, nel qual luogo bisogna bene auvertire intorno quello, che da Franchino è stato detto, cioè che 'l concento è quello, che è detto Ccontrapunto, Pper laqual cosa pare, che egli contradica in questa seconda autoritaà àa quello che ha detto di sopra, Iimperocheé bisognauva, che egli facesse differenza tra il concento, il quale procede per la nota simile contro la sua simile, & il concento, il quale cade tra molte note tra seé simili, ouvero dissimili, come accade nel diminuire delle note, il qual mo-do di comporre si usa ne' concenti,; & secondo la diffinitione di Franchino, in tali concenti non caderaà il Ccontrapunto dallui diffinito, percheé la sua diffinitione solo saraà intesa conuvenire a quegli concenti, i quali solamente a nota contra nota simile procedono, douve piuù note, simili o non simili, sono pronontiate per una nota loro dissimile, et è contra,. A corroboratione di cioò dice l'eccellente mMesser Gioan sSpadaro, che egli è da notare, douve Franchino ha detto che il Ccontrapunto ouvero Cconcento, o Mmodula-tione consiste di uvoci intra seé distanti per interuvalli commensurabili, che egli apertamente si contradice a seé stesso in molte sentenze scritte dallui ne' suoi trattati, percheé primieramente laà douve tratta del Ccontrapunto, la sesta [sic: terza] minore & la maggiore, cioè il Ssemidittono, & il Ddittono,, & la sesta minore et la maggiore, cioè il Ddiapente col Ssemituono, & il Ddiapente col Ttuono, dallui sono essercitate, come buone consonan-ze,; Eet poi ne' trattati suoi dice, che tali distanze sono incommensurabili, percheé ca-dono in una incerta proportione, cioè lontana dalla multiplicitaà, & alla sopra par-ticolarità,. Et sottogionge, che il predetto Franchino nel preallegato luogo, seguitando a ciascuna uveritaà, delle terze, & seste predette assegna chiara, & nota propor-tione, apparente per termini, & numeri comparati, la sentenza del quale dice esse-re falsissima, percheé fra le date zifre numerali, ouvero nella discreta quantitaà, comunque elle si sia, o aliena, o non dalla moltiplicità, & sopra particolarità, non si daà page 60proportione incommensurabile, ouvero irrationale, per la qual cosa appare, che da sua Reuverenza sia state [sic: stata] male intesa quella sentenza di Guido mMonaco dallui regi-strata in quel suo cap., percheé da Guido non fu scritto in tal modo, che dallui fosse tenuto, che il Ssemidittono, & il Ddittono non habbiano certa, & nota proportione, & che non si possano condurre et formare per seé nel Mmonacordo musico, come dal-lui nel suo Ttrattato chiamato Postille è stato prouvato,. Ma dal predetto Guido fu scrritto [sic: scritto] per tal modo, che diuvidendo la corda sonora del Mmonacordo in due, in tre, i quuattro [sic: in quattro], & in nouve parti uguali, da tal diuvisione nasce la Ddiapason, la Ddiapente, la Ddiatessaron, & anchora il Ttuono, delle quali distanze facilmente egli si forma, & riduce a perfettione uno Mmonacordo secondo il genere Ddiatonico compito, & diuviso, nel qual Mmonacordo in tal modo partito appare prodotto il Ssemituono, il Ssemidittono, & il Ddittono, & lo spatio di ciascuna delle seste predette, cioè la minore, & la maggiore, senza essere essercitata la loro propia numerosità, & partitione,. Per tanto si dee intendere, chelle parole di Guido predette suonino come qui,:
pPercheé essi siano ammessi nel cantare, nondimeno nel Ccordotono non riceuvono diuvisione, Eet questo adiuviene, percheé tali distanze sono tacitamente prodotte dalle predette partitioni,.Et Bartholomeo Rami, in un certo suo compendio composto in lingua materna dice;, Cche gli antichi diceuvano, che il contrapunto ouvero organizatione non era altro, che considerare la consonanza, che fanno duoi suoni, ouvero due uvoci, o piuù, una piuù acuta, o piuù grauve dell'altra, giuntamete profferite., Aa confermatione della qual cosa l'eccellente, & consumato musico Messer Gioan sSpadaro dice, che 'l medesimo Bartholomeo Rami, suo maestro, nel cap. primo della seconda parte della sua pPratica, dice, che tutto il corpo musico consiste nella distanza dello Ddiapason, la quale cosiste di otto uvoci, ouver suoni, Eet che al Ccontrapunto assai basta dichiarare, come le predette uvoci conuvengono intra loro, & che dapoi procedendo, pone, & colloca le uvoci tra seé equali, ouveramente unisone tra il numero delle consonanze, non percheé intra le uvoci equali, & unisone cada interuvallo, ouvero distanza, ma solamente, percheé sono una medesima cosa, & pari in suono; che tutto che egli dica, che l'unisono non è differente da seé stesso, non peroò egli dice, che l'unisono sia consonan-za, percheé come piace a Boetio, la consonanza non si fa di uvoci simili, le quali sia-no insieme unite in concordia in modo che la loro sonoritaà peruvenga soauve, & gra-ta al senso dell'udire,; Ddapoi che egli dice, che l'unisono stàa in quella guisa nella mu-sica, che sta la unità nella Aarithmetica, perciocheé siì come essa unità no è numero, ma stàa come principio di numero, per tal modo l'unisono non stàa nella musica come consonanza, ma stàa come origine, & fonte delle consonanze, Iintorno la qual cosa an-noi pare, che ciò dal suo precettore sia stato meglio inteso che da Franchino nel se-condo cap. del terzo libro della sua Pratica, douve egli dice, che l'unisono rispetto alle musiche distanze stàa come il punto Ggeometrico rispetto alla linea in Ggeometria, ouvero in continouva quantitaà considerata, Nnella qual cosa Franchino, è in grande er-page 61rore, percheé se l'unisono considerato dal musico ha natura del punto Ggeometrico, egli non potraà hauvere natura, neé similitudine uvera con la unità in Aarithmetica con-siderata,. Et questo auverraà, percheé tra il punto Ggeometrico & la unità Aarithmetica cade non poca contrarietaà, & questo nasce, percheé la unità in producere il nume-ro, ouvero la discreta quantitaà, saraà molte uvolte presa, la qual cosa del punto Ggeome-trico in creare la continua quantitaà non si uvede auvenire,. Laonde, se il numero si uvede non esser altro, che una moltitudine di unità, la linea certamente, o altra continua quantitaà, non potraà constare di moltitudine di punti, ma solamente di dui, fra' quali è tirata,. Similmente la unitaà in arithmetica considerata non potraà in minute parti essere diuvisa, il qual effetto dal punto Ggeometrico per modo uveruno non potraà na-scere, percheé esso punto non è quantitaà, ma è immaginato, siì come è futo affermato da Euclide, laà douve diffinendo esso punto, dice, che 'l punto è quello del quale non ci è parte,. Per le predette Mmathematiche dimostrationi appare, che l'unisono dal Mmusico considerato solamente si potraà assomigliare alla unità, la quale è principio della discreta quantitaà, la quale unità, come disopra è stato detto, potraà esser molte uvolte presa, & fare di seé numero, & anchora potraà essere in parti minute separata, & questo auverrà, percheé il suono, il qual consiste in tempo, & in quantitaà sonora, potraà similmente essere aggregato, & in parti diuviso, come è manifesto comparando il suono grauve al suono acuto, & il suono acuto, al grauve, Iimperocheé, come il suono grauve contiene in seé il suono acuto, cosiì l'acuto saraà parte del suono grauve, come da Aristotile è stato confermato ne' suoi Problemi,. Si potrebbe però conuvene-uvolmente assomigliare l'unisono alla linea Ggeometrica, la quale è una lunghezza senza latitudine, percheé tal lunghezza potraà essere molte uvolte presa, & creare un numero, & moltitudine di linee, & anchora in parti minute potraà essere diuvisa, a similitudine della data, & considerata unitaà in Aarithmetica intesa,. Ma non puoò giaà essere che l'unisono sia paragonato al punto, considerato dal Ggeometrico per prin-cipio della continouva quantitaà, perciocheé, essendo immaginato, non puoò essere quan-titaà, & per consequente saraà indiuvisibile,. Et dato che fosse molte uvolte preso, non sa-raà peroò di seé linea, percheé come è stato detto, la linea è considerata dal punto dal quale, hauvendo origine, è tirata, & non da quello molte uvolte preso, perciocheé ouve cosiì fosse, egli seguiteria, che la linea, & ciascuna altra continouva quantitaà, si potesse risoluvere nel punto, in quel modo, che il numero si puoò risoluvere nella semplice unità, Eet appresso, che tra la continouva, et la discreta quantitaà non cadessero quelle contrarietaà, le quali per loro natura loro sono assegnate da' dotti, et intendenti Mmathematici.
Come il punto non puoò far imperfetta una nota simile inanzi a un'al-tra sua simile. Cap. V.
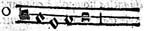 Nnel qual essempio chiaro si conosce, chella breuve, per cagione delle tre semibreuvi segueti, le quali creano un te-po perfetto, resta permanente, intera, e perfetta, ma che traponendosi il punto fra
la prima, & la seconda semibreuve, esso faraà imperfetta la nominata prima breuve,
come qui.
Nnel qual essempio chiaro si conosce, chella breuve, per cagione delle tre semibreuvi segueti, le quali creano un te-po perfetto, resta permanente, intera, e perfetta, ma che traponendosi il punto fra
la prima, & la seconda semibreuve, esso faraà imperfetta la nominata prima breuve,
come qui. 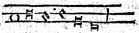 Et questo accaderaà per non hauver essa bre-uve altra nota appresso a seé simile,. Per tanto tal punto non haraà forza, come loro piacer, di dar imperfet-tione mai a una nota a seé simile, come seguitando uvedi.,
Et questo accaderaà per non hauver essa bre-uve altra nota appresso a seé simile,. Per tanto tal punto non haraà forza, come loro piacer, di dar imperfet-tione mai a una nota a seé simile, come seguitando uvedi.,
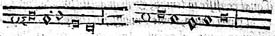 Lla quale oppenione essen-do approuvata dall'eccellente dDon Franchino, al capi-tolo decimo [sic: undecimo] del libro secondo della sua Prattica dice,:
Lla quale oppenione essen-do approuvata dall'eccellente dDon Franchino, al capi-tolo decimo [sic: undecimo] del libro secondo della sua Prattica dice,: Egli è fra questo mez-zo da douver esser inteso, che una nota posta dauvanti ad un'altra sua simile non puoò essere fatta imperfetta,& da noi al capitolo uventesimo nono del pri-mo libro del nostro Toscanello, il medesimo fu dichiarato, per la qual cosa uver-gognensi adunque tutti coloro, i quali tengono, & credono, che tale oppenione possa esser uvera. Ci sono anchora molti, i quali non solamente consentono, & cre-dono che tal similitudine, & perfettione sia manifesta, & ragioneuvole, ma etiandio maggiormente uvogliono, chella detta breuve, posta dinanzi la figura maggiore di seé, sia perfetta, Lla oppenione de' quali chiaramente si uvede essere falsa, perciocheé egli faraà ben di mestieri, che uno fosse rozzo, & senza giuditio a douver credere, che una lunga fosse simile a una breuve, & meno poi la detta breuve a una massima. Pertan-to questo loro argomentare, se una simile posta dauvanti a un'altra simile non puoò essere fatta imperfetta, maggiormente essendo posta dinanzi a una maggiore di seé, non potraà riceuvere imperfettione, Nnon uvale, neé hanno bene apparato Lloica, percio-cheé non trouverranno Mmusico, neé moderno, neé antico, che approuvi questa loro conse-quenza, & oppenione, perciocheé questo non ha luogo se non in quelle note, che sono simili di forma, & di corpo, come habbiamo detto disopra,. Ma pur uvolendo il Ccom-positore far perfetta la nota posta innanzi la maggiore, essa non hauvraà sempre tal perfettione, ma saraà in facoltaà del Mmusico, & secondo piaceraà allui, come essami-nando molte compositioni in quelle, cosiì in note, come in pause trouverrai, & come la figura seguente ti mostra. page 63
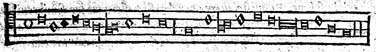
 non peroò saraà simile
la apparente pausa, ma saraà simile al suo proprio uvalore, percheé la forma della
pausa non ha similitudine colla figura breuve, la qual perfettione dicono essere piuù
ferma alle due, tre, o quatro breuvi continouvate, che alla breuve, & alla sua pau-sa, le quali sentenze, & oppenioni non saranno da noi per modo alcuno concedu-te, neé approuvate, bencheé ne' trattati nostri sia in contrario dichiarato, non affine
di dare quello, che quiuvi scrissi, per regola, ma piuù tosto per modo di disputare,
perciocheé la pausa della breuve resta permanente, ferma, & stabile, come quella che
sempre si dimostra perfetta, & imperfetta, senza cangiar forma, come fa quella
della lunga, la quale per seé si muta, & uvaria.
non peroò saraà simile
la apparente pausa, ma saraà simile al suo proprio uvalore, percheé la forma della
pausa non ha similitudine colla figura breuve, la qual perfettione dicono essere piuù
ferma alle due, tre, o quatro breuvi continouvate, che alla breuve, & alla sua pau-sa, le quali sentenze, & oppenioni non saranno da noi per modo alcuno concedu-te, neé approuvate, bencheé ne' trattati nostri sia in contrario dichiarato, non affine
di dare quello, che quiuvi scrissi, per regola, ma piuù tosto per modo di disputare,
perciocheé la pausa della breuve resta permanente, ferma, & stabile, come quella che
sempre si dimostra perfetta, & imperfetta, senza cangiar forma, come fa quella
della lunga, la quale per seé si muta, & uvaria.
Come il cantore dee osseruvare la misura ne' segni de' modulati con-centi dal Mmusico, & Ccompositore ordinati. Cap. VI.
 , a loro beneplacito, la qual misura
non saraà quella, che al segno si conuviene, neé che dal Mmusico è considerata, come in
molti canti si ritrouva, i quali haranno nel principio il segno diminuto di sopra mostrato, per lo qual segno essi danno la misura sopra la semibreuve, & questo incon-uveniente commettono per poter con piuù loro facilitaà cantare,. Et per tal modo in-corrono in errore, & in non poca confusione, percheé la misura, che essi tengono
nella semibreuve, uverrà a dannare quello, che dal Ccompositore è inteso, & immaginato, conciosia cosa che dopo molte note nasceraà una sesqualtera habitudine, Pper
laqual cosa io uvorrei un poco, che mi dicessero questi tali, che danno la misura so-pra una semibreuve per battuta, poscia che saranno giunti alla detta sesqualtera, che
proportione saraà quella? Certo non si puoò dire che essa habbia da essere sequaltera [sic: sesqualtera], ma tripla siì bene,. Et questo auverraà percheé essi passeranno tre semibreuvi so-pra la battuta della detta semibreuve, Llaqual cosa è falsissima,. lLaà onde ti saraà ne-cessario auvertire, & dare la misura ouver battuta nel segno sopradetto nella figu-ra breuve, & non nella semibreuve, & cosiì passeranno nella sesqualtera tre semibre-uvi per una battuta contra le due semibreuvi, o contro una breuve del segno diminuto,
o tagliato,. Et quanti ce ne sono anchora, che cantando tal segno per una semibre-uve per battuta, giunti alla sesqualtera, muteranno misura per accomodarsi a quella
della sesqualtera, per gli quali inconuvenienti ci è paruto cosa conuveneuvole chia-rire tal modo, & misura, peroò le [sic: li] diciamo essa non essere altro, che una lunghez-za finita per equali interuvalli, la qual misura, ouvero modo di misurare in questa
facoltaà di Mmusica è considerata in dui modi, cioè annouverando le note cantabili, et
non cantibili dal principio del canto insino al fine secondo il uvalore della nota a seé
maggiore propinqua, cioè cogliendo insieme tre minime per una semibreuve perfet-ta, & due per una imperfetta, Eet similmente tre semibreuvi per una breuve perfet-ta, & due per una imperfetta, Iil simile facendo delle breuvi rispetto alla lunga, &
delle lunghe rispetto alla massima, la quale non saraà misurata, percheé dopo essa non
si daà nota maggiore, della quale essa massima sia molte uvolte contenuta,; & tale ordine i Mmusici propiamente chiamano misurare, percheé tale ordine, & modo dimo-stra se il canto ha tutto il suo numero, cioè del Mmodo, del Ttempo, & della Pprola-tione, secondo la dimostratione del segno innanzi del canto posto;. La seconda consideratione, & modo di misurare nasce da quella misura, la qual considera il Mmu-sico, ouvero Ccantore, quando esso leuva, & abbassa la mano, o anchora il piede, il
quale inalzamento, & abbassamento i phisici chiamano Ssistole, & Ddiastole,. pPer-tanto a colui, il quale desidera rettamente misurare, & cantare, saraà di necessità,
che cantando, in atto ouvero nella mente consideri un certo mouvimento, & battuta
inuvariabile, ouve tutte le note proportioneuvolmente si riduchino, al qual moto, ouver
misura è stato ordinato da' dotti, chelle figure, o note di ciascuno segno debbano mi-suratamente concorrere, per la qual cosa il presente segno.,
, a loro beneplacito, la qual misura
non saraà quella, che al segno si conuviene, neé che dal Mmusico è considerata, come in
molti canti si ritrouva, i quali haranno nel principio il segno diminuto di sopra mostrato, per lo qual segno essi danno la misura sopra la semibreuve, & questo incon-uveniente commettono per poter con piuù loro facilitaà cantare,. Et per tal modo in-corrono in errore, & in non poca confusione, percheé la misura, che essi tengono
nella semibreuve, uverrà a dannare quello, che dal Ccompositore è inteso, & immaginato, conciosia cosa che dopo molte note nasceraà una sesqualtera habitudine, Pper
laqual cosa io uvorrei un poco, che mi dicessero questi tali, che danno la misura so-pra una semibreuve per battuta, poscia che saranno giunti alla detta sesqualtera, che
proportione saraà quella? Certo non si puoò dire che essa habbia da essere sequaltera [sic: sesqualtera], ma tripla siì bene,. Et questo auverraà percheé essi passeranno tre semibreuvi so-pra la battuta della detta semibreuve, Llaqual cosa è falsissima,. lLaà onde ti saraà ne-cessario auvertire, & dare la misura ouver battuta nel segno sopradetto nella figu-ra breuve, & non nella semibreuve, & cosiì passeranno nella sesqualtera tre semibre-uvi per una battuta contra le due semibreuvi, o contro una breuve del segno diminuto,
o tagliato,. Et quanti ce ne sono anchora, che cantando tal segno per una semibre-uve per battuta, giunti alla sesqualtera, muteranno misura per accomodarsi a quella
della sesqualtera, per gli quali inconuvenienti ci è paruto cosa conuveneuvole chia-rire tal modo, & misura, peroò le [sic: li] diciamo essa non essere altro, che una lunghez-za finita per equali interuvalli, la qual misura, ouvero modo di misurare in questa
facoltaà di Mmusica è considerata in dui modi, cioè annouverando le note cantabili, et
non cantibili dal principio del canto insino al fine secondo il uvalore della nota a seé
maggiore propinqua, cioè cogliendo insieme tre minime per una semibreuve perfet-ta, & due per una imperfetta, Eet similmente tre semibreuvi per una breuve perfet-ta, & due per una imperfetta, Iil simile facendo delle breuvi rispetto alla lunga, &
delle lunghe rispetto alla massima, la quale non saraà misurata, percheé dopo essa non
si daà nota maggiore, della quale essa massima sia molte uvolte contenuta,; & tale ordine i Mmusici propiamente chiamano misurare, percheé tale ordine, & modo dimo-stra se il canto ha tutto il suo numero, cioè del Mmodo, del Ttempo, & della Pprola-tione, secondo la dimostratione del segno innanzi del canto posto;. La seconda consideratione, & modo di misurare nasce da quella misura, la qual considera il Mmu-sico, ouvero Ccantore, quando esso leuva, & abbassa la mano, o anchora il piede, il
quale inalzamento, & abbassamento i phisici chiamano Ssistole, & Ddiastole,. pPer-tanto a colui, il quale desidera rettamente misurare, & cantare, saraà di necessità,
che cantando, in atto ouvero nella mente consideri un certo mouvimento, & battuta
inuvariabile, ouve tutte le note proportioneuvolmente si riduchino, al qual moto, ouver
misura è stato ordinato da' dotti, chelle figure, o note di ciascuno segno debbano mi-suratamente concorrere, per la qual cosa il presente segno.,  3., chiamato Mmodo
con Ttempo, per la auttorità [sic: autorità] de' dotti antichi, et moderni insegna dare la misura nel
cantare sopra quella nota chiamata da loro Ttempo, il quale altrimenti è detto breuve,. Et con tal modo ne' segni, ne' quali la breuve saraà dimostrata perfetta, per una
battuta passeraà una breuve pfetta, ouvero il suo uvalore,; Eet in quegli, che harano il modo minor pfetto et impfetto col Ttempo dimostrato impfetto, come i segueti.,
3., chiamato Mmodo
con Ttempo, per la auttorità [sic: autorità] de' dotti antichi, et moderni insegna dare la misura nel
cantare sopra quella nota chiamata da loro Ttempo, il quale altrimenti è detto breuve,. Et con tal modo ne' segni, ne' quali la breuve saraà dimostrata perfetta, per una
battuta passeraà una breuve pfetta, ouvero il suo uvalore,; Eet in quegli, che harano il modo minor pfetto et impfetto col Ttempo dimostrato impfetto, come i segueti.,  2.,
2.,  2.,
sempre la uvera misura caderaà sopra la breuve imperfetta, o due semibreuvi,; Ddi quel-lo che si dee operare ne' dui seguenti segni, come qui,
2.,
sempre la uvera misura caderaà sopra la breuve imperfetta, o due semibreuvi,; Ddi quel-lo che si dee operare ne' dui seguenti segni, come qui,  .,
.,  , assai chiaro al cap. 38.
del primo libro del nostro Toscanello habbiamo scritto;. Ma nel circolo, & nel se-micircolo senza il punto, la battuta, ouvero misura caderaà nella semibreuve, & im-peroò se un Ttenore, o altra parte saraà segnato con uno de' presenti segni,
, assai chiaro al cap. 38.
del primo libro del nostro Toscanello habbiamo scritto;. Ma nel circolo, & nel se-micircolo senza il punto, la battuta, ouvero misura caderaà nella semibreuve, & im-peroò se un Ttenore, o altra parte saraà segnato con uno de' presenti segni,  .,
.,  ., &
che le altre parti di tal canto siano segnate con ciascuno di questi.,
., &
che le altre parti di tal canto siano segnate con ciascuno di questi.,  3.,
3.,  3.,
3.,  2.,
2.,  2.,
alhora una minima di quegli dui segni col punto in mezzo harà tanta uvertuù, & uvapage 65lore, quanto una intera breuve di ciascuno de' quattro segni disopra mostrati,. Et an-chora per una minima de' dui segni puntati, passeraà una semibreuve per battuta di
questi dui non puntati.,
2.,
alhora una minima di quegli dui segni col punto in mezzo harà tanta uvertuù, & uvapage 65lore, quanto una intera breuve di ciascuno de' quattro segni disopra mostrati,. Et an-chora per una minima de' dui segni puntati, passeraà una semibreuve per battuta di
questi dui non puntati.,  .,
.,  . Hauvendo uveduto, & chiaramente compreso la natura,
& forma de' sopradetti segni non diminuti, potrai ageuvolmente intendere quello.
che nel diminuto si contiene, conciosia cosa che egli sia da considerare, che essi se-gni diminuti siano nella loro semplice integrità, come disopra si dimostrano,. pPer-tanto essendo passato una breuve per battuta, se essi saranno diminuti ouver tagliati,
come qui.,
. Hauvendo uveduto, & chiaramente compreso la natura,
& forma de' sopradetti segni non diminuti, potrai ageuvolmente intendere quello.
che nel diminuto si contiene, conciosia cosa che egli sia da considerare, che essi se-gni diminuti siano nella loro semplice integrità, come disopra si dimostrano,. pPer-tanto essendo passato una breuve per battuta, se essi saranno diminuti ouver tagliati,
come qui.,  3.,
3.,  3.,
3.,  2.,
2.,  2., per una battuta, o tempo passeraà nel termine di quella
prima breuve la quantitaà di una lunga, & la battuta, la quale cadeuva sopra la semi-breuve ne' presenti,
2., per una battuta, o tempo passeraà nel termine di quella
prima breuve la quantitaà di una lunga, & la battuta, la quale cadeuva sopra la semi-breuve ne' presenti,  .,
.,  ., nel diminuto caderaà sopra la breuve,; Eet quella, la quale in
questi.,
., nel diminuto caderaà sopra la breuve,; Eet quella, la quale in
questi.,  .,
.,  ., cadeuva sopra la minima, essendo diminuti, caderaà sopra la semibreuve,; Eet questo s'intende sempre ponendo, & passando due figure simili in nome, &
quantitaà del segno diminuto àa comperatione del segno non diminuto.
., cadeuva sopra la minima, essendo diminuti, caderaà sopra la semibreuve,; Eet questo s'intende sempre ponendo, & passando due figure simili in nome, &
quantitaà del segno diminuto àa comperatione del segno non diminuto.
Delle parti, & imperfettioni delle note. Cap. VII.
 ,
,  ., potraà
essere fatta imperfetta dalla sua terza parte, o dal suo uvalore, in questo modo.
., potraà
essere fatta imperfetta dalla sua terza parte, o dal suo uvalore, in questo modo.
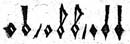 Possono alcuna uvolta tali semiminime piene stare in
tali segni puntati, massimamente ne' canti, che con tali segni sono dimostrati, douve non cadano minime piene, le quali alle uvolte sono usate affine di ischifare al-teratione, o per qualche altra lecita cagione,. Alcuni altri dicono, che quando una
sola nota saraà considerata perfetta in qualche canto, ouve accada far la imperfetta,
Ttal nota considerata perfetta dalla sua terza parte, ouvero dal suo uvalore, che alhora tale terza parte, o suo uvalore dee esser tutto posto dalla parte dinanzi ouveramente dopo, et no una parte innanzi, & una parte dopo la nota fatta impfetta, come qui,
Possono alcuna uvolta tali semiminime piene stare in
tali segni puntati, massimamente ne' canti, che con tali segni sono dimostrati, douve non cadano minime piene, le quali alle uvolte sono usate affine di ischifare al-teratione, o per qualche altra lecita cagione,. Alcuni altri dicono, che quando una
sola nota saraà considerata perfetta in qualche canto, ouve accada far la imperfetta,
Ttal nota considerata perfetta dalla sua terza parte, ouvero dal suo uvalore, che alhora tale terza parte, o suo uvalore dee esser tutto posto dalla parte dinanzi ouveramente dopo, et no una parte innanzi, & una parte dopo la nota fatta impfetta, come qui,
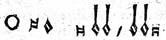 Ee no in questo modo.,
Ee no in questo modo., 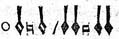 o in altri simili, i quali possono accadere,. Et questo dicono auvenire, percheé diuvidendo la semibreuve nelle sue parte minute, come sono le minime, le semiminime, & l'al-tre, & ponendo una parte della detta semibreuve alla parte dinanzi, & una parte
dopo la breuve, egli pare, che una delle tre semibreuvi contenuta in essa breuve sia fatta
imperfetta dalla minima posta dalla parte dinanzi, & dalla minima posta dopo
tal breuve,. Pertanto dicono, che se un canto saraà segnato col segno della prolation
perfetta, che in quel caso tale positione saraà lecita, & con ragione posta, & ben
considerata, come qui.
o in altri simili, i quali possono accadere,. Et questo dicono auvenire, percheé diuvidendo la semibreuve nelle sue parte minute, come sono le minime, le semiminime, & l'al-tre, & ponendo una parte della detta semibreuve alla parte dinanzi, & una parte
dopo la breuve, egli pare, che una delle tre semibreuvi contenuta in essa breuve sia fatta
imperfetta dalla minima posta dalla parte dinanzi, & dalla minima posta dopo
tal breuve,. Pertanto dicono, che se un canto saraà segnato col segno della prolation
perfetta, che in quel caso tale positione saraà lecita, & con ragione posta, & ben
considerata, come qui. 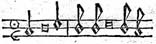 Tuttauvia certamente si conosce, che tale positione in
questo modo considerata,
Tuttauvia certamente si conosce, che tale positione in
questo modo considerata,
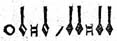 non debba essere in parte alcuna dubbiosa al detto inten-dente, perciocheé dallui è compreso, che per la priuvatione
del punto del circolo, la prolatione, ouvero la semibreuve
resta imperfetta,. Pertanto non si potraà considerare, chella minima, la quale è po-sta dinanzi la breuve, neé anchora la minima posta dopo essa breuve, siano terze par-ti di alcuna delle semibreuvi tolte dalla breuve,. pPerò bisogna considerare, che in tali
occorrenze siano prese insieme la minima posta dinanzi alla breuve, & quella dopo,
lequali faranno la quantitaà, o uvalore di una semibreuve, il qual uvalore saraà quello,
dal quale la breuve in mezzo delle due minime posta saraà fatta imperfetta, Iintorno
lequai cose bisogna auvertire, che tale o simile positione di figure è in potestaà, et uvolere del Ccompositore, per che il Mmusico, o Ccompositore, per sodisfare al poco sapere di
alcuni;, non è tenuto a non esprimere, et conducere il concento al suo debito fine se-condo la sua intentione,. Et questo che di sopra è stato detto della breuve posta fra le
minime del segno, douve solamente il Ttempo saraà perfetto, si intenderaà anchora della page 67lunga posta fra due semibreuvi, douve solamente il modo minore saraà perfetto, & della Mmassima posta fra le breuvi, douve solamente il Mmodo maggiore saraà perfetto.
non debba essere in parte alcuna dubbiosa al detto inten-dente, perciocheé dallui è compreso, che per la priuvatione
del punto del circolo, la prolatione, ouvero la semibreuve
resta imperfetta,. Pertanto non si potraà considerare, chella minima, la quale è po-sta dinanzi la breuve, neé anchora la minima posta dopo essa breuve, siano terze par-ti di alcuna delle semibreuvi tolte dalla breuve,. pPerò bisogna considerare, che in tali
occorrenze siano prese insieme la minima posta dinanzi alla breuve, & quella dopo,
lequali faranno la quantitaà, o uvalore di una semibreuve, il qual uvalore saraà quello,
dal quale la breuve in mezzo delle due minime posta saraà fatta imperfetta, Iintorno
lequai cose bisogna auvertire, che tale o simile positione di figure è in potestaà, et uvolere del Ccompositore, per che il Mmusico, o Ccompositore, per sodisfare al poco sapere di
alcuni;, non è tenuto a non esprimere, et conducere il concento al suo debito fine se-condo la sua intentione,. Et questo che di sopra è stato detto della breuve posta fra le
minime del segno, douve solamente il Ttempo saraà perfetto, si intenderaà anchora della page 67lunga posta fra due semibreuvi, douve solamente il modo minore saraà perfetto, & della Mmassima posta fra le breuvi, douve solamente il Mmodo maggiore saraà perfetto.
Altre considerationi intorno la imperfettione delle note. Cap. VIII.
 2.,
2.,  2.,
2.,  ., et alcuna uvolta essa
breuve è dimostrata imperfetta con la sua minore propinqua perfetta, come dichia-ra il presente segno.,
., et alcuna uvolta essa
breuve è dimostrata imperfetta con la sua minore propinqua perfetta, come dichia-ra il presente segno.,  . Et alcuna tal breuve saraà perfetta, & la sua seguente mino-re saraà imperfetta, come dimostrano questi segni,
. Et alcuna tal breuve saraà perfetta, & la sua seguente mino-re saraà imperfetta, come dimostrano questi segni,  3.,
3.,  3.,
3.,  . La breuve adunque go-uvernata sopra i dimostrati segni, senza altri accidentali segni considerata, non di-uventeraà imperfetta, cioè non saraà diminuta di alcuna sua particola, Mma sempre staraà in quel uvalore, & uvertuù, il quale le saraà attribuito dal segno,; ma la breuve perfetta per questi segni dimostrata,
. La breuve adunque go-uvernata sopra i dimostrati segni, senza altri accidentali segni considerata, non di-uventeraà imperfetta, cioè non saraà diminuta di alcuna sua particola, Mma sempre staraà in quel uvalore, & uvertuù, il quale le saraà attribuito dal segno,; ma la breuve perfetta per questi segni dimostrata,  3.,
3.,  3.,
3.,  ., per non essere in loro altra nota perfet-ta, potraà solamente essere fatta imperfetta dalla sua terza parte, et non in altro modo,. Et quando la breuve saraà imperfetta, & che uvaleraà due semibreuvi perfette, come
dimostra la semicircolar figura,
., per non essere in loro altra nota perfet-ta, potraà solamente essere fatta imperfetta dalla sua terza parte, et non in altro modo,. Et quando la breuve saraà imperfetta, & che uvaleraà due semibreuvi perfette, come
dimostra la semicircolar figura,  , alhora tal breuve non potraà essere fatta imper-fetta senon dalla sua terza parte, percheé non resta diuvisa in tre parti equali, ma potraà ben diuventare imperfetta inquanto alle parte propinque, cioè rispetto alle semi-breuvi, percheé tali sue semibreuvi sono dimostrate perfette dal punto apparente nella
semicircolar figura,. Et tale imperfettione potraà occorrere in dui modi, cioè che delle due semibreuvi perfette considerate in essa breuve una sola potraà essere imperfetta,
& l'altra perfetta, come qui,
, alhora tal breuve non potraà essere fatta imper-fetta senon dalla sua terza parte, percheé non resta diuvisa in tre parti equali, ma potraà ben diuventare imperfetta inquanto alle parte propinque, cioè rispetto alle semi-breuvi, percheé tali sue semibreuvi sono dimostrate perfette dal punto apparente nella
semicircolar figura,. Et tale imperfettione potraà occorrere in dui modi, cioè che delle due semibreuvi perfette considerate in essa breuve una sola potraà essere imperfetta,
& l'altra perfetta, come qui,  & secondo ogni precetto, & or-dine dato da' dotti, & consu- maticonsumati Mmusici, cosiì moderni, come
antichi, tali breuvi rettamente si potranno ritrouvare ragioneuvol-mente tutte imperfette, come qui,
& secondo ogni precetto, & or-dine dato da' dotti, & consu- maticonsumati Mmusici, cosiì moderni, come
antichi, tali breuvi rettamente si potranno ritrouvare ragioneuvol-mente tutte imperfette, come qui, 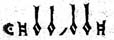 et cosiì,
et cosiì,  Eet in molti altri modi simili, iquali per breuvitaà si lasceranno,. mMa la
breuve, laquale saraà formata di tre semibreuvi perfette, come in questo segno si con-tiene,
Eet in molti altri modi simili, iquali per breuvitaà si lasceranno,. mMa la
breuve, laquale saraà formata di tre semibreuvi perfette, come in questo segno si con-tiene,  , potraà essere fatta imperfetta dalla sua terza parte, cioè da una semibre-uve perfetta, come qui,
, potraà essere fatta imperfetta dalla sua terza parte, cioè da una semibre-uve perfetta, come qui,  ouvero da oltretanto suo uvalore, come di tre mini-me, & l'altre due potranno far imperfette quelle due semibreuvi, lequa-li dopo la imperfettione della predetta breuve restano in tal breuve atte a poterla far
imperfetta, come si dimostra per li seguenti essempiji.
ouvero da oltretanto suo uvalore, come di tre mini-me, & l'altre due potranno far imperfette quelle due semibreuvi, lequa-li dopo la imperfettione della predetta breuve restano in tal breuve atte a poterla far
imperfetta, come si dimostra per li seguenti essempiji. 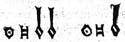 Anchora nella breuve per tal modo segnata potranno es-sere solamente due semibreuvi perfette, & una imperfet-ta, Iimperocheé come è stato detto, la breuve in tal segno uvale tre semibreuvi perfette,
delle quali semibreuvi una sola rimarrà imperfetta dalla seguente minima, & per
tal modo tal breuve haraà il uvalore di otto minime,. Appresso nella detta breuve le due
minime potranno far imperfette le due semibreuvi, rimanendo l'altra perfetta, co-page 68me qui,
Anchora nella breuve per tal modo segnata potranno es-sere solamente due semibreuvi perfette, & una imperfet-ta, Iimperocheé come è stato detto, la breuve in tal segno uvale tre semibreuvi perfette,
delle quali semibreuvi una sola rimarrà imperfetta dalla seguente minima, & per
tal modo tal breuve haraà il uvalore di otto minime,. Appresso nella detta breuve le due
minime potranno far imperfette le due semibreuvi, rimanendo l'altra perfetta, co-page 68me qui,  Ddouve la breuve ritenerà il uvalore di sette minime,. Et hab-biamo da considerare, che accadendo, che tal breuve sia fatta im-perfet- taperfetta da tre minime, come qui,
Ddouve la breuve ritenerà il uvalore di sette minime,. Et hab-biamo da considerare, che accadendo, che tal breuve sia fatta im-perfet- taperfetta da tre minime, come qui,  Ssi dee inten-dere, chella breuve sia fatta imperfetta dalla sua terza parte, cioò
è dal uvalore di una semibreuve perfetta, et che le tre semibreuvi p-fette, le quali uvagliano quanto una breuve perfetta, non saranno fatte imperfette da
quelle tre minime poste dopo tal breuve, percheé ouve cosiì fosse, egli seguiterebbe, chel-la breuve perfetta disopra assegnata non si potesse fare imperfetta dalla semi-breuve perfetta, come uvuole la natura del far imperfetto, cioè che ogni nota per-fetta, laquale sia composta di tre note perfette, non potraà essere fatta imperfetta se
non le saraà tolto uvia una nota perfetta, la quale sia la terza parte della nota fatta
imperfetta,. pPertanto se uvogliamo, chelle tre minime poste dopo la breuve siano in
quella guisa messe per far imperfette quelle tre semibreuvi, lequali sono coprese per-fette nella breuve, ilche non auviene di essa breuve, Ddico, che non potraà stare, percheé
tolta la perfettione a ciascheduna delle tre semibreuvi considerate perfette nella
predetta breuve, egli seguiterebbe, che tale breuve restasse perfetta di tre semibreuvi
imperfette,. pPer tal modo, tal breuve dopo la imperfettione delle predette tre semibreuvi sarebbe fatta imperfetta di una semibreuve imperfetta, la qual cosa sarebbe molto
repugnante, et contraria al segno, percheé esso dimostra, che il tempo, ouvero la breuve è composta di tre semibreuvi perfette,. uVolendo adunque, che la breuve sia fatta im-perfetta, egli saraà dibisogno, chella nota, che ha forza di far imperfetto, sia perfetta, & non imperfetta, ma se pur tal nota, che puoò leuvare la perfettione, saraà imperfetta, bisognerà, che essa insieme con una delle sue parte concorra affare imperfet-ta essa breuve, come qui.
Ssi dee inten-dere, chella breuve sia fatta imperfetta dalla sua terza parte, cioò
è dal uvalore di una semibreuve perfetta, et che le tre semibreuvi p-fette, le quali uvagliano quanto una breuve perfetta, non saranno fatte imperfette da
quelle tre minime poste dopo tal breuve, percheé ouve cosiì fosse, egli seguiterebbe, chel-la breuve perfetta disopra assegnata non si potesse fare imperfetta dalla semi-breuve perfetta, come uvuole la natura del far imperfetto, cioè che ogni nota per-fetta, laquale sia composta di tre note perfette, non potraà essere fatta imperfetta se
non le saraà tolto uvia una nota perfetta, la quale sia la terza parte della nota fatta
imperfetta,. pPertanto se uvogliamo, chelle tre minime poste dopo la breuve siano in
quella guisa messe per far imperfette quelle tre semibreuvi, lequali sono coprese per-fette nella breuve, ilche non auviene di essa breuve, Ddico, che non potraà stare, percheé
tolta la perfettione a ciascheduna delle tre semibreuvi considerate perfette nella
predetta breuve, egli seguiterebbe, che tale breuve restasse perfetta di tre semibreuvi
imperfette,. pPer tal modo, tal breuve dopo la imperfettione delle predette tre semibreuvi sarebbe fatta imperfetta di una semibreuve imperfetta, la qual cosa sarebbe molto
repugnante, et contraria al segno, percheé esso dimostra, che il tempo, ouvero la breuve è composta di tre semibreuvi perfette,. uVolendo adunque, che la breuve sia fatta im-perfetta, egli saraà dibisogno, chella nota, che ha forza di far imperfetto, sia perfetta, & non imperfetta, ma se pur tal nota, che puoò leuvare la perfettione, saraà imperfetta, bisognerà, che essa insieme con una delle sue parte concorra affare imperfet-ta essa breuve, come qui.  Il simile auverraà, sella detta semibreuve saraà di-uvisa in tre minime, & etiandio in note piuù minute, percheé la natura,
& l'arte ci amaestra, che quando egli si trouva una nota, laquale habbia uvertuù, & uvalore di tre minori perfette a seé propinque, noi debbiamo prima ha-uver riguardo, se tal nota saraà perfetta, cioè se nel concento resterà conseruvata dal-la imperfettione, perciocheé ouve non uvi restasse, sarebbe necessario chella nota che
arreca imperfettione fosse apparente in forma, in pausa, o in uvalore,. Pertanto, quando dopo tal nota, o innanzi, si trouveraà tanto di uvalore, che aggionga alla terza parte di quella nota perfetta, laquale contiene tre note perfette, alhora tal uvalore si dee
applicare alla imperfettione di quella nota, la quale comprende il ternario numero
delle minori perfette a seé propinque,. Et se dopo tal terza parte, altro numero di fi-gure minute auvanzano atte affare imperfette le figure perfette comprese da essa nota, tali note si debbono accomodare affar imperfette tal note perfette minori con-tenute piuù uvolte in essa maggiore,. Et però, quando dopo la breuve in tal segno segna-ta,
Il simile auverraà, sella detta semibreuve saraà di-uvisa in tre minime, & etiandio in note piuù minute, percheé la natura,
& l'arte ci amaestra, che quando egli si trouva una nota, laquale habbia uvertuù, & uvalore di tre minori perfette a seé propinque, noi debbiamo prima ha-uver riguardo, se tal nota saraà perfetta, cioè se nel concento resterà conseruvata dal-la imperfettione, perciocheé ouve non uvi restasse, sarebbe necessario chella nota che
arreca imperfettione fosse apparente in forma, in pausa, o in uvalore,. Pertanto, quando dopo tal nota, o innanzi, si trouveraà tanto di uvalore, che aggionga alla terza parte di quella nota perfetta, laquale contiene tre note perfette, alhora tal uvalore si dee
applicare alla imperfettione di quella nota, la quale comprende il ternario numero
delle minori perfette a seé propinque,. Et se dopo tal terza parte, altro numero di fi-gure minute auvanzano atte affare imperfette le figure perfette comprese da essa nota, tali note si debbono accomodare affar imperfette tal note perfette minori con-tenute piuù uvolte in essa maggiore,. Et però, quando dopo la breuve in tal segno segna-ta,  , seguita il uvalore di piuù di una semibreuve, Sse tal parte, laquale auvanzeraà ol-tra la semibreuve intiera, saraà minore di essa semibreuve, come sua terza parte, et che
essa sia reintegrata, alhora essa terza parte saraà computata affar imperfetta una page 69di quelle semibreuvi, le quali rimangono nella breuve dopo la imperfettione di essa breuve,. mMa se esse saranno due parti dopo la imperfettione della predetta breuve, saran-no computate affar imperfette quelle due semibreuvi, le quali dopo la imperfettione
della breuve resterano in essa breuve, come si potraà coprendere per li essempi seguenti.
, seguita il uvalore di piuù di una semibreuve, Sse tal parte, laquale auvanzeraà ol-tra la semibreuve intiera, saraà minore di essa semibreuve, come sua terza parte, et che
essa sia reintegrata, alhora essa terza parte saraà computata affar imperfetta una page 69di quelle semibreuvi, le quali rimangono nella breuve dopo la imperfettione di essa breuve,. mMa se esse saranno due parti dopo la imperfettione della predetta breuve, saran-no computate affar imperfette quelle due semibreuvi, le quali dopo la imperfettione
della breuve resterano in essa breuve, come si potraà coprendere per li essempi seguenti.
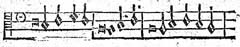 Nel primo, & nel secondo es-sempio, la breuve per le predet-te ragioni uvaleraà cinque mi-nime, ouvero una semibreuve
perfetta & una imperfetta, ma nel terzo, ouvero ultimo, essa uvaleraà quattro mini-me, ouvero due semibreuvi imperfette,. Et percheé in tale consideratione potrebbono nascere molti dubbi, et accidenti contrariji alla uvolontaà del Ccompositore, pertanto per
maggior chiarezza è lecito tal uvolta porre simili punti tra le note, che fanno la imperfettione, come si uvede nel secondo, & nel terzo essempio, de' quali punti, gli ul-timi apparenti nella seconda, & nella terza figura saranno rettamente chiamati
punti di ridutione, per liquali tali note sono dimostrate essere ridotte, ouvero trasportate alle note innanzi alloro poste, & tali note solamente sono ridotte affar imperfette altre note di lor maggiori, & non per accompagnarsi con altre loro simili in
forma, neé in uvalore,. Ma le note nel primo modo trasportate possono far imperfette
le loro maggiori propinque, & anchora si possono accompagnare colle loro simili
in forma, & in uvalore, & essi punti di ridutione dopo la nota ridotta posti saranno
sempre con participatione, & non per seé, come alla quinta oppenione habbiamo
dimostrato,. oOltra le predette cose, Eegli è da sapere, chelle figure, le quali sono causa
della imperfettione, possono stare in molti altri modi diuversi da quelliche habbiamo narrati, rispetto alla nota fatta imperfetta, come saraà la semibreuve innanzi la breuve,
come qui,
Nel primo, & nel secondo es-sempio, la breuve per le predet-te ragioni uvaleraà cinque mi-nime, ouvero una semibreuve
perfetta & una imperfetta, ma nel terzo, ouvero ultimo, essa uvaleraà quattro mini-me, ouvero due semibreuvi imperfette,. Et percheé in tale consideratione potrebbono nascere molti dubbi, et accidenti contrariji alla uvolontaà del Ccompositore, pertanto per
maggior chiarezza è lecito tal uvolta porre simili punti tra le note, che fanno la imperfettione, come si uvede nel secondo, & nel terzo essempio, de' quali punti, gli ul-timi apparenti nella seconda, & nella terza figura saranno rettamente chiamati
punti di ridutione, per liquali tali note sono dimostrate essere ridotte, ouvero trasportate alle note innanzi alloro poste, & tali note solamente sono ridotte affar imperfette altre note di lor maggiori, & non per accompagnarsi con altre loro simili in
forma, neé in uvalore,. Ma le note nel primo modo trasportate possono far imperfette
le loro maggiori propinque, & anchora si possono accompagnare colle loro simili
in forma, & in uvalore, & essi punti di ridutione dopo la nota ridotta posti saranno
sempre con participatione, & non per seé, come alla quinta oppenione habbiamo
dimostrato,. oOltra le predette cose, Eegli è da sapere, chelle figure, le quali sono causa
della imperfettione, possono stare in molti altri modi diuversi da quelliche habbiamo narrati, rispetto alla nota fatta imperfetta, come saraà la semibreuve innanzi la breuve,
come qui,  Eet in ciascuno altro segno di tempo
perfetto, Nnelquale precedente essempio sola la
breuve sa- rasarà imperfetta, come anchora dimo-stra il primo essempio,. mMa in questo seguente,
Eet in ciascuno altro segno di tempo
perfetto, Nnelquale precedente essempio sola la
breuve sa- rasarà imperfetta, come anchora dimo-stra il primo essempio,. mMa in questo seguente,
 Lla breuve saraà imperfetta, & anchora una di quelle due semi-breuvi, le quali dopo la imperfettione della breuve sono restate
in essa breuve,; & nel seguente essempio si dimostra.,
Lla breuve saraà imperfetta, & anchora una di quelle due semi-breuvi, le quali dopo la imperfettione della breuve sono restate
in essa breuve,; & nel seguente essempio si dimostra.,
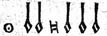 Lla breuve saraà imperfetta con quelle due semibreuvi contenute in tale breuve, Eet in molti altri innumerabili modi potranno accadere tali imperfettioni, lequali per breuvità si tace-ranno, percheé hauveremmo troppo facenda & sarebbe processo molto lungo, &
quasi senza fine,. Adunque per quello, che di sopra è stato detto, chiaramente si uvede,
chella nota, nella quale consiste la perfettione, non si dice essere imperfetta, se non
le saraà leuvato la sua terza parte, laquale sia nota intera, o il uvalore della minore uvi-cina, per la qual cosa errano quegli, i quali in questo essempio,
Lla breuve saraà imperfetta con quelle due semibreuvi contenute in tale breuve, Eet in molti altri innumerabili modi potranno accadere tali imperfettioni, lequali per breuvità si tace-ranno, percheé hauveremmo troppo facenda & sarebbe processo molto lungo, &
quasi senza fine,. Adunque per quello, che di sopra è stato detto, chiaramente si uvede,
chella nota, nella quale consiste la perfettione, non si dice essere imperfetta, se non
le saraà leuvato la sua terza parte, laquale sia nota intera, o il uvalore della minore uvi-cina, per la qual cosa errano quegli, i quali in questo essempio, 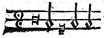 Eet altri simili dicono, che la prima breuve sia fatta imperfetta page 70dalla seguente minima, Eet similmente dicono, chella seconda breuve resta imperfetta
dalle due seguenti minime, Iimperocheé una sola minima, & anchora due, non sono la
terza parte della breuve segnata con questo segno,
Eet altri simili dicono, che la prima breuve sia fatta imperfetta page 70dalla seguente minima, Eet similmente dicono, chella seconda breuve resta imperfetta
dalle due seguenti minime, Iimperocheé una sola minima, & anchora due, non sono la
terza parte della breuve segnata con questo segno,  ,. Laà onde quella minima sola
faraà rimanere imperfetta una di quelle tre semibreuvi in seé raccolte dalla prima breuve del predetto segno, la quale è perfetta,. Cosiì la seconda breuve non saraà fatta im-perfetta dalle due seguenti minime, ma le due semibreuvi siì bene in essa breuve consi-derate resteranno imperfette, la quale intelligenza & uveritaà si potraà chiaramente
dimostrare in questi modi
,. Laà onde quella minima sola
faraà rimanere imperfetta una di quelle tre semibreuvi in seé raccolte dalla prima breuve del predetto segno, la quale è perfetta,. Cosiì la seconda breuve non saraà fatta im-perfetta dalle due seguenti minime, ma le due semibreuvi siì bene in essa breuve consi-derate resteranno imperfette, la quale intelligenza & uveritaà si potraà chiaramente
dimostrare in questi modi 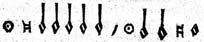 Eet in altri
simili,. E certo quanto al primo es-sempio, douve appaiono cinque mini-me dopo la breuve, egli non si puoò negare, chelle tre non facciano la predetta breuve
imperfetta, percheé sono il uvalore, & la quantità di una terza parte di quella, cioè
di una semibreuve perfetta,. Cosiì anchora quelle due minime, le quali auvanzano do-po le tre, saranno computate nella detta breuve affare imperfette le due semibreuvi,
lequali oltra quelle, che fanno imperfetta la breuve restarono perfette in essa breuve,.
Il medesimo anchora accaderaà nella seconda dimostratione, percheé la semibreuve posta dopo la breuve faraà imperfetta essa breuve, & le due minime poste dinanzi a tal
breuve faranno imperfette quelle due semibreuvi, le quali dopo la imperfettione della
breuve rimasono in detta breuve,. Se adunque in ciascheduno de gli essempi predetti saraà mossa ouvero leuvata uvia la imperfettione delle due semibreuvi sopradette, cioè quelle due minime, le quali alle tre minime sopra auvanzano, & similmente quelle due
minime, le quali sono poste dinanzi la breuve del secondo essempio, seguiterà, che sola la breuve resteraà imperfetta, & cosiì in contrario, Sse dal primo, & dal secondo
essempio saraà tolta uvia la imperfettione delle predette due semibreuvi, cioè le due minime, solo il tempo, ouvero la breuve resteraà imperfetta, & le due semibreuvi in esso
tempo rinchiuse saranno perfette,. Et questo tale ordine è tenuto per fermo, & uvero
da ogni Mmusico, & dotto Ccompositore.
Eet in altri
simili,. E certo quanto al primo es-sempio, douve appaiono cinque mini-me dopo la breuve, egli non si puoò negare, chelle tre non facciano la predetta breuve
imperfetta, percheé sono il uvalore, & la quantità di una terza parte di quella, cioè
di una semibreuve perfetta,. Cosiì anchora quelle due minime, le quali auvanzano do-po le tre, saranno computate nella detta breuve affare imperfette le due semibreuvi,
lequali oltra quelle, che fanno imperfetta la breuve restarono perfette in essa breuve,.
Il medesimo anchora accaderaà nella seconda dimostratione, percheé la semibreuve posta dopo la breuve faraà imperfetta essa breuve, & le due minime poste dinanzi a tal
breuve faranno imperfette quelle due semibreuvi, le quali dopo la imperfettione della
breuve rimasono in detta breuve,. Se adunque in ciascheduno de gli essempi predetti saraà mossa ouvero leuvata uvia la imperfettione delle due semibreuvi sopradette, cioè quelle due minime, le quali alle tre minime sopra auvanzano, & similmente quelle due
minime, le quali sono poste dinanzi la breuve del secondo essempio, seguiterà, che sola la breuve resteraà imperfetta, & cosiì in contrario, Sse dal primo, & dal secondo
essempio saraà tolta uvia la imperfettione delle predette due semibreuvi, cioè le due minime, solo il tempo, ouvero la breuve resteraà imperfetta, & le due semibreuvi in esso
tempo rinchiuse saranno perfette,. Et questo tale ordine è tenuto per fermo, & uvero
da ogni Mmusico, & dotto Ccompositore.
Qual sia stato il primo, e 'l secondo segno da gli antichi, & dotti Mmusici dimostrato. Cap. IX.
 3.; Iil secondo con un semicircolo & una cifra ternaria.,
3.; Iil secondo con un semicircolo & una cifra ternaria.,  3.; Iil terzo con un circolo, & una cifra binaria, come qui.,
3.; Iil terzo con un circolo, & una cifra binaria, come qui.,  2.; Iil quar-page 71to col semicircolo, Eet una binaria cifra, come qui.,
2.; Iil quar-page 71to col semicircolo, Eet una binaria cifra, come qui.,  2,; i quali quattro segni di-mostrati, come al capitolo 28. del primo libro del Toscanello habbiamo detto, sono
applicati al Mmodo minore perfetto, & al modo imperfetto, ouveramente alla lunga,
Pper laqual cosa, se un concento saraà segnato con questa figura, cioè col primo.,
2,; i quali quattro segni di-mostrati, come al capitolo 28. del primo libro del Toscanello habbiamo detto, sono
applicati al Mmodo minore perfetto, & al modo imperfetto, ouveramente alla lunga,
Pper laqual cosa, se un concento saraà segnato con questa figura, cioè col primo.,  3.,
la lunga uvaleraà tre breuvi, & la breuve tre semibreuvi, percheé sempre quella nota si dice esser perfetta, alla quale il circolo è attribuito, il qual modo essendo, cosiì se-gnato, la breuve, ouvero tempo saraà perfetta, percheé essa è in tre parti delle sue mi-nori propinque diuvisa, alla qual breuve tal cifra ternaria è attribuita,. mMa se un al-tro canto saraà segnato col secondo, come qui.,
3.,
la lunga uvaleraà tre breuvi, & la breuve tre semibreuvi, percheé sempre quella nota si dice esser perfetta, alla quale il circolo è attribuito, il qual modo essendo, cosiì se-gnato, la breuve, ouvero tempo saraà perfetta, percheé essa è in tre parti delle sue mi-nori propinque diuvisa, alla qual breuve tal cifra ternaria è attribuita,. mMa se un al-tro canto saraà segnato col secondo, come qui.,  3., alhora la lunga non uvaleraà altro,
che due breuvi, & questo adiuviene, percheé il semicircolo, ilquale è appropiato al Mmo-do minore, ouveramente alla lunga dinota imperfettione, ouvero binaria aggregatio-ne di tempi, et in tal segno la breuve saraà perfetta, percheé la cifra ternaria posta dopo il semicircolo dimostra al Ttempo ternaria diuvisione. Gli altri duoi seguenti se-gni, hauvendo chiaramente inteso la natura, & la proprietaà de' sopra detti, facilmente saranno intesi, de' quali l'uno saraà, questo.,
3., alhora la lunga non uvaleraà altro,
che due breuvi, & questo adiuviene, percheé il semicircolo, ilquale è appropiato al Mmo-do minore, ouveramente alla lunga dinota imperfettione, ouvero binaria aggregatio-ne di tempi, et in tal segno la breuve saraà perfetta, percheé la cifra ternaria posta dopo il semicircolo dimostra al Ttempo ternaria diuvisione. Gli altri duoi seguenti se-gni, hauvendo chiaramente inteso la natura, & la proprietaà de' sopra detti, facilmente saranno intesi, de' quali l'uno saraà, questo.,  2., per lo quale saraà compreso la lunga essere di tre breuvi, & la breuve di due semibreuvi, rispetto alla cifra, laqual dimo-stra binario numero,. Et nell'altro, che è questo,
2., per lo quale saraà compreso la lunga essere di tre breuvi, & la breuve di due semibreuvi, rispetto alla cifra, laqual dimo-stra binario numero,. Et nell'altro, che è questo,  2, ultimo da noi segnato, non caderaà alcuna perfettione, percheé non si dimostra per figura circolare, neé con cifra ternaria; ptanto il modo, ouver la lunga, et la breuve saranno imperfette. Il secondo segno
da' musici dimostrato, ilquale è chiamato Ttempo con prolatione, è come qui,
2, ultimo da noi segnato, non caderaà alcuna perfettione, percheé non si dimostra per figura circolare, neé con cifra ternaria; ptanto il modo, ouver la lunga, et la breuve saranno imperfette. Il secondo segno
da' musici dimostrato, ilquale è chiamato Ttempo con prolatione, è come qui,  . sSimilmente ha quattro uvarietà di segni, cioè, Iil circolo col punto, come di sopra si uvede,
Eet il semicircolo col punto, come qui,
. sSimilmente ha quattro uvarietà di segni, cioè, Iil circolo col punto, come di sopra si uvede,
Eet il semicircolo col punto, come qui,  , Iil terzo, e 'l quarto un circolo, & un semicir
lo [sic: semicircolo] senza punto, la perfettione de' quali consiste nella breuve, & nella semibreuve, come
chiaramente si uvede al capitolo 8. del primo libro del nostro Toscanello,. Quan-to a' segni diminuti, dicono alcuni, che il segno diminuto ne' canti usato, non è altro,
che quado una figura acquista il uvalore della nota minore a seé propinqua del segno
non diminuto, cioè, quando la massima è intesa per una lunga, la lunga per la bre-uve, & la breuve per una semibreuve, & cosiì dell'altre seguenti, Aalla qual oppenione
in contrario dannoi è detto, perciocheé ne' segni de diminutione imperfetti potraà bene
ciascheduna nota conuvertirsi nella minore àa seé propinqua, peroò tutto che tal dimi-nuimento accada nelle note comprese sotto il segno che significa perfettione, non ha-uveraà luogo nella breuve, come si dimostra nel presente essempio,
, Iil terzo, e 'l quarto un circolo, & un semicir
lo [sic: semicircolo] senza punto, la perfettione de' quali consiste nella breuve, & nella semibreuve, come
chiaramente si uvede al capitolo 8. del primo libro del nostro Toscanello,. Quan-to a' segni diminuti, dicono alcuni, che il segno diminuto ne' canti usato, non è altro,
che quado una figura acquista il uvalore della nota minore a seé propinqua del segno
non diminuto, cioè, quando la massima è intesa per una lunga, la lunga per la bre-uve, & la breuve per una semibreuve, & cosiì dell'altre seguenti, Aalla qual oppenione
in contrario dannoi è detto, perciocheé ne' segni de diminutione imperfetti potraà bene
ciascheduna nota conuvertirsi nella minore àa seé propinqua, peroò tutto che tal dimi-nuimento accada nelle note comprese sotto il segno che significa perfettione, non ha-uveraà luogo nella breuve, come si dimostra nel presente essempio,  Nnelquale chiaro si uvede, che ciascuna di quelle quattro breuvi dopo il segno circolare poste saranno perfette, & uvaleranno tre
semibreuvi, ma se tal segno saraà diminuto, ouveramente tagliato, come qui,
Nnelquale chiaro si uvede, che ciascuna di quelle quattro breuvi dopo il segno circolare poste saranno perfette, & uvaleranno tre
semibreuvi, ma se tal segno saraà diminuto, ouveramente tagliato, come qui,  , alhora
quella uvergola, laquale attrauversa o taglia il circolo, o altro segno, sempre dimostra
diminutione,. lLaà onde saraà forza che ciascuna di quelle quattro breuvi del segmo [sic: segno] ta-gliato sia per seé considerata per la metà rispetto alla quantità del segno circolare
non tagliato. sSeguiteraà adunque, che ciascheduna breuve perfetta del circolar segno
tagliato non potraà uvalere una semibreuve del segno non tagliato, ouveramente dimi-page 72nuto, percheé la breuve del tempo perfetto passa per tre battute, per laqual cosa saraà
di bisogno chella breuve del tempo perfetto diminuto comparato, passi per tre mini-me, al segno non tagliato, per loqual rispetto non si potraà conuvertire una nota nella
sua minor seguente, ma trouvandosi tal figuratione,
, alhora
quella uvergola, laquale attrauversa o taglia il circolo, o altro segno, sempre dimostra
diminutione,. lLaà onde saraà forza che ciascuna di quelle quattro breuvi del segmo [sic: segno] ta-gliato sia per seé considerata per la metà rispetto alla quantità del segno circolare
non tagliato. sSeguiteraà adunque, che ciascheduna breuve perfetta del circolar segno
tagliato non potraà uvalere una semibreuve del segno non tagliato, ouveramente dimi-page 72nuto, percheé la breuve del tempo perfetto passa per tre battute, per laqual cosa saraà
di bisogno chella breuve del tempo perfetto diminuto comparato, passi per tre mini-me, al segno non tagliato, per loqual rispetto non si potraà conuvertire una nota nella
sua minor seguente, ma trouvandosi tal figuratione, 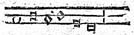 ciascuna breuve, & semibreuve sotto la data diminutione
haraà uvalore della parte minore a seé propinqua, & questo si intende procedendo nel canto, percheé le note del segno tagliato si cantano piuù
uvelocemente per lo doppio, per laqual cosa saraà meglio diffinire, che la diminutione
non sia altro, che quando una nota ha uvertuù della metà del suo uvalore intero, la qual
diffinitione saraà cosentanea, et amica all'uno, et all'altro numero, cioè al perfetto, et
allo imperfetto,. mMa quella, che di sopra habbiamo detto essere di altri, solamente sodisfaraà al numero, & alle note imperfette, la qual diminutione, come habbiamo
detto, si conosce quando i segni sopradetti saranno tagliati, òo attrauversati,; onde tali
segni saranno chiamati segni di modo, con tempo, diminuti,. Et quando haranno il
punto in mezzo, essendo pure tagliati, saranno detti segni di tempo con prolatione,
come alla oppenione. 6. del canto figurato àa sufficienza habbiamo conchiuso,. mMa
bene auvertirai, che se ben tali segni saranno diminuti, le loro note in tali segni messe
sempre resteranno in quella quantitaà et numero perfetto, et imperfetto, nel quale erano inanzi alla loro diminutione, di maniera, che tra loro non hauvraà differenza alcuna, eccetto che nelle note, percheé laà douve nel segno non tagliato per una battuta pas-sa una semibreuve, nel tagliato ne passano due, & una minima per due minime,. Et il
medesimo accaderaà delle altre figure,. Et percheé alcuni hanno detto, che nella diminutione, la misura sola è quella, che uvaria, et non le note, Qqua habbiamo da considerare, che altro no è misura, che una lunghezza di interuvalli equali finita,. pPertanto tali figure del seguente essempio,
ciascuna breuve, & semibreuve sotto la data diminutione
haraà uvalore della parte minore a seé propinqua, & questo si intende procedendo nel canto, percheé le note del segno tagliato si cantano piuù
uvelocemente per lo doppio, per laqual cosa saraà meglio diffinire, che la diminutione
non sia altro, che quando una nota ha uvertuù della metà del suo uvalore intero, la qual
diffinitione saraà cosentanea, et amica all'uno, et all'altro numero, cioè al perfetto, et
allo imperfetto,. mMa quella, che di sopra habbiamo detto essere di altri, solamente sodisfaraà al numero, & alle note imperfette, la qual diminutione, come habbiamo
detto, si conosce quando i segni sopradetti saranno tagliati, òo attrauversati,; onde tali
segni saranno chiamati segni di modo, con tempo, diminuti,. Et quando haranno il
punto in mezzo, essendo pure tagliati, saranno detti segni di tempo con prolatione,
come alla oppenione. 6. del canto figurato àa sufficienza habbiamo conchiuso,. mMa
bene auvertirai, che se ben tali segni saranno diminuti, le loro note in tali segni messe
sempre resteranno in quella quantitaà et numero perfetto, et imperfetto, nel quale erano inanzi alla loro diminutione, di maniera, che tra loro non hauvraà differenza alcuna, eccetto che nelle note, percheé laà douve nel segno non tagliato per una battuta pas-sa una semibreuve, nel tagliato ne passano due, & una minima per due minime,. Et il
medesimo accaderaà delle altre figure,. Et percheé alcuni hanno detto, che nella diminutione, la misura sola è quella, che uvaria, et non le note, Qqua habbiamo da considerare, che altro no è misura, che una lunghezza di interuvalli equali finita,. pPertanto tali figure del seguente essempio, 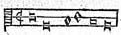 saranno intese douver essere
annouverate nel cantare in dui modi, cioè semplicemente,
& non, sotto la misura considerata dal mouvimento dello
abbassare, et dello inalzare,. Et intorno il primo modo di misurare, o annouverare in
questo segno,
saranno intese douver essere
annouverate nel cantare in dui modi, cioè semplicemente,
& non, sotto la misura considerata dal mouvimento dello
abbassare, et dello inalzare,. Et intorno il primo modo di misurare, o annouverare in
questo segno,  diminuto, si cercheraà la quantitaà del tempo, ouvero della breuve, pi-gliando due semibreuvi, o 'l loro uvalore, dato che anchora fussero sotto il segno semi-circolare non diminuto, come qui,.
diminuto, si cercheraà la quantitaà del tempo, ouvero della breuve, pi-gliando due semibreuvi, o 'l loro uvalore, dato che anchora fussero sotto il segno semi-circolare non diminuto, come qui,. 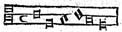 Onde secondo questo
modo di misurare il canto, la misu- ramisura, la quale accaderaà
nell'annouverare le note del segno di sopra diminuto, non saraà uvaria dal misurar le note del segno non tagliato, percheé in ciascun segno, la bre-uve si diuvide in due semibreuvi,. Quanto al secondo, considerando il canto sottoposto
al semicircolo diminuto, & dato dal Mmusico, o Ccantore, alla misura si faraà altra
consideratione, Iimperocheé alhora le note sotto al segno diminuto poste procederanno per lo doppio rispetto alle note del segno non tagliato, nelqual segno diminuto,
tanto uvalore haraà una breuve, quanto una semibreuve del segno non diminuto, & per
tal modo le semibreuvi del segno diminuto, cosiì nelle pause, come nelle note cantabili page 73haranno uvalore, et uvertuù di minime rispetto al secondo segno diminuto,. Conchiuderemo adunque, chella oppenione di questi tali sia falsissima, perciocheé, come chiara-mente appare, la misura presa nel principio del canto mai non uvaria, ma le note
sono quelle, lequali fanno la uvariatione, percheé come disopra è stato detto, per una
semibreuve del segno non diminuto, sotto quel medesimo mouvimento, & misura pas-sano due semibreuvi, ouveramente una breuve del segno tagliato,. Et per essere al presen-te al proposito nostro, è cosa necessaria auvertire che molti, & molti si ritrouvano,
liquali secondo la loro fantasia, & senza consideratione alcuna commettono euvi-dentissimi errori circa le proportioni, & massimamente della sesqualtera habitudi-ne da' Mmusici & Ccompositori communemente essercitata, laquale con poca auvertenza da quegli che cantano è prononciata, l'errore de' quali di qui nasce, che dopo la
misura data al principio del canto, secondo il segno apparente, dopo alcune note parandosi loro inannzi [sic: innanzi] la sesqualtera porportione [sic: proportione], le daranno una nouva misura con-traria a quello, che saraà stato il uvero intelletto del Mmusico, et Ccompositore di quella,
dal quale inconuveniente ne risulteraà una proportione non considerata dal Mmusico,
percheé mutando la misura alla apparente sesqualtera, come quella, che per seé non
potendo stare, è relata & comparata al segno, ouvero alle note dinanzi a seé poste,
per tal mutatione essa, contro la oppenione del Ccompositore, non saraà sesqualtera,
ma quasi sempre tripla, come dimostra il seguente essempio,
Onde secondo questo
modo di misurare il canto, la misu- ramisura, la quale accaderaà
nell'annouverare le note del segno di sopra diminuto, non saraà uvaria dal misurar le note del segno non tagliato, percheé in ciascun segno, la bre-uve si diuvide in due semibreuvi,. Quanto al secondo, considerando il canto sottoposto
al semicircolo diminuto, & dato dal Mmusico, o Ccantore, alla misura si faraà altra
consideratione, Iimperocheé alhora le note sotto al segno diminuto poste procederanno per lo doppio rispetto alle note del segno non tagliato, nelqual segno diminuto,
tanto uvalore haraà una breuve, quanto una semibreuve del segno non diminuto, & per
tal modo le semibreuvi del segno diminuto, cosiì nelle pause, come nelle note cantabili page 73haranno uvalore, et uvertuù di minime rispetto al secondo segno diminuto,. Conchiuderemo adunque, chella oppenione di questi tali sia falsissima, perciocheé, come chiara-mente appare, la misura presa nel principio del canto mai non uvaria, ma le note
sono quelle, lequali fanno la uvariatione, percheé come disopra è stato detto, per una
semibreuve del segno non diminuto, sotto quel medesimo mouvimento, & misura pas-sano due semibreuvi, ouveramente una breuve del segno tagliato,. Et per essere al presen-te al proposito nostro, è cosa necessaria auvertire che molti, & molti si ritrouvano,
liquali secondo la loro fantasia, & senza consideratione alcuna commettono euvi-dentissimi errori circa le proportioni, & massimamente della sesqualtera habitudi-ne da' Mmusici & Ccompositori communemente essercitata, laquale con poca auvertenza da quegli che cantano è prononciata, l'errore de' quali di qui nasce, che dopo la
misura data al principio del canto, secondo il segno apparente, dopo alcune note parandosi loro inannzi [sic: innanzi] la sesqualtera porportione [sic: proportione], le daranno una nouva misura con-traria a quello, che saraà stato il uvero intelletto del Mmusico, et Ccompositore di quella,
dal quale inconuveniente ne risulteraà una proportione non considerata dal Mmusico,
percheé mutando la misura alla apparente sesqualtera, come quella, che per seé non
potendo stare, è relata & comparata al segno, ouvero alle note dinanzi a seé poste,
per tal mutatione essa, contro la oppenione del Ccompositore, non saraà sesqualtera,
ma quasi sempre tripla, come dimostra il seguente essempio,
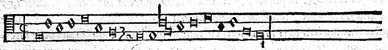 Pper lo qual processo molti cantori poco pratici daranno la misura àa tal principio
sopra la semibreuve, & questo faranno per piuù loro facilità, Iilqual modo saraà con-trario alle note seguenti dopo la sesqualtera, percheé facendo passare nel principio
una semibreuve per battuta, peruvenuti alla sesqualtera;, ne passeranno tre sotto quel-la, per lequali ne nasceraà la tripla, & non la sesqualtera, Eet per questo ne segui-rebbe quello, che disopra habbiamo detto, cioè che la misura sarebbe uvaria, & non
le note,. pPertanto ti saraà necessario sempre in tali processi dar la misura sopra la
breuve, o sopra la sua quantitaà, & senza mutar altra misura, cantar tre note simili
contra le due dette dinanzi, lequali cagioneranno la sesqualtera intesa, et immagina-ta dal Ccompositore, dalqual modo uveramente si uvede, & conosce, chelle note sono
quelle, che uvariano, & non la misura, laquale sempre si dee osseruvare dal principio
al fine secondo la natura del segno;, quantunque ne seguitassero cento proportioni,.
Similmente ne occorre un altro inconuveniente manifestissimo intorno la sesqualtera
proportione, nellaquale molti senza consideratione alcuna creano una proportione
per un'altra, come dimostra il seguente essempio., page 74
Pper lo qual processo molti cantori poco pratici daranno la misura àa tal principio
sopra la semibreuve, & questo faranno per piuù loro facilità, Iilqual modo saraà con-trario alle note seguenti dopo la sesqualtera, percheé facendo passare nel principio
una semibreuve per battuta, peruvenuti alla sesqualtera;, ne passeranno tre sotto quel-la, per lequali ne nasceraà la tripla, & non la sesqualtera, Eet per questo ne segui-rebbe quello, che disopra habbiamo detto, cioè che la misura sarebbe uvaria, & non
le note,. pPertanto ti saraà necessario sempre in tali processi dar la misura sopra la
breuve, o sopra la sua quantitaà, & senza mutar altra misura, cantar tre note simili
contra le due dette dinanzi, lequali cagioneranno la sesqualtera intesa, et immagina-ta dal Ccompositore, dalqual modo uveramente si uvede, & conosce, chelle note sono
quelle, che uvariano, & non la misura, laquale sempre si dee osseruvare dal principio
al fine secondo la natura del segno;, quantunque ne seguitassero cento proportioni,.
Similmente ne occorre un altro inconuveniente manifestissimo intorno la sesqualtera
proportione, nellaquale molti senza consideratione alcuna creano una proportione
per un'altra, come dimostra il seguente essempio., page 74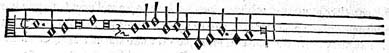 Iintorno ilquale hacci di quelli, iquali pensando cantare le note sesqualterate per uvera proportoine [sic: proportione] sesqualtera, inconsideratamente uvi producono una sotto sesquiterza,
percheé fanno passare tre di quelle minime sottoposte al termine sesqualtero contro
una breuve, o 'l suo uvalore del primo segno diminuto, la qual comparatione o modo di
cantare non è sesqualtera proportione, ma sotto sesquiterza, percheé passano tre minime contro a quattro,. Laà onde, per rimouvere tali inconuvenienti, & manifesti erro-ri, auvertirai, a cantare sei di quelle minime sesqualterate o 'l loro uvalore in un solo
tempo del segno diminuto inanzi posto,. Et in ogni altro modo simile, sempre in que-sta guisa procederai.
Iintorno ilquale hacci di quelli, iquali pensando cantare le note sesqualterate per uvera proportoine [sic: proportione] sesqualtera, inconsideratamente uvi producono una sotto sesquiterza,
percheé fanno passare tre di quelle minime sottoposte al termine sesqualtero contro
una breuve, o 'l suo uvalore del primo segno diminuto, la qual comparatione o modo di
cantare non è sesqualtera proportione, ma sotto sesquiterza, percheé passano tre minime contro a quattro,. Laà onde, per rimouvere tali inconuvenienti, & manifesti erro-ri, auvertirai, a cantare sei di quelle minime sesqualterate o 'l loro uvalore in un solo
tempo del segno diminuto inanzi posto,. Et in ogni altro modo simile, sempre in que-sta guisa procederai.
De' quattro modi da gli antichi, & moderni musici ordinati. Cap. X.
 2.,
2.,  3.,
3.,  2.,
2.,
 3., era rimosso il nome del tempo, & permutato nel modo detto minore, Eet le ci-page 75fre erano assegnate al tempo perfetto, & imperfetto,; ma se erano col circolo, &
col semicircolo due cifre, di modo minore il circolo, e 'l semicircolo diuventauva maggiore, & la prima cifra era detta Mmodo minore, & la seconda Ttempo,. oOltre di
ciò, se nel principio era il circolo, esso era chiamato modo maggior pfetto, laà douve se
uvi era il semicircolo, si domandauva modo maggior impfetto, di maniera che la cifra
seguente essendo ternaria, era detta modo minor perfetto, et se era binaria, imperfetto,; Eet l'ultima seguente cifra, se era ternaria, tempo perfetto,, & se binaria, imper-fetto era detta, come da noi al cap. 27. del primo libro del nostro Toscanello alcu-ne cose anchora ne sono state dette. Alla minima non si daà segno alcuno, conciosia
cosa che essendo dallei diuviso il tempo, essa è l'ultima figura di esso secondo l'ordine
delle cinque figure essentiali. considerate, delle quali daremo notitia, & cognitio-ne piuù breuve, & facile, che per noi sia possibile. Diciamo adunque, che se un canto
saraà segnato, come qui,
3., era rimosso il nome del tempo, & permutato nel modo detto minore, Eet le ci-page 75fre erano assegnate al tempo perfetto, & imperfetto,; ma se erano col circolo, &
col semicircolo due cifre, di modo minore il circolo, e 'l semicircolo diuventauva maggiore, & la prima cifra era detta Mmodo minore, & la seconda Ttempo,. oOltre di
ciò, se nel principio era il circolo, esso era chiamato modo maggior pfetto, laà douve se
uvi era il semicircolo, si domandauva modo maggior impfetto, di maniera che la cifra
seguente essendo ternaria, era detta modo minor perfetto, et se era binaria, imperfetto,; Eet l'ultima seguente cifra, se era ternaria, tempo perfetto,, & se binaria, imper-fetto era detta, come da noi al cap. 27. del primo libro del nostro Toscanello alcu-ne cose anchora ne sono state dette. Alla minima non si daà segno alcuno, conciosia
cosa che essendo dallei diuviso il tempo, essa è l'ultima figura di esso secondo l'ordine
delle cinque figure essentiali. considerate, delle quali daremo notitia, & cognitio-ne piuù breuve, & facile, che per noi sia possibile. Diciamo adunque, che se un canto
saraà segnato, come qui,  33., la massima haraà il uvalore di tre lunghe perfette, & la
lunga di tre breuvi perfette, & la breuve di tre semibreuvi, & la semibreuve di tre mi-nime. Et desiderando intendere qual nota sia alterata, dico, che le lunghe saranno
alterate, le breuvi, le semibreuvi, & le minime rispetto alla massima, alla lunga, alla
breuve, et alle semibreuvi, le quali sono perfette,. Et essendo segnato cosiì,
33., la massima haraà il uvalore di tre lunghe perfette, & la
lunga di tre breuvi perfette, & la breuve di tre semibreuvi, & la semibreuve di tre mi-nime. Et desiderando intendere qual nota sia alterata, dico, che le lunghe saranno
alterate, le breuvi, le semibreuvi, & le minime rispetto alla massima, alla lunga, alla
breuve, et alle semibreuvi, le quali sono perfette,. Et essendo segnato cosiì,  23., la mas-sima, la breuve, & la semibreuve saranno perfette, & per conseguente altereraà la lunga, la se-mibreuve, & la minima,. Ma se hauveraà questo segno,
23., la mas-sima, la breuve, & la semibreuve saranno perfette, & per conseguente altereraà la lunga, la se-mibreuve, & la minima,. Ma se hauveraà questo segno,  22., la massima, & la semibre-uve saranno perfette, Eet la semibree [sic: lunga], & la minima saranno alterate,. Ma trouvan-dosi in questo modo.,
22., la massima, & la semibre-uve saranno perfette, Eet la semibree [sic: lunga], & la minima saranno alterate,. Ma trouvan-dosi in questo modo.,  32., la massima, la lunga, & la semibreuve saranno perfette,
alterando le lunghe, le breuvi, & le minime,. Et mutando la figura in questo modo.,
32., la massima, la lunga, & la semibreuve saranno perfette,
alterando le lunghe, le breuvi, & le minime,. Et mutando la figura in questo modo.,  33., la mas-sima perderaà la sua perfettione, per essere il semicircolo inanzi posto, & la lunga,
la breuve, & la semibreuve resteranno perfette, & le breuvi, le semibreuvi, & le mini-me altereranno,. Ma stando cosiì.,
33., la mas-sima perderaà la sua perfettione, per essere il semicircolo inanzi posto, & la lunga,
la breuve, & la semibreuve resteranno perfette, & le breuvi, le semibreuvi, & le mini-me altereranno,. Ma stando cosiì.,  32., la lunga, & la semibreuve saranno perfette,
alterando le breuvi, & le minime,. Et se staraà a questo modo.,
32., la lunga, & la semibreuve saranno perfette,
alterando le breuvi, & le minime,. Et se staraà a questo modo.,  23., le breuvi, & le se-mibreuvi saranno perfette, Eet solamente le brei [sic: semibrevi], & le minime altereranno,; Eet se
cosiì,
23., le breuvi, & le se-mibreuvi saranno perfette, Eet solamente le brei [sic: semibrevi], & le minime altereranno,; Eet se
cosiì,  22., le semibreuvi resteranno perfette, & solamente la minima saraà alterata,.
Anchora il trouverai in questo modo.,
22., le semibreuvi resteranno perfette, & solamente la minima saraà alterata,.
Anchora il trouverai in questo modo.,  33., nelquale la massima, la lunga, & la breuve saranno perfette, alterando le lunghe, le breuvi, & le semibreuvi,. E trouvandolo cosiì,
33., nelquale la massima, la lunga, & la breuve saranno perfette, alterando le lunghe, le breuvi, & le semibreuvi,. E trouvandolo cosiì,
 32, la massima, & la lunga, saranno perfette, Eet solo le lunghe, & le breuvi alte-reranno,. Ma se saraà cosiì,
32, la massima, & la lunga, saranno perfette, Eet solo le lunghe, & le breuvi alte-reranno,. Ma se saraà cosiì,  23., la massima, & la breuve saranno perfette, & le lunghe, & le semibreuvi saranno alterate,; Eet se cosiì.,
23., la massima, & la breuve saranno perfette, & le lunghe, & le semibreuvi saranno alterate,; Eet se cosiì.,  22., la massima saraà perfetta, et
le lunghe haranno alteratione,. Nella seguente figura.,
22., la massima saraà perfetta, et
le lunghe haranno alteratione,. Nella seguente figura.,  33., la lunga, & la breuve saranno perfette, Eet per conseguente altereranno le breuvi, & le semibreuvi,. Et in que-sto,
33., la lunga, & la breuve saranno perfette, Eet per conseguente altereranno le breuvi, & le semibreuvi,. Et in que-sto,  32., la lunga saraà perfetta, & solo altereranno le sue breuvi,. Et ouve il ritrouvas-si in questa guisa.,
32., la lunga saraà perfetta, & solo altereranno le sue breuvi,. Et ouve il ritrouvas-si in questa guisa.,  23., le breuvi saranno perfette, & solamente le semibreuvi altere-ranno,. Resta la seguente, & ultima figura.,
23., le breuvi saranno perfette, & solamente le semibreuvi altere-ranno,. Resta la seguente, & ultima figura.,  22., nella quale non hauveraà luogo il
far imperfetto, neé l'alterare, rispetto al semicircolo, & alle cifre binarie,. Et quan-tunque tali segni al presente non si usino, nondimeno non ti dee essere molesto l'ha-page 76uvere apparato in che modo essi siano da douver esser intese.
22., nella quale non hauveraà luogo il
far imperfetto, neé l'alterare, rispetto al semicircolo, & alle cifre binarie,. Et quan-tunque tali segni al presente non si usino, nondimeno non ti dee essere molesto l'ha-page 76uvere apparato in che modo essi siano da douver esser intese.
Del tacito uvalore della Mmassima. Cap. XI.
 Iil qual modo da' moderni Mmusici, è stato ordinato, e tralasciati i so-pradetti segni dagli antichi usati, i quali, nel seguente ordine di pau-se ternario, & binario, dimostrano il medesimo effetto, che faceano gli antichi ne'
sopradetti segni.
Iil qual modo da' moderni Mmusici, è stato ordinato, e tralasciati i so-pradetti segni dagli antichi usati, i quali, nel seguente ordine di pau-se ternario, & binario, dimostrano il medesimo effetto, che faceano gli antichi ne'
sopradetti segni.
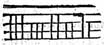
Valor di massi-me & lunghe.
 33., da gli antichi usato per dimostrare il suo Mmodo maggio-re, e 'l modo minore, e 'l Ttempo perfetti, si uvale del seguente,
33., da gli antichi usato per dimostrare il suo Mmodo maggio-re, e 'l modo minore, e 'l Ttempo perfetti, si uvale del seguente,  Iilquale dimostra chella mente del Ccompositore fu che in qualunque canto, douve esso
si ritrouvasse, desse notitia, chella massima douvesse hauvere il uvalore delle
tre lunghe, & la lunga delle breuvi,. Et per quest'altro.,
Iilquale dimostra chella mente del Ccompositore fu che in qualunque canto, douve esso
si ritrouvasse, desse notitia, chella massima douvesse hauvere il uvalore delle
tre lunghe, & la lunga delle breuvi,. Et per quest'altro.,  32., da essi antichi era di-mostrata la massima perfetta, & la lunga, siì come da' moderni dimostrano, le tre
pause di tre tempi,. Et quando essi antichi & dotti musici uvoleuvano rappresentare
la massima perfetta, insieme posta col tempo perfetto, da loro era usato il pre-sente segno.,
32., da essi antichi era di-mostrata la massima perfetta, & la lunga, siì come da' moderni dimostrano, le tre
pause di tre tempi,. Et quando essi antichi & dotti musici uvoleuvano rappresentare
la massima perfetta, insieme posta col tempo perfetto, da loro era usato il pre-sente segno.,  23., & i moderni, il circolo, con tre pause di lunga di tre tem-pi l'una. Et se uvoleuvano figurare la massima perfetta, la lunga, & la breuve
imperfette, non con altro, che col presente segno.,
23., & i moderni, il circolo, con tre pause di lunga di tre tem-pi l'una. Et se uvoleuvano figurare la massima perfetta, la lunga, & la breuve
imperfette, non con altro, che col presente segno.,  22., le dimostrauvano, siì come
hor dal Mmusico moderno con questo,
22., le dimostrauvano, siì come
hor dal Mmusico moderno con questo,  sono rappresentate,. Et quando il Mmusico antico uvoleuva intendere, che la massima fosse imperfetta, & la lun-ga, & la breuve perfette, era il suo segno, come qui si uvede.,
sono rappresentate,. Et quando il Mmusico antico uvoleuva intendere, che la massima fosse imperfetta, & la lun-ga, & la breuve perfette, era il suo segno, come qui si uvede.,  33. Laà on-de i moderni a sua similitudine fecero quest'altro.
33. Laà on-de i moderni a sua similitudine fecero quest'altro.  Appresso uvolendo gli an-tichi che sol la lunga restasse pfetta, ciò no con altro, che col presente segno page 77dimostrauvano.,
Appresso uvolendo gli an-tichi che sol la lunga restasse pfetta, ciò no con altro, che col presente segno page 77dimostrauvano.,  32., laà douve dal moderno ciò co questo,
32., laà douve dal moderno ciò co questo,  fu significato,. Et quado essi uvoleuvano dar a conoscere il tempo perfetto, da loro era usato il pre-sente segno.,
fu significato,. Et quado essi uvoleuvano dar a conoscere il tempo perfetto, da loro era usato il pre-sente segno.,  23., come da' moderni il segno seguen- teseguente.
23., come da' moderni il segno seguen- teseguente.  Et tutto
che il presente segno.,
Et tutto
che il presente segno.,  22., non sia d'importanza alcuna, siì co- mecome quello,
delquale i detti antichi Mmusici non si uvaleuvano ad altro uso, che a dimostrare ogni
figura binaria, peroò ci è paruto di metterlo, p no macare dell'ordine incominciato.
22., non sia d'importanza alcuna, siì co- mecome quello,
delquale i detti antichi Mmusici non si uvaleuvano ad altro uso, che a dimostrare ogni
figura binaria, peroò ci è paruto di metterlo, p no macare dell'ordine incominciato.
Oppenione di alcuni intorno la breuve perfetta & imperfetta. Cap. XII.
 essa debba sempre essere perfetta in quella guisa, che è
ogni simile posta innanzi alla sua simile, conciosia cosa che le dette pause di semi-breuvi siano del uvalimento di una breuve imperfetta, Aalla qual oppenione dannoi è risposto, che se tal ordine potesse essere tenuto, si uvederebbe da' precetti Mmusici nascere gran confusione,. pPer tanto non è da dire che le due pause con la forma, o corpo
della detta breuve siano simili, conciosia cosa che la breuve si uvegga hauvere diuversa
figura dalle pause, ma ben si potraà dire esse pause essere del medesimo uvalore della
breuve imperfetta,. Et se alcuni ci si oppenessero, dicedo chella regola data della breuve perfetta dinanzi la sua propia pausa, non fosse sempre perfetta, perciocheé essa
pausa non ha somiglianza con la detta breuve, tutto che ella sia del medesimo uvalo-re, dannoi si risponde, chella pausa di breuve è degna, & merita chella figura bre-uve, inanzi allei posta, sempre sia conseruvata perfetta, cociosia che essa pausa sia stabile, & permanente, & dal Mmusico ordinata perfetta, & imperfetta, perfetta nel
segno circolare, et imperfetta nel semicircolare, senza mai cangiare la sua forma,.
lLaà onde le due pausette della semibreuve insieme messe non haranno tal potere, che
sempre aumentino la breuve al uvalor del numero ternario, perciocheé ciò stàa nel uvolere del Mmusico, & Ccompositore, dal quale uveggiamo molte uvolte essa breuve essere fatta perfetta, et imperfetta, Iimperfetta dalla parte dauvati da una minore di lei, o da oltre tato uvalore, dalla parte dopo da un punto posto fra le due pausette,. Et piuù, a maggior loro biasimo, et confusione uvogliono chella breuve dinanzi la seguente legatura,
ouvero nota maggior di seé, ouvero dinanzi a un tepo di semibreuvi insieme unito, sia per-fetta, lequali oppenioni sono false, et senza ragione alcuna da loro intese, et credute,.
Raffermeremo adunque, et cochiuderemo, chella breuve inazi alla lunga, o alla massima et alle pausette di semibreuvi, Eet similmete dinazi alla quantitaà del numero ternario, et alla legatura, è in arbitrio del Ccompositore, come la figura seguete dimostra.
essa debba sempre essere perfetta in quella guisa, che è
ogni simile posta innanzi alla sua simile, conciosia cosa che le dette pause di semi-breuvi siano del uvalimento di una breuve imperfetta, Aalla qual oppenione dannoi è risposto, che se tal ordine potesse essere tenuto, si uvederebbe da' precetti Mmusici nascere gran confusione,. pPer tanto non è da dire che le due pause con la forma, o corpo
della detta breuve siano simili, conciosia cosa che la breuve si uvegga hauvere diuversa
figura dalle pause, ma ben si potraà dire esse pause essere del medesimo uvalore della
breuve imperfetta,. Et se alcuni ci si oppenessero, dicedo chella regola data della breuve perfetta dinanzi la sua propia pausa, non fosse sempre perfetta, perciocheé essa
pausa non ha somiglianza con la detta breuve, tutto che ella sia del medesimo uvalo-re, dannoi si risponde, chella pausa di breuve è degna, & merita chella figura bre-uve, inanzi allei posta, sempre sia conseruvata perfetta, cociosia che essa pausa sia stabile, & permanente, & dal Mmusico ordinata perfetta, & imperfetta, perfetta nel
segno circolare, et imperfetta nel semicircolare, senza mai cangiare la sua forma,.
lLaà onde le due pausette della semibreuve insieme messe non haranno tal potere, che
sempre aumentino la breuve al uvalor del numero ternario, perciocheé ciò stàa nel uvolere del Mmusico, & Ccompositore, dal quale uveggiamo molte uvolte essa breuve essere fatta perfetta, et imperfetta, Iimperfetta dalla parte dauvati da una minore di lei, o da oltre tato uvalore, dalla parte dopo da un punto posto fra le due pausette,. Et piuù, a maggior loro biasimo, et confusione uvogliono chella breuve dinanzi la seguente legatura,
ouvero nota maggior di seé, ouvero dinanzi a un tepo di semibreuvi insieme unito, sia per-fetta, lequali oppenioni sono false, et senza ragione alcuna da loro intese, et credute,.
Raffermeremo adunque, et cochiuderemo, chella breuve inazi alla lunga, o alla massima et alle pausette di semibreuvi, Eet similmete dinazi alla quantitaà del numero ternario, et alla legatura, è in arbitrio del Ccompositore, come la figura seguete dimostra.
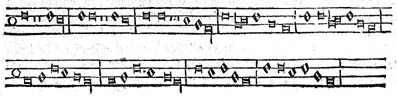 page 78
page 78Percheé la Mmassima non ha pausa. Cap. XIII.
 la qual pausa sarebbe chiamata dal Ttempo imperfetto,; Ll'altro,
che tal pausa piglierebbe la forma di tre semibreuvi, come qui,
la qual pausa sarebbe chiamata dal Ttempo imperfetto,; Ll'altro,
che tal pausa piglierebbe la forma di tre semibreuvi, come qui,  la qual occu-parebbe un spatio intiero, & la metà di esso,. Et per tal modo la pausa del Ttempo
perfetto con quella del modo maggiore sarebbono fra seé simili, non ostante, che in
tal consideratione tra loro cadessi non poca dissomiglianza, percheé la immaginata
& non data pausa dimostrerebbe moltitudine di tempi, & quella breuve dinotereb-be il Ttempo in tre terze parti diuviso. Si potrebbe intorno la similitudine delle dimo-strate domandare ad alcuni, se egli fosse in uso di segnare il Ttempo perfetto con la
pausa di breuve occuparte [sic: occupante] uno intero spatio & la metà di esso, come qui,
la qual occu-parebbe un spatio intiero, & la metà di esso,. Et per tal modo la pausa del Ttempo
perfetto con quella del modo maggiore sarebbono fra seé simili, non ostante, che in
tal consideratione tra loro cadessi non poca dissomiglianza, percheé la immaginata
& non data pausa dimostrerebbe moltitudine di tempi, & quella breuve dinotereb-be il Ttempo in tre terze parti diuviso. Si potrebbe intorno la similitudine delle dimo-strate domandare ad alcuni, se egli fosse in uso di segnare il Ttempo perfetto con la
pausa di breuve occuparte [sic: occupante] uno intero spatio & la metà di esso, come qui,  & page 79l'imperfetto di uno intero spacio, Eet appresso non ritrouvandosi il circolo, ilquale
dimostrasse la perfettione del Ttempo, ma sol le pause delle due semibreuvi, come qui.
& page 79l'imperfetto di uno intero spacio, Eet appresso non ritrouvandosi il circolo, ilquale
dimostrasse la perfettione del Ttempo, ma sol le pause delle due semibreuvi, come qui.
 sSe si direbbe che tal binaria positione di pause desse cognitione della breuve
perfetta, diciamo di no, percheé trouvandosi la propia pausa del Ttempo perfetto, &
imperfetto, come qui
sSe si direbbe che tal binaria positione di pause desse cognitione della breuve
perfetta, diciamo di no, percheé trouvandosi la propia pausa del Ttempo perfetto, &
imperfetto, come qui  tal pause delle due semibreuvi nel canto, sarebbono di
souverchio, & in uvano addotte circa la perfettione del Ttempo, percheé non oppererebbono l'effetto accidentale del circolo, neé di altro segno,. Et se alcuno fosse di contraria oppenione dicendo, che tali pause di semibreuvi insieme poste potrebbono essere
in questa consideratione necessarie, come qui,
tal pause delle due semibreuvi nel canto, sarebbono di
souverchio, & in uvano addotte circa la perfettione del Ttempo, percheé non oppererebbono l'effetto accidentale del circolo, neé di altro segno,. Et se alcuno fosse di contraria oppenione dicendo, che tali pause di semibreuvi insieme poste potrebbono essere
in questa consideratione necessarie, come qui, 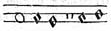 Ssi rispode, che
alhora le dette pause no hauverebbono forza di dimostrare
perfettione alcuna, per essere loro innazi posto il segno circolare, ma sarebbono intese a douver diuvidere la pausa del Ttempo imperfetto in due
parti equali, percheé, come dimostra la seguente figura, sarebbe dibisogno che la se-conda semibreuve alterasse, come qui,
Ssi rispode, che
alhora le dette pause no hauverebbono forza di dimostrare
perfettione alcuna, per essere loro innazi posto il segno circolare, ma sarebbono intese a douver diuvidere la pausa del Ttempo imperfetto in due
parti equali, percheé, come dimostra la seguente figura, sarebbe dibisogno che la se-conda semibreuve alterasse, come qui,  siì come comanda la rego-la dell'alteratione,. Onde il Musi- comusico, per rimouvere tal alteratione, diuvideraà la pausa del tempo imperfetto in due pause di
semibreuvi, per lequali ragioni, a noi pare, che esse piuù regolarmente douveranno es-ser poste se saranno separate dall'una riga a l'altra, come qui,
siì come comanda la rego-la dell'alteratione,. Onde il Musi- comusico, per rimouvere tal alteratione, diuvideraà la pausa del tempo imperfetto in due pause di
semibreuvi, per lequali ragioni, a noi pare, che esse piuù regolarmente douveranno es-ser poste se saranno separate dall'una riga a l'altra, come qui, 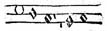 percheé le pause, lequali secondo il misurare del canto cadono
diuvise, non debbono per tal cagione essere insieme poste,. nNondi-meno in questa consideratione, o siano separate, o no, non è di molta, o di niuna importanza. Hauvendo con tali fondamenti dimostrato, come la pausa della breuve si
possa ritrouvare uvariabile, cioè di Ttempo perfetto, et imperfetto, manifestamente ap-pare, che essendo nella guisa che habbiamo detto segnata dal musico, le pause delle
semibreuvi, come qui,
percheé le pause, lequali secondo il misurare del canto cadono
diuvise, non debbono per tal cagione essere insieme poste,. nNondi-meno in questa consideratione, o siano separate, o no, non è di molta, o di niuna importanza. Hauvendo con tali fondamenti dimostrato, come la pausa della breuve si
possa ritrouvare uvariabile, cioè di Ttempo perfetto, et imperfetto, manifestamente ap-pare, che essendo nella guisa che habbiamo detto segnata dal musico, le pause delle
semibreuvi, come qui,  non potranno dimostrare il Ttempo essere perfetto,
Ppercheé se la pausa della breuve perfetta fosse prodotta diuversa dalla pausa del Ttem-po imperfetto, le pause delle semibreuvi disopra mostrate intorno la perfettione del
Ttempo, sarebbono indarno poste, percheé ciascuna di esse breuvi harebbe la sua pro-pia pausa, Eet a questo modo bisognerebbe fare la medesima differenza nella massima, percheé uvolendo assegnare a ciascun temporal uvalore & quantitaà di quella ogni
sua propia pausa, sarebbe necessario constituire una uvirgola, o pausa, la qual con-tenesse quando fosse perfetta nouve tempi, & quando imperfetta sei, & alcuna uvol-ta quattro, per loquale ordine, & modo chiaro si uvede che in tutti i canti nascereb-be non poca confusione, percheé alle consuete righe ordinate per li nomi delle note
sarebbe forza aggiongerne dell'altre alla grandezza della pausa de' sei tempi, &
molto maggiormente poscia a quella de' nouve. Dalle sopradette ragioni adunque
si puoò conoscere, chella massima resteraà priuva della propria pausa, & quando essa
haraà bisogno del suo tacito uvalore, con oltre tante pause di lunga saraà reintegrata,
le quali quantitaà, & uvalori nascono tutte da esso tempo Mmusico, ilquale piuù uvolte
preso genera il modo minore & il maggiore, et diuviso in parti minute, crea & gepage 80nera la prelation [sic: prolation] minore, & la maggiore,. lLaà onde essendo esso primo, & capo per
eccellenzza [sic: eccellenza], merita pausa propia, et inuvariabile,. Alcuni si mouvono dicendo, che non
essendo ordinato dal Mmusico propia pausa alla massima, per conseguente non si dee
neé anche dare pausa alla breuve, Eet dicono esser necessario dare alla breuve il tacito
suo uvalore con la pausa della minore a seé propinqua, tante uvolte presa quanto saraà
il uvalore di essa breuve, cioè se il tempo saraà perfetto, tal sua perfettione, ouvero ter-naria diuvisione sia dimostrata con tre pause di semibreuvi in una riga, come qui,
non potranno dimostrare il Ttempo essere perfetto,
Ppercheé se la pausa della breuve perfetta fosse prodotta diuversa dalla pausa del Ttem-po imperfetto, le pause delle semibreuvi disopra mostrate intorno la perfettione del
Ttempo, sarebbono indarno poste, percheé ciascuna di esse breuvi harebbe la sua pro-pia pausa, Eet a questo modo bisognerebbe fare la medesima differenza nella massima, percheé uvolendo assegnare a ciascun temporal uvalore & quantitaà di quella ogni
sua propia pausa, sarebbe necessario constituire una uvirgola, o pausa, la qual con-tenesse quando fosse perfetta nouve tempi, & quando imperfetta sei, & alcuna uvol-ta quattro, per loquale ordine, & modo chiaro si uvede che in tutti i canti nascereb-be non poca confusione, percheé alle consuete righe ordinate per li nomi delle note
sarebbe forza aggiongerne dell'altre alla grandezza della pausa de' sei tempi, &
molto maggiormente poscia a quella de' nouve. Dalle sopradette ragioni adunque
si puoò conoscere, chella massima resteraà priuva della propria pausa, & quando essa
haraà bisogno del suo tacito uvalore, con oltre tante pause di lunga saraà reintegrata,
le quali quantitaà, & uvalori nascono tutte da esso tempo Mmusico, ilquale piuù uvolte
preso genera il modo minore & il maggiore, et diuviso in parti minute, crea & gepage 80nera la prelation [sic: prolation] minore, & la maggiore,. lLaà onde essendo esso primo, & capo per
eccellenzza [sic: eccellenza], merita pausa propia, et inuvariabile,. Alcuni si mouvono dicendo, che non
essendo ordinato dal Mmusico propia pausa alla massima, per conseguente non si dee
neé anche dare pausa alla breuve, Eet dicono esser necessario dare alla breuve il tacito
suo uvalore con la pausa della minore a seé propinqua, tante uvolte presa quanto saraà
il uvalore di essa breuve, cioè se il tempo saraà perfetto, tal sua perfettione, ouvero ter-naria diuvisione sia dimostrata con tre pause di semibreuvi in una riga, come qui,
 , Eet similmente il uvalore del Ttempo imperfetto, ouveramente breuve imperfetta con due altre pausette, come qui,
, Eet similmente il uvalore del Ttempo imperfetto, ouveramente breuve imperfetta con due altre pausette, come qui,  le quali tre pause disopra dimostrate senza altro segno daranno notitia della breuve perfetta, come le binarie dimostre-ranno la breuve imperfetta, pur che nel canto non appaiano le tre disopra mostrate,
per li quali segni le note saranno annouverate a tre, et a due,. Si risponde, & conchiude, che tutto che al uvalore binario, & ternario della massima siano date oltre tan-te pause di lunga, non si conuviene peroò dare alla pausa della breuve oltre tante pausette di semibreuvi, quanto si conuvenga alla quantitaà sua ternaria, & binaria, per-cheé da essa depende ogni altra pausa, et figura,. pP tanto la massima, quando le saraà di
bisogno tacere, dependeraà dalla pausa di bree [sic: lunga] tante uvolte moltiplicata, quanto saraà
il suo uvalore, ma non giaà allo 'ncontro la pausa della breuve non potraà deriuvare da
quella della massima [sic: semibreve] molte uvolte presa, percheé esse pause della massima, diriuvando
da quelle della breuve, conuviene che esse le restino soggette. Altri dubitando si mouvo-no dicendo, che se il modo maggiore perfetto si conosce per la apparenza delle tre
pause della lunga di pari poste, Eet quelle dello imperfetto maggiore per le due pause dette, seguiteraà, che nell'istesso canto caderaà contrarietaà, quando l'una, et l'altra
positione delle dette pause uvi si trouveranno, come appare in questo essempio.
le quali tre pause disopra dimostrate senza altro segno daranno notitia della breuve perfetta, come le binarie dimostre-ranno la breuve imperfetta, pur che nel canto non appaiano le tre disopra mostrate,
per li quali segni le note saranno annouverate a tre, et a due,. Si risponde, & conchiude, che tutto che al uvalore binario, & ternario della massima siano date oltre tan-te pause di lunga, non si conuviene peroò dare alla pausa della breuve oltre tante pausette di semibreuvi, quanto si conuvenga alla quantitaà sua ternaria, & binaria, per-cheé da essa depende ogni altra pausa, et figura,. pP tanto la massima, quando le saraà di
bisogno tacere, dependeraà dalla pausa di bree [sic: lunga] tante uvolte moltiplicata, quanto saraà
il suo uvalore, ma non giaà allo 'ncontro la pausa della breuve non potraà deriuvare da
quella della massima [sic: semibreve] molte uvolte presa, percheé esse pause della massima, diriuvando
da quelle della breuve, conuviene che esse le restino soggette. Altri dubitando si mouvo-no dicendo, che se il modo maggiore perfetto si conosce per la apparenza delle tre
pause della lunga di pari poste, Eet quelle dello imperfetto maggiore per le due pause dette, seguiteraà, che nell'istesso canto caderaà contrarietaà, quando l'una, et l'altra
positione delle dette pause uvi si trouveranno, come appare in questo essempio.
 Onde tal contrarietaà dicono auvenire, percheé in un solo cocento, o subietto caderanno duoi contrari di perfettione, et d'imperfettione, Aal
qual dubbio si risponde, chelle due pause di lunga possono ragione-uvolmente stare ne' canti del modo maggior perfetto senza producere alcuna con-trarietà, come quelle che hanno in seé perfettione, & imperfettione, come anchora
accade delle breuvi perfette, & imperfette, lequali hanno luogo nel Ttempo perfetto,
pur che essa massima, ouver pause siano reintegrate dalla terza loro parte, o per pausa, o per nota cantabile, Ccome disopra la figura dimostra,. Ma quelle a tre insie-me poste non si conuveranno porre nel modo maggiore imperfetto, perciocheé in ta-le consideratione esse sono annouverate per misura binaria, & non ternaria, come anchora non è licito segnare le pause, che significano perfettione sotto il segno della
imperfettione, come si uvede qua.
Onde tal contrarietaà dicono auvenire, percheé in un solo cocento, o subietto caderanno duoi contrari di perfettione, et d'imperfettione, Aal
qual dubbio si risponde, chelle due pause di lunga possono ragione-uvolmente stare ne' canti del modo maggior perfetto senza producere alcuna con-trarietà, come quelle che hanno in seé perfettione, & imperfettione, come anchora
accade delle breuvi perfette, & imperfette, lequali hanno luogo nel Ttempo perfetto,
pur che essa massima, ouver pause siano reintegrate dalla terza loro parte, o per pausa, o per nota cantabile, Ccome disopra la figura dimostra,. Ma quelle a tre insie-me poste non si conuveranno porre nel modo maggiore imperfetto, perciocheé in ta-le consideratione esse sono annouverate per misura binaria, & non ternaria, come anchora non è licito segnare le pause, che significano perfettione sotto il segno della
imperfettione, come si uvede qua. 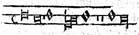 Ma accadendo al Mmusico a segnare le tre pause di lunga, esso saraà co-stretto segnarle in tal guisa, & modo, come la seguente figura ti dimostra. page 81
Ma accadendo al Mmusico a segnare le tre pause di lunga, esso saraà co-stretto segnarle in tal guisa, & modo, come la seguente figura ti dimostra. page 81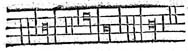 Similmente, senza commettere errore, gli saraà
conceduto porre nel modo maggior perfetto
due pause di lunga inegualmente poste, co-me il seguente.,
Similmente, senza commettere errore, gli saraà
conceduto porre nel modo maggior perfetto
due pause di lunga inegualmente poste, co-me il seguente.,
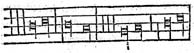 & in altri modi, i quali da noi per breuvitaà
sono lasciati, da' quali altri tutti modi ti
guarderai tu, Ccompositore, di non incorreruvi, saluvo che in quelli, che da me sono stati
posti, i quali appresso ogni dotto senza alcun dubbio sono & saranno confermati.
& in altri modi, i quali da noi per breuvitaà
sono lasciati, da' quali altri tutti modi ti
guarderai tu, Ccompositore, di non incorreruvi, saluvo che in quelli, che da me sono stati
posti, i quali appresso ogni dotto senza alcun dubbio sono & saranno confermati.
Come il Mmusico non ha riguardo di far imperfetta piuù l'una che l'altra di di [sic: di] molte note in un corpo unite. Cap. XIIII.
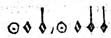 & dato che il primo, & il secon-do essempio per la posi- tionepositione delle semiminime sia tra seé
differente, però in cioò non cade errore alcuno, percheé alcuna uvolta le dette minime piene possono in tali segni puntati dal Mmusico essere in-tese per euvitare l'alteratione, che senza esse si uvedrebbe sortire, pur che ne' canti do-uve esse fanno tal effetto, non si ritrouvino dell'altre note simili, sopra la quale imperfettione da molti sono addotte alcune ragioni da' dotti non concedute, neé approuva-te, delle quali alcune dannoi saranno dimostrate nel seguente segno,.
& dato che il primo, & il secon-do essempio per la posi- tionepositione delle semiminime sia tra seé
differente, però in cioò non cade errore alcuno, percheé alcuna uvolta le dette minime piene possono in tali segni puntati dal Mmusico essere in-tese per euvitare l'alteratione, che senza esse si uvedrebbe sortire, pur che ne' canti do-uve esse fanno tal effetto, non si ritrouvino dell'altre note simili, sopra la quale imperfettione da molti sono addotte alcune ragioni da' dotti non concedute, neé approuva-te, delle quali alcune dannoi saranno dimostrate nel seguente segno,.  Essi dicono che le due minime del presente segno poste dopo la breuve,
facendo delle tre semibreuvi, che in essa sono immaginate due imperfette, & l'altra rimanendo perfetta, per tal modo la breuve uverraà a restare di uvalo-re di sette minime,. Et se tal breuve tre minime continue hauvraà dopo seé, come qui,
Essi dicono che le due minime del presente segno poste dopo la breuve,
facendo delle tre semibreuvi, che in essa sono immaginate due imperfette, & l'altra rimanendo perfetta, per tal modo la breuve uverraà a restare di uvalo-re di sette minime,. Et se tal breuve tre minime continue hauvraà dopo seé, come qui,
 credono, che tali tre minime facciano imperfette quelle tre se-mibreuvi contenute nella detta breuve, la quale oppenione è fal-sa, & male intesa, percheé le tre semibreuvi, lequali sono il uva-lore di essa breuve perfetta, non possono essere fatte imperfette dalle tre dette mini-me, percheé ouve cosiì fosse, egli seguiterebbe che la breuve perfetta non si potesse fare
imperfetta della sua terza parte, laquale è la semibreuve, laqual cosa sarebbe con-tro la regola, laquale coma da che ogni nota perfetta si possa fare imperfetta quanpage 82do le se toglie la terza sua parte, laquale è la semibreuve o 'l suo uvalore. pPertanto, uvo-lendo questi tali, che quelle tre minime habbiano forza di far imperfette le tre se-mibreuvi continue nel corpo della detta breuve, si conchiude tal loro parere essere fuori di ogni ragione, percheé tolta la perfettione a ciascheduna delle tre semibreuvi considerate perfette nella detta breuve, essa resterebbe perfetta di tre semibreuvi imper-fette, Eet per tal modo, la breuve dopo la imperfettione delle tre semibreuvi sarebbe fatta imperfetta da una semibreuve perfetta, la qual immaginatione sarebbe cotraria al
sopradetto segno, percheé esso dimostra che 'l tempo, ouver la breuve è formata di tre
semibreuvi,. Et percheé alcune cose dette disopra fanno, in questo luogo al proposito
nostro non ci è paruto inconuveniente reiterar, per poter meglio conchiudere quel-lo, che da ogni huomo forse non è inteso, è da alcun creduto, che quando il Mmusico,
òo Ccompositore ne' suoi canti dimostra la presente figuratione.,
credono, che tali tre minime facciano imperfette quelle tre se-mibreuvi contenute nella detta breuve, la quale oppenione è fal-sa, & male intesa, percheé le tre semibreuvi, lequali sono il uva-lore di essa breuve perfetta, non possono essere fatte imperfette dalle tre dette mini-me, percheé ouve cosiì fosse, egli seguiterebbe che la breuve perfetta non si potesse fare
imperfetta della sua terza parte, laquale è la semibreuve, laqual cosa sarebbe con-tro la regola, laquale coma da che ogni nota perfetta si possa fare imperfetta quanpage 82do le se toglie la terza sua parte, laquale è la semibreuve o 'l suo uvalore. pPertanto, uvo-lendo questi tali, che quelle tre minime habbiano forza di far imperfette le tre se-mibreuvi continue nel corpo della detta breuve, si conchiude tal loro parere essere fuori di ogni ragione, percheé tolta la perfettione a ciascheduna delle tre semibreuvi considerate perfette nella detta breuve, essa resterebbe perfetta di tre semibreuvi imper-fette, Eet per tal modo, la breuve dopo la imperfettione delle tre semibreuvi sarebbe fatta imperfetta da una semibreuve perfetta, la qual immaginatione sarebbe cotraria al
sopradetto segno, percheé esso dimostra che 'l tempo, ouver la breuve è formata di tre
semibreuvi,. Et percheé alcune cose dette disopra fanno, in questo luogo al proposito
nostro non ci è paruto inconuveniente reiterar, per poter meglio conchiudere quel-lo, che da ogni huomo forse non è inteso, è da alcun creduto, che quando il Mmusico,
òo Ccompositore ne' suoi canti dimostra la presente figuratione.,  che la
semibreuve posta dinazi alla lunga possa far impfetta la prima breuve
contenuta nel corpo della lunga, Eet che quella posta dopo la lunga
del seguente essempio,
che la
semibreuve posta dinazi alla lunga possa far impfetta la prima breuve
contenuta nel corpo della lunga, Eet che quella posta dopo la lunga
del seguente essempio,  habbia forza di far imperfetta la secoda breuve di quella, Lle oppenioni, et inconsiderate considerationi de' qua-li procedono per ter- minitermini non ragioneuvoli, percheé si estendono in
quello, che non puoò stare neé essere inteso, perciocheé il contenere che fa la lunga del-le due breuvi non è siì come essi credono secondo la quantitaà discreta, ma secondo la
uvertuù, che essa ha di natura, percheé dato che in tal lunga siano due breuvi, non peroò
tal breuvi saranno in tal lunga secondo il lor uvalore formale,. Mancando adunque
della forma loro propia di breuve, per conseguete loro mancheraà etiandio l'esser dette, prima, seconda, & terza breuve, quando esse nella lunga saranno fatte imperfet-te,. oOnde se a tal lunga, per cagion delle breuvi, fosse fatto distintione di prima, secon-da, o terza, ne nascerebbe alcuna uvolta la similitudine che è tra loro,. oOnde la semi-breuve in tal modo intesa,
habbia forza di far imperfetta la secoda breuve di quella, Lle oppenioni, et inconsiderate considerationi de' qua-li procedono per ter- minitermini non ragioneuvoli, percheé si estendono in
quello, che non puoò stare neé essere inteso, perciocheé il contenere che fa la lunga del-le due breuvi non è siì come essi credono secondo la quantitaà discreta, ma secondo la
uvertuù, che essa ha di natura, percheé dato che in tal lunga siano due breuvi, non peroò
tal breuvi saranno in tal lunga secondo il lor uvalore formale,. Mancando adunque
della forma loro propia di breuve, per conseguete loro mancheraà etiandio l'esser dette, prima, seconda, & terza breuve, quando esse nella lunga saranno fatte imperfet-te,. oOnde se a tal lunga, per cagion delle breuvi, fosse fatto distintione di prima, secon-da, o terza, ne nascerebbe alcuna uvolta la similitudine che è tra loro,. oOnde la semi-breuve in tal modo intesa,  non potrebbe far imperfetta la prima breuve
di essa lunga, & questo accaderebbe, rispetto alla prima breuve della
lunga, laqual sarebbe innanzi alla sua simile, come il presente pro-cesso dimostra.
non potrebbe far imperfetta la prima breuve
di essa lunga, & questo accaderebbe, rispetto alla prima breuve della
lunga, laqual sarebbe innanzi alla sua simile, come il presente pro-cesso dimostra.  Per tanto non è da considerare che in tal lunga, & altre simili fi- gurefigure maggiori, o minori si possa ritrouvare tal distentione di prima, neé seconda, neé terza, ma è da credere, che la lunga habbia la uver-tuù, & uvalore di due breuvi, & non la forma di breuve, Eet che ciascuna di esse breuvi
possa restare imperfetta da una di quelle semibreuvi, Eet tal lunga sia permanente albergo & madre di tali note fatte imperfette,. lLaà onde, humanissimo & candido let-tore, considerando le sopradette cose in altro modo, ageuvolmente rimarresti ingan-nato, & quanto piuù note perfette si trouvassero in una figura maggiore, tanto piuù
manifesti errori da te sarebbono commessi.
Per tanto non è da considerare che in tal lunga, & altre simili fi- gurefigure maggiori, o minori si possa ritrouvare tal distentione di prima, neé seconda, neé terza, ma è da credere, che la lunga habbia la uver-tuù, & uvalore di due breuvi, & non la forma di breuve, Eet che ciascuna di esse breuvi
possa restare imperfetta da una di quelle semibreuvi, Eet tal lunga sia permanente albergo & madre di tali note fatte imperfette,. lLaà onde, humanissimo & candido let-tore, considerando le sopradette cose in altro modo, ageuvolmente rimarresti ingan-nato, & quanto piuù note perfette si trouvassero in una figura maggiore, tanto piuù
manifesti errori da te sarebbono commessi.
Oppenione, & Rresolutione, circa i Mmandriali a Nnote nere. Cap. XV. For further information on black-note madrigals, see The Anthologies of Black-Note Madrigals, ed. Don Harrán (Corpus mensurabilis musicae, 73; Neuhausen-Stuttgart, 1978-1981).
Aa note nere,sopra de' quali scriuvono, & dicono,
Cantasi a breuve.Et per tal cieco modo & corruttela, l'uno dapo [sic: dopo] l'altro, nella fossa si getta-no,. Questo adiuviene, cheé mancano della intelligenza del semircolo [sic: semicircolo] dalloro segna-to, Cconciosia cosa che, da ogni Mmusico antico, & moderno, non è, neé fu mai det-to, che tal segno semicircolare non tagliato, si douvesse cantare alla battuta, o misu-ra della breuve,. Et cheé questo sia la uveritaà, considera, et bene esamina la natura de' seguenti segni,

 , douve conoscerai il mvnifestissimo [sic: manifestissimo] tuo errore, & corruttela, per
che non fai differenza l'uno dall'altro, dicendo in questo segno,
, douve conoscerai il mvnifestissimo [sic: manifestissimo] tuo errore, & corruttela, per
che non fai differenza l'uno dall'altro, dicendo in questo segno,  ,
, Cantasi a bre-uve,Pper laqual cosa, si domanda, che misura si daraà a questo,
 ,. Non ho dubbio al-cuno, che tu non dica, che la misura saraà sopra la breuve, o di tanto sua uvalore,. Se
cosiì è, ne seguiteraà, che questi dui segni,
,. Non ho dubbio al-cuno, che tu non dica, che la misura saraà sopra la breuve, o di tanto sua uvalore,. Se
cosiì è, ne seguiteraà, che questi dui segni,  ,
,  , saranno eguali, Ddouve se cosiì fusse, Ssarebbe di souverchio, uno di esso, & contro a ogni precetto si procederebbe, percheé
questo,
, saranno eguali, Ddouve se cosiì fusse, Ssarebbe di souverchio, uno di esso, & contro a ogni precetto si procederebbe, percheé
questo,  , fa doppia proportione al seguente,
, fa doppia proportione al seguente,  , & al contrario, Ssotto doppia proportione, Pper le quali dimostrationi, & comparationi, non saraà uvero quello che da
te è creduto,. Et se bene da te saraà considerato, tu conoscerai, che tali Mmandriali a
note nere, non saranno cantati a' breuvi, ma a' semibreuvi, percheé in un tempo, ouver
battuta, non passa altro, che una semibreuve, o tanto suo uvalore, laqual semibreuve,
o quantitaà sua, in detto segno,
, & al contrario, Ssotto doppia proportione, Pper le quali dimostrationi, & comparationi, non saraà uvero quello che da
te è creduto,. Et se bene da te saraà considerato, tu conoscerai, che tali Mmandriali a
note nere, non saranno cantati a' breuvi, ma a' semibreuvi, percheé in un tempo, ouver
battuta, non passa altro, che una semibreuve, o tanto suo uvalore, laqual semibreuve,
o quantitaà sua, in detto segno,  , indugia tanto, quanto la breuve di questo segno,
, indugia tanto, quanto la breuve di questo segno,  ,
passa,. Et per tal modo da te è compreso, & creduto, che tali Mmandriali si cantino
a breuve, & non secondo il propio, & natura del segno, Cconchiudendo che tal misu-ra, o tempo non è a breuve, ma a semibreuve, Ppercheé come habbiamo detto, non altro
passa, che una semibreuve per tempo, Eet questo per la uvelocitaà delle note apparenti,
& dimostranti.
,
passa,. Et per tal modo da te è compreso, & creduto, che tali Mmandriali si cantino
a breuve, & non secondo il propio, & natura del segno, Cconchiudendo che tal misu-ra, o tempo non è a breuve, ma a semibreuve, Ppercheé come habbiamo detto, non altro
passa, che una semibreuve per tempo, Eet questo per la uvelocitaà delle note apparenti,
& dimostranti.
Oppenione, & Rresolutione, Iintorno le Ccompositioni. Cap. XVI.
 ,, Cconchiudendo che tali modi ouvero passaggi, non sono da douver essere usati, ma rilasciati. Restaci da considerare, alcune sorti di Cconsonanze, Cconciosia cosa che, esse non siano tutte atte, neé condecenti, al nostro genere Ddiatonico,
Nnondimeno saranno dannoi dichiarate, lequali sono, il Ddiatessaron maggiore, &
il minore, il Ddittono maggiore, & il minore, il Ttuono maggiore, & il minore, il
Ssemituono magglore [sic: maggiore], & il minore. Il Ddiatessaron maggiore, si chiameraà quella
distanza, delle quattro uvoci, lequali nascono da, F, grauve, a
,, Cconchiudendo che tali modi ouvero passaggi, non sono da douver essere usati, ma rilasciati. Restaci da considerare, alcune sorti di Cconsonanze, Cconciosia cosa che, esse non siano tutte atte, neé condecenti, al nostro genere Ddiatonico,
Nnondimeno saranno dannoi dichiarate, lequali sono, il Ddiatessaron maggiore, &
il minore, il Ddittono maggiore, & il minore, il Ttuono maggiore, & il minore, il
Ssemituono magglore [sic: maggiore], & il minore. Il Ddiatessaron maggiore, si chiameraà quella
distanza, delle quattro uvoci, lequali nascono da, F, grauve, a  mi, acuto, & il
minore procede, da, D, ad, G, grauvi. Il Ddittono maggiore, saraà quello, che cade, da G, grauve, a
mi, acuto, & il
minore procede, da, D, ad, G, grauvi. Il Ddittono maggiore, saraà quello, che cade, da G, grauve, a  mi, acuto, & il minore, da, G, dettn [sic: detto] grauve, segnato con que-sto segno,
mi, acuto, & il minore, da, G, dettn [sic: detto] grauve, segnato con que-sto segno,  , a C [sic: delete], acuto,. Il Ttuono maggiore, si dimostra da C, a, D, acuti, Eet il
minore, ha principio da, C, acuto, con questa figura,
, a C [sic: delete], acuto,. Il Ttuono maggiore, si dimostra da C, a, D, acuti, Eet il
minore, ha principio da, C, acuto, con questa figura,  , ad E la, mi, acuta, con il
seguente segno, b
, ad E la, mi, acuta, con il
seguente segno, b ,. dDel Ssemituono maggiore, & del minore, alcuni ne hanno fatto
dichiaratione,. nNasce tal Ssemituono maggiore, dalla sillaba fa, alla sillaba, mi, del-la Ppositione chiamata, b
,. dDel Ssemituono maggiore, & del minore, alcuni ne hanno fatto
dichiaratione,. nNasce tal Ssemituono maggiore, dalla sillaba fa, alla sillaba, mi, del-la Ppositione chiamata, b fa,
fa,  , mi, ilqual Ssemituono per seé non si prononza, ben-cheé alcuni habbiano, tal falso parere.
, mi, ilqual Ssemituono per seé non si prononza, ben-cheé alcuni habbiano, tal falso parere.
LIBRO QVUARTO.
DELLA MVUSICA DORIA. CAP. I.
 , rotondo et del
, rotondo et del  , quadro
è coposta, per laqual cosa appresso di noi il primo tuono a loro somiglianza è detto Pprotho, ouvero Aautentico, habile, mobile, & lieto, come nel tTrattato nostro de'
tuoni habbiamo dichiarato. page 85
, quadro
è coposta, per laqual cosa appresso di noi il primo tuono a loro somiglianza è detto Pprotho, ouvero Aautentico, habile, mobile, & lieto, come nel tTrattato nostro de'
tuoni habbiamo dichiarato. page 85Della Lidia.
 , duro eè segnata, Iil percheé il Qquinto Ttuono Lli-dio è chiamato, ouver trito, cioè terzo autentico, diletteuvole, temperato, et allegro.
, duro eè segnata, Iil percheé il Qquinto Ttuono Lli-dio è chiamato, ouver trito, cioè terzo autentico, diletteuvole, temperato, et allegro.
Della Frigia.
 , molle è retta, & gouvernata, dal qual segno
nasce soauve, & dolce armonia;, laqual cosa adiuviene per rispetto de' Ppentacordi,
& de' Ttetracordi dal loro naturale rimossi, et mutati, per laqualcosa, per ritrouvar-si come habbiamo detto uvarie lingue, & popoli, conseguentemente da quelli deriuva-no, diuverse musiche, & pronontie, siì come della nostra, di quella de' Franciosi, o
delli Hispagnuoli, o delli Inglesi, o de' Tedeschi, & di altre nationi si uvede auvenire,.
lLaà onde da alcuni loro uvariji titoli, & appellationi sono state appropiati, siì come àa
Franciosi il catare, alli Inglesi il giubilare, alli Hispagnuoli il piagnere [sic: piangere], a' Tedeschi
l'urlare, Eet all'Italiani il caprezzare, See Franchino Gaffurio, Theorica musicae, lib. 5, cap. 8. laqualcosa non mi si puoò far a credere, che
da altro proceda, che da inuvidia, & malignitaà, essendo da questi tali stato non so-lamente dato il luogo da sezzo alla Italia, ma anche quella di uvituperoso, & biasi-meuvole nome chiamata,. Non è da douver esser fatto certamente tal giuditio, percio-cheé posto che la natura di particolare, & spetial gratia non habbia conceduto alla
Italia, che in essa tutto siano eccellenti in questa facoltaà di Mmusica, non è peroò, che
cosiì fra noi non uvi habbia di buoni, & eccellenti Mmusici, come in Francia, & in
qualunque altra prouvincia, siì come in quelle medesimamente di ogni maniera se ne
ritrouvano,. Anzi uvuo', che a loro consolatione, & conforto sappiano questi nostri maliuvoli, & detrattori, che se ' Franciosi, Tedeschi, òo niun altro barbaro hanno qual-che parte, che traluca in loro, che tutto hanno (sia detto con loro pace) apparato in
Italia, come quella, che è cimento, & paragone di tutti i belli & buoni ingegni, &
douve loro conuviene che uvengano a pigliare il giuditio e 'l condimento di ogni lor sapere,. A torto adunque questi tali, tal nome di imperfettione danno a gli Italiani, conciosia cosa che giaà molti, cosiì huomini, come donne, degni & eccellenti cantori sia-no stati, & hora siano in Italia, de' quali alcuni (cheé lungo fora a raccontargli tutti),
parte per non defraudarli di quello, che loro meritamente si conuviene, & parte per
dar a diuvedere a questi tali quanto sia falsa la loro oppenione, & il giuditio, che page 86fanno de gli Italiani, dannoi saranno ricordati, & celebrati,. Et primieramente
non è niuno, che non sappia di quanta eccellenza sia stato, & siano.:
, molle è retta, & gouvernata, dal qual segno
nasce soauve, & dolce armonia;, laqual cosa adiuviene per rispetto de' Ppentacordi,
& de' Ttetracordi dal loro naturale rimossi, et mutati, per laqualcosa, per ritrouvar-si come habbiamo detto uvarie lingue, & popoli, conseguentemente da quelli deriuva-no, diuverse musiche, & pronontie, siì come della nostra, di quella de' Franciosi, o
delli Hispagnuoli, o delli Inglesi, o de' Tedeschi, & di altre nationi si uvede auvenire,.
lLaà onde da alcuni loro uvariji titoli, & appellationi sono state appropiati, siì come àa
Franciosi il catare, alli Inglesi il giubilare, alli Hispagnuoli il piagnere [sic: piangere], a' Tedeschi
l'urlare, Eet all'Italiani il caprezzare, See Franchino Gaffurio, Theorica musicae, lib. 5, cap. 8. laqualcosa non mi si puoò far a credere, che
da altro proceda, che da inuvidia, & malignitaà, essendo da questi tali stato non so-lamente dato il luogo da sezzo alla Italia, ma anche quella di uvituperoso, & biasi-meuvole nome chiamata,. Non è da douver esser fatto certamente tal giuditio, percio-cheé posto che la natura di particolare, & spetial gratia non habbia conceduto alla
Italia, che in essa tutto siano eccellenti in questa facoltaà di Mmusica, non è peroò, che
cosiì fra noi non uvi habbia di buoni, & eccellenti Mmusici, come in Francia, & in
qualunque altra prouvincia, siì come in quelle medesimamente di ogni maniera se ne
ritrouvano,. Anzi uvuo', che a loro consolatione, & conforto sappiano questi nostri maliuvoli, & detrattori, che se ' Franciosi, Tedeschi, òo niun altro barbaro hanno qual-che parte, che traluca in loro, che tutto hanno (sia detto con loro pace) apparato in
Italia, come quella, che è cimento, & paragone di tutti i belli & buoni ingegni, &
douve loro conuviene che uvengano a pigliare il giuditio e 'l condimento di ogni lor sapere,. A torto adunque questi tali, tal nome di imperfettione danno a gli Italiani, conciosia cosa che giaà molti, cosiì huomini, come donne, degni & eccellenti cantori sia-no stati, & hora siano in Italia, de' quali alcuni (cheé lungo fora a raccontargli tutti),
parte per non defraudarli di quello, che loro meritamente si conuviene, & parte per
dar a diuvedere a questi tali quanto sia falsa la loro oppenione, & il giuditio, che page 86fanno de gli Italiani, dannoi saranno ricordati, & celebrati,. Et primieramente
non è niuno, che non sappia di quanta eccellenza sia stato, & siano.:
CANTORI A LIBRO.Many of the names on this list are identified by Peter Bergquist, The Theoretical Writings of Pietro Aaron (Ph.D. diss., Columbia University, 1964), p. 83.
- Il Signor Conte Nicolo d'Arco.,
- Il Signor Lodouvico Strozzi da Mantouva.,
- Messer Bidone.,
- Messer Costanzo Festa.,
- Messer Don Timoteo.,
- Messer Marc'Antonio del Doge da Vinegia.,
- Messer pre Francesco Bifetto da Bergomo,
- Messer pre Gioan Maria da Chiari.,
- Messer Gioanni Ferraro da Chiari.,
- Messer fra Pietro da Hostia.,
- Messer Girolamo Donismondo da Mantouva.,
- Maestro Girolamo Lorino da Chiari, maestro di Ccapella in Brescia.,
- Messer Lucio da Bergomo.,
- Messer Biasino da Pesaro.,
- Messer Bernardino, ouvero il Rizzo della Rocca contrada.
CANTORI AL LIVUTO.
- Il Signor Conte Lodouvico Martinengo.,
- Messer Ognibene da Vinegia.,
- Messer Bartholomeo Tromboncino,
- Messer Marchetto Mantoano.,
- Messer Ipolito Tromboncino.,
- Messer Bartholomeo Gazza.,
- Il Rreuverendo Messer Marc'Antonio Fontana, Aarchidiacono di Como.,
- Messer Francesco da Faenza.,
- Messer Angioletto da Vinegia.,
- Messer Iacopo da San Secondo.,
- Il Mmagnifico Messer Camillo Michele Vinitiano.,
- Messer Paolo Melanese.
DONNE A LIVUTO ET A LIBRO.
- La Signora Antonia Aragona da Napoli.,
- La Signora Costanza da Nuuvolara., page 87
- La Signora Lucretia da Coreggio.,
- La Signora Franceschina Bellaman.,
- La Signora Gineuvra Palauvigina.,
- La Signora Barbara Palauvigina.,
- La Signora Susana Ferra Ferrarese.,
- La Signora Girolama di Sant'Andrea.,
- La Signora Marieta Bellamano.,
- La Signora Helena Vinitiana.,
- La Signora Isabella Bolognese.
Per che cagione sia stato trovata l'alteratione. Capitolo II.
Ll'alteratione è stata ordinata, et trouvata, acciocheé due note sole non resti-no senza ternario numero,.Rispondiamo non essere questa la causa propia di tale alteratione, Iimperocheé accade di raro, chelle note non si possano riducere al terna-rio numero, Eet tale oppenione solamente s'intenderaà hauver luogo in qualche Ccanto douve non fosse alteratione ordinaria, & usata, ma secondo il uvolere del Mmusico, come la presente figura dichiara,
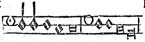 Nnel primo essempio della quale, se saraà considerata, si uvederaà una altera-tione non secondo che uvuole la regola, ma secondo la
uvolontaà, come habbiamo detto, del Ccompositore, pcheé uvolendo misurare il canto, saraà
forza pigliare la prima minima co la secoda alterata, accioò si ritrouvi il numero ternario delle minime, Eet il simile fare della prima semibreuve colla seconda del secondo page 88essempio,. Ma in altro modo che in quello, che habbiamo mostrato, la loro oppenione
loro non saraà cocedutta, percheé se nel tepo perfetto et altri simili si potraà hauvere tre
note fra due loro maggiori, come qui,
Nnel primo essempio della quale, se saraà considerata, si uvederaà una altera-tione non secondo che uvuole la regola, ma secondo la
uvolontaà, come habbiamo detto, del Ccompositore, pcheé uvolendo misurare il canto, saraà
forza pigliare la prima minima co la secoda alterata, accioò si ritrouvi il numero ternario delle minime, Eet il simile fare della prima semibreuve colla seconda del secondo page 88essempio,. Ma in altro modo che in quello, che habbiamo mostrato, la loro oppenione
loro non saraà cocedutta, percheé se nel tepo perfetto et altri simili si potraà hauvere tre
note fra due loro maggiori, come qui,  Iimperocheé si debbe cosiderare & bene auvertire di preuvalersi della facilitaà, & non
oscuritaà, Pper tanto non è dibisogno an- darandar cercando modi o-scuri, neé faticosiì, come qui,
Iimperocheé si debbe cosiderare & bene auvertire di preuvalersi della facilitaà, & non
oscuritaà, Pper tanto non è dibisogno an- darandar cercando modi o-scuri, neé faticosiì, come qui,  per hauvere il numero ternario con le loro minori. Altri piuù sot- tilmentesottilmente intorno cioò considerando, di-cono che tal alteratione da gli antichi, (come quelli, che a' segni
douve accadeuva la perfettione, dauvano sempre la misura sopra del tempo) è stata ritrouvata, & ordinata per manco confusione, & ornamento del Ccontrapunto, Eet
che per tal causa il Ccompositore non è tenuto a continouvare neé osseruvare un sol modo intorno le positioni delle note, ma puoò uvariare secondo che allui piace,. Et però,
quando il Ccompositore uvuole che 'l tempo olla misura resti diuvisa nel cantare, lo di-mostra in questo modo,
per hauvere il numero ternario con le loro minori. Altri piuù sot- tilmentesottilmente intorno cioò considerando, di-cono che tal alteratione da gli antichi, (come quelli, che a' segni
douve accadeuva la perfettione, dauvano sempre la misura sopra del tempo) è stata ritrouvata, & ordinata per manco confusione, & ornamento del Ccontrapunto, Eet
che per tal causa il Ccompositore non è tenuto a continouvare neé osseruvare un sol modo intorno le positioni delle note, ma puoò uvariare secondo che allui piace,. Et però,
quando il Ccompositore uvuole che 'l tempo olla misura resti diuvisa nel cantare, lo di-mostra in questo modo,  & altri simili, cioè chella prima terza parte del tempo sia separata, & da seé posta, Eet appresso l'ultime due
terze parti di essa bre- uebreve, o tempo siano unite in una sola nota, per
laqual cosa dannoi è detto, che tale alteratione è stata ritrouvata da gli antichi, non
percheé due note non restino sole, et senza ternario numero, come essi dicono, Mma per-cheé tali due note possano hauvere la loro terza parte per sincopa dalla parte dinan-zi, ouveramente per punti di diuvisione, possano essere trasportate dopo,. Et se alcuni
uvolessero contradire dicendo, che 'l Ccompositore potraà condure un concento secondo
il suo uvolere senza considerare alteratione alcuna, come qui,
& altri simili, cioè chella prima terza parte del tempo sia separata, & da seé posta, Eet appresso l'ultime due
terze parti di essa bre- uebreve, o tempo siano unite in una sola nota, per
laqual cosa dannoi è detto, che tale alteratione è stata ritrouvata da gli antichi, non
percheé due note non restino sole, et senza ternario numero, come essi dicono, Mma per-cheé tali due note possano hauvere la loro terza parte per sincopa dalla parte dinan-zi, ouveramente per punti di diuvisione, possano essere trasportate dopo,. Et se alcuni
uvolessero contradire dicendo, che 'l Ccompositore potraà condure un concento secondo
il suo uvolere senza considerare alteratione alcuna, come qui, 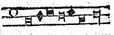 & non colle due semibreuvi bianche messe, ouveramente considerate in mezzo de' due breuvi, del sopraposto circolo,
Ssi risponde che 'l primo essempio disopra non ha luogo per tutte le note, o segni, iquali mostrino perfettione, massimamente in quelli, iquali contengono in seé piuù note
perfette, come dimostrano nelle compositioni, nelle quali le breuvi, & le semibreuvi
sono apparenti, & ordinate nel segno ouver figura del segno chiamato circolo puntato, ouveramente tempo con prolatione., Ppercheé tutto che quella breuve piena habbia
uvertuù, et tanto uvalore quanto harebbe la semibreuve alterata, ouvero raddoppiata, no-dimeno la detta semibreuve piena mediante essa pienezza resteraà imperfetta, & cosiì
seguiteraà, chella breuve piena, & la semibreuve non si potranno unire insieme al ri-compimento d'un tempo perfetto contenente in seé tre semibreuvi perfette, come chia-ramente per rispetto dell'alteratione si comprende in questo presente essempio.
& non colle due semibreuvi bianche messe, ouveramente considerate in mezzo de' due breuvi, del sopraposto circolo,
Ssi risponde che 'l primo essempio disopra non ha luogo per tutte le note, o segni, iquali mostrino perfettione, massimamente in quelli, iquali contengono in seé piuù note
perfette, come dimostrano nelle compositioni, nelle quali le breuvi, & le semibreuvi
sono apparenti, & ordinate nel segno ouver figura del segno chiamato circolo puntato, ouveramente tempo con prolatione., Ppercheé tutto che quella breuve piena habbia
uvertuù, et tanto uvalore quanto harebbe la semibreuve alterata, ouvero raddoppiata, no-dimeno la detta semibreuve piena mediante essa pienezza resteraà imperfetta, & cosiì
seguiteraà, chella breuve piena, & la semibreuve non si potranno unire insieme al ri-compimento d'un tempo perfetto contenente in seé tre semibreuvi perfette, come chia-ramente per rispetto dell'alteratione si comprende in questo presente essempio.
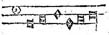 Dicono alcuni altri, contrari a tale alteratione, che per ca-gione del punto di perfettione, si potraà saluvare tal semibreuve
nella sua quatitaà perfetta, come qui,
Dicono alcuni altri, contrari a tale alteratione, che per ca-gione del punto di perfettione, si potraà saluvare tal semibreuve
nella sua quatitaà perfetta, come qui, 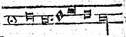 & trasportandola, troarli [sic: trovarle] altro numero ternario ouve ella si riduca affare imperfetta quella ultima breuve, ouvera-mente pigliado tal Ssemibreuve, laquale è fra la secoda, e terza breuve,. Si rispode che page 89[gap — ] non pigliando la detta semibreuve con la seguente breuve piena per un tempo finito,
ilqual uvuole, che non possano essere poste note nere se non è compito il tempo, tutto
che alcuni questo non habbiano osseruvato,. Ma quelli, iquali hanno intorno l'altera-tione tante dubbitationi, douverebbono pensare che egli sarebbe loro assai piuù ageuvole a considerare la detta alteratione in quella guisa, che dagli antichi ella fu ordi-nata, che con tate ragioni uvoler introducere un modo, pe 'l quale essa fosse annulla-ta, Eet uvolendo pur questi tali seguire questa loro oppenione, è dibisogno chella bre-uve piena habbia anche essa al supplimento del tempo la semibreuve piena,. Molti altri
inconuvenienti nascerebbono, & errori, ouve tale alteratione non fosse apparente neé
essercitata, Eet per conseguente non sarebbe in podestaà del Mmusico, ouver Ccompositore di fare quanto piace allui, perciocheé conuverebbe, che egli seguitasse & seruvisse
alle note, & non le note allui. Similmente sarebbe errore, uvolendo, chella minima alterasse innanzi alle breuve, & la semibreuve innanzi alla lunga, Eet la breuve inanzi
la massima,. Egli è ben uvero, che esse altereranno inanzi alle loro maggiori a seé propinque, cioè la minima inanzi alla semibreuve, la semibreuve inanzi la breuve, la bre-uve inanzi la lunga, & la lunga inanzi la massima, cosiì in nota, come in pausa,. Ap-presso la nota non dee mai alterare inanzi alla sua simile, siì in note come in pausa,
come la minima inanzi la minima, la semibreuve inanzi la semibreuve, et simili, Iiquali ordini, & regole sono da essere osseruvate, & non da essere reputate in potere del
Mmusico, eccetuando la lunga, laquale non puoò alterare inanzi la pausa della massi-ma, percheé come è stato detto, la massima non ha propria pausa,. Laà onde è stato dal
Mmusico ordinato, chella lunga nel modo maggior perfetto possa alterare inanzi a
due pause di lunga insieme poste, come il presente essempio dimostra.
& trasportandola, troarli [sic: trovarle] altro numero ternario ouve ella si riduca affare imperfetta quella ultima breuve, ouvera-mente pigliado tal Ssemibreuve, laquale è fra la secoda, e terza breuve,. Si rispode che page 89[gap — ] non pigliando la detta semibreuve con la seguente breuve piena per un tempo finito,
ilqual uvuole, che non possano essere poste note nere se non è compito il tempo, tutto
che alcuni questo non habbiano osseruvato,. Ma quelli, iquali hanno intorno l'altera-tione tante dubbitationi, douverebbono pensare che egli sarebbe loro assai piuù ageuvole a considerare la detta alteratione in quella guisa, che dagli antichi ella fu ordi-nata, che con tate ragioni uvoler introducere un modo, pe 'l quale essa fosse annulla-ta, Eet uvolendo pur questi tali seguire questa loro oppenione, è dibisogno chella bre-uve piena habbia anche essa al supplimento del tempo la semibreuve piena,. Molti altri
inconuvenienti nascerebbono, & errori, ouve tale alteratione non fosse apparente neé
essercitata, Eet per conseguente non sarebbe in podestaà del Mmusico, ouver Ccompositore di fare quanto piace allui, perciocheé conuverebbe, che egli seguitasse & seruvisse
alle note, & non le note allui. Similmente sarebbe errore, uvolendo, chella minima alterasse innanzi alle breuve, & la semibreuve innanzi alla lunga, Eet la breuve inanzi
la massima,. Egli è ben uvero, che esse altereranno inanzi alle loro maggiori a seé propinque, cioè la minima inanzi alla semibreuve, la semibreuve inanzi la breuve, la bre-uve inanzi la lunga, & la lunga inanzi la massima, cosiì in nota, come in pausa,. Ap-presso la nota non dee mai alterare inanzi alla sua simile, siì in note come in pausa,
come la minima inanzi la minima, la semibreuve inanzi la semibreuve, et simili, Iiquali ordini, & regole sono da essere osseruvate, & non da essere reputate in potere del
Mmusico, eccetuando la lunga, laquale non puoò alterare inanzi la pausa della massi-ma, percheé come è stato detto, la massima non ha propria pausa,. Laà onde è stato dal
Mmusico ordinato, chella lunga nel modo maggior perfetto possa alterare inanzi a
due pause di lunga insieme poste, come il presente essempio dimostra.
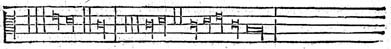
Dubitationi necessarie intorno l'alteratione. Cap. III.
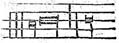 percheé trouvandosi dopo tal massima le pause delle lunghe
non di pari poste, ma l'una piuù alta dell'altra, la massima
non potraà essere reintegrata perfetta, ma dalla nota dinanzi a seé saraà fatta imper-fetta, o da oltretanto suo uvalore,. Diciamo che il Mmusico poco si cura comuque esse
siano poste, percheé tal modo di pause uvariate non offende l'harmonia, la quale consiste nel pronuntiare delle uvoci,. Et a quello similmente, che essi dicono, che loro non
piace, che la lunga sia alterata inanzi alle sopradette pause, ma che douvendo pure
essere alterata, che ella deèe essere in forma, come disopra appare, Rrispondiamo,
che tal alteratione di lunga è stata usata da molti altri, iquali essedo dotti, si deèe credere, che con ragione habbiano proceduto, come quelli che hanno considerato, che
non hauvendo la massima propia pausa, il uvalore delle pause della lunga piuù uvolte
prese debba bastare al compimento di essa,. Altri anchora si muouvono dicendo, che
tal lunga inanzi alle dette pause con ragione alcuna non potraà essere ridotta nella
forma della massima, percheé ouve questo auvenisse, ne risulterebbono alcuni inconuve-nienti contrariji alle regole date, come si uvede in questo essempio,
percheé trouvandosi dopo tal massima le pause delle lunghe
non di pari poste, ma l'una piuù alta dell'altra, la massima
non potraà essere reintegrata perfetta, ma dalla nota dinanzi a seé saraà fatta imper-fetta, o da oltretanto suo uvalore,. Diciamo che il Mmusico poco si cura comuque esse
siano poste, percheé tal modo di pause uvariate non offende l'harmonia, la quale consiste nel pronuntiare delle uvoci,. Et a quello similmente, che essi dicono, che loro non
piace, che la lunga sia alterata inanzi alle sopradette pause, ma che douvendo pure
essere alterata, che ella deèe essere in forma, come disopra appare, Rrispondiamo,
che tal alteratione di lunga è stata usata da molti altri, iquali essedo dotti, si deèe credere, che con ragione habbiano proceduto, come quelli che hanno considerato, che
non hauvendo la massima propia pausa, il uvalore delle pause della lunga piuù uvolte
prese debba bastare al compimento di essa,. Altri anchora si muouvono dicendo, che
tal lunga inanzi alle dette pause con ragione alcuna non potraà essere ridotta nella
forma della massima, percheé ouve questo auvenisse, ne risulterebbono alcuni inconuve-nienti contrariji alle regole date, come si uvede in questo essempio,  percheé uvolendo trouvare il numero conuveniente al segno circolare,
sarebbe dibisogno seruvare un modo no usato di alterare quella se-conda semibreuve dinanzi alla breuve segnata, laquale semibreuve, se fosse ridotta alla
figura di una breuve, ne nascerebbe la forma della simile inazi alla simile, Eet a que-sto modo non si potrebbe saluvare, neé anullare quella nota alterata,. Similmente in
quest'altro,
percheé uvolendo trouvare il numero conuveniente al segno circolare,
sarebbe dibisogno seruvare un modo no usato di alterare quella se-conda semibreuve dinanzi alla breuve segnata, laquale semibreuve, se fosse ridotta alla
figura di una breuve, ne nascerebbe la forma della simile inazi alla simile, Eet a que-sto modo non si potrebbe saluvare, neé anullare quella nota alterata,. Similmente in
quest'altro,  dicono, ehella [sic: chella] massima di necessità non puoò essere fatta
pfetta, ma siì bene imperfetta da quella lunga dinanzi a seé posta, Eet
conchiudono, che tal massima colle tre pause non hauvraà somiglian-za, ma che essa saraà inanzi al uvalore di lei,. Et percheé alcuni potrebbono di leggie-ri incorrere in quello, che niuna legge, o regola della Ttheorica non comanda, neé page 91uvuole, dannoi si hauvraà riguardo a ricordare alcuni altri precetti necessariji intor-no la sopradetta alteratione, Cconciosia cosa che essa si possa intendere in dui mo-di, secondo l'uno de' quali essa è detta Aalteratione regolare, Eet secondo l'altro Aal-teratione sottointesa,. La regolare alteratione saraà quella, che dal Mmusico è ordina-to, cioè quando egli uvuole che, essendo due semibreuvi fra due breuvi, la seconda sia al-terata,. Et prima che mostriamo quale sia alteratione sottointesa, acciocheé da te
non sia preso errore, Ssaprai, che sempre tal figura, o nota seconda dee alterare, ma
se tu trouverai punto fra le due semibreuvi, alhora per forza di quel punto di diuvisione, tal semibreuve non saraà piuù alterata, come si uvede in molte compositioni, Eet simil-mente quando dal Ccompositore saraà intesa piena,. Appresso trouvandosi cinque se-mibreuvi, ouvero otto fra due breuvi, la quinta, & la ottauva saranno alterate,; dico al-terate, raddoppiate secondo la loro forma, & non come molti credono, fatte perfet-te, da cioò ingannati, che credono, che alterare significhi far perfetto,. Pertanto si
uvuol ben considerare, che la nota, laquale è sottoposta alla alteratione, sia dopo 'l
segno, nelqual si ritrouvi la seguente maggiore di lei, & non dopo altro differente
segno, come questo,
dicono, ehella [sic: chella] massima di necessità non puoò essere fatta
pfetta, ma siì bene imperfetta da quella lunga dinanzi a seé posta, Eet
conchiudono, che tal massima colle tre pause non hauvraà somiglian-za, ma che essa saraà inanzi al uvalore di lei,. Et percheé alcuni potrebbono di leggie-ri incorrere in quello, che niuna legge, o regola della Ttheorica non comanda, neé page 91uvuole, dannoi si hauvraà riguardo a ricordare alcuni altri precetti necessariji intor-no la sopradetta alteratione, Cconciosia cosa che essa si possa intendere in dui mo-di, secondo l'uno de' quali essa è detta Aalteratione regolare, Eet secondo l'altro Aal-teratione sottointesa,. La regolare alteratione saraà quella, che dal Mmusico è ordina-to, cioè quando egli uvuole che, essendo due semibreuvi fra due breuvi, la seconda sia al-terata,. Et prima che mostriamo quale sia alteratione sottointesa, acciocheé da te
non sia preso errore, Ssaprai, che sempre tal figura, o nota seconda dee alterare, ma
se tu trouverai punto fra le due semibreuvi, alhora per forza di quel punto di diuvisione, tal semibreuve non saraà piuù alterata, come si uvede in molte compositioni, Eet simil-mente quando dal Ccompositore saraà intesa piena,. Appresso trouvandosi cinque se-mibreuvi, ouvero otto fra due breuvi, la quinta, & la ottauva saranno alterate,; dico al-terate, raddoppiate secondo la loro forma, & non come molti credono, fatte perfet-te, da cioò ingannati, che credono, che alterare significhi far perfetto,. Pertanto si
uvuol ben considerare, che la nota, laquale è sottoposta alla alteratione, sia dopo 'l
segno, nelqual si ritrouvi la seguente maggiore di lei, & non dopo altro differente
segno, come questo,  Pperciocheé, dato che tal modo dimostri qual-che poco di ueri- tàverità, nondimeno la ragione nol consente;, neé do-po quest'altro suo contrario, cosiì,
Pperciocheé, dato che tal modo dimostri qual-che poco di ueri- tàverità, nondimeno la ragione nol consente;, neé do-po quest'altro suo contrario, cosiì,  percheé la
nota alterata del segno tagliato non hauverebbe forza di due in
potere, & uvertuù, ma sarebbe scemata della sua metà per la forza del segno antecedente diminuto, Eet quella dopo il circolo non tagliato accresce-rebbe, & raddoppierebbe il suo uvalore,. Si conchiude adunqu- [sic: adunque], che tali modi non sono conceduti, percheé la nota alterata dopo il segno tagliato non crescerebbe in dop-pio, come uvuole la ragione dell'alteratione, ma sarebbe deffettiuva della sua retta,
& ordinata quantità.; Eet per tal modo nascerebbe uno inconuveniente manifestissi-mo, che presa la semibreuve dinanzi al segno diminuto co l'ultima dopo il segno non
diminuto, tali due semibreuvi non farebbono numero ternario, ma producerebbono
un certo numero di note inequali,. Il simile accaderebbe se la semibreuve fosse dopo il
segno circolare,. La sottointesa ouvero irregolare alteratione, secondo che al Mmusico
piace, appare in diuversi modi, come la presente figura ti dimostra.
percheé la
nota alterata del segno tagliato non hauverebbe forza di due in
potere, & uvertuù, ma sarebbe scemata della sua metà per la forza del segno antecedente diminuto, Eet quella dopo il circolo non tagliato accresce-rebbe, & raddoppierebbe il suo uvalore,. Si conchiude adunqu- [sic: adunque], che tali modi non sono conceduti, percheé la nota alterata dopo il segno tagliato non crescerebbe in dop-pio, come uvuole la ragione dell'alteratione, ma sarebbe deffettiuva della sua retta,
& ordinata quantità.; Eet per tal modo nascerebbe uno inconuveniente manifestissi-mo, che presa la semibreuve dinanzi al segno diminuto co l'ultima dopo il segno non
diminuto, tali due semibreuvi non farebbono numero ternario, ma producerebbono
un certo numero di note inequali,. Il simile accaderebbe se la semibreuve fosse dopo il
segno circolare,. La sottointesa ouvero irregolare alteratione, secondo che al Mmusico
piace, appare in diuversi modi, come la presente figura ti dimostra.
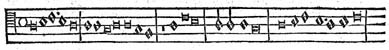
Come si puoò formare ciascuna spetie, semplice, & composta, nelle due congiunte. Cap. IIII.
 , ro-tondo nella positione di E la mi grauve, & per tal congionta si trouveraà lo spatio se-condo sesquiottauvo chiamato re, -mi,; & laà douve che il terzo, fa, -sol, senza altra congionta naturalmente si dimostra, il quarto, & ultimo sesquiottauvo spatio, ilquale
è sol, -la, saraà accidentale per la congionta, ouver segno del, b
, ro-tondo nella positione di E la mi grauve, & per tal congionta si trouveraà lo spatio se-condo sesquiottauvo chiamato re, -mi,; & laà douve che il terzo, fa, -sol, senza altra congionta naturalmente si dimostra, il quarto, & ultimo sesquiottauvo spatio, ilquale
è sol, -la, saraà accidentale per la congionta, ouver segno del, b , molle in,
, molle in,  , mi grauve considerato,. Et con tale ordine discorrendo, di ogni altro spatio di tuono facilmente harai notitia,. Ma uvolendo nella detta positione, o corda hauvere il minor
semituono, ti saraà di necessitaà nella corda del detto, C, grauve fingere, & presuporre il b, giacente ouvero Ddiesi, & siì come prima ci era, ut, &, fa, rimossi tali
nomi, cioeè, re, -mi, fa, -sol, & sol, -la, saraà detto mi, -fa, &, fa, -mi, spatio del nominato semituon minore,. sSeguitando alla seguente consonanza, chiamata Ddittono,
per essere natural spetie sola, esso, resteraà propio senza altro accidentale,. Et
percheé forse alcuni non sono chiari, donde uvenga la differenza delle due spetiji semidittonali, auvertirai, che essa no prouviene da altro, che dal semituono, che uvaria, come
in questa spetie, cioè, re, -fa, et mi, -sol, ilqual, re, -fa, nel secondo interuvallo ha il semituono, et mi, -sol, nel primo. Per tato uvolendo nella detta positione trouvare le due spetiji, no
altrimenti che col, b
, mi grauve considerato,. Et con tale ordine discorrendo, di ogni altro spatio di tuono facilmente harai notitia,. Ma uvolendo nella detta positione, o corda hauvere il minor
semituono, ti saraà di necessitaà nella corda del detto, C, grauve fingere, & presuporre il b, giacente ouvero Ddiesi, & siì come prima ci era, ut, &, fa, rimossi tali
nomi, cioeè, re, -mi, fa, -sol, & sol, -la, saraà detto mi, -fa, &, fa, -mi, spatio del nominato semituon minore,. sSeguitando alla seguente consonanza, chiamata Ddittono,
per essere natural spetie sola, esso, resteraà propio senza altro accidentale,. Et
percheé forse alcuni non sono chiari, donde uvenga la differenza delle due spetiji semidittonali, auvertirai, che essa no prouviene da altro, che dal semituono, che uvaria, come
in questa spetie, cioè, re, -fa, et mi, -sol, ilqual, re, -fa, nel secondo interuvallo ha il semituono, et mi, -sol, nel primo. Per tato uvolendo nella detta positione trouvare le due spetiji, no
altrimenti che col, b , molle in E la mi, & col Ddiesi in, C, fa ut le trouverai, da' quali segni saranno comprese le due spetiji sopradette,. Et per meglio chiarirti qual sia
la causa, che 'l Ddittono non ha piuù d'una spetie, questo auviene, percheé la detta spetie
non è formata di semituono alcuno, bencheé alcuni uvogliano esserci due spetiji di Ddit-tono, cioè, Vut, -mi, & fa, -la, come quelli, iquali senza consideratione credono, che,
Vut, -mi, et fa, -la, siano differenti, laqual oppenione è falsa, conciosiacosa che esse naturalmente secondo l'ordine delle note in tali processi siano, le piuù uvolte simili, percheé
dicendo, Vut -mi, ci saraà anchora fa, -la, - dico secondo l'ordine naturale, - percheé uvolendo procedere da,
, molle in E la mi, & col Ddiesi in, C, fa ut le trouverai, da' quali segni saranno comprese le due spetiji sopradette,. Et per meglio chiarirti qual sia
la causa, che 'l Ddittono non ha piuù d'una spetie, questo auviene, percheé la detta spetie
non è formata di semituono alcuno, bencheé alcuni uvogliano esserci due spetiji di Ddit-tono, cioè, Vut, -mi, & fa, -la, come quelli, iquali senza consideratione credono, che,
Vut, -mi, et fa, -la, siano differenti, laqual oppenione è falsa, conciosiacosa che esse naturalmente secondo l'ordine delle note in tali processi siano, le piuù uvolte simili, percheé
dicendo, Vut -mi, ci saraà anchora fa, -la, - dico secondo l'ordine naturale, - percheé uvolendo procedere da,  , mi acuto a D, la, sol, re, per lo segno del, b
, mi acuto a D, la, sol, re, per lo segno del, b , molle, senza
dubbio harai solamente fa, -sol, -la, & non ut, -re, -mi, ma rimouvendo la roton-da figura, ritorneraà mi, -sol, processo naturale,. Et per tal modo saraà una sola spe-tie, laquale non puoò uvariare senza la spetie semidittonale, come al terzo Ccap. del
libro secondo del nostro Toscanello non si è taciuto. Similmente, se uvorremo trouvar
le tre spetiji del Ttetracordo, non rimouvendo, come è stato detto, la positione di, C, grauve, bisogneraà segnare la figura, b
, molle, senza
dubbio harai solamente fa, -sol, -la, & non ut, -re, -mi, ma rimouvendo la roton-da figura, ritorneraà mi, -sol, processo naturale,. Et per tal modo saraà una sola spe-tie, laquale non puoò uvariare senza la spetie semidittonale, come al terzo Ccap. del
libro secondo del nostro Toscanello non si è taciuto. Similmente, se uvorremo trouvar
le tre spetiji del Ttetracordo, non rimouvendo, come è stato detto, la positione di, C, grauve, bisogneraà segnare la figura, b , nella positione di E la mi, con laquale harai il primo Ttetracordo, ouvero spetie da esso, C, a, F, grauve,; ma la seconda spetie da, C,
ad, F grauve saraà euvidente per lo segno del, b
, nella positione di E la mi, con laquale harai il primo Ttetracordo, ouvero spetie da esso, C, a, F, grauve,; ma la seconda spetie da, C,
ad, F grauve saraà euvidente per lo segno del, b , molle posto in D, grauve, & la ter-page 93za naturalmete si dimostra. Appresso habbiamo da uvedere le quattro spetiji del Ddiapente, o uvuoi dire pentacordo, la prima spetie del quale saraà compresa dal segno del,
b
, molle posto in D, grauve, & la ter-page 93za naturalmete si dimostra. Appresso habbiamo da uvedere le quattro spetiji del Ddiapente, o uvuoi dire pentacordo, la prima spetie del quale saraà compresa dal segno del,
b , molle in E la mi grauve posto insino a, D, acuto, &, C, grauve, estremi,. Il se-condo Ppentacordo, o spetie ci saraà nota ponendo tal figura, b
, molle in E la mi grauve posto insino a, D, acuto, &, C, grauve, estremi,. Il se-condo Ppentacordo, o spetie ci saraà nota ponendo tal figura, b , in, D, in, E, grauvi, & in, A, acuto,; la terza, incominciando da, C, positione grauve, insino a, D,
acuto, ponendo la figura Ddiesi in, F, grauve,. lLa quarta senza segni è naturale,. Et percheé la sesta maggiore, non uvolendo mutare la corda di, C, grauve alla sua formatione, produraà poco diuverse tra seé le sue spetiji, senza empire il foglio in ragionar di lei
dannoi saraà lasciata a dietro, non ostante che ella ne habbia due accidentali, quan-do, loro è posta la figura, b
, in, D, in, E, grauvi, & in, A, acuto,; la terza, incominciando da, C, positione grauve, insino a, D,
acuto, ponendo la figura Ddiesi in, F, grauve,. lLa quarta senza segni è naturale,. Et percheé la sesta maggiore, non uvolendo mutare la corda di, C, grauve alla sua formatione, produraà poco diuverse tra seé le sue spetiji, senza empire il foglio in ragionar di lei
dannoi saraà lasciata a dietro, non ostante che ella ne habbia due accidentali, quan-do, loro è posta la figura, b , nella positione di E la mi grauve. Procedendo alla se-sta minore, & alla prima spetie di lei, ella non si puoò dimostrare altramente, che
co duoi segni del b
, nella positione di E la mi grauve. Procedendo alla se-sta minore, & alla prima spetie di lei, ella non si puoò dimostrare altramente, che
co duoi segni del b , molle, iquali si dimostrino in E grauve, et A, acuto, ilqual processo
faraà re, -mi, -fa, -re, -mi, -fa,. lLa terminatione della seconda spetie non si potraà creare, se
prima non appare col, b
, molle, iquali si dimostrino in E grauve, et A, acuto, ilqual processo
faraà re, -mi, -fa, -re, -mi, -fa,. lLa terminatione della seconda spetie non si potraà creare, se
prima non appare col, b , rotondo, ilquale conuviene, che sia nella positione di, D
& E [sic: D, E & G], grauvi, ilqual processo soneraà mi, -fa, -re, -mi, -fa, -sol,. lLa terza spetie procederaà in
questo modo, cioè mi, -fa, -sol, -re, -mi, -fa, il qual modo, & ordine nasceraà dalla posi-tione, ouver figura del, b
, rotondo, ilquale conuviene, che sia nella positione di, D
& E [sic: D, E & G], grauvi, ilqual processo soneraà mi, -fa, -re, -mi, -fa, -sol,. lLa terza spetie procederaà in
questo modo, cioè mi, -fa, -sol, -re, -mi, -fa, il qual modo, & ordine nasceraà dalla posi-tione, ouver figura del, b , molle posta in D, in, E, grauvi, & in, A, acuto,. Et per
essere la quarta & la quinta spetie simili alla prima, & alla seconda, dannoi saranno tralasciate. La consideratione della prima spetie Ddiapasonica, cioè re, -mi -fa, -re, -
mi, -fa, -sol, -la, si conosceraà da, C, grauve & da, C, acuto,; peroò uvolendo procedere per
li mezzi di essi estremi, dando nome a tutte le seguenti note, è necessario segnare la
figura, b
, molle posta in D, in, E, grauvi, & in, A, acuto,. Et per
essere la quarta & la quinta spetie simili alla prima, & alla seconda, dannoi saranno tralasciate. La consideratione della prima spetie Ddiapasonica, cioè re, -mi -fa, -re, -
mi, -fa, -sol, -la, si conosceraà da, C, grauve & da, C, acuto,; peroò uvolendo procedere per
li mezzi di essi estremi, dando nome a tutte le seguenti note, è necessario segnare la
figura, b in, E, grauve, & in, A, acuto, per loqual modo harai la prima spetie,;
& similmente hauveraà la seconda, se da te saranno considerati i mezzi delli stremi,
iquali nomi, o sillabe non ritrouverai, oe da te la figura iesi non sia segnata in C
acuto & la figura in D & E, grai [sic: ove da te la figura
in, E, grauve, & in, A, acuto, per loqual modo harai la prima spetie,;
& similmente hauveraà la seconda, se da te saranno considerati i mezzi delli stremi,
iquali nomi, o sillabe non ritrouverai, oe da te la figura iesi non sia segnata in C
acuto & la figura in D & E, grai [sic: ove da te la figura  non sia segnata in D, E & G gravi, & in A & B acuti],. lLa terza spetie, per essere naturale,
dannoi non saraà detta;. lLa quarta procederaà co' seguenti nomi, cioè re, -mi, -fa, -sol, -re, -
mi, -fa, -sol, iquali saranno dimostrati colla figura, b
non sia segnata in D, E & G gravi, & in A & B acuti],. lLa terza spetie, per essere naturale,
dannoi non saraà detta;. lLa quarta procederaà co' seguenti nomi, cioè re, -mi, -fa, -sol, -re, -
mi, -fa, -sol, iquali saranno dimostrati colla figura, b , segnata in, E, grauve, & in,
, segnata in, E, grauve, & in,
 mi acuto. I nomi, & mezzi della quinta spetie faranno tal processo, mifasolre
misolfala [sic: mi-fa-sol-re-mi-fa-sol-la], douve bisogneraà segnare il seguente b
mi acuto. I nomi, & mezzi della quinta spetie faranno tal processo, mifasolre
misolfala [sic: mi-fa-sol-re-mi-fa-sol-la], douve bisogneraà segnare il seguente b , rotondo nella positione di, D,
grauve, & A, acuto;. lLa sesta haraà il suo processo co' presenti nomi, fa, -sol, -re, -mi, -fa, -re, -
mi, -fa, iquali non con altro saranno compresi, che col segno della figura Ddiesi, la-quale si manifesta sopra la corda detta, F, grauve, p loqual ordine harai la sesta Ddia-pason;. La settima, et ultima Ddiapason consiste in tali nomi, et note, cioè Vut, -re, -mi, -fa, -
re, -mi, -fa, -sol, iquali saranno conosciuti se in
, rotondo nella positione di, D,
grauve, & A, acuto;. lLa sesta haraà il suo processo co' presenti nomi, fa, -sol, -re, -mi, -fa, -re, -
mi, -fa, iquali non con altro saranno compresi, che col segno della figura Ddiesi, la-quale si manifesta sopra la corda detta, F, grauve, p loqual ordine harai la sesta Ddia-pason;. La settima, et ultima Ddiapason consiste in tali nomi, et note, cioè Vut, -re, -mi, -fa, -
re, -mi, -fa, -sol, iquali saranno conosciuti se in  mi acuto nasceraà il, b
mi acuto nasceraà il, b , rotodo,. Molte
altre cose si potrebbono dire in tal proposito,; peroò per mezzo di questa poca
instruttione, che ti habbiamo data, potrai ageuvolmente intendere il fine di ogni altra
sonanza.
, rotodo,. Molte
altre cose si potrebbono dire in tal proposito,; peroò per mezzo di questa poca
instruttione, che ti habbiamo data, potrai ageuvolmente intendere il fine di ogni altra
sonanza.
Delle sei sillabe considerate da, A, a, F, & da,  , a, D [sic: G], Eet da, D, a,
, a, D [sic: G], Eet da, D, a,
 & da. E, a, C, & da F, a, D. Cap. V.
& da. E, a, C, & da F, a, D. Cap. V.
 mi grauve, conciosia cosa che il detto b
mi grauve, conciosia cosa che il detto b mi, se
ben [sic: se ben] considererai, manchi d'un Ccoma alla sua terza maggiore,; onde, uvolendo a
una a una formare le sei sillabe, harai, Vut nel detto,
mi, se
ben [sic: se ben] considererai, manchi d'un Ccoma alla sua terza maggiore,; onde, uvolendo a
una a una formare le sei sillabe, harai, Vut nel detto,  , mi, grauve, & il, re, al ta-sto negro sopra di, C, grauve, detto semituon maggiore, ilquale produce dal
, mi, grauve, & il, re, al ta-sto negro sopra di, C, grauve, detto semituon maggiore, ilquale produce dal  lo
spatio d'un tuono,. Et da, C, a, D, harai lo spatio del semituono maggiore nel
grauve, Eet il minore nel acuto, & quello di, D, & E, in contrario, percheé il semi-tuon maggiore saraà nello inteso & il minore nel remesso,. lLaà onde, per esserci duoi semituoni minori continouvati, l'uno fra, C, &, D, & l'altro fra, D, &, E, grauvi, lo spatio del seguente tuono, detto mi, saraà diminuto del Ccoma, alla reintegratio-ne del quale è dibisogno, come da noi nel Toscanello fu dimostrato, che sopra la corda del detto tasto negro, esso sia aumentato di tanto interuvallo, che il ne faccia perfetto, Pper loqual fondamento tu potrai conoscere la tua oppenione essere falsa,. Et se
tu non sai donde nasca tale inconuveniente, percheé
lo
spatio d'un tuono,. Et da, C, a, D, harai lo spatio del semituono maggiore nel
grauve, Eet il minore nel acuto, & quello di, D, & E, in contrario, percheé il semi-tuon maggiore saraà nello inteso & il minore nel remesso,. lLaà onde, per esserci duoi semituoni minori continouvati, l'uno fra, C, &, D, & l'altro fra, D, &, E, grauvi, lo spatio del seguente tuono, detto mi, saraà diminuto del Ccoma, alla reintegratio-ne del quale è dibisogno, come da noi nel Toscanello fu dimostrato, che sopra la corda del detto tasto negro, esso sia aumentato di tanto interuvallo, che il ne faccia perfetto, Pper loqual fondamento tu potrai conoscere la tua oppenione essere falsa,. Et se
tu non sai donde nasca tale inconuveniente, percheé  mi non ha terza maggiore, auvertirai che da altro non procede se non dalla congionta del, b
mi non ha terza maggiore, auvertirai che da altro non procede se non dalla congionta del, b , molle, nata, & posta in E la mi grauve, ilqual, b
, molle, nata, & posta in E la mi grauve, ilqual, b , molle appare sotto del detto E la mi per lo spatio d'un
Aappotome,. Il medesimo inconuveniente in frra [sic: in fra] 'l,
, molle appare sotto del detto E la mi per lo spatio d'un
Aappotome,. Il medesimo inconuveniente in frra [sic: in fra] 'l,  , & il, D acuti trouverai,. eEt percheé tu uvegga l'ordine delle sei sillabe, diremo il loro principio essere in Gama ut,
ilquale, cociosiacosa che il loro processo in esso sia naturale, saraà tacciuto, pigliando
A re grauve, sopra del quale diremo, Vut, Iin,
, & il, D acuti trouverai,. eEt percheé tu uvegga l'ordine delle sei sillabe, diremo il loro principio essere in Gama ut,
ilquale, cociosiacosa che il loro processo in esso sia naturale, saraà tacciuto, pigliando
A re grauve, sopra del quale diremo, Vut, Iin,  , mi, re, Iin C, fa, ut, mi, col se-gno del Ddiesi, Iin, D, sol, re, fa, Iin, E la mi, sol, Eet in, F, la, segnato col Ddiesi.; Vut in,
, mi, re, Iin C, fa, ut, mi, col se-gno del Ddiesi, Iin, D, sol, re, fa, Iin, E la mi, sol, Eet in, F, la, segnato col Ddiesi.; Vut in,  , mi;, re in, C, fa, ut colla figura Ddiesi, mi in, D, sol, re col segno
detto;, fa in E la mi col molle segnato [sic: E la mi];, sol, in, F, Eet, la, in, G,; Vut in,
D, sol, re;, re, in E, la mi;, mi in F, grauve con la figura Ddiesi;, fa, in, G, sol page 95in A, acuto; Eet, la, in b
, mi;, re in, C, fa, ut colla figura Ddiesi, mi in, D, sol, re col segno
detto;, fa in E la mi col molle segnato [sic: E la mi];, sol, in, F, Eet, la, in, G,; Vut in,
D, sol, re;, re, in E, la mi;, mi in F, grauve con la figura Ddiesi;, fa, in, G, sol page 95in A, acuto; Eet, la, in b , quadro, acuto; Vut in E, la, mi, re in, F, grauve col se-gno del Ddiesi;, mi, in G, col segno detto Ddiesi;, fa, in A, acuto, sol, in b
, quadro, acuto; Vut in E, la, mi, re in, F, grauve col se-gno del Ddiesi;, mi, in G, col segno detto Ddiesi;, fa, in A, acuto, sol, in b , quadro acuto,
la, in C, acuto inteso col Ddiesi.; Vut in, F, Eet per essere la detta positione nota, & facile,
non le daremo altra dichiaratione, neé similmente al seguente luogo G, sol, re, ut, gra-uve,; Vut in E [sic: A], la, mi, re;, re in b
, quadro acuto,
la, in C, acuto inteso col Ddiesi.; Vut in, F, Eet per essere la detta positione nota, & facile,
non le daremo altra dichiaratione, neé similmente al seguente luogo G, sol, re, ut, gra-uve,; Vut in E [sic: A], la, mi, re;, re in b , mi quadro detto;, mi, in C, acuto col segno del Ddiesi;,
fa, in D, acuto;, sol, in E, &, la, in F, acuto col Ddiesi apparente.; Vut, in b
, mi quadro detto;, mi, in C, acuto col segno del Ddiesi;,
fa, in D, acuto;, sol, in E, &, la, in F, acuto col Ddiesi apparente.; Vut, in b , qua-dro acuto;, re in C, acuto col segno detto;, mi in D, acuto col segno Ddiesi;, fa in E,
acuto;, sol, in F, col Ddiesi; Eet la in G, colla detta figura Ddiesi.; Vut in C, acuto,
del quale non faremo mentione, essendo il suo processo chiaro, & naturale,; Vut in D,
acuto;, re, in E;, mi, in F, dimostrante il Ddiesi;, fa, in G;, Ssol in A;, Lla, in b
, qua-dro acuto;, re in C, acuto col segno detto;, mi in D, acuto col segno Ddiesi;, fa in E,
acuto;, sol, in F, col Ddiesi; Eet la in G, colla detta figura Ddiesi.; Vut in C, acuto,
del quale non faremo mentione, essendo il suo processo chiaro, & naturale,; Vut in D,
acuto;, re, in E;, mi, in F, dimostrante il Ddiesi;, fa, in G;, Ssol in A;, Lla, in b qua-dro,; Vut, in E, acuto;, re, in F, segnato del Ddiesi;, mi, in G, col medesimo segno;,
fa, in A;, sol in b
qua-dro,; Vut, in E, acuto;, re, in F, segnato del Ddiesi;, mi, in G, col medesimo segno;,
fa, in A;, sol in b quadro sopracuto; & la, in C.; Vut, in F, seguente corda saraà si-mile al primo, cioè F, Eet per essere il rimanente delle positioni simile a quello, che di
esse habbiamo detto, faremo fine,. Et percheé nel seguente capitolo si tratteraà della
congionta del b
quadro sopracuto; & la, in C.; Vut, in F, seguente corda saraà si-mile al primo, cioè F, Eet per essere il rimanente delle positioni simile a quello, che di
esse habbiamo detto, faremo fine,. Et percheé nel seguente capitolo si tratteraà della
congionta del b quadro, & del b
quadro, & del b , rotondo, nelle quali si dimostreraà, come, & in
che modo procederanno le sei sillabe, cioè ut, -re, -mi, -fa, -sol, -la, in ciascun luogo della mano, peroò non è stato fuor di proposito hauver trattato, come tal sillabe possa-no procedere da luogo a luogo continouvate, ouvero incomposte. Et a maggior uver-gogna, & biasimo del tuo errore, poi che di senno ti credi pareggiare Solomone, si
domaada [sic: domanda], se tali nomi, ouver sillabe si potranno trouvare per la congionta del b
, rotondo, nelle quali si dimostreraà, come, & in
che modo procederanno le sei sillabe, cioè ut, -re, -mi, -fa, -sol, -la, in ciascun luogo della mano, peroò non è stato fuor di proposito hauver trattato, come tal sillabe possa-no procedere da luogo a luogo continouvate, ouvero incomposte. Et a maggior uver-gogna, & biasimo del tuo errore, poi che di senno ti credi pareggiare Solomone, si
domaada [sic: domanda], se tali nomi, ouver sillabe si potranno trouvare per la congionta del b , ro-tondo in questo nostro stormento chiamato Oorgano,; Ccertamente no, perciocheé uvo-lendo in E grauve segnare il segno del detto b
, ro-tondo in questo nostro stormento chiamato Oorgano,; Ccertamente no, perciocheé uvo-lendo in E grauve segnare il segno del detto b , rotondo, & in tal corda dire, ut, Ccerto si uvede, che tal processo delle sei note non si potraà con spatiji debiti continouvare
l'una dopo l'altra, percheé essendo diuviso lo spatio Ssesquiottauvo fra G, grauve, & A,
acuto, col Ssemituon maggiore nel Ggrauve, & il Mminore nel Aacuto, seguita, che a
tal procedere loro mancheraà lo spatio del Ssemituon minore, ilquale nasce fra il se-condo, e 'l terzo interuvallo, tolto, & occupato dalla congionta del b
, rotondo, & in tal corda dire, ut, Ccerto si uvede, che tal processo delle sei note non si potraà con spatiji debiti continouvare
l'una dopo l'altra, percheé essendo diuviso lo spatio Ssesquiottauvo fra G, grauve, & A,
acuto, col Ssemituon maggiore nel Ggrauve, & il Mminore nel Aacuto, seguita, che a
tal procedere loro mancheraà lo spatio del Ssemituon minore, ilquale nasce fra il se-condo, e 'l terzo interuvallo, tolto, & occupato dalla congionta del b quadro nascente fra G, grauve, & A, acuto,. Et un altro inconuveniente ne nasceraà, perciocheé uvo-lendo il terzo spatio Ssesquiottauvo, fa, -sol detto, a buona hotta uvorrò, che mi sappia dire, douve il trouverai, percheé dopo il dimostrato Ssemituono maggiore, fra esso
& A, acuto, non si trouva altro, che il minore, & dal detto A, a quadro [sic:
quadro nascente fra G, grauve, & A, acuto,. Et un altro inconuveniente ne nasceraà, perciocheé uvo-lendo il terzo spatio Ssesquiottauvo, fa, -sol detto, a buona hotta uvorrò, che mi sappia dire, douve il trouverai, percheé dopo il dimostrato Ssemituono maggiore, fra esso
& A, acuto, non si trouva altro, che il minore, & dal detto A, a quadro [sic:  molle] acuto
un altro minore, i quali insieme presi non creano il Ssesquiottauvo spatio,. Pertanto
tali semituoni minori, non si conuvengono al genere Ddiatonico, essendo l'uno dopo
l'altro,. Questo medesimo harai in E acuto, & in altri simili,. Essendo stato per le
dimostrate ragioni riprouvato quello, che con poca esperienza hai creduto, per l'in-nanzi ti starai cheto.
molle] acuto
un altro minore, i quali insieme presi non creano il Ssesquiottauvo spatio,. Pertanto
tali semituoni minori, non si conuvengono al genere Ddiatonico, essendo l'uno dopo
l'altro,. Questo medesimo harai in E acuto, & in altri simili,. Essendo stato per le
dimostrate ragioni riprouvato quello, che con poca esperienza hai creduto, per l'in-nanzi ti starai cheto.
Del modo di procedere con le sei sillabe accidentali nello stormento detto Oorgano. Cap. VI.

 , molle,. Et percheé, come disopra habbiamo detto, questi tali Mmusici solo attendono alla loro commoditaà, senza considerare quello, chell'Oorganista
puoò operare, Aaccaderà, che, uvolendo il detto Ssonatore sodisfare a tali loro comodi,
che esso non potrà rettamente procedere secondo il Ccanto fermo, & quello andare
imitando, cioè, che dando principio al sesto tuono nella corda, o positione di, E,
col segno detto del b
, molle,. Et percheé, come disopra habbiamo detto, questi tali Mmusici solo attendono alla loro commoditaà, senza considerare quello, chell'Oorganista
puoò operare, Aaccaderà, che, uvolendo il detto Ssonatore sodisfare a tali loro comodi,
che esso non potrà rettamente procedere secondo il Ccanto fermo, & quello andare
imitando, cioè, che dando principio al sesto tuono nella corda, o positione di, E,
col segno detto del b , molle, & uvolendo procedere secondo il discorso di tal tuono,
gli mancherà il Ssemituon minore, ilqual per la congionta del b
, molle, & uvolendo procedere secondo il discorso di tal tuono,
gli mancherà il Ssemituon minore, ilqual per la congionta del b quadro riman maggiore,. Dicono alcuni che questo no è di molta importanza, bisognando al suo discorso tal Ssemituon minore, et trouvadone un maggiore, perciocheé essendo il Ccoma particola insensibile, & che non puoò essere pronontiata dalla uvoce humana, Iil semituon
maggiore puoò sodisfare in uvece del minore;. Si risponde, essere la uveritaà, ch'el Cco-ma, per essere particola minuta, non potrebbe essere prononciato dalla uvoce huma-na, quando esso hauvesse proprio spatio,; peroò, conchiudo tale oppenione non essere conceduta, percheé dato che esso Ccoma per seé non sia senbile [sic: sensibile], nondimeno composto resta
sensibile, come appare, quando l'Oorganista si uvuol preuvalere, & accomodarsi di
qualche Tterza, o Ddecima maggiore,. Appresso, che egli sia sensibile, chiaramente
si consce [sic: conosce] nelle diuvisioni de' tuoni dell'Oorgano, le quali essendo da te bene essaminate,
trouverai dal, C, grauve al seguente tasto negro essere maggiore parte che non è da page 97esso tasto negro al seguente bianco,. Et similmente, procedendo da, F, a, G, grauvi,
da, F, al tasto negro saraà maggiore spatio, che non saraà dal detto tasto negro al se-guente bianco,. Et non per altro nasce tal quantità maggiore, che per lo spatio di
esso Ccoma, ilqual per seé non si dimostra,. Conchiudo adunque, che egli è di mestie-ri, che il maestro di Ccapella habbia cognitione di sapersi accomodare all'orga
no [sic: organo], altrimenti ne risulteraà confussione [sic: confusione], come molte uvolte da noi è stato auvertito, se
giaà tali Oorgani non fossero stati ridotti allo loro perfettione.
quadro riman maggiore,. Dicono alcuni che questo no è di molta importanza, bisognando al suo discorso tal Ssemituon minore, et trouvadone un maggiore, perciocheé essendo il Ccoma particola insensibile, & che non puoò essere pronontiata dalla uvoce humana, Iil semituon
maggiore puoò sodisfare in uvece del minore;. Si risponde, essere la uveritaà, ch'el Cco-ma, per essere particola minuta, non potrebbe essere prononciato dalla uvoce huma-na, quando esso hauvesse proprio spatio,; peroò, conchiudo tale oppenione non essere conceduta, percheé dato che esso Ccoma per seé non sia senbile [sic: sensibile], nondimeno composto resta
sensibile, come appare, quando l'Oorganista si uvuol preuvalere, & accomodarsi di
qualche Tterza, o Ddecima maggiore,. Appresso, che egli sia sensibile, chiaramente
si consce [sic: conosce] nelle diuvisioni de' tuoni dell'Oorgano, le quali essendo da te bene essaminate,
trouverai dal, C, grauve al seguente tasto negro essere maggiore parte che non è da page 97esso tasto negro al seguente bianco,. Et similmente, procedendo da, F, a, G, grauvi,
da, F, al tasto negro saraà maggiore spatio, che non saraà dal detto tasto negro al se-guente bianco,. Et non per altro nasce tal quantità maggiore, che per lo spatio di
esso Ccoma, ilqual per seé non si dimostra,. Conchiudo adunque, che egli è di mestie-ri, che il maestro di Ccapella habbia cognitione di sapersi accomodare all'orga
no [sic: organo], altrimenti ne risulteraà confussione [sic: confusione], come molte uvolte da noi è stato auvertito, se
giaà tali Oorgani non fossero stati ridotti allo loro perfettione.
Domanda del b , molle in C, & in F, considerato, ouvero
immaginato. Cap. VII.
, molle in C, & in F, considerato, ouvero
immaginato. Cap. VII.
 , molle, & del Ddiesi immaginati, considerati in C, in F, in
, molle, & del Ddiesi immaginati, considerati in C, in F, in  & in E, naturali. Quanto sia honesta, & ragioneuvole tal loro dimanda, si
dimostrerà nel presente capitolo, ma per sodisfatione di quegli, che fanno tal Qque-sito, Eegli eè dibisogno, che tu sappia, che egli è impossibile, che tal dimanda sia chia-rita per uvia del genere Ddiatonico;. Volendo tu adunque immaginarti il segno di, b
& in E, naturali. Quanto sia honesta, & ragioneuvole tal loro dimanda, si
dimostrerà nel presente capitolo, ma per sodisfatione di quegli, che fanno tal Qque-sito, Eegli eè dibisogno, che tu sappia, che egli è impossibile, che tal dimanda sia chia-rita per uvia del genere Ddiatonico;. Volendo tu adunque immaginarti il segno di, b ,
in C, grauve, & con tal uvoce fa, hauvere ogni altra nota, lequali rettamente procedano, a te potrebbe interuvenir forse quello, che altrui è interuvenuto, iquali hanno creduto, che quando il Mmusico, ouver Ccompositore ne' suoi processi musicali adduce la
figura del, b
,
in C, grauve, & con tal uvoce fa, hauvere ogni altra nota, lequali rettamente procedano, a te potrebbe interuvenir forse quello, che altrui è interuvenuto, iquali hanno creduto, che quando il Mmusico, ouver Ccompositore ne' suoi processi musicali adduce la
figura del, b , molle, o del Ddiesi, che quella nota dal proprio suo luogo non si rimo-uva., ma stia permanente, & che tali segni siano quasi di souverchio. Però, per isganar-ti di questo errore, saperai, che tal sillaba, o nota, fa, posta in C, col detto segno, b
, molle, o del Ddiesi, che quella nota dal proprio suo luogo non si rimo-uva., ma stia permanente, & che tali segni siano quasi di souverchio. Però, per isganar-ti di questo errore, saperai, che tal sillaba, o nota, fa, posta in C, col detto segno, b ,
è indi rimossa, & piuù non è laà douve prima si ritrouvauva, ma sotto di, b
,
è indi rimossa, & piuù non è laà douve prima si ritrouvauva, ma sotto di, b , mi grauve,
per un spatio del Ccoma, ilquale non sta naturalmente in tal positione,. pPer tanto non
hauvendo il, b
, mi grauve,
per un spatio del Ccoma, ilquale non sta naturalmente in tal positione,. pPer tanto non
hauvendo il, b , positione commoda, per conseguente il mi, quiuvi non si potraà ritro-uvare, per essere il tuon sesquiottauvo da, A, & B
, positione commoda, per conseguente il mi, quiuvi non si potraà ritro-uvare, per essere il tuon sesquiottauvo da, A, & B , mi grauvi diuviso per lo Sse-mituon maggiore nel acuto, & il minore nel grauve, & procedendo al mi, non lo
potrai ritrouvare, conciosia cosa che il Ssemituon geminato nasca fra, B
, mi grauvi diuviso per lo Sse-mituon maggiore nel acuto, & il minore nel grauve, & procedendo al mi, non lo
potrai ritrouvare, conciosia cosa che il Ssemituon geminato nasca fra, B , mi, &
A, & fra, A, & G, iquali semituoni sono sottoposti al genere Ccromatico,. Discor-rendo la uvoce Vut, tal sillaba saraà per un semituon maggiore sotto a Gamma ut,.This explanation is not satisfactory. Saying fa on a hypothetical C flat makes it possible to say mi on B flat, while re and
ut on A flat and G flat were unavailable on standard keyboards in Aaron's time. Onde, quando per piuù facilitaà uvorrai intendere tal Ttetracordo da, C, a Gamma acci-dentale col detto, b
, mi, &
A, & fra, A, & G, iquali semituoni sono sottoposti al genere Ccromatico,. Discor-rendo la uvoce Vut, tal sillaba saraà per un semituon maggiore sotto a Gamma ut,.This explanation is not satisfactory. Saying fa on a hypothetical C flat makes it possible to say mi on B flat, while re and
ut on A flat and G flat were unavailable on standard keyboards in Aaron's time. Onde, quando per piuù facilitaà uvorrai intendere tal Ttetracordo da, C, a Gamma acci-dentale col detto, b , dimostrato, quanto saraà il fa, da, C, abbassato, tanto disotto a
Gamma saraà la uvoce ut,; Eet seguitando alla nota sol, per essere sopra del, C, il semi-tuon maggiore, saranno dal suo, fa, al sol, duoi semituoni maggiori, iquali souverchiano il tuono dello spatio del Ccoma,. sSimilmente, uvolendo la uvoce, sol [sic: la], per la continouvatione di duoi semituon minori, mancheraà il tuono dello spatio del detto Ccoma.
, dimostrato, quanto saraà il fa, da, C, abbassato, tanto disotto a
Gamma saraà la uvoce ut,; Eet seguitando alla nota sol, per essere sopra del, C, il semi-tuon maggiore, saranno dal suo, fa, al sol, duoi semituoni maggiori, iquali souverchiano il tuono dello spatio del Ccoma,. sSimilmente, uvolendo la uvoce, sol [sic: la], per la continouvatione di duoi semituon minori, mancheraà il tuono dello spatio del detto Ccoma.
Del, b , molle in A [sic: F], collocate [sic: collocato]. Cap. VIII.
, molle in A [sic: F], collocate [sic: collocato]. Cap. VIII.
 , nella positione di, F, gra-uve, perciocheé il detto fa, saraà inteso, & immaginato sotto la positione di, E, grauve
per un Ccoma, ilquale cambia il semituon maggiore in minore, nascente fra, E & D,
per laqual cosa quel fa, accidentale haraà nel discendere il semituon minore, ilqual nasce al tasto negro posto fra esso, D, & E, & dal mi, a, re, per essere dal detto tasto negro al D, duoi semituon minori l'un dopo l'altro, iquali si comprendono dal tasto
bianco del D, grauve al negro seguente, non si potraà hauver lo spatio del tuono,. Onde
saraà dibisogno aumentarlo d'un Ccoma sotto al detto tasto negro posto fra, C, et D,
grauvi;. Appresso non harai la uvoce, Vut, per essere in tali positioni duoi semituoni minori continouvati. lLaà onde saraà di necessità sotto b
, nella positione di, F, gra-uve, perciocheé il detto fa, saraà inteso, & immaginato sotto la positione di, E, grauve
per un Ccoma, ilquale cambia il semituon maggiore in minore, nascente fra, E & D,
per laqual cosa quel fa, accidentale haraà nel discendere il semituon minore, ilqual nasce al tasto negro posto fra esso, D, & E, & dal mi, a, re, per essere dal detto tasto negro al D, duoi semituon minori l'un dopo l'altro, iquali si comprendono dal tasto
bianco del D, grauve al negro seguente, non si potraà hauver lo spatio del tuono,. Onde
saraà dibisogno aumentarlo d'un Ccoma sotto al detto tasto negro posto fra, C, et D,
grauvi;. Appresso non harai la uvoce, Vut, per essere in tali positioni duoi semituoni minori continouvati. lLaà onde saraà di necessità sotto b , mi grauve immaginarsi un altro
Ccoma, Eet questo ordine, & modo accidentale intorno le dette positioni, & segni
nel seguente capitolo intenderai, & seguitando diremo tutto quello è necessario in-torno la cognitione della figura, o segno Ddiesi, in bB, & in E, immaginato.
, mi grauve immaginarsi un altro
Ccoma, Eet questo ordine, & modo accidentale intorno le dette positioni, & segni
nel seguente capitolo intenderai, & seguitando diremo tutto quello è necessario in-torno la cognitione della figura, o segno Ddiesi, in bB, & in E, immaginato.
Del segno del Ddiesi in bB, & in E, grauvi consi-derato. Cap. XI [sic: IX].
 , quadro primo, & uvolendo il seguente
tuono ritrouvare, ilqual, è, mi, -re, Eet per essere diuviso, & compassato tal spatio sesqui-ottauvo per semituon maggiore in acuto, & appresso continouvando duoi semituoni
maggiori, alla reintegratione di quel tuono superato dal Ccoma, & a [sic: sarebbe] dibisogno che 'l
detto interuvallo hauvesse il semituon minore nell'intenso, & il maggiore nel remesso,
per le sopradette cose appare, che egli è di souverchio tal segno in bB, grauve conside-rato,; nondimeno, seguitando al grauve:, trouverai la uvoce, Vut, percheé lo spatio del Cco-ma supera il tasto nero ordinato fra, b
, quadro primo, & uvolendo il seguente
tuono ritrouvare, ilqual, è, mi, -re, Eet per essere diuviso, & compassato tal spatio sesqui-ottauvo per semituon maggiore in acuto, & appresso continouvando duoi semituoni
maggiori, alla reintegratione di quel tuono superato dal Ccoma, & a [sic: sarebbe] dibisogno che 'l
detto interuvallo hauvesse il semituon minore nell'intenso, & il maggiore nel remesso,
per le sopradette cose appare, che egli è di souverchio tal segno in bB, grauve conside-rato,; nondimeno, seguitando al grauve:, trouverai la uvoce, Vut, percheé lo spatio del Cco-ma supera il tasto nero ordinato fra, b , mi, grauve & A re,. lLaà onde dal detto Ccoma
al tasto bianco dimostrante la corda di A re, saraà l'interuvallo d'un Aappotome, et dal
detto A, al tasto nero seguente appare il semituon minore, ilquale giunto insieme col
maggiore fanno, lo spatio sesquiottauvo perfetto, dato che il Ccoma sopra di, b
, mi, grauve & A re,. lLaà onde dal detto Ccoma
al tasto bianco dimostrante la corda di A re, saraà l'interuvallo d'un Aappotome, et dal
detto A, al tasto nero seguente appare il semituon minore, ilquale giunto insieme col
maggiore fanno, lo spatio sesquiottauvo perfetto, dato che il Ccoma sopra di, b , mi grauve non habbia luogo propio,. Et cosiì sopra della uvoce detta mi, seguiteranno il fa, il
sol, e 'l, la,. Et bisognando procedera [sic: procedere] al semituon minore, tal semituono saraà immagi-nato dal Ccoma sopra la corda di, C, grauve al tasto nero fra C, et D, grauve, et indi al
sol, quinta nostra uvoce, si uvede esso non poter hauvere luogo naturale, & proprio, per
essere diminuto d'un Ccoma, & questo adiuviene. per rispetto de' duoi semituon minori
considerati, & apparenti dal tasto nero al bianco detto, D, & dal detto bianco al
seguente nero fra D, & E, ilqual Ccoma saraà inteso sopra del tasto, che cade fra D,
& E,; & la sillaba ultima nasceraà sopra di F, grauve, per un Ccoma. page 99
, mi grauve non habbia luogo propio,. Et cosiì sopra della uvoce detta mi, seguiteranno il fa, il
sol, e 'l, la,. Et bisognando procedera [sic: procedere] al semituon minore, tal semituono saraà immagi-nato dal Ccoma sopra la corda di, C, grauve al tasto nero fra C, et D, grauve, et indi al
sol, quinta nostra uvoce, si uvede esso non poter hauvere luogo naturale, & proprio, per
essere diminuto d'un Ccoma, & questo adiuviene. per rispetto de' duoi semituon minori
considerati, & apparenti dal tasto nero al bianco detto, D, & dal detto bianco al
seguente nero fra D, & E, ilqual Ccoma saraà inteso sopra del tasto, che cade fra D,
& E,; & la sillaba ultima nasceraà sopra di F, grauve, per un Ccoma. page 99Del Ddiesi in E, immaginato. Cap. X.
 , quadro,
neé in E, neé il b
, quadro,
neé in E, neé il b , molle, nel C, nel F, come seguitando per le congionte intenderai.
, molle, nel C, nel F, come seguitando per le congionte intenderai.
Della congionta del b , molle, & del b
, molle, & del b , quadro. Cap. XI.
, quadro. Cap. XI.
 molle, & della
figura b
molle, & della
figura b duro, Nno deono però da te essere istimate di souverchio, neé uvane, ma necessarie, & al proposito a coloro, iquali desiderano tali considerationi, Cconciosia
che poche, o quasi niuna al presente se ne ritrouvi, Llaqual cosa adiuviene, percheé poca quantità ne furono impresse,.'Perché poca quantità ne furono impresse': this is a reference to Aaron's Treatise on mutations. Pertanto a sodisfattione di quelli, che non ne han-no potuto hauvere, diremo, chelle congionte, come piace al musicale consortio, sono
due, delle quali l'una è detta di b
duro, Nno deono però da te essere istimate di souverchio, neé uvane, ma necessarie, & al proposito a coloro, iquali desiderano tali considerationi, Cconciosia
che poche, o quasi niuna al presente se ne ritrouvi, Llaqual cosa adiuviene, percheé poca quantità ne furono impresse,.'Perché poca quantità ne furono impresse': this is a reference to Aaron's Treatise on mutations. Pertanto a sodisfattione di quelli, che non ne han-no potuto hauvere, diremo, chelle congionte, come piace al musicale consortio, sono
due, delle quali l'una è detta di b , molle, ouveramente b
, molle, ouveramente b , rotondo, la quale si puoò se-gnare con questo segno, b
, rotondo, la quale si puoò se-gnare con questo segno, b , in ciascuna corda, o positione della semplice mano di
Guido, eccetto che in C, & in F, et la seconda è nominata dalla figura di b
, in ciascuna corda, o positione della semplice mano di
Guido, eccetto che in C, & in F, et la seconda è nominata dalla figura di b duro, ouvero di b
duro, ouvero di b quadro, Llaquale puoò essere segnata co questo segno,
quadro, Llaquale puoò essere segnata co questo segno,  , in ciascuna delle positioni naturali, ouvero semplici della detta mano, saluvo che in B, et in E,; ma percheé
questo, B
, in ciascuna delle positioni naturali, ouvero semplici della detta mano, saluvo che in B, et in E,; ma percheé
questo, B , non si segni in C, neé in F, naturali, neé questo,
, non si segni in C, neé in F, naturali, neé questo,  , in B neé in E, seguitando saraà detto,. Adunque questo segno, b
, in B neé in E, seguitando saraà detto,. Adunque questo segno, b , si potraà segnare in cinque luoghi, o positioni dif-ferenti della mano, cioè in A, in B, in D, in E, & in G, Eet questo,
, si potraà segnare in cinque luoghi, o positioni dif-ferenti della mano, cioè in A, in B, in D, in E, & in G, Eet questo,  , similmente si potraà segnare in altre cinque positioni della mano semplice predetta, cioè in A, in C,
in D, in F, & in G,; & la sillaba, ouvero nome officiale assegnata, o sottoposta a questo segno, b
, similmente si potraà segnare in altre cinque positioni della mano semplice predetta, cioè in A, in C,
in D, in F, & in G,; & la sillaba, ouvero nome officiale assegnata, o sottoposta a questo segno, b , saraà la sillaba fa, & a questo,
, saraà la sillaba fa, & a questo,  , saraà assegnata la sillaba mi,; & de
qui nasce, che quando questo segno, b
, saraà assegnata la sillaba mi,; & de
qui nasce, che quando questo segno, b , è posto nell'uno delle positioni della sopradet-ta mano, alhora quel Ttuono naturale, il qual cade fra tale positione segnata, & la
inferiore natural propinqua, resta diuviso per lo maggior semituono nell'acuto, &
per lo minore nel grauve, come dimostra il Ttuono, il quale cade tra A, & B
, è posto nell'uno delle positioni della sopradet-ta mano, alhora quel Ttuono naturale, il qual cade fra tale positione segnata, & la
inferiore natural propinqua, resta diuviso per lo maggior semituono nell'acuto, &
per lo minore nel grauve, come dimostra il Ttuono, il quale cade tra A, & B , qua-page 100dro acuti, quando questo segno b
, qua-page 100dro acuti, quando questo segno b , è segnato in
, è segnato in  mi grauve,. Ma quando questo se-gno,
mi grauve,. Ma quando questo se-gno,  , è nell'una delle positioni predette naturali, alhora quel tuono natura-le, il quale è posto fra tal positione segnata, & la superiore propinqua, resteraà di-uviso col maggiore Ssemituono nel grauve, & col minore nell'acuto, Pper laqual cosa
accaderaà, che essendo segnata ciascuna delle predette positioni della semplice ma-no co' detti dui segni, b
, è nell'una delle positioni predette naturali, alhora quel tuono natura-le, il quale è posto fra tal positione segnata, & la superiore propinqua, resteraà di-uviso col maggiore Ssemituono nel grauve, & col minore nell'acuto, Pper laqual cosa
accaderaà, che essendo segnata ciascuna delle predette positioni della semplice ma-no co' detti dui segni, b , &
, &  [sic: delete], che ciascuno spacio de' tuoni naturali della mano, ouvero semplice Mmonacordo, resteraà (come ho detto) diuviso per lo maggiore semi-tuono nel grauve, & per lo minore nell'acuto, & anchora per lo minor semituono
nel grauve, & per lo maggior nell'acuto, in modo, che tra ciascuno spatio di Ttuo-no naturale appareranno doi minori semituoni, cioè l'uno nel grauve, & l'altro nel
l'acuto, iquali Ssemituoni saranno dimezzati, & fra loro distanti per lo spatio di
un Ccoma, come accade ne' Mmonacordi, & Oorgani moderni in quello spatio del Ttuono cadente tra G, et A, naturali, tra le quali estremità cadono doi tasti neri, de' quali
quello, che è piuù appresso al G, saraà semituono minore con la predetta lettera G, et
coll'A, saraà maggiore, Iilqual tasto nasce da questo segno, b
[sic: delete], che ciascuno spacio de' tuoni naturali della mano, ouvero semplice Mmonacordo, resteraà (come ho detto) diuviso per lo maggiore semi-tuono nel grauve, & per lo minore nell'acuto, & anchora per lo minor semituono
nel grauve, & per lo maggior nell'acuto, in modo, che tra ciascuno spatio di Ttuo-no naturale appareranno doi minori semituoni, cioè l'uno nel grauve, & l'altro nel
l'acuto, iquali Ssemituoni saranno dimezzati, & fra loro distanti per lo spatio di
un Ccoma, come accade ne' Mmonacordi, & Oorgani moderni in quello spatio del Ttuono cadente tra G, et A, naturali, tra le quali estremità cadono doi tasti neri, de' quali
quello, che è piuù appresso al G, saraà semituono minore con la predetta lettera G, et
coll'A, saraà maggiore, Iilqual tasto nasce da questo segno, b , posto nell'A, predet-ta,; & l'altro tasto nero saraà anchora Ssemituon minore colla lettera A, & mag-giore col G, & quella distanza sonora, la quale cade tra i predetti duoi tasti ne-gri, Ttheoricamente parlando, saraà spatio di un Ccoma,. Compreso adunque quello,
che è stato detto, si haraà chiara cognitione di quello, che detto habbiamo di sopra,
cioè che in B, & in E, naturali non si segneraà questo segno
, posto nell'A, predet-ta,; & l'altro tasto nero saraà anchora Ssemituon minore colla lettera A, & mag-giore col G, & quella distanza sonora, la quale cade tra i predetti duoi tasti ne-gri, Ttheoricamente parlando, saraà spatio di un Ccoma,. Compreso adunque quello,
che è stato detto, si haraà chiara cognitione di quello, che detto habbiamo di sopra,
cioè che in B, & in E, naturali non si segneraà questo segno  , & che in C, & anchora in F, naturali non si segneraà questo, b
, & che in C, & anchora in F, naturali non si segneraà questo, b , Llaqual cosa aduverà, percheé la lettera B,
& E, naturali non hanno sopra di seé lo spatio propinquo di Ttuono, ilquale mediante tal segno possa restare diuviso per lo Ssemituono maggiore nel grauve, & per lo minore nell'acuto. Ma tal segno,
, Llaqual cosa aduverà, percheé la lettera B,
& E, naturali non hanno sopra di seé lo spatio propinquo di Ttuono, ilquale mediante tal segno possa restare diuviso per lo Ssemituono maggiore nel grauve, & per lo minore nell'acuto. Ma tal segno,  , ouve fosse posto in B, & in E, naturali, producerebbe
un suono, il quale ascenderebbe sopra C, et F, per uno spatio di un Ccoma, molto inutile nell'harmonico stormento,. sSimilmente, se questo segno, b
, ouve fosse posto in B, & in E, naturali, producerebbe
un suono, il quale ascenderebbe sopra C, et F, per uno spatio di un Ccoma, molto inutile nell'harmonico stormento,. sSimilmente, se questo segno, b , fosse dato in C, ouvero in
F, naturale, il suo suono discenderebbe sotto B, & E, naturali per lo spatio di un
Ccoma, molto incommodo, & di souverchio,. Et per tal cagione i detti segni non so-no collocati nelle positioni di sopra dette,. Quando adunque questi segni, b
, fosse dato in C, ouvero in
F, naturale, il suo suono discenderebbe sotto B, & E, naturali per lo spatio di un
Ccoma, molto incommodo, & di souverchio,. Et per tal cagione i detti segni non so-no collocati nelle positioni di sopra dette,. Quando adunque questi segni, b ,
,  , da
molti chiamati accidetali, sarano segnati nelle predette naturali positioni della
mano di Guido, alhora seguiteraà che in ciascuno luogo, & positione di essa si po-traà ritrouvare ciascheduna delle sei sillabe, cioè ut, re, mi, fa, sol, la, con le loro de-bite distanze, delle quali sillabe alcune nasceranno dall'ordine primo chiamato semplice, o naturale, & alcune da' segni predetti, come qui, b
, da
molti chiamati accidetali, sarano segnati nelle predette naturali positioni della
mano di Guido, alhora seguiteraà che in ciascuno luogo, & positione di essa si po-traà ritrouvare ciascheduna delle sei sillabe, cioè ut, re, mi, fa, sol, la, con le loro de-bite distanze, delle quali sillabe alcune nasceranno dall'ordine primo chiamato semplice, o naturale, & alcune da' segni predetti, come qui, b ,
,  , Ll'origine, & nascimento delle quali tre prime sillabe, cioè, ut, re, mi, uvolendo ritrouvare, ti couverrà, essendo prodotte da tali segni accidentali, ascendere, percheé hanno il loro semituono cadente tra mi, & fa, sopra di loro,. Ma uvolendo ritrouvare le predette sei sillabe
uguali in suono con Gama ut naturale, saraà dannoi detto, chella prima sillaba, cioè
ut, è naturale in tal luogo, Ddapoi chella sillaba seconda, cioè, re, nasceraà da questo
segno, b
, Ll'origine, & nascimento delle quali tre prime sillabe, cioè, ut, re, mi, uvolendo ritrouvare, ti couverrà, essendo prodotte da tali segni accidentali, ascendere, percheé hanno il loro semituono cadente tra mi, & fa, sopra di loro,. Ma uvolendo ritrouvare le predette sei sillabe
uguali in suono con Gama ut naturale, saraà dannoi detto, chella prima sillaba, cioè
ut, è naturale in tal luogo, Ddapoi chella sillaba seconda, cioè, re, nasceraà da questo
segno, b , segnato in b
, segnato in b mi grauve naturale,. lLa terza sillaba, mi, nasceraà anchora da page 101questo b
mi grauve naturale,. lLa terza sillaba, mi, nasceraà anchora da page 101questo b , segnato in A re,. Ma la quarta sillaba, fa, hauveraà principio da questo segno,
, segnato in A re,. Ma la quarta sillaba, fa, hauveraà principio da questo segno,
 , segnato in F, acquisito, il quale naturalmente è distante da esso Gama ut, per un
tuono, & è in ottauva con F, grauve,. Et la quinta sillaba, cioè sol, caderaà in tal luogo naturalmente, percheé saraà prodotta dal C, acquisito, il quale si trouva in ottauva
nel grauve con C, grauve,. Ma l'ultima sillaba, cioè la, deriuveraà da questo segno, b
, segnato in F, acquisito, il quale naturalmente è distante da esso Gama ut, per un
tuono, & è in ottauva con F, grauve,. Et la quinta sillaba, cioè sol, caderaà in tal luogo naturalmente, percheé saraà prodotta dal C, acquisito, il quale si trouva in ottauva
nel grauve con C, grauve,. Ma l'ultima sillaba, cioè la, deriuveraà da questo segno, b , posto in E, acquisito, distante per una ottauva da E, grauve,; et per tal modo, come a
molti piace, accaderaà, che tutti i nomi officiali, che accidentalmente sono equali in
suono con Gama ut, saranno retti, & gouvernati da questo segno, b
, posto in E, acquisito, distante per una ottauva da E, grauve,; et per tal modo, come a
molti piace, accaderaà, che tutti i nomi officiali, che accidentalmente sono equali in
suono con Gama ut, saranno retti, & gouvernati da questo segno, b , eccetto il fa,
ilquale è gouvernato da questo segno,
, eccetto il fa,
ilquale è gouvernato da questo segno,  , & anchora ut, & sol, i quali si gouvernano
per l'ordine semplice, ouvero naturale. Poscia che habbiamo dimostrato la depen-denza, de' sei nomi officiali considerati equali in suono con Gamma ut, pri-ma positione dell'ordine semplice della mano, hora seguitando intorno della depen-denza, & nascimento delle predette sei sillabe considerate ugualmente in suono con
A re, si tratterà,. Diciamo, adunque, chella prima sillaba, ut, considerata equale in
suono con A re predetto, procede da questo segno,
, & anchora ut, & sol, i quali si gouvernano
per l'ordine semplice, ouvero naturale. Poscia che habbiamo dimostrato la depen-denza, de' sei nomi officiali considerati equali in suono con Gamma ut, pri-ma positione dell'ordine semplice della mano, hora seguitando intorno della depen-denza, & nascimento delle predette sei sillabe considerate ugualmente in suono con
A re, si tratterà,. Diciamo, adunque, chella prima sillaba, ut, considerata equale in
suono con A re predetto, procede da questo segno,  , segnato in C, grauve,. Et la seconda, cioè re, sta naturalmente in tal luogo,. Et la terza, cioè mi, nasce da questo se-gno, b
, segnato in C, grauve,. Et la seconda, cioè re, sta naturalmente in tal luogo,. Et la terza, cioè mi, nasce da questo se-gno, b , posto in B
, posto in B mi quadro grauve,. Et la quarta, cioè fa, ha origine da questo
segno,
mi quadro grauve,. Et la quarta, cioè fa, ha origine da questo
segno,  , collocato in Gamma ut,. lLa quinta, cioè sol, nasce da questo segno,
, collocato in Gamma ut,. lLa quinta, cioè sol, nasce da questo segno,  , messo
in F, acquisito, il qual F, naturalmente si trouva sotto Gamma ut, un Ttuono piuù bas-so,. Ma la sesta sillaba, cioè, la, naturalmente sta in essa positione, & è generata
dal C, acquisito posto una ottauva sotto C, fa, ut, grauve,. Et per tal modo appare,
che tutti i nomi delle sillabe cadenti equali in suono con A, naturale nascono da questo segno,
, messo
in F, acquisito, il qual F, naturalmente si trouva sotto Gamma ut, un Ttuono piuù bas-so,. Ma la sesta sillaba, cioè, la, naturalmente sta in essa positione, & è generata
dal C, acquisito posto una ottauva sotto C, fa, ut, grauve,. Et per tal modo appare,
che tutti i nomi delle sillabe cadenti equali in suono con A, naturale nascono da questo segno,  , eccetto mi, ilquale deriuva da questo, b
, eccetto mi, ilquale deriuva da questo, b , & anchora la sillaba la, & re,
che nascono dall'ordine semplice ouvero naturale. Visto, et essaminato come le sei sil-labe, o nomi officiali nella prima, & nella seconda positione sono considerate, Aal
presente si daraà chiara notitia, come i predetti sei nomi debbono essere considerati
in b
, & anchora la sillaba la, & re,
che nascono dall'ordine semplice ouvero naturale. Visto, et essaminato come le sei sil-labe, o nomi officiali nella prima, & nella seconda positione sono considerate, Aal
presente si daraà chiara notitia, come i predetti sei nomi debbono essere considerati
in b , quadro, terza positione. Egli è adunque da sapere, chella prima sillaba, ut,
ha origine da questo segno,
, quadro, terza positione. Egli è adunque da sapere, chella prima sillaba, ut,
ha origine da questo segno,  , segnato in D, sol, re, secondo l'ordine semplice,. eE la se-conda, cioè, re, ha il suo nascimento dal predetto segno posto in C, grauve. Ma la
terza sillaba, cioè, mi, sta in tal luogo naturalmente,. La quarta sillaba, fa, nasce
da questo segno,
, segnato in D, sol, re, secondo l'ordine semplice,. eE la se-conda, cioè, re, ha il suo nascimento dal predetto segno posto in C, grauve. Ma la
terza sillaba, cioè, mi, sta in tal luogo naturalmente,. La quarta sillaba, fa, nasce
da questo segno,  , collocato in A re. Et la quinta, cioè sol, procede dal predetto se-gno messo in Gamma ut,. Et l'ultima, detta, la, nasce da questo segno,
, collocato in A re. Et la quinta, cioè sol, procede dal predetto se-gno messo in Gamma ut,. Et l'ultima, detta, la, nasce da questo segno,  , dimostrato
in F, acquisito, ilquale nel grauve è sotto di Gama ut, per lo spatio di un tuono,. On-de per le predette dimostrationi appare, che tutti i nomi, officiali, iquali sono considerati equalmente in suono con b
, dimostrato
in F, acquisito, ilquale nel grauve è sotto di Gama ut, per lo spatio di un tuono,. On-de per le predette dimostrationi appare, che tutti i nomi, officiali, iquali sono considerati equalmente in suono con b quadro naturale, & dependono [sic: dependono] da questo se-gno,
quadro naturale, & dependono [sic: dependono] da questo se-gno,  , eccetto mi, ilquale è dell'ordine primo detto naturale.
, eccetto mi, ilquale è dell'ordine primo detto naturale.
 , segnato in E la mi grauve,; & Lla terza, cioè, mi, ha principio dal pre-detto segno posto in D sol re,. La quarta, cioeè fa, sta naturalmente in tal luogo,. Ma page 102la quinta, detta, sol, nasce anchora da questo segno, b
, segnato in E la mi grauve,; & Lla terza, cioè, mi, ha principio dal pre-detto segno posto in D sol re,. La quarta, cioeè fa, sta naturalmente in tal luogo,. Ma page 102la quinta, detta, sol, nasce anchora da questo segno, b , collocato in b
, collocato in b , quadro gra-uve,; & la sesta, chiamata, la, depende dal sopra detto segno segnato in A re. Per tanto,
appare, che tutti i nomi officiali, liquali sono considerati essere equali in suono nella
lettera. C. naturale, deriuvano dal detto segno, eccetto, ut, et fa, iquali si appartengo-no al primo ordine,. eEt con tale modo seguitado alla quinta positione, detta, D, sol, re.,
Ddiremo che la prima sillaba nasceraà da questo segno,
, quadro gra-uve,; & la sesta, chiamata, la, depende dal sopra detto segno segnato in A re. Per tanto,
appare, che tutti i nomi officiali, liquali sono considerati essere equali in suono nella
lettera. C. naturale, deriuvano dal detto segno, eccetto, ut, et fa, iquali si appartengo-no al primo ordine,. eEt con tale modo seguitado alla quinta positione, detta, D, sol, re.,
Ddiremo che la prima sillaba nasceraà da questo segno,  , posto in F, grauve,. La se-conda, cioè, re, sta in tal luogo naturalmente,. La terza, detta mi, procede da questo,
b
, posto in F, grauve,. La se-conda, cioè, re, sta in tal luogo naturalmente,. La terza, detta mi, procede da questo,
b , segnato in E la mi,. La quarta, detta fa, nasce da questo segno,
, segnato in E la mi,. La quarta, detta fa, nasce da questo segno,  , messo in C, grauve,.
La quinta, detta sol, sta in tal luogo naturalmente,. L'ultima, cioè, la, depede da questo segno, b
, messo in C, grauve,.
La quinta, detta sol, sta in tal luogo naturalmente,. L'ultima, cioè, la, depede da questo segno, b , posto in b
, posto in b quadro grauve,. Et per tal modo accaderaà, che tutti i nomi
officiali, cosiderati equali in suono in D, grauve naturale, dependono da questo segno,
b
quadro grauve,. Et per tal modo accaderaà, che tutti i nomi
officiali, cosiderati equali in suono in D, grauve naturale, dependono da questo segno,
b , ecceto fa, et ut, liquali hanno origine da questo segno,
, ecceto fa, et ut, liquali hanno origine da questo segno,  , & re, & sol, iquali na-turalmente si comprendono,. Appresso seguitando diremo, che delle sei predette
sillabe considerate equalmente in suono nella sesta positione naturale, chiamata E la
mi, Lla prima sillaba, ut, ha il suo nascimento da questo segno,
, & re, & sol, iquali na-turalmente si comprendono,. Appresso seguitando diremo, che delle sei predette
sillabe considerate equalmente in suono nella sesta positione naturale, chiamata E la
mi, Lla prima sillaba, ut, ha il suo nascimento da questo segno,  , segnato in G acu-to, ouvero grauve,. Et la seconda, cioeè, re, nasce dal predetto segno posto in F, grauve,.
Ma la terza sillaba, cioeè, mi, sta in tal luogo naturalmente,. Et la quarta, cioeè fa, ha
origine da questo segno,
, segnato in G acu-to, ouvero grauve,. Et la seconda, cioeè, re, nasce dal predetto segno posto in F, grauve,.
Ma la terza sillaba, cioeè, mi, sta in tal luogo naturalmente,. Et la quarta, cioeè fa, ha
origine da questo segno,  , collocato in D, grauve,. lLa quinta, cioeè sol, uviene da questo
segno messo nel C, grauve. La sesta, cioeè la, sta naturalmente in tal luogo, in modo
che tutti i nomi officiali, considerati equali in suono in E la mi, hanno dependenza da
questo segno,
, collocato in D, grauve,. lLa quinta, cioeè sol, uviene da questo
segno messo nel C, grauve. La sesta, cioeè la, sta naturalmente in tal luogo, in modo
che tutti i nomi officiali, considerati equali in suono in E la mi, hanno dependenza da
questo segno,  , eccetto mi, et la, che sono cosiderati dal primo ordine detto naturale.
Puossi similmente dimostrare, come nella settima positione nascono sei nomi officiali con equale sonoritaà. Pertanto adiuviene, che il primo, cioeè ut, ha origine da questo
segno, b
, eccetto mi, et la, che sono cosiderati dal primo ordine detto naturale.
Puossi similmente dimostrare, come nella settima positione nascono sei nomi officiali con equale sonoritaà. Pertanto adiuviene, che il primo, cioeè ut, ha origine da questo
segno, b , segnato in b
, segnato in b quadro naturale acuto,. Et il secondo, re, nasce da questo
segno, b
quadro naturale acuto,. Et il secondo, re, nasce da questo
segno, b , posto in aA acuto,. Et il terzo, detto mi, deriuva dal sopradetto segno dimostrato in G acuto, o grauve,. Ma il quarto, cioè fa, sta naturalmente nel suo luogo,. Et il
quinto, cioeè sol, nasce dal predetto segno, come qua, b
, posto in aA acuto,. Et il terzo, detto mi, deriuva dal sopradetto segno dimostrato in G acuto, o grauve,. Ma il quarto, cioè fa, sta naturalmente nel suo luogo,. Et il
quinto, cioeè sol, nasce dal predetto segno, come qua, b , messo in E la mi grauve,. Ma l'ul-timo, cioeè la, nasce dal b
, messo in E la mi grauve,. Ma l'ul-timo, cioeè la, nasce dal b rotondo posto in D sol, re,. Et per tal modo appare, che i no-mi officiali, equalmente considerati nel detto F, fa, ut, naturale, dependono da questo
segno, b
rotondo posto in D sol, re,. Et per tal modo appare, che i no-mi officiali, equalmente considerati nel detto F, fa, ut, naturale, dependono da questo
segno, b , eccetto, fa, ilquale nasce dal ordine primo.
, eccetto, fa, ilquale nasce dal ordine primo.
 , segnato in b
, segnato in b , mi acuto naturale. Et la terza, cioè mi, ha origine page 103dal predetto segno posto in aA, acuto,. Et la quarta, cioè fa, deriuva dal detto se-gno Ddiesi collocato in F, grauve,. Ma la quinta, cioè sol, sta naturale nel suo luogo,. Et
la sesta, cioè la, procede da questo segno, b
, mi acuto naturale. Et la terza, cioè mi, ha origine page 103dal predetto segno posto in aA, acuto,. Et la quarta, cioè fa, deriuva dal detto se-gno Ddiesi collocato in F, grauve,. Ma la quinta, cioè sol, sta naturale nel suo luogo,. Et
la sesta, cioè la, procede da questo segno, b , posto in E la mi naturale, & grauve.
, posto in E la mi naturale, & grauve.
 , segna-to in C, acuto. Et il secondo, cioè, re, sta naturalmente in tal luogo,. Il terzo, cioè mi,
deriuva da questo segno, b
, segna-to in C, acuto. Et il secondo, cioè, re, sta naturalmente in tal luogo,. Il terzo, cioè mi,
deriuva da questo segno, b , posto in b
, posto in b quadro acuto,. Il quarto, detto fa, nasce da
questo segno,
quadro acuto,. Il quarto, detto fa, nasce da
questo segno,  , collocato in G acuto,. Il quinto, cioè sol, depende dal segno sopradet-to posto in F, grauve,. La sesta sillaba, la, naturalmente sta nel detto luogo.
, collocato in G acuto,. Il quinto, cioè sol, depende dal segno sopradet-to posto in F, grauve,. La sesta sillaba, la, naturalmente sta nel detto luogo.
 , quadro acuto, ha conuvenenza con b
, quadro acuto, ha conuvenenza con b , quadro grauve, ouvero naturale. Pertanto la prima sillaba, ut, nasce da questo segno,
, quadro grauve, ouvero naturale. Pertanto la prima sillaba, ut, nasce da questo segno,  , posto
in D, acuto,. La seconda, cioè, re, nasce dal detto segno posto in C, acuto,. La terza,
detta mi, sta naturalmente in tal luogo,. La quarta, detta fa, ha origine dal detto se-gno Ddiesi segnato in aA acuto,. La quinta, detta sol, nasce dal detto segno dimostrato
in G acuto,. Ma la sesta, cioè la, nasce dal detto segno collocato in F grauve.
, posto
in D, acuto,. La seconda, cioè, re, nasce dal detto segno posto in C, acuto,. La terza,
detta mi, sta naturalmente in tal luogo,. La quarta, detta fa, ha origine dal detto se-gno Ddiesi segnato in aA acuto,. La quinta, detta sol, nasce dal detto segno dimostrato
in G acuto,. Ma la sesta, cioè la, nasce dal detto segno collocato in F grauve.
 ,
posto in E, acuto,. Il terzo, detto mi, ha origine della figura b
,
posto in E, acuto,. Il terzo, detto mi, ha origine della figura b dimostrato in D acuto,.
Il quarto, nomato fa, di sua natura dimora nel suo lugo [sic: luogo],. Il quinto, detto sol, deriuva da
la detta figura iesi [sic: delete] messo in b
dimostrato in D acuto,.
Il quarto, nomato fa, di sua natura dimora nel suo lugo [sic: luogo],. Il quinto, detto sol, deriuva da
la detta figura iesi [sic: delete] messo in b quadro acuto,. Il sesto & ultimo descende da que-sto segno, b
quadro acuto,. Il sesto & ultimo descende da que-sto segno, b , posto in aA, acuto.
, posto in aA, acuto.
 , posto in E la mi acuto,. Il quarto, detto fa, procede dal detto segno Ddiesi dimostrato in C, acuto,. Il quinto, cioè sol, deriuva dall'ordine naturale,. Ma l'ultimo, detto
la, ha principio da questo segno, b
, posto in E la mi acuto,. Il quarto, detto fa, procede dal detto segno Ddiesi dimostrato in C, acuto,. Il quinto, cioè sol, deriuva dall'ordine naturale,. Ma l'ultimo, detto
la, ha principio da questo segno, b , messo in b
, messo in b quadro acuto, & naturale.
quadro acuto, & naturale.
 segnato in G sopracuto. lLa seconda, cioè re, prouviene dal detto
segno posto in F, acuto,. La terza, detta mi, naturalmente appare,. La quarta, chia-mata fa, nasce dal detto segno Ddiesi dimostrato in D, acuto,. La quinta ha comin-ciamento dal detto segno Ddiesi messo in C, acuto,. La sesta, cioè la, resta naturalmente in tale positione.
segnato in G sopracuto. lLa seconda, cioè re, prouviene dal detto
segno posto in F, acuto,. La terza, detta mi, naturalmente appare,. La quarta, chia-mata fa, nasce dal detto segno Ddiesi dimostrato in D, acuto,. La quinta ha comin-ciamento dal detto segno Ddiesi messo in C, acuto,. La sesta, cioè la, resta naturalmente in tale positione.
 , segnato in b
, segnato in b quadro sopra acuto,. La seconda, detta re, deri-uva dal predetto segno posto in A, sopra acuto,. La terza, appellata mi, è prodotta anchora da questa figura o segno, b
quadro sopra acuto,. La seconda, detta re, deri-uva dal predetto segno posto in A, sopra acuto,. La terza, appellata mi, è prodotta anchora da questa figura o segno, b , messo in G, sopracuto,. La quarta, cioè fa, naturalmente si dimostra,. La quinta, nominata sol, depende da questo segno, b
, messo in G, sopracuto,. La quarta, cioè fa, naturalmente si dimostra,. La quinta, nominata sol, depende da questo segno, b , posto in E,
acuto,. La sesta, cioè la, procede da quello segno, b
, posto in E,
acuto,. La sesta, cioè la, procede da quello segno, b , segnato in D, acuto.
, segnato in D, acuto.
 , posto in b
, posto in b quadro sopracuto,. Et il terzo, nomato mi, depende dal segno inanzi detto segnato in aA,
sopracuto. Il quinto, detto fa, procede dal detto segno Ddiesi dimostrato in F, acuto,.
Ma il quinto, detto sol, sta naturalmente nel suo luogo,. Et l'ultimo, detto la, ha origi-ne da questo segno, b
quadro sopracuto,. Et il terzo, nomato mi, depende dal segno inanzi detto segnato in aA,
sopracuto. Il quinto, detto fa, procede dal detto segno Ddiesi dimostrato in F, acuto,.
Ma il quinto, detto sol, sta naturalmente nel suo luogo,. Et l'ultimo, detto la, ha origi-ne da questo segno, b , locato in E la mi acuto.
, locato in E la mi acuto.
 , posto in b
, posto in b , mi gra
e sopra acuto [sic: sopra acuto],. La quarta, detta fa, depende dal detto segno
, mi gra
e sopra acuto [sic: sopra acuto],. La quarta, detta fa, depende dal detto segno  posto in G, sopra acu-to,. La quinta, detta sol, ha principio dal detto segno collocato in F acuto,. La sesta,
detta la, naturalmente si comprende,. La decima settima corda, detta b
posto in G, sopra acu-to,. La quinta, detta sol, ha principio dal detto segno collocato in F acuto,. La sesta,
detta la, naturalmente si comprende,. La decima settima corda, detta b , mi grae so
pracuto [sic: sopracuto], puoò hauvere la sillaba ut, in suono equale, et ha depedenza dal detto segno se-gnato in D, sopra acuto,; & anchora puoò hauvere la sillaba re, laqual nasce dal pre-detto segno collocato in C, sopra acuto,. La terza, detta mi, sta naturalmete,. La quarta, detta fa, procede dal detto segno Ddiesi posto in A sopra acuto,. La quinta, detta sol,
ha origine dal segno sopra detto, dimostrato in G, sopra acuto,. La sesta, detta la, deriuva dal su detto segno messo in F acuto.
, mi grae so
pracuto [sic: sopracuto], puoò hauvere la sillaba ut, in suono equale, et ha depedenza dal detto segno se-gnato in D, sopra acuto,; & anchora puoò hauvere la sillaba re, laqual nasce dal pre-detto segno collocato in C, sopra acuto,. La terza, detta mi, sta naturalmete,. La quarta, detta fa, procede dal detto segno Ddiesi posto in A sopra acuto,. La quinta, detta sol,
ha origine dal segno sopra detto, dimostrato in G, sopra acuto,. La sesta, detta la, deriuva dal su detto segno messo in F acuto.
 , segnato in E sopra acuto. Et il suo mi, ha origine da questo segno, b
, segnato in E sopra acuto. Et il suo mi, ha origine da questo segno, b , posto
in D, sopra acuto,. La quarta sillaba, detta fa, sta naturalmente in tal luogo,. Et la
quinta, detta sol, nasce da questo segno, b
, posto
in D, sopra acuto,. La quarta sillaba, detta fa, sta naturalmente in tal luogo,. Et la
quinta, detta sol, nasce da questo segno, b , posto in B
, posto in B , mi, sopra acuto,. La sesta, detta
la, procede da questo segno, b
, mi, sopra acuto,. La sesta, detta
la, procede da questo segno, b , dimostrato in A, sopra acuto,.
, dimostrato in A, sopra acuto,.
 , posto in E, sopra acuto,. Et il fa, nasce dal detto segno Ddiesi dimostrato in C, sopra acuto, a seé propinquo,. Et il sol, naturalmente sta nel suo proprio
luogo,. Et la, ultima sillaba, nasce da questo segno, G [sic: delete], messo in B
, posto in E, sopra acuto,. Et il fa, nasce dal detto segno Ddiesi dimostrato in C, sopra acuto, a seé propinquo,. Et il sol, naturalmente sta nel suo proprio
luogo,. Et la, ultima sillaba, nasce da questo segno, G [sic: delete], messo in B mi sopra acuto.
mi sopra acuto.
 , dimostrato in C, sopra acuto. Ma la sesta, detta la,
naturalmente resta nel suo luogo. page 105
, dimostrato in C, sopra acuto. Ma la sesta, detta la,
naturalmente resta nel suo luogo. page 105Come in ciascun luogo della mano si possono trouvare 30, muta-tioni. Cap. XII.
 quadro segnata in G acuto con questo segno,
quadro segnata in G acuto con questo segno,  ,
nella cogionta di
,
nella cogionta di  quadro posto in F grauve con questo segno,
quadro posto in F grauve con questo segno,  ,. Appresso mutado re in ut, anchora si ascederaà, tenedo contrario ordine, & cosiì haremo due mutationi. Ma se da poi faremo mutatione di ut, in mi, essa ascenderaà, dalla predetta
congionta, segnata con il segno del Ddiesi in G acuto, nella proprietaà di natura
grauve, secondo l'ordine semplice,. Ma mutando mi, in ut, ascendendo si faraà il contrario, et per tal modo haremo 4, mutationi. Dapoi mutando ut, in fa, tal processo staraà
per discendere della sopradetta congionta di b
,. Appresso mutado re in ut, anchora si ascederaà, tenedo contrario ordine, & cosiì haremo due mutationi. Ma se da poi faremo mutatione di ut, in mi, essa ascenderaà, dalla predetta
congionta, segnata con il segno del Ddiesi in G acuto, nella proprietaà di natura
grauve, secondo l'ordine semplice,. Ma mutando mi, in ut, ascendendo si faraà il contrario, et per tal modo haremo 4, mutationi. Dapoi mutando ut, in fa, tal processo staraà
per discendere della sopradetta congionta di b duro messo in G acuto, nella congionta similmente di b
duro messo in G acuto, nella congionta similmente di b duro, dimostrata con il detto segno Ddiesi in D, grauve,; & mu-tando fa, in ut, saranno 6, mutationi,. Ma ouve auvenga, che sia mutato ut, in sol, tal mutatione staraà per discendere dal detto segno del Ddiesi, posto in G acuto, nella con-gionta di b
duro, dimostrata con il detto segno Ddiesi in D, grauve,; & mu-tando fa, in ut, saranno 6, mutationi,. Ma ouve auvenga, che sia mutato ut, in sol, tal mutatione staraà per discendere dal detto segno del Ddiesi, posto in G acuto, nella con-gionta di b , duro segnata in C, fa, ut, col detto segno, & mutando sol, in ut, per contrario, haremo 10, mutationi. Oltra di cioò, cangiando re, nel mi, tal mutatione staraà per
ascendere dalla congionta del Ddiesi accidentale, segnato come qui,
, duro segnata in C, fa, ut, col detto segno, & mutando sol, in ut, per contrario, haremo 10, mutationi. Oltra di cioò, cangiando re, nel mi, tal mutatione staraà per
ascendere dalla congionta del Ddiesi accidentale, segnato come qui,  , in F, gra-uve, nella naturale proprietaà detta natura grauve. Et essendo mutato mi, nel re, etiandio in contrario si ascenderaà, & in questa guisa saranno, 12, muiationi [sic: mutationi]. Ma mutando il re, nel fa, tal mutatione saraà per discendere dal sopra detto segno posto in F,
grauve, nella congionta del b
, in F, gra-uve, nella naturale proprietaà detta natura grauve. Et essendo mutato mi, nel re, etiandio in contrario si ascenderaà, & in questa guisa saranno, 12, muiationi [sic: mutationi]. Ma mutando il re, nel fa, tal mutatione saraà per discendere dal sopra detto segno posto in F,
grauve, nella congionta del b quadro segnata con questa figura,
quadro segnata con questa figura,  , in D, sol, re. Et fa-cendo mutatione di fa, in re, auverraà il contrario, & per tal maniera saranno, 14.
Ma se conuvertiremo, la sillaba re, nella sillaba sol, tal mutatione staraà per discen-dere dal su detto segno, come qui,
, in D, sol, re. Et fa-cendo mutatione di fa, in re, auverraà il contrario, & per tal maniera saranno, 14.
Ma se conuvertiremo, la sillaba re, nella sillaba sol, tal mutatione staraà per discen-dere dal su detto segno, come qui,  , posto in F grauve, nella congionta di
, posto in F grauve, nella congionta di  duro, segnata col medesimo segno in C, fa, ut. Et per il contrario, cangiando sol,in re, sa-ranno. 16. mutationi,. Quindi mutando re, in la, tale mutatione saraà per discende-re dal predetto segno del Ddiesi posto in F, grauve, nella natural propietaà di
duro, segnata col medesimo segno in C, fa, ut. Et per il contrario, cangiando sol,in re, sa-ranno. 16. mutationi,. Quindi mutando re, in la, tale mutatione saraà per discende-re dal predetto segno del Ddiesi posto in F, grauve, nella natural propietaà di  qua-dro grauve,; Eet cangiando la, nel re, seguiteraà il contrario. Et per tal uvia saranno
18. mutationi. Appresso conuvertendo mi, in fa, tal mutatione saraà per discendere page 106della propietaà di natura grauve nella congionta, come qui,
qua-dro grauve,; Eet cangiando la, nel re, seguiteraà il contrario. Et per tal uvia saranno
18. mutationi. Appresso conuvertendo mi, in fa, tal mutatione saraà per discendere page 106della propietaà di natura grauve nella congionta, come qui,  , segnata in D, sol, re, naturale. Et facendo mutatione di fa, in mi, nasceraà il contrario, per laqual cosa sa-ranno 20. mutationi. Ma mutando mi, nel sol, tale ordine saraà per discendere della
predetta proprietaà naturale nella congionta, del b
, segnata in D, sol, re, naturale. Et facendo mutatione di fa, in mi, nasceraà il contrario, per laqual cosa sa-ranno 20. mutationi. Ma mutando mi, nel sol, tale ordine saraà per discendere della
predetta proprietaà naturale nella congionta, del b quadro, come disopra, in C, gra-uve. Et cangiando sol, in mi, seguiteraà il contrario, & alhora haremo 22. mutationi.
Dapoi trasmutando mi, in la, & la, in mi., Ttale ordine staraà per discendere, & per
ascendere di natura nel
quadro, come disopra, in C, gra-uve. Et cangiando sol, in mi, seguiteraà il contrario, & alhora haremo 22. mutationi.
Dapoi trasmutando mi, in la, & la, in mi., Ttale ordine staraà per discendere, & per
ascendere di natura nel  duro, & da b
duro, & da b duro in natura secondo l'ordine naturale,
e cosiì sarano 24, mutationi. Oltra di cioò, mutando il fa, nel sol, tal mutatione saraà
per discendere dalla congionta del b
duro in natura secondo l'ordine naturale,
e cosiì sarano 24, mutationi. Oltra di cioò, mutando il fa, nel sol, tal mutatione saraà
per discendere dalla congionta del b quadro, segnata con questo segno,
quadro, segnata con questo segno,  , in D sol, re,
nella congionta similmente di b
, in D sol, re,
nella congionta similmente di b quadro col detto segno posto in C, fa, ut,. Ma can-giando sol, in fa, staraà per discendere, ma intorno l'origine nasceraà il contrario, et
alhora haremo 26. mutationi,. uVolgendo fa, in la, si faraà varietaà di questo segno,
quadro col detto segno posto in C, fa, ut,. Ma can-giando sol, in fa, staraà per discendere, ma intorno l'origine nasceraà il contrario, et
alhora haremo 26. mutationi,. uVolgendo fa, in la, si faraà varietaà di questo segno,  ,
segnato nel predetto D, discendendo nella natural proprietaà di b
,
segnato nel predetto D, discendendo nella natural proprietaà di b quadro grauve,. Et
facendo mutatione di la, in fa, discendendo, nasceraà il contrario,. Et per tal ragione
haremo 28. mutationi. Ma se ultimamente il sol, saraà mutato nel la, tal uvarietaà nasceraà per discendere di questo segno,
quadro grauve,. Et
facendo mutatione di la, in fa, discendendo, nasceraà il contrario,. Et per tal ragione
haremo 28. mutationi. Ma se ultimamente il sol, saraà mutato nel la, tal uvarietaà nasceraà per discendere di questo segno,  , segnato in C, grauve, nella natural proprietaà
di b
, segnato in C, grauve, nella natural proprietaà
di b quadro grauve. Et cangiando la, in sol, etiandio discendendo, si haraà il contra-rio, & alhora saranno 30. mutationi chiare, & con ragioni dimostrate, alle quali
per piuù chiarezza, & comodo di tutti habbiamo dato principio in E, la, mi, & non
in altra positione piuù grauve, acciocheé non fosse stato dibisogno ricorrere alle posi-tioni finte ouvero acquisite, & poste sotto Gamma ut.
quadro grauve. Et cangiando la, in sol, etiandio discendendo, si haraà il contra-rio, & alhora saranno 30. mutationi chiare, & con ragioni dimostrate, alle quali
per piuù chiarezza, & comodo di tutti habbiamo dato principio in E, la, mi, & non
in altra positione piuù grauve, acciocheé non fosse stato dibisogno ricorrere alle posi-tioni finte ouvero acquisite, & poste sotto Gamma ut.