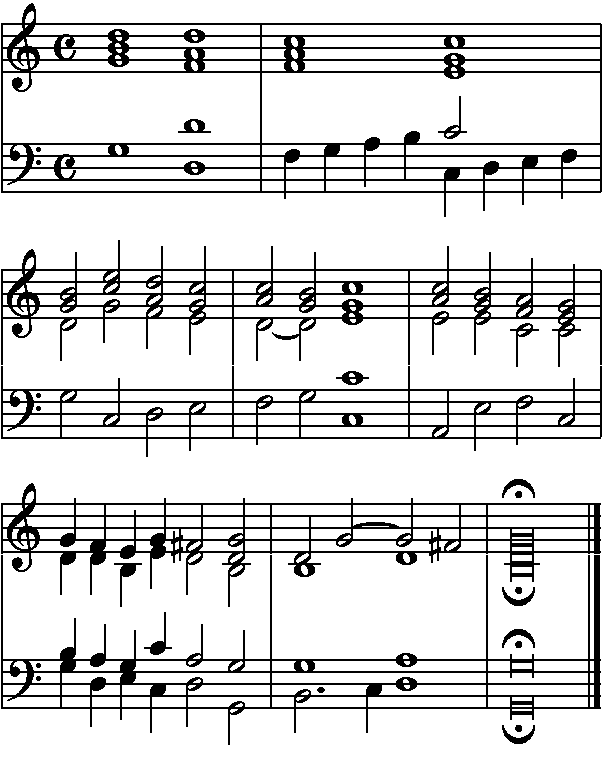Per osseruar l'ordine, e la breuità, che si richiede in tutte le cose
da trattarsi, hauendo noi al presente à fauellare di Stromenti Musi-cali, bisogna primamente far di loro diuisione secondo il nostro sog-getto, e proposta materia. Per tanto diuideremo essi stromenti in du-oi ordini; cioe in alcuni, come fondamento; et in altri, come ornamento.
Come fondamento sono quei, che guidano, e sostengono tutto il corpo
delle voci, e stromenti di detto Concerto; quali sono, Organo, Grauicem-balo &c. e similmente in occasion di poche, e sole voci, Leuto, Tiorba, Ar-pa &c. Come ornamento sono quelli, che scherzando, e contrapontegian-do, rendono più aggradeuole, e sonora l'armonia; cioe Leuto, Tiorba, Ar-pa, Lirone, Cetera, Spinetto, Chitarrina, Violino, Pandora, et altri simili.
Di più gli stromenti, altri sono di corde, altri di fiato. Di questi secondi
(eccettuando l'Organo) non diremo cosa alcuna, per non esser in vso
ne' buoni e dolci conserti, per la poca vnione con quei di corde, e per l'al
-terazione, cagionata loro dal fiato vmano, se ben'in concerti strepitosi,
e grandi si meschiano: e tal volta il trombone in picciol conserto, s'ado
-pera per contrabasso, quando sono organetti all'ottaua alti: ma che sia ben
suonato, e dolce: e questo si dice in vniuersale, perche nel particolare pos
-son esser tali stromenti suonati con tal'eccellenza da maestreuol mano,
che sia per acconciar'il conserto, et abbellirlo.
page 4Medesimamente li stromenti di corde, alcuni contengono in loro perfetta ar
-monia di parti, quale è l'Organo, Grauicembalo, Leuto, Arpadoppia &c: alcu
-ni l'hanno imperfetta, quale è Cetera ordinaria, Lirone, Chitarrina; et altri
poca, ò niente, come Viola, Violino, Pandora etc. Noi per tanto trattare
-mo primamente di quei del
p.o ordine, che sono fondamento, et hanno perfetta
armonia, e nel
2.do luogo diremo di quei, che seruono per ornamento.
Fatta dunque tal diuisione, e distesi i sopradetti principij, veniamo all'inse
-gnamento di suonar sopra 'l Basso. Dico dunque che chi vuole suonar bene,
gli conuien posseder tre cose: prima saper contraponto, ò per lo meno can
-tar sicuro, ed intender le proporzioni, e tempi, e legger per tutte le chiaui,
saper risoluer le cattiue con le buone, conoscer
3. e
6. maggiori, e minori,
et altre simiglanti cose. Seconda deue saper suonar bene il suo stromento, in
-tendendo l'intauolatura, ò spartitura, et hauer molta prattica nella tastatu
-ra, ò manico del medesimo, per non star'à mendicar le consonanze, e cercar le
botte, mentre si canta, sapendo che l'occhio è occupato in guardar le parti po
-steli dauanti. Terza deue hauer buon orecchio, per sentir lo mouimento, che
fanno le parti infra di loro; del che non ne ragiono, per n
on poter'io col mio
discorso farglielo buono, hauendolo cattiuo dalla natura.
Ma per venir'all'atto, conchiudo che non si può dar determinata regola
di suonar l'opere, doue non sono segni alcuni, conciosia che bisogna obedir
la mente del componitore, quale è libera; e può, à suo arbitrio, sopra vna nota,
nella prima parte de essa metter
5.a ò
6.a e per il contrario: e quella maggiore, ò
minore, secondo gli par più à proposito, ouero che sia necessitato à questo
dalle parole. E se bene qualche scrittore, che tratta di contraponto, habbia
diffinito l'ordine di proceder da vna consonanza all'altra, quasi che altri
-menti non si possi fare, ne stia bene; mi perdonerà questo tale, perche mostra
page 5di non hauer inteso, che le consonanze, e tutta l'armonia, sono soggette, e
sottoposte alle parole, e non per il contrario: e questo lo diffenderemo c
on
tutte le ragioni all'occasione. E ben vero, che semplicemente, e per lo più po
-trebbesi dar certa regola di caminare, ma doue sono parole, bisogna vestir
-le di quell'armonia conueneuole, che faccia, ò dimostri quell'affetto.
Non potendosi dar regola ferma, bisogna necessariamente à chi suona, va
-lersi dell'orecchio, e secondar l'opera, e suoi mouimenti: ma, volendo trouar
modo facile di fuggir questi intoppi, e suonar l'opera giusta, vsarete questo;
cioè, sopra le note del basso segnarete co i numeri, quelle consonanze, ò dis
-sonanze, che vi sono applicate dal componitore; come se nella prima parte
della nota vi è
5.a ouer
6.a per il contrario,
4.a e poi
3.a come per essempio.
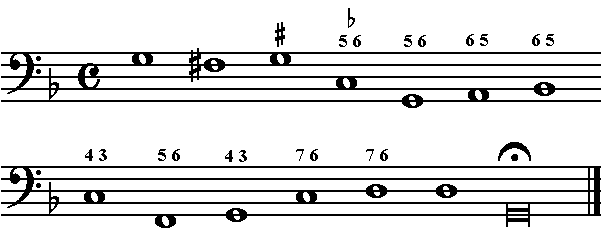
Douete in oltre sapere, che tutte le consonanze, ò sono naturali di
quel tuono, ò sono accidentali; quando son naturali, non si fa segno al
-cuno; come per bequadro la terza sopra Gsolreut, che è befabemi, viene
terza maggiore naturalmente: ma volendola far minore, bisogna sopra
la nota del Gesolreut farci il Bemolle; et allora è minore accid
ental
-mente. E cosi all'incontro, se si canta per Bemolle, volendola far mag
-giore, conuien segnarci il Diesis sopra; e cosi dico delle seste, auuer
-tendo, che il segno, che è sotto, ò vicino alla nota, s'intende di quella
stessa nota; ma quello, che è sopra, s'intende della consonanza, che gli
s'ha à dare, come nell'essempio.
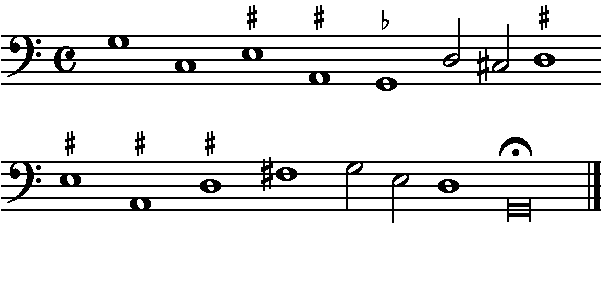 page 6
page 6Tutte l'accadenze, ò mezzane, ò finali, voglion la terza maggiore, e
però alcuni non le segnano; ma per maggior sicurezza, conseglio à
farui il segno, massime nelle mezzane.
Essendo dunque gli stromenti diuisi in due classi: quindi nasce, che han-no diuerso vfficio, e diuersamente s'adoperano: percioche, quando si
suona stromento, che serue per fondamento, si deue suonare con mol-to giudizio, hauendo la mira al corpo delle voci; perche se sono molte,
conuien suonar pieno, e raddoppiar registri; ma se sono poche, schemar-li, e metter poche consonanze, suonando l'opera più pura, e giusta, che
sia possibile, non passeggiando, ò rompendo molto; ma si bene aiutando-la con qualche contrabasso, e fuggendo spesso le voci acute, perche oc-cupano le voci, massime i soprani, ò falsetti: doue è da auuertire di fuggi-re per quanto si puole, quel medesimo tasto, che il soprano canta: ne dimi-nuirlo con tirata, per non far quella raddoppiezza, et offoscar la bontà
di detta voce, ò il passaggio, che il buon cantante ci fa sopra; però è buo-no suonar assai stretto, e graue.
Il simile dico del Leuto, Arpa, Tiorba, Arpicordo, etc. quando seruo-no per fondamento, cantandoui vna, ò più voci sopra; perche in tal caso
deuon tener l'armonia ferma, sonora, e continouata, per sostener la vo-ce, toccando hora piano, hora forte, secondo la qualità, e quantità delle
voci, del luogo, e dell'opera, non ribattendo troppo le corde, mentre la vo-ce fa il passaggio, e qualche affetto, per non interromperla.
Volendo finalemente insegnar à suonar sopra l' Basso (non semplicem
ente
à suonar, perche deue prima sapere) presopponiamo molti principi, e ter
-mini; come è l'andar dall'imperfetta, alla perfetta, con la più vicina; sico
-me per lo più è vero, che l'accadenze voglion terze maggiori; le risolu
-page 7tioni delle cattiue, con le buone più vicine; come la settima dalla sesta,
la quarta dalla terza: quando la parte, che risolue, vien sopra; ma se
vien sotto, al contrario; per tanto non ne discorreremo alla lunga; e chi
non le sa, l'impari; non insegnaremo al presente il portar la mano nell'or
-gano.
In molte maniere camina il Basso, cioè ò continouato, ò per salto, ò con
tirata continouata, ò con nere disgionte, se va continouato all'insù, si de
-ue con la mano disopra venir all'in giù, ò continouatamente, ò con sal
-to; et così per il contrario, se la mano di sotto saglie, ò scende, per salto di
terza, di quarta, ò di quinta: allora con la mano di sopra douete proce
-der continouatamente; perche non è bene salire, ò scender insieme, che è
brutto vedere, e sentire; e non vi è varietà alcuna, anzi sarebbon tutte
ottaue, e quinte: se il basso va all
' in sù con tirata, la man sopra sta fer
-ma; se per nere disciolte, si deue dare à ogni nota la sua accompagna
-tura. Ecco l'essempio del tutto.
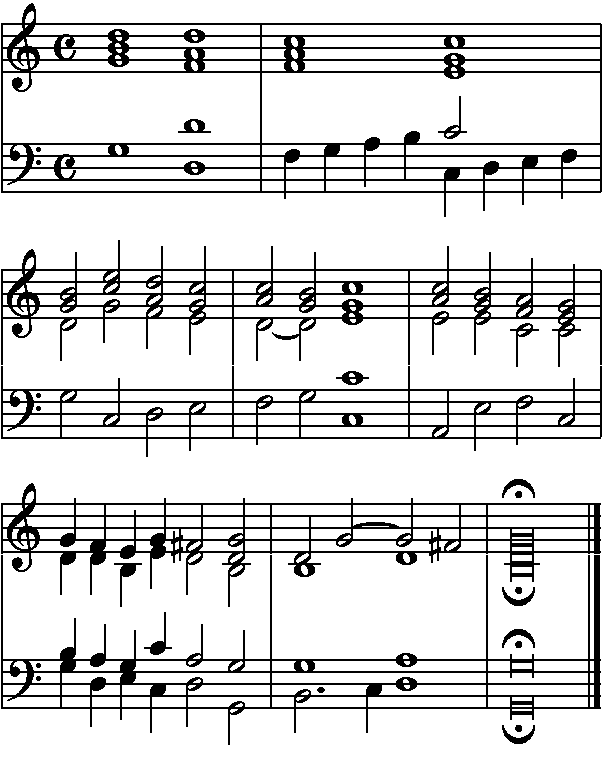
Hauendo fin qui detto à bastanza delli stromenti, come fondam
ento,
tanto però che l'huomo giudizioso potrà con questo picciol raggio aq
-quistarsi molto lume; perche il dir troppo genera confusione; diremo ho
-ra breuemente qual cosa delli stromenti d'ornamento.
page 8Li stromenti, che si meschiano con le voci variatamente, no per al
-tro, credo io, che per ornar, et abbellir, anzi condire detto conserto, si me
-schiano: et allora conuien in altra maniera adoperarli dal primo; per
-cioche, come prima teneuano il tenore, e l'armonia ferma, hora deueno
con varietà di bei contraponti, secondo la qualità dello stromento fiori
-re, e render vaga la melodia. Ma in questo è differente l'vno dell'al
-tro; perche il primo hauendo à suonar il basso postoli auanti, come sta;
non ricerca, che l'huomo habbi gran scienza di contraponto: ma il se
-condo lo ricerca; poiche deue sopra il medesimo basso compor nuoue parti
sopra, e nuoui, e variati passaggi, e contraponti. Onde chi suona leuto,
essendo stromento nobilissimo fra gl'altri, deue nobilmente suonarlo con
molta inuentione, e diuersità; non come fanno alcuni, i quali per hauer
buona dispostezza di mano, non fanno altro che tirare, e diminuire dal
principio al fine, e massime in compagnia d'altri stromenti, che fanno il
simile, doue non si sente altro che zuppa, e confusione, cosa dispiaceuole, et
ingrata, à chi ascolta. Deuesi dunque, hora con botte, e ripercosse dolci;
hor con passaggio largo, et hora stretto, e raddoppiate, poi c
on qualche sbor
-donata, con belle gare e perfidie, repetendo, e cauando le medesime fuge in
diuerse corde, e luoghi; in somma con lunghi gruppi e trilli, et accenti à suo
tempo, intrecciare le voci, che dia vaghezza al conserto, e gusto, e diletto
all'vditori: guardando con giudizio di non offendersi l'vn l'altro; ma
dandosi tempo, massime quando sono stromenti simili; il che per mio con
-seglio deue fuggirsi; se però non vi fusse gran lontananza, ouero fussero
accordati in diuersi toni, e diuerse grandezze. E quello che dichiamo
del leuto, come di strom
ento principale, vogliamo che s'int
enda de gl'altri nel
suo genere, perche lungo sarebbe à ragionar di tutti nel particolare.
page 9Ma per hauer ogni stromento suoi termini propri di quello, pe
-rò deue, chi suona, valersi di quei stessi, e reggersi conforme quelli,
per far buon lauoro. Verbi grazia; li stromenti d'arco hanno diuer
-sa maniera da gl'altri di penna, ò deta: perciò chi suona lirone, de
-ue tirare l'arcate lunge, chiare, e sonore, cauando bene le parti di
mezzo, auuertendo alle terze, e seste maggiori, e minori; cosa difficil, ed
importante di quello stromento. Il violino richiede bei passaggi, distin
-ti, e lunghi, scherzi, rispostine, e fughette replicate in più luoghi, affet
-tuosi accenti, arcate mute, gruppi, trilli &c. Il Violone come parte
graue procede grauemente, sostenendo con la sua dolce risonanza l'
armonia dell'altre parti, trattenendosi più che si può, nelle corde
grosse, toccando spesso i contrabassi. La Tiorba poi, co le sue piene, e
dolci consonanze, accresce molto la melodia, ripercuotendo, e passeggi
an-do leggiadramente i suoi bordoni, particolar eccellenza di quello stro
-mento, con trilli, et accenti muti, atti con la mano di sotto. L'Arpa dop
-pia, qual è stromento, che val per tutto, tanto ne soprani, come ne bas
-si, deuesi tutta ricercare, con dolci pizzicate, con risposte d'ambi le
mani, con trilli, &c, in somma vuol buon contraponta. La Cetera, ò sia
ordinaria, ò Ceterone, deue vsarsi come l'altri stromenti scherzando,
e contraponteggiando sopra la parte. Ma ogni cosa si deue vsar
con prudenza; perche se li stromenti sono soli in conserto, deuono far
il tutto, e condir il conserto; se sono in compagnia, bisogna hauersi ri
-guardo l'vn l'altro, dandosi campo, e non offendendosi; e se sono molti,
aspettar ogn'vno il suo tempo; e non far come il passeraio, tutti in
vn tempo, et à chi può più gridare. E questo poco sia detto solo per
dar alquanto di lume, à chi desidera imparare; perche chi sá da per
page 10se, non ha bisogno d'insegnamento d'alcuno, e per tali io non scri
-uo; poiche gli stimo, et honoro; ma se qualche bell'humore, come acca
-de, desidera discorrer più oltre in simigliante materia, sarò sempre
pronto.
Finalmente conuiene saper anco trasportare le Cantilene da vn
tasto ad vn'altro, quando però vi sono tutte le consonanze naturali, e
proprie di quel tono; perche altrimenti non si debbon trasportare,
perche fa brutissimo sentire, come io alle volte ho osseruato, che tra-sportando vn primo, ouer secondo tono, che sono di natura soaue,
per le molte corde di B. molle, in qualche tasto, ch 'l suo tuono sia di
B. quadro, difficilmente potrà, chi suona, esser tanto cauto, che non in-ciampi in qualche contraria voce; e così vien à guastarsi il con-serto, et offender l'vdito de gl'ascoltanti con tal crudezza; anzi mai
mostra la naturalezza di quel tuono. Trasportar alla quarta, ò quin-ta, è più naturale, e commodo di tutti: e tal volta vna voce più giù,
ò più sù; ed in somma conuien veder quel più proprio e conferen-te à quel tuono: e non come fanno alcuni, che pretendono suonar
ogni tuono in ogni corda; perche s'io potessi disputar alla lunga,
gli mostrarei l'impropietà, ed error loro.
Hauendo io sin'hora trattato di suonar sopra 'l Basso, mi è pa
-ruto bene dir qual cosa intorno à esso, poiche só, che vien biasimato
da qualchuno, quale ò non intende il suo fine, ò non gli basta l'ani
-mo sonarlo. Per tre cagioni dunque è stato messo in vso questo mo
-do: prima per lo stile moderno di cantar recitatiuo, e comporre:
seconda per la commodità: terza per la quantità, e varietà d'ope
-re, che sono necessarie al conserto.
page 11Della prima dico, che essendosi vltimamente trouato il vero sti
-le d'esprimere le parole, imitando lo stesso ragionare nel meglior
modo possibile; il che meglio succede, con vna, ò poche voci, come
sono l'arie moderne d'alcuni valenthuomini, e come al presen
-te s'vsa assai in Roma ne' conserti; non è necessario far sparti
-tura, ò intauolatura; ma basta vn Basso con i suoi segni, come
habbiamo detto sopra. Ma se alcuno mi dicesse, che à suonar l'ope
-re antiche piene di fughe, e contrapunti, non è basteuole il basso;
à ciò rispondo, non esser in vso più simil cantilene, per la confu
-sione, e zuppa delle parole, che dalle fughe lunghe ed intrecciate
nascono; ed anco perche non hanno vaghezza: poiche cant
andosi
à tutte le voci, non si sente ne periodo, ne senso; essendo per le fu
-ghe interrotto, e sopraposto; anzi nel medesimo tempo ogni voce
canta parole differenti dall'altro; il che à gl'huomini intendenti, e giu
-diciosi dispiacere poco mancò, che per questa cagione n
on fosse sban
-dita la Musica da S. Chiesa, da vn Sommo Pontefice, se da Giouan
Palestrino non fosse stato preso riparo, mostrando d'esser vitio,
ed errore de' componitori, e non della Musica; e à confermatio
-ne di questo fece la Messa intitolata:
MISSA PAPAE MAR-CELLI. Onde se bene per regola di contraponto sono buone ta
-li compositioni; nondimeno per regola di vera e buona musica
sono vitiose; il che nacque per non intender il fine, et vfficio, e
buoni precetti di essa: volendo questi tali star solo nell'osseru
an-za della fuga, ed imitatione delle note, e non dell'affetto, e somi
-glianza delle parole: anzi molti faceuano prima la musica, e poi
ci appiccauano le parole; e ciò basti per hora, non essendo à pro
-page 12posito in questo luogo il discorrer alla lunga di tal materia.
La seconda cagione è la commodità grande; perche con pic-ciola fatica hauete molto capitale per le occorrenze, oltre che
chi desidera imparare à sonare, e sciolto dalla intauolatura, co-sa à molti difficile e noiosa; anzi molto soggetta à gl'errori per-che l'occhio, e la mente è tutta occupata in guardar tante parti
massime venendo occasione di consertar all'improuiso.
La terza finalmente, che è la quantità dell'opere necessarie al
conserto, mi pare sola basteuole ad introdurre simil commodità
di sonare: poiche se si hauessero ad intauolare, ò spartire tutte l'
opere, che si cantano fra l'anno in vna sola Chiesa di Roma; do-ue si fa professione di consertare, bisognarebbe all'Organista che
hauesse maggior libraria, che qual si voglia Dottor di legge: onde
à molta ragione si è introdotto simil basso, col modo però sopra-detto; conchiudendo non esser bisogno, ne necessario à chi suona, far
sentir le parti come stanno, mentre si suona per cantaruisi, e non
per sonar l'opera come sta, che è diuersa cosa dal nostro soggetto.
E questo che si è detto, basti per lo molto, che si potrebbe dire;
volendo io breuemente sodisfar più alle vostre cortese dimande;
come più volte mi hauete fatto instanza, che al mio genio, quale è
più d'imparar da gl'altri, che d'insegnare. Accettatelo dunque
come egli è, e scusatemi per la breuità del tempo.
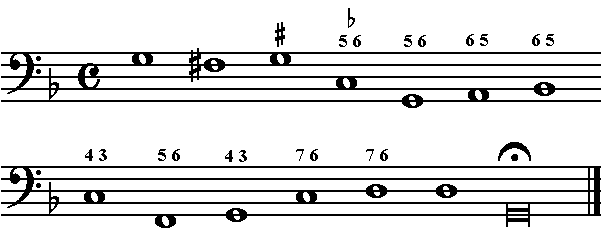
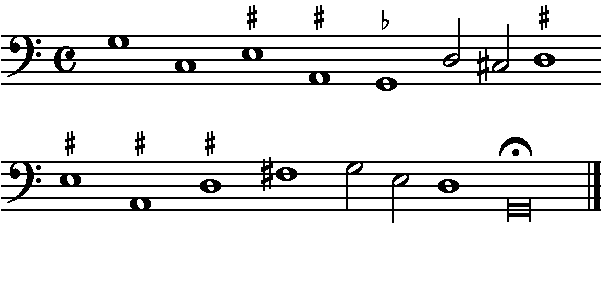 page 6
page 6