Title: Dialogo di musica
Author: Pietro Pontio
Publication: Erasmo Viotti (Parma, 1595)
Principal editors: Frans Wiering; Russell E. Murray, Jr.
Funder: Utrecht University Netherlands Organization for Scientific Research (NWO)
Edition: 2001
Department of Information and Computing Sciences Utrecht University P.O. Box 80.089 3508 TB Utrecht NetherlandsALL'ILLVSTRISSIMI SIG.RI ACADEMICI FILARMONICI DI VERONA.
Signori miei colendissimi.
Di Parma il 15. Agosto 1595.
Delle SS. VV. Illustriss. Affettionatiss. Seruitore Pietro Pontio.
Sonetto d'Antonio Maria Prati.
A I SIGNORI ACADEMICI Filarmonici di Verona.
FAmosi CIGNI; il cui celeste canto
Le fere alletta, e gli elementi intorno;
E doue nasce, e doue more il giorno,
Et altrui porge inuidia, e toglie il vanto.
Se ogni altra voce pàr di roco pianto,
E cede à l'Harmonia, c'hà in voi soggiorno.
Come cede à Real di gemme adorno,
Di Bifolco, ò Pastor, pouero manto;
E se di quella sete ampio Occeàno,
Giust'è, che 'l PONTIO entro à cerulei campi
V'offra gli accenti suoi: canoro pesce;
O pur, qual Rè de' fiumi, in viso humano,
Porga il tributo de l'humor, che gli esce
Dal crine ogn'hor, con gloriosi lampi.
Sonetto dell'istesso Prati.
AL REVEREN. SIGNOR DON PIETRO PONTII.
COME tal'hor Nocchier, che dianzi à i venti
Fidò spesso le vele, e i legni à l'onde;
E del mar periglioso ambe le sponde
Varcò fra mille rischi, e mille stenti,
L'arte sua spiega à peregrini intenti:
Oue l'acque sian meno, ò più profonde:
Gli scogli, e l'aure auuerse, e le seconde,
Et i lumi del Ciel fidi, e lucenti.
Cosi Tù, che sin'hor, con nome altero,
Di MVSICA in solcando i vasti flutti,
Spendesti gli anni, & imbiancasti il crine:
Vago di posa homai, sotto non vero
Sembiante, insegni altrui di quella i frutti,
E gli honori, e i perigli, e le dottrine.
DIALOGO DI MVSICA INTERLOCVTORI Gli Ilustriss. Signori. Il Sig. Conte Giordano Sarego. Il Sig. Conte Marco Verità. Il Sig. Conte Alessandro Beuilaqua. Prima parte.
Dictus & Amphion Thebanae conditor arcis Saxa mouere sono testudinis, & prece blanda Ducere, quò vellet.
Ch'Empedocle co 'l suono estinse l'ira d'vn Giouane Tauromitano: che co 'l canto Damone Pithagorico temprò la dishonesta vita d'alcuni Gio-uani inuolti nel vitio della Lussuria. Tefasue per placar le passioni dell'a-nimo commandaua che si suonasse la piua; il che faceua ancora Theofraste. Senocrate con la Musica liberaua gli spiritati, si legge parimenti nel primo libro delli Rè al decimo sesto Capitolo, che Dauide acquetaua lo spirito maligno di Saulle con la Musica. E' scritto di Peone Medico, che sanò con questa vn'infermo di salute disperata. Aulo Gelio nel libro quarto nel capitolo decimo terzo dice, che la Musica acqueta il dolore della Sciatica. Si scrive di Terpandro Lesbio, che con questa più volte placò gli Spattani riuolti alle discordie, & alle seditioni. Di Talete Candiotto si legge, che co 'l suonar della cetra scacciò la pestilenza da Mesina. Si vede pur anche hoggidì, che il suono risana i feriti del morso della Tarantola. Di più si truoua, che Asclepiade molte voltè [sic: volte] sopì con la Musica la discordia nata nel popolo, e co 'l suono della tromba rese l'vdito à sordi, co 'l qual suono si vede pur anco à giorni nostri andar gli huomini à fiere battaglie, & iui far proue di se stessi, del che ci fà fede il gran Basilio nel-l'Homilia quinquagesima quarta, oue dice, che Timoteo incitaua Ales-sandro à prender l'armi; E perciò conoscendo il Rè della Lidia Haliatte la forza di questa Musica, volse i suonatori nel suo essercito contro i Mi-lesij, come racconta Herodoto nel principio del primo libro: e tali suona-tori parimente voleuano i Lacedemoni ne' suoi esserciti, come testifica page 5Aulo Gelio nel primo libro, nel capitolo vndecimo. Cosi ancora quelli dì [sic: di] Creta volsero i suonatori, come si vede in Ateheneo [sic: Atheneo] nel libro decimo quarto al capitolo vndecimo. Similmente si legge nella Profetia terza di Daniele, che 'l Rè Nabucdonosor volle, che, mentre il popolo adoraua la sua statua, vi fosse d'ogni sorte d'istromenti Musicali. I Romani ancora sì nell'allegrezze, come ne i funerali oprauano la Musica. Il qual costume è seguito sin'a giorni nostri, posciache nelli conuiti, e nelli funerali pari-mente si vsa questa Musica, la quale è di accrescimento, d'allegrezza, e di gioia in quelli; e di alleggiamento del dolore, e della noia in questi. Nelle Chiese non si cessa mai di lodare Iddio con hinni, e salmi fatti in Musica. Nel sesto capo del secondo libro de' Rè si troua scritto, che Dauide ord-inò, che fosse la Musica all'Arca foederis. Ma che dirò del Cielo, oue habitano i Santi? frà di loro pur'anco stassi la Musica; poiche continuamente cantano auanti Iddio, come gli vintiquattro vecchi co 'l suono di cetra, e con la voce il lodano. Ilche si può vedere nel capitolo quinto, & decimo quarto delle reuelationi di San Gioanni. Siche questa Musica hà parte in tutte le attioni. Si vede, che gli huomini mal conditionati dall'infirmità, all'vdir della Musica, si alleggeriscono alquanto dal dolore. Si legge di più nel libro quarto delli Rè al capitolo terzo, ch'Eliseo Profeta non vol-se predire à Giosafatto Rè di Giuda quel, ch'ei douesse fare, perche l'es-sercito non perisse di sete, se prima non gli fù condotto vn Musico, che cantasse: per il qual canto fù dallo Spirito Diuino ispirato, e predisse il tutto. Similmente è scritto, che alcuni huomini Religiosi stauano sopra vn Monticello, oue non cessauano giorno, e notte con soaui cantilene, & istromenti Musicali di lodare il sommo Iddio, donde diuentarono profe-ti. Se leggerete il capitolo ottauo del nono libro di Plinio, trouarete, che i Delfini hanno gran diletto dal sentir la Musica. Talche alcuni dissero, che volendo i marinari dar la morte ad Arione, esso gli pregò, che prima lo lasciassero suonar la Cetra. Del che compiacciutosi, sentendo i Delfini tal'harmonia, & approssimandosi alla naue, egli gettossi nel mare, e per questa sua Musica fù portato à saluamento alla riua, e liberato dalla morte da vn di quei Delfini. Racconta Franchino nel Capitolo primo della sua Theorica nel primo libro, che i Cerui sono presi co 'l suono della Fi-stola. Et, che i Cigni siano guidati, ouunque si vuole, co 'l canto, l'attesta Martiano Capella nel libro nono, oue ragione della Musica. Vedemo si-milmente, che gli Augelli vengono nella rete per il suono, e restano dalli vccellatori presi, e morti. Perciò disse Plutarco nel principio del proemio della sua Musica simili parole. Neminem autem puto tam stupidum, tam plumbeum, qui cantu non moueatur. Disse anche Macrobio nel libro secondo de Somno Scipionis nel terzo capitolo, che la Musica è dominatrice page 6d'ogni cosa viuente cosi fra gli animali, come fra gli huomini. Più oltre vi dirò, che non può essere buono, e perfetto l'Architetto, che sia priuo della scienza Musicale, per le machine, & diuisioni de' Teatri. Ne può il Medico esser parimente perfetto della Medicina, se non hà cognitione della Musica, per la depositione, & eleuatione del polso, che in quella rapresenta la misura; poiche col mezzo di quello fù ritrouata, & da esso ci vien dimostrata la sanità, e la infirmità del corpo. Che dirò dell'Astrologo? certò egli non può hauere perfetta cognitione delle sfere, & orbi celesti, se non possede la Musica, già ehe [sic: che] in esse sfere, come alcuni vogliono, si troua posta la Musica mondana. Ne potrà il Poeta, ch'è priuo del-la Musica, esser compito, nè tampoco esprimere il suo concetto versificando. Che dirò dell'Oratore? conuien pur'anche à lui l'esser'amaestrato in questa scienza della Musica; perche sappia con la voce hor graue, & hor acuta, esprimendo il suo concetto, muouere, e dilettare gli animi, e l'orec-chie delli Auditori. Perilche si legge, che Gaio Gracco dignissimo Orato-re, per non saper Musica, hauea sempre dietro à se vn Musico, che nell'o-rare gli somministraua à luogo, e tempo i modi della pronuntia, hor gra-ue, & hora acuta, come faceua bisogno. Mà, se verremo poi alla consideratione de i sonatori, potremo dire con vera ragione, che niun di lor sia buono, e perfetto nell'arte sua (sia pur di qual si voglia stromento) se non possiede la Musica. Et in somma si può dir, ch'essa condisce, & adorna assai l'altre virtù, come mostrò Franchino nel proemio dell'opra sua inti-tolata Prattica di Musica, oue sono queste parole. Non solamente gioua à se stessa (parlando della Musica) mà ancora alle altre virtù, e scienze. Et veramente essa tiene in sè questo particolare, che, aggionta à qualonque virtù, e scienza, la fà perfetta. Il che confermò Isidoro nel capitolo terzo del terzo libro delle sue Etimologie, mentre disse, che niuna scienza non poteua esser perfetta senza questa Musica. Da questi adunque e da mille altri essempij, che le potrei addurre, e principalmente da questo, che in-finiti sono gl'honorati virtuosi, che quinci traggono il vitto, e 'l vestito decentemente à se stessi, e à tutta la loro famiglia, chiaro le sia di quanta vtilità, e necessità sia questa: che, per non recar alle Signorie vostre noia, non m'estenderò più oltre. G. Da questo, ch'essa à sufficienza, & à nostra intelligenza hà detto, si potrà dire, che la Musica sia ornamento, e deco-ro di tutte l'altre scienze; poiche à ciascuna d'esse porge aiuto, & fauore. A. Cosi veramente si può dire, abbracciando ella (come hanno inteso) tutte le scienze, e virtù, e facendole perfette. E perciò disse Platone nel Dialogo de Republica, vel de Iusto à carte 384, che i putti deono impa-rar Musica, come principio delle altre virtù. Il che confermò Eusebio de praeparatione Euangelica, nel decimo quarto capitolo del duodecimo page 7libro. Onde apresso gli antichi non si permetteua, che l'huomo fosse pri-uo della Musica, douendo essere bene istituito, e compitamente nelle scienze come attesta Isidoro nel capitolo, e libro sopra allegato, mentre dice, che non iscema meno il decoro all'huomo il non saper Mu-sica, che il non saper lettere. Però si troua nelle leggi, & istitutioni delli Antichi, che dopò la Grammatica faceano imparare à i loro putti prima d'ogni altra scienza la Musica, come si legge nel terzo, quinto, e sesto capitolo dell'ottauo libro della Politica d'Aristotele, oue dice, che si facea insegnare à i putti la Musica; perche si cognoscea per la longa isperienza, che quella abbraccia, e porge aiuto alle altre virtù, e scienze, & è in quel-le, e in molte altre cose di grande vtilitade all'huomo. Quiui anche quel-li d'Arcadia (come riferisce Atheneo nell'vndecimo capitolo del decimo quarto libro) haueano per lege, che si deuesse imparar la Musica; & vno, che solo di Musica, e non d'altra scienza fosse stato dotato, apò loro era di scusa degno: e si teneua per cosa bruttissima l'esser di quella priuo; an-zi simil persona, che non ne fosse ammaestrato, riputauasi per persona di poco valore. Il che mostrò Cicerone nel libro delle Tusculane nel princi-pio, oue disse, che rifiutando Themistocle di suonar la lira, fù riputato huomo di poco valore. Licurgo Rè de' Lacedemoni tra le sue seuerissime legi lodò pur anch'egli l'imparar di Musica; perche cognosceua la necessità, gli mirabili effetti, e l'operationi di quella nell'huomo. E per certo, se ben ciò si considera, si vede, ch'essendo ella essercitata santamente, e con diuotione, leua la mente nostra à Dio, come attestò Santo Hilario Vesco-uo nel proemio, oue ragiona sopra i Salmi, dicendo, che per mezzo della Musica si considera la beatitudine; e s'inducono gli huomini à frequentar la Chiesa per lodare il sommo Iddio. ilche riferisce la somma Tabiena nel capitolo cantus à carte 63 secondo il mio testo. Si vede dipiù, ch'ella (vsata modestamente, e virtuosamente) hà possanza di radicare in noi vn'habito de' buoni, & ottimi costumi. Ilche si troua scritto nel decimo cap. del decimo quarto libro di Atheneo. Ben da tutte queste ragioni chiaramente si cognosce, quanto siano i tempi nostri tenebrosi, ciechi, e pie-ni d'errori; posciache hoggidì fra i mortali è tralasciato, e quasi sprezza-to lo studio di cosi nobile virtù, e scienza ritrouata specialmente per lo-dar il sommo Fattore, come riferisce il Profeta nel salmo nonagesimo quinto dicendo. Cantate domino canticum nouum, cantate domino omnis terra. Cantate domino, & benedicite nomini eius, annunciate de die in diem salutare eius, annunciate inter gentes gloriam eius, in omnibus populis mira-bilia eius. Et per leuare la mente nostra alle cose diuine. Benche tutta-uolta è da molti moderni malamente vsurpata, & essercitata in lodare cose mortali, caduche, e profane, ponendo in Musica parole lorde, e vergo-page 8gnose. Cosa sommamente abomineuole, essendosi per questo falsificato il primo carattere di sì nobile scienza, hauuta già in veneratione, e consi-deratione cotanta dalli nostri precessori. Per conchiusione adunque del nostro ragionamento dico, che infiniti sono i beneficij, che da questa Musica vengono ad honore, & vtile dell'huomo, come di già hanno vdito, e come anche potrei mostrare con mille altri essempij, e nuoue ragioni, & autorità, le quali tutte tralascio per non le infastidire. M. Io non vi dubito punto. Et per certo conosco l'vtilità, che da questa Musica prouiene, & in che cosa l'huomo se ne può seruire: e ciò apprendo chiaramente dal ragionamento di V. S. che ci è stato sommamente grato, e sommamente ne le rende obligati. A. Non hebbi pensiero mai, nè tam poco voglio, che di ciò m'habbiamo obligo alcuno; posciache questo cosi è mio debito di compiacerle, ouunque mi commandaranno, come sono pronto, se più oltre da me vogliono cosa, ch'io possa di seruirle. G. Siamo ben sicu-ri, che 'l tutto procede da sua mera e infinita cortesia, la qual m'affida, e mi dà libero campo di poterle chiedere il modo, co 'l quale Pithagora hebbe cognitione di questa Musica per il peso di quei martelli; e che cosa importaua l'esser'vno di lire dodeci, l'altro di sei, e l'altro di quattro. A. Portaua questo, che fra i pesi predetti si trouaua relatione di propor-tioni, dalle quali veniuano alcune consonanze, che generauano, e causauano quella harmonia, per la quale Pithagora hebbe cognitione della Mu-sica. M. Mà qual proportione si trouaua da dodici à sei, e da sei à quat-tro? A. Lo dirò. Da 12 à 6 si troua la proportione Dupla, prima spe-cie del Genere Moltiplice, la quale dà la consonanza ottaua: e da 6 à 4 si contiene la sesquialtra proportione, prima specie del Genere superparti-colare, la quale porge la consonanza quinta, & ambedue questi Generi sono atti à produrre le consonanze. M. Vi sono altri Generi di più di quelli, ch'essa hà nominati? A. Sono cinque i Generi d'inequalità. Il primo è detto Moltiplice, Il secondo superparticolare, Il terzo superpartiente, Il quarto Moltiplice superparticolare, Il quinto Moltiplice superpartiente. M. E perche si chiamano cosi Generi d'inequalità? A. Perche sono diffe-renti di proportione dalla proportione d'equalità. M. E che differenza si troua dalla proportione di equalità à quella d'inequalità? A. la differenza è questa,che la proportione di equalità hà i numeri l'vno contra l'altro eguali, come quì
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 4 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | ||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| 8 | 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | |||
| differenze | ||||
| 6 | 4 | 3 | ||
| 2 | 1 | |||
| differenze | ||||
| Dupla diuisa | ||||
| 4 | 3 | 2 | ||
| Sesqui-terza. | Sesqui-altra. | |||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| Trip la [sic: Tripla] diuisa | ||||
| 3 | 2 | 1 | ||
| Sesquial-tra. | Dupla | |||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| Sesquialtra diuisa | ||||
| 6 | 5 | 4 | ||
| Sesqui-quinta. | Sesqui-quarta. | |||
| 1 | 1 | |||
| differenze. | ||||
| 4 | 2 |
| 4 2 | 6 4 | 8 6 | 10 6 |
| 4 | 2 | |||
| dupla | ||||
| 4 | 3 | 2 | ||
| Dupla diuisa | ||||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| 3 | 1 | |||
| Tripla | ||||
| 3 | 2 | 1 | ||
| Tripla diuisa | ||||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| 6 | 4 | |||
| Sesquialtra | ||||
| 6 | 5 | 4 | ||
| Sesquialtra diuisa. | ||||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| 8 | 6 | |||
| Sesquiterza | ||||
| 8 | 7 | 6 | ||
| Sesquiterza diuisa. | ||||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| 10 | 8 | |||
| Sesquiquarta | ||||
| 10 | 9 | 8 | ||
| Sesquiquarta diuisa. | ||||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| 5 | 3 | |||
| Superbipartiente terza. | ||||
| 5 | 4 | 3 | ||
| Superbipartiente terza diuisa. | ||||
| 1 | 1 | |||
| differenze. | ||||
| 7 | 5 | |||
| Superbipartiente quinta. | ||||
| 7 | 6 | 5 | ||
| Superbipartiente quinta diuisa. | ||||
| 1 | 1 | |||
| differenze | ||||
| 7 | 4 | |||
| Supertripartiente quarta. | ||||
| 14 | 11 | 8 | ||
| Supertripartiente quarta diuisa. | ||||
| 3 | 3 | |||
| differenze | ||||
| 4 | 3 | 2 | ||
| 1 | 1 |
| 5 | 2 | |||
| Dupla sesquialtra | ||||
| 10 | 7 | 4 | ||
| Dupla sesquialtra diuisa | ||||
| 3 | 3 | |||
| differenze | ||||
| 7 | 3 | |||
| Dupla sesquiterza | ||||
| 7 | 5 | 3 | ||
| Dupla sesquiterza diuisa | ||||
| 2 | 2 | |||
| differenze | ||||
| 7 | 2 | |||
| Tripla sesquialtra | ||||
| 14 | 9 | 4 | ||
| Tripla sesquialtra diuisa | ||||
| 5 | 5 | |||
| differenze | ||||
| 8 | 3 | |||
| Dupla superbipar-tiente terza | ||||
| 16 | 11 | 6 | ||
| Dupla superbipar-tiente terza diuisa | ||||
| 5 | 5 | |||
| differenze | ||||
| 11 | 4 | |||
| Dupla supertripar-tiente quarta | ||||
| 22 | 15 | 8 | ||
| Dupla supertripar-tiente quarta diuisa | ||||
| 7 | 7 | |||
| differenze | ||||
| 14 | 5 | |||
| Dupla superquadri-partiente quinta | ||||
| 28 | 19 | 10 | ||
| Dupla superquadri-partiente quinta diuisa | ||||
| 9 | 9 | |||
| differenze | ||||
| 4 | 2 |
| 16 | 8 | 4 |
| 4 | 2 | |||
| Dupla | ||||
| 16 | 8 | 4 | ||
| Dupla | ||||
| 8 | 4 | |||
| differenze | ||||
| 3 | 1 | |||
| Tripla | ||||
| 9 | 3 | 1 | ||
| Tripla | ||||
| 6 | 2 | |||
| differenze | ||||
| 4 | 1 | |||
| Quadrupla | ||||
| 16 | 4 | 1 | ||
| Quadrupla | ||||
| 12 | 3 | |||
| differenze | ||||
| 16 8 | 8 4 |
| 4 | 2 | |||
| Dupla | ||||
| 16 | 8 | 4 | ||
| Dupla | ||||
| 8 | 4 | |||
| differenze | ||||
| Dupla | ||||
| 4 | 1 | |||
| Quadrupla | ||||
| 16 | 4 | 1 | ||
| Quadrupla | ||||
| 12 | 3 | |||
| differenze | ||||
| Quadrupla | ||||
| 5 | 1 | |||
| Quincupla | ||||
| 25 | 5 | 1 | ||
| Quincupla | ||||
| 20 | 4 | |||
| differenze | ||||
| Quincupla. | ||||
| 3 | 2 | |||
| Sesquialtra | ||||
| 9 | 6 | 4 | ||
| Sesquialtra | ||||
| 3 | 2 | |||
| differenze | ||||
| 4 | 3 | |||
| Sesquiterza | ||||
| 16 | 12 | 9 | ||
| Sesquiterza | ||||
| 4 | 3 | |||
| differenze | ||||
| 5 | 4 | |||
| Sesquiquarta | ||||
| 25 | 20 | 16 | ||
| Sesquiquarta | ||||
| 5 | 4 | |||
| differenze | ||||
| 5 | 3 | |||
| Superbipartiente terza | ||||
| 25 | 15 | 4 | ||
| Superbipartiente terza | ||||
| 10 | 6 | |||
| differenze | ||||
| 7 | 4 | |||
| Supertripartiente quarta | ||||
| 49 | 28 | 16 | ||
| Supertripartiente quarta | ||||
| 21 | 12 | |||
| differenze | ||||
| 7 | 5 | |||
| Superbipartiente quinta | ||||
| 49 | 35 | 25 | ||
| Superbipartiente quinta | ||||
| 14 | 10 | |||
| differenze | ||||
| 5 | 2 | |||
| Dupla sesquialtra | ||||
| 25 | 10 | 4 | ||
| Dupla sesquialtra | ||||
| 15 | 6 | |||
| differenze | ||||
| 7 | 3 | |||
| Dupla sesquiterza | ||||
| 49 | 21 | 9 | ||
| Dupla sesquiterza | ||||
| 28 | 12 | |||
| differenze | ||||
| 7 | 2 | |||
| Tripla sesquialtra | ||||
| 49 | 14 | 4 | ||
| Tripla sesquialtra | ||||
| 35 | 10 | |||
| differenze | ||||
| 8 | 3 | |||
| Dupla Superbipar-tiente terza | ||||
| 64 | 24 | 9 | ||
| Dupla superbipar-tiente terza | ||||
| 40 | 15 | |||
| differenze | ||||
| 11 | 4 | |||
| Dupla Supertripar-tiente quarta | ||||
| 121 | 44 | 16 | ||
| Dupla Supertripar-tiente quarta | ||||
| 77 | 28 | |||
| differenze | ||||
| 14 | 5 | |||
| Dupla superquadri-partiente quinta. | ||||
| 196 | 70 | 25 | ||
| Dupla superquadri-partiente quinta. | ||||
| 126 | 45 | |||
| differenze | ||||
| 4 | 3 | 2 |
| 12 | 8 | 6 |
| 12 | 8 |
| 8 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | ||
| Dupla | ||||
| 12 | 8 | 6 | ||
| Dupla ridotta | ||||
| 4 | 2 | |||
| Proportioni, & diffe-renze ineguali. | ||||
| 6 | 4 | 2 | ||
| Tripla | ||||
| 24 | 12 | 8 | ||
| Tripla ridotta | ||||
| 12 | 4 | |||
| Proportioni, & diffe-renze ineguali. | ||||
| 8 | 5 | 2 | ||
| Quadrupla | ||||
| 40 | 16 | 10 | ||
| Quadrupla ridotta. | ||||
| 24 | 6 | |||
| Proportioni, & diffe-renze ineguali. | ||||
| 6 | 5 | 4 | ||
| Sesquialtra | ||||
| 30 | 24 | 20 | ||
| Sesquialtra ridotta. | ||||
| 6 | 4 | |||
| Proportioni, & differenze ineguali. | ||||
| 8 | 7 | 6 | ||
| Sesquiterza | ||||
| 56 | 48 | 42 | ||
| Sesquiterza ridotta. | ||||
| 8 | 6 | |||
| Proportioni, & differenze ineguali. | ||||
| 10 | 9 | 8 | ||
| Sesquiquarta. | ||||
| 90 | 80 | 72 | ||
| Sesquiquarta ridotta. | ||||
| 10 | 8 | |||
| Proportioni, & differenze ineguali. | ||||
| 18 | 17 | 16 | ||
| Sesquiottaua | ||||
| 306 | 288 | 272 | ||
| Sesquiottaua ridotta. | ||||
| 18 | 16 | |||
| Proportioni, & diffe-renze ineguali. | ||||
| 5 | 4 | 3 | ||
| Superbipartiente terza. | ||||
| 20 | 15 | 12 | ||
| Superbipartiente terza ridotta. | ||||
| 5 | 3 | |||
| Proportioni inegua-li, & differenze ineguali. | ||||
| 7 | 6 | 5 | ||
| Superbipartiente quinta | ||||
| 42 | 35 | 30 | ||
| Superbipartiente quinta ridotta. | ||||
| 7 | 5 | |||
| Proportioni inegua-li, & differenze ineguali. | ||||
| 14 | 11 | 8 | ||
| Supertripartiente quarta | ||||
| 154 | 112 | 88 | ||
| Supertripartiente quarta ridotta. | ||||
| 42 | 24 | |||
| Proportioni ineguali, & differenze ineguali. | ||||
| 10 | 7 | 4 | ||
| Dupla sesquialtra | ||||
| 70 | 40 | 28 | ||
| Dupla sesquialtra ridotta | ||||
| 30 | 12 | |||
| Proportioni ineguali, & differenze ineguali | ||||
| 7 | 5 | 3 | ||
| Dupla sesquiterza | ||||
| 35 | 21 | 15 | ||
| Dupla sesquiterza ridotta | ||||
| 14 | 6 | |||
| Proportioni ineguali, & differenze ineguali | ||||
| 14 | 9 | 4 | ||
| Tripla sesquialtra | ||||
| 126 | 56 | 86 | ||
| Tripla sesquialtra rdotta [sic: ridotta] | ||||
| 70 | 20 | |||
| Proportioni inegua-li, & differenze ineguali | ||||
| 16 | 11 | 6 | ||
| Dupla superbipar-tiente terza | ||||
| 176 | 96 | 66 | ||
| Dupla superbipar-tiente terza ridotta | ||||
| 80 | 30 | |||
| Proportioni, & differenze ineguali | ||||
| 22 | 14 | 6 | ||
| Tripla superbipar-tiente terza | ||||
| 308 | 132 | 84 | ||
| Tripla superbipar-tiente terza ridotta | ||||
| 176 | 48 | |||
| Proportioni, & differenze ineguali | ||||
| 4 | 3 | 2 | ||
| Dupla | ||||
| 12 | 8 | 6 | ||
| 4 | 2 | |||
| differenze | ||||
| Dupla | ||||
| 6 | 4 | 2 | ||
| Tripla | ||||
| 24 | 12 | 8 | ||
| 12 | 4 | |||
| differenze | ||||
| Tripla | ||||
| 6 | 5 | 4 | ||
| Sesquialtra | ||||
| 30 | 24 | 20 | ||
| 6 | 4 | |||
| differenze | ||||
| Sesquialtra | ||||
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3 | 1 | Tripla |
| 4 | 2 | Dupla |
| 6 | 4 | Sesquialtra per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 8 | 2 | Quadrupla |
| 3 | 1 | Tripla |
| 8 | 6 | Sesquialtra per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 8 | 2 | Quadrupla |
| 4 | 2 | Dupla |
| 16 | 8 | Dupla per ec-cesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 | Dupla |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 4 | 3 | Sesquiterza per eccesso. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 6 | 4 | Sequialtra per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 8 | 5 | Supertripartiente quinta per eccesso. |
| 2 | 4 | Dupla |
| 6 | 5 | Sesquiquinta |
| 10 | 6 | Superbipartien-te terza per ec-cesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 9 | 8 | Sesquiottaua |
| 16 | 9 | Soprasettepartien-tenona per ec-cesso. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 10 | 9 | Sesquinona |
| 18 | 10 | Superquadripar-tiente quinta per eccesso, fuori de' suoi termini radicali. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza. |
| 6 | 5 | Sesquiquinta per eccesso. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 7 | 4 | Supertripartiente quarta |
| 8 | 7 | Sesquisettima per eccesso. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 9 | 5 | Superquadripar-tiente quinta |
| 10 | 9 | Sesquinona per eccesso. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 5 | 2 | Dupla sesquial-tra. |
| 4 | 5 | Subsesquiquarta per eccesso. |
| 2 | 1 | Dupla |
| 8 | 3 | Dupla Superbipar-tiente terza |
| 6 | 8 | Subsesquiterza per eccesso fuori de' suoi termini radi-cali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 9 | 8 | Sesquiottaua per eccesso |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 12 | 10 | Sesquiquinta per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 6 | 5 | Sesquiquinta |
| 15 | 12 | Sesquiquarta per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 9 | 8 | Sesquiottaua |
| 24 | 18 | Sesquiterza per ec-cesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 10 | 9 | Sesquinona |
| 27 | 20 | Supersettepartiente vigesima per ecces-so. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 16 | 15 | Sesquiquintadecima per eccesso. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 6 | 5 | Sesquiquinta |
| 20 | 18 | Sesquinona per ec-cesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 9 | 8 | Sesquiottaua |
| 32 | 27 | Superquinquepar-tiente vigesima set-tima per eccesso. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 10 | 9 | Sesquinona |
| 36 | 30 | Sesquiquinta per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 10 | 9 | Sesquinona per eccesso |
| 7 | 4 | Supertripartiente quarta |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 14 | 12 | Sesquisesta per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 15 | 12 | Sesquiquarta per eccesso fuori de' suoi termini radi-cali. |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 5 | 4 | Sesquiterza |
| 20 | 15 | Sesquiquarta per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 9 | 8 | Sesquiottaua |
| 40 | 27 | Supertredecipar-tiente vigesima settima per eccesso. |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 10 | 9 | Sesquinona |
| 45 | 30 | Sesquialtra per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 2 | Dupla sesquialtra |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 15 | 10 | Sesquialtra per ec-cesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 2 | Dupla sesquial-tra. |
| 3 | 1 | Tripla |
| 5 | 6 | Subsequiquinta per eccesso. |
| 5 | 2 | Dupla sesqui-altra |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 15 | 8 | Supersettepartiente ottaua per eccesso. |
| 5 | 2 | Dupla Sesquialtra |
| 7 | 3 | Dupla Sesquiterza |
| 15 | 14 | Sesquiquattordeci-ma per eccesso. |
| 5 | 2 | Dupla Sesquialtra |
| 9 | 4 | Dupla sesquiquarta |
| 20 | 18 | Sesquinona per ec-cesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 8 | 3 | Dupla superbipar-tiente terza |
| 3 | 1 | Tripla |
| 8 | 9 | Subsesquiottaua per eccesso. |
| 8 | 3 | Dupla superbipar-tiente terza |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 16 | 9 | Supersettepartiente nona |
| 8 | 3 | Dupla superbipar-tiente terza |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 24 | 12 | Dupla per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 8 | 3 | Dupla superbipartien-te terza |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 24 | 15 | Supertripartiente quinta per eccesso fuori de' suoi termini radicali. |
| 8 | 3 | Dupla superbipartien-te terza |
| 5 | 2 | Dupla sesquialtra |
| 16 | 15 | Sesquiquindecima per eccesso |
| 8 | 9 | Sesquiottaua |
| 10 | 9 | Sesquinona |
| 81 | 80 | Sesquiottaua vigesima per eccesso |
| 2 | 1 | Dupla |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 4 | 3 | eccesso |
| 12 | 6 | Dupla fuori de' suoi termini radicali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 9 | 8 | eccesso |
| 36 | 24 | Sesquialtra fuori de' suoi termini radi-cali. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 16 | 15 | eccesso |
| 80 | 60 | Sesquiterza fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 10 | 9 | eccesso |
| 30 | 18 | Superbipartiente terza |
| 5 | 2 | Dupla Sesquialtra |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 10 | 6 | Ecesso |
| 30 | 12 | Dupla Sesquialtra fuori de' suoi termi-ni radicali. |
| 8 | 3 | Dupla Superbipar-tiente terza |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 16 | 9 | Eccesso |
| 48 | 18 | Dupla superbipartien-te terza fuori de' suoi termini radicali. |
| 40 | 20 |
| 2 | 1 |
| 20 | 20 |
| 2 | 1 | Dupla ne' suoi termini radicali. |
| 40 | 20 | fuori de' suoi termini radicali |
| 20 | 20 | Proportione di equa-lità |
| 3 | 2 | Sesquialtra ne' suoi ter-mini radicali |
| 12 | 8 | Fuori de' suoi termini radicali |
| 4 | 4 | Proportione di equalità |
| 5 | 3 | Superbipartiente terza ne' suoi ter-mini radicali. |
| 25 | 15 | Fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 5 | Proportione di equalità. |
| 5 | 2 | Dupla sesquialtra ne' suoi termini radicali. |
| 30 | 12 | Fuori de' suoi termini radicali |
| 6 | 6 | Proportioni di equalità |
| 8 | 3 | Dupla superbipartiente terza ne' suoi ter-mini radicali. |
| 32 | 12 | fuori de' suoi termi-ni radicali. |
| 4 | 4 | Proportione di equa-lità. |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 12 | 6 | Ottaua fuori de' suoi termini radi-cali. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 9 | 8 | Sesquiottaua |
| 36 | 24 | Quinta fuori de' suoi termini radicali. |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 6 | 5 | Sesquiquinta |
| 30 | 20 | Quinta fuori de' suoi termini radicali. |
| 6 | 5 | Sesquiquinta |
| 10 | 9 | Sesquinona |
| 60 | 45 | Quarta fuori de' suoi termini radicali. |
| 9 | 8 | Sesquiottaua |
| 10 | 9 | Sesquinona |
| 90 | 72 | Terza maggiore. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 20 | 12 | Sesta maggiore fuori de' suoi ter-mini radicali. |
| 4 | 3 | Sesquiterza |
| 6 | 5 | Sesquiquinta |
| 24 | 15 | Sesta minore fuori de' suoi termini ra-dicali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 15 | 8 | Settima maggiore ne' suoi termini radicali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 6 | 5 | Sesquiquinta |
| 18 | 10 | Settima minore fuori de' suoi termini radi-cali. |
| 3 | 2 | Sesquialtra |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 15 | 8 | Settima maggiore nelli suoi termini radicali. |
| 5 | 4 | Sesquiquarta |
| 9 | 8 | Sesquiottaua |
| 45 | 32 | Tritono ne' suoi ter-mini radicali. |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | 3 |
DIALOGO DI MVSICA, INTERLOCVTORI, Il Sig. Conte Marco Verità. Il Sig. Conte Alessandro Beuilacqua, & il Sig. Conte Giordano Sarego. Seconda Parte.
| 2 a 2 |
| 3 a 3 |
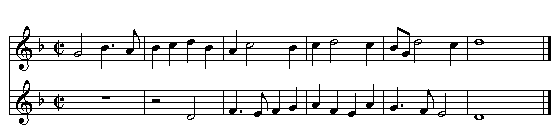 page 47Si vede, come per interualli proprij, & bene accommodati se ne vanno le inuentioni d'ambidue le parti senza discommodo del Cantore. Et à que-sto modo conuiene, che vadino le inuentioni, volendo, che habbiano il nome di belle, e vaghe. M. Veggio in effetto, che quelle inuentioni van-no con leggiadro modo, trouando i suoi interualli senza punto di fatica. Mà rende alquanto di difficultà l'hauer detto, che in questo è necessario, che siano i suoi interualli secondo il tuono; volendo dire (quanto posso considerare) che di tale inuentione non mi posso seruire in altro tuono, eccetto in quello, per cui è fatta detta compositione. A. Non ha à dubi-tar punto di questo. M. La cagione volentieri saprei, perche di questa inuentione non mi potrei seruire nel quarto, e quinto tuono, & nelli altri. A. Molte ragioni addurrò, perche questo non sia lecito. Vna è, che, vo-lendosi seruire nel quarto tuono di tal inuentione, conuerria, che il sopra-no cominciasse in D la sol re, la qual chorda non è propria del quarto tuono; nè per principio, nè per medietà, nè tampoco per fine, come dal-le compositioni de' Periti di Musica si può cauare. Se principiarà poi in A la mi re il soprano, l'Alto conuerrà principiare nella chorda di E la mi; & all'hora la inuentione non serà reale; poiche vna parte dirà.
page 47Si vede, come per interualli proprij, & bene accommodati se ne vanno le inuentioni d'ambidue le parti senza discommodo del Cantore. Et à que-sto modo conuiene, che vadino le inuentioni, volendo, che habbiano il nome di belle, e vaghe. M. Veggio in effetto, che quelle inuentioni van-no con leggiadro modo, trouando i suoi interualli senza punto di fatica. Mà rende alquanto di difficultà l'hauer detto, che in questo è necessario, che siano i suoi interualli secondo il tuono; volendo dire (quanto posso considerare) che di tale inuentione non mi posso seruire in altro tuono, eccetto in quello, per cui è fatta detta compositione. A. Non ha à dubi-tar punto di questo. M. La cagione volentieri saprei, perche di questa inuentione non mi potrei seruire nel quarto, e quinto tuono, & nelli altri. A. Molte ragioni addurrò, perche questo non sia lecito. Vna è, che, vo-lendosi seruire nel quarto tuono di tal inuentione, conuerria, che il sopra-no cominciasse in D la sol re, la qual chorda non è propria del quarto tuono; nè per principio, nè per medietà, nè tampoco per fine, come dal-le compositioni de' Periti di Musica si può cauare. Se principiarà poi in A la mi re il soprano, l'Alto conuerrà principiare nella chorda di E la mi; & all'hora la inuentione non serà reale; poiche vna parte dirà.
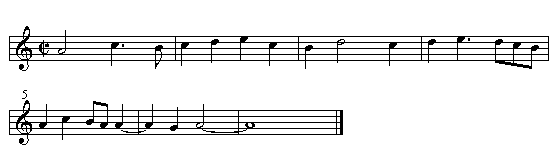 Et l'altra dirà.
Et l'altra dirà.
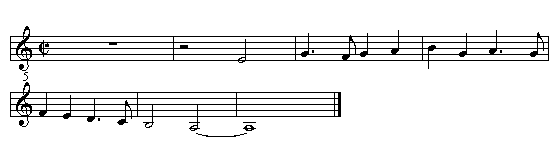
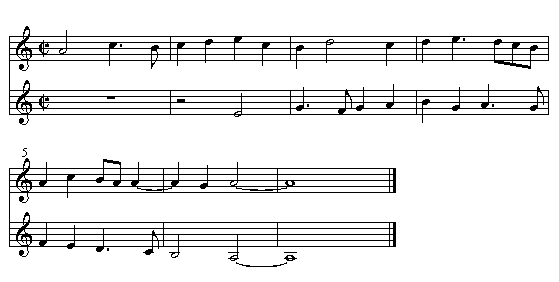 Talmente, che l'inuentioni non seranno conformi, nè si poco il nome delle figure. L'altra inconuenienza serà, che il Contralto più del suo ordinario si estenderà nell'acuto, in modo tale, che il Cantore non potrà esprime-re con la voce tal figure. Se poi, fattosi cominciar il Contralto, si farà ri-spondere il Tenore, il medesimo disordine si ritrouarà; perche le parti non seranno conformi, ne 'l nome delle figure, come ho detto. Circa il quinto tuono, e cosi circa gli altri, detta inuentione non può seruire in modo alcuno per gli incommodi, & inconuenienti, che ne auuerrebbe, come da loro stesse considerando, lo potranno vedere. M. Ditemi per cortesia, non mi potrò seruir nel secondo tuono? A. Potrà seruirsi, & questo auuiene per esser compagno del primo; mà conuerrà mutar le Parti, page 48& anco le sue Chiaui, & che siano per b molle. M. In che modo? A. Conuien far cominciar l'Alto, & poi il Tenore in questa forma.
Talmente, che l'inuentioni non seranno conformi, nè si poco il nome delle figure. L'altra inconuenienza serà, che il Contralto più del suo ordinario si estenderà nell'acuto, in modo tale, che il Cantore non potrà esprime-re con la voce tal figure. Se poi, fattosi cominciar il Contralto, si farà ri-spondere il Tenore, il medesimo disordine si ritrouarà; perche le parti non seranno conformi, ne 'l nome delle figure, come ho detto. Circa il quinto tuono, e cosi circa gli altri, detta inuentione non può seruire in modo alcuno per gli incommodi, & inconuenienti, che ne auuerrebbe, come da loro stesse considerando, lo potranno vedere. M. Ditemi per cortesia, non mi potrò seruir nel secondo tuono? A. Potrà seruirsi, & questo auuiene per esser compagno del primo; mà conuerrà mutar le Parti, page 48& anco le sue Chiaui, & che siano per b molle. M. In che modo? A. Conuien far cominciar l'Alto, & poi il Tenore in questa forma.
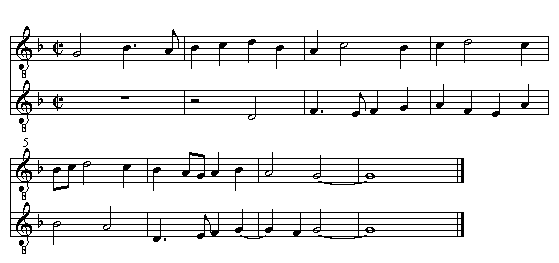 M. Facciane gratia di dirci la cagione, perche conuiene cominciar l'Alto, & non il Tenore. A. Per risposta dico, che conuiene far cominciar l'Al-to; perche con più commodo le altre Parti cominciaranno nelli suoi proprij luoghi. M. Mà auanti, che V. S. passi ad altro, ne dica (la prego) per-che non si potrà dar principio alla chorda di D la sol re; essendoche iui può venire tal'inuentione con molto commodo. A. V. S. dice il vero, che si potrà far cominciare il Tenore, ouero il Soprano nella chorda detta, mentre al Compositore torna commodo; & l'altra parte, che deurà dar principio, non eccede più di duoi Tempi d'vna Breue; poiche dalli buoni Compositori altrimente non è permesso, come si può veder nelle loro buone, e regolate compositioni. Vero è, che nelli Ricercarij si permette il posare auanti, che si dia principio all'altra Parte per vno spatio di duoi Tempi di Breue, e mezo, & alle volte di più, si come l'occasione porta; perche cosi vuole, e ricerca il modo di tal compositione, accioche esse inuentioni (ancorche longhe) sijno dalli Ascoltanti intese, come essami-nando i Ricercarij di Iaques Bus, di Claudio da Correggio, di Annibale, del Luzzasco, e d'altri simili si può vedere. Ben'è vero, che in altra occa-sione io giudico, che 'l fermarsi tanto non sia lecito. Hora hanno intesa la cagione, per la qual conuiene cominciare il Contralto nella chorda di G sol re vt; perche cominciando in D la sol re, ne verrebbe il già detto disordine. M. Credo, che habbiamo inteso questo à bastanza, ma dica-ne; perche detta inuentione potrà seruire nel secondo tuono, & non in altro. A. Perche il primo, e 'l secondo tuono sono formati da vna medesima specie della quinta, & della quarta, & finiscono in vna medesima chorda. E questa è la ragione, che detta Inuentione può seruire anco nel secondo Tuono, mutando le Parti, come già hò detto. M. Hora hauen-do inteso, perche mi posso seruire di detta Inuentione si nel Primo Tuo-no, come nel secondo; &, come deggio far, desidero saper; perche con-uien mutar le Chiaui, come disse di sopra. A. Perche le Inuentioni ha-page 49ueranno i suoi proprij interualli, & seranno proprij del secondo Tuono; che essendo fatte per la Chiaue di G sol re vt, non haueranno i proprij interualli del secondo Tuono; ma seranno del primo. Et, acciò meglio in-tendano, come ciò s'habbia à fare, quì formerò vn'essempio con tutte le quattro parti, che seranno secondo il proprio del secondo Tuono, e nelli suoi proprij luoghi.
M. Facciane gratia di dirci la cagione, perche conuiene cominciar l'Alto, & non il Tenore. A. Per risposta dico, che conuiene far cominciar l'Al-to; perche con più commodo le altre Parti cominciaranno nelli suoi proprij luoghi. M. Mà auanti, che V. S. passi ad altro, ne dica (la prego) per-che non si potrà dar principio alla chorda di D la sol re; essendoche iui può venire tal'inuentione con molto commodo. A. V. S. dice il vero, che si potrà far cominciare il Tenore, ouero il Soprano nella chorda detta, mentre al Compositore torna commodo; & l'altra parte, che deurà dar principio, non eccede più di duoi Tempi d'vna Breue; poiche dalli buoni Compositori altrimente non è permesso, come si può veder nelle loro buone, e regolate compositioni. Vero è, che nelli Ricercarij si permette il posare auanti, che si dia principio all'altra Parte per vno spatio di duoi Tempi di Breue, e mezo, & alle volte di più, si come l'occasione porta; perche cosi vuole, e ricerca il modo di tal compositione, accioche esse inuentioni (ancorche longhe) sijno dalli Ascoltanti intese, come essami-nando i Ricercarij di Iaques Bus, di Claudio da Correggio, di Annibale, del Luzzasco, e d'altri simili si può vedere. Ben'è vero, che in altra occa-sione io giudico, che 'l fermarsi tanto non sia lecito. Hora hanno intesa la cagione, per la qual conuiene cominciare il Contralto nella chorda di G sol re vt; perche cominciando in D la sol re, ne verrebbe il già detto disordine. M. Credo, che habbiamo inteso questo à bastanza, ma dica-ne; perche detta inuentione potrà seruire nel secondo tuono, & non in altro. A. Perche il primo, e 'l secondo tuono sono formati da vna medesima specie della quinta, & della quarta, & finiscono in vna medesima chorda. E questa è la ragione, che detta Inuentione può seruire anco nel secondo Tuono, mutando le Parti, come già hò detto. M. Hora hauen-do inteso, perche mi posso seruire di detta Inuentione si nel Primo Tuo-no, come nel secondo; &, come deggio far, desidero saper; perche con-uien mutar le Chiaui, come disse di sopra. A. Perche le Inuentioni ha-page 49ueranno i suoi proprij interualli, & seranno proprij del secondo Tuono; che essendo fatte per la Chiaue di G sol re vt, non haueranno i proprij interualli del secondo Tuono; ma seranno del primo. Et, acciò meglio in-tendano, come ciò s'habbia à fare, quì formerò vn'essempio con tutte le quattro parti, che seranno secondo il proprio del secondo Tuono, e nelli suoi proprij luoghi.
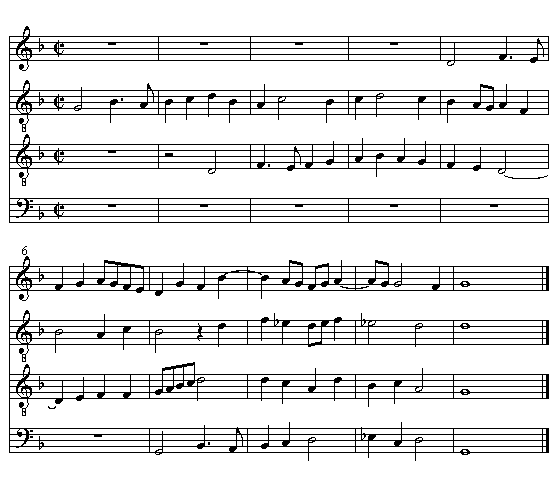 Qui si vede, che tutte le Parti fanno principio nelle sue Diapente, e Dia-tessaron del Tuono. M. Ci è stato carissimo intendere ciò, che V. S. hà detto sopra di questo per nostro auuertimento, degno inuero di tenerne particolar memoria. G. Anch'io confesso, che non è da sprezzar. Mà hauendo V. S. di sopra fatta mentione d'Inuentione Reale, desidero sapere, qual si habbia à dimandar inuentione Reale. A. Non senza ragione hò detto Inuentione Reale, essendo, che in trè modi si ponno fare esse inuentioni: e perciò tal volta si faranno, che vna parte risponderà all'altra, & seranno simili di figure, di nomi, & d'interualli, come di sopra dall'vltimo essempio si può vedere. Et questa si chiama Reale, perche tutte le Parti sono conformi di nomi, di figure, e d'interualli. Alcuna volta si faranno simili di nome, e d'interualli, ma non già di figure, come quì. page 50
Qui si vede, che tutte le Parti fanno principio nelle sue Diapente, e Dia-tessaron del Tuono. M. Ci è stato carissimo intendere ciò, che V. S. hà detto sopra di questo per nostro auuertimento, degno inuero di tenerne particolar memoria. G. Anch'io confesso, che non è da sprezzar. Mà hauendo V. S. di sopra fatta mentione d'Inuentione Reale, desidero sapere, qual si habbia à dimandar inuentione Reale. A. Non senza ragione hò detto Inuentione Reale, essendo, che in trè modi si ponno fare esse inuentioni: e perciò tal volta si faranno, che vna parte risponderà all'altra, & seranno simili di figure, di nomi, & d'interualli, come di sopra dall'vltimo essempio si può vedere. Et questa si chiama Reale, perche tutte le Parti sono conformi di nomi, di figure, e d'interualli. Alcuna volta si faranno simili di nome, e d'interualli, ma non già di figure, come quì. page 50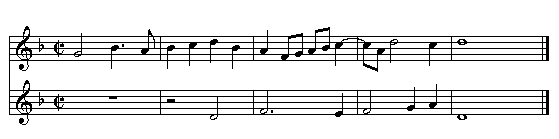 Queste Inuentioni sono simili di nome, & d'interualli, ma non già di fi-gure; poiche il Contr'alto và in alcuna parte con moto, & figure più tarde del soprano. Talche con giusta ragione non si potrà dir tale Inuentione esser reale; poiche le parti non sono conformi di moto, nè di figure. Il terzo modo d'Inuentione è, quando vi serà la similitudine delle figu-re, & delli interualli, ma non già del nome, come quì.
Queste Inuentioni sono simili di nome, & d'interualli, ma non già di fi-gure; poiche il Contr'alto và in alcuna parte con moto, & figure più tarde del soprano. Talche con giusta ragione non si potrà dir tale Inuentione esser reale; poiche le parti non sono conformi di moto, nè di figure. Il terzo modo d'Inuentione è, quando vi serà la similitudine delle figu-re, & delli interualli, ma non già del nome, come quì.
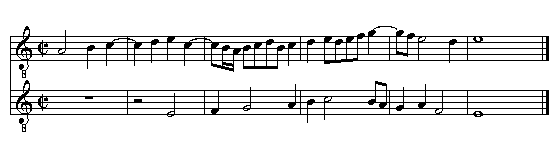 Et queste sono le trè varietà, che si trouano fra le Inuentioni de' Musici. Non voglio però tacere due altre Inuentioni differenti dalle prime, delle quali si sogliono alle volte seruire i Musici nelle loro compositioni.
Et queste sono le trè varietà, che si trouano fra le Inuentioni de' Musici. Non voglio però tacere due altre Inuentioni differenti dalle prime, delle quali si sogliono alle volte seruire i Musici nelle loro compositioni.
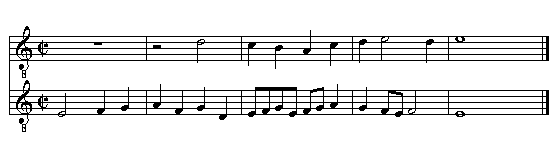 page 51Il qual modo d'Inuentioni si potrà con vera ragione ridurre alle Inuen-tioni reali, essendoui conformità di figure per trouarsi per moto contra-rio. Et questo modo osseruò Pietro Pontio nel Motetto. Verbum iniquum, nel primo libro de' suoi motetti à cinque voci. Nel resto poi sono con-formi le parti, come si può vedere. Et di questo modo d'inuentioni si po-tranno seruire per Quinta, per Quarta, e per Terza, come à loro più pia-cerà. Et, perche meglio s'intenda questo modo, quì formarò vn'essem-pio per Quinta lontano.
page 51Il qual modo d'Inuentioni si potrà con vera ragione ridurre alle Inuen-tioni reali, essendoui conformità di figure per trouarsi per moto contra-rio. Et questo modo osseruò Pietro Pontio nel Motetto. Verbum iniquum, nel primo libro de' suoi motetti à cinque voci. Nel resto poi sono con-formi le parti, come si può vedere. Et di questo modo d'inuentioni si po-tranno seruire per Quinta, per Quarta, e per Terza, come à loro più pia-cerà. Et, perche meglio s'intenda questo modo, quì formarò vn'essem-pio per Quinta lontano.
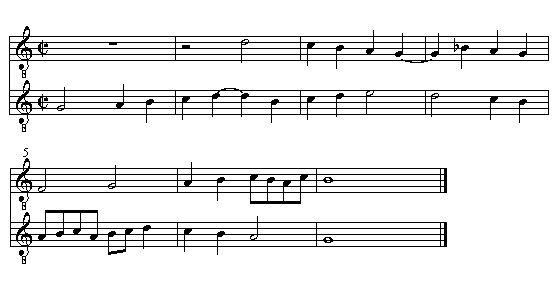 Si trouar vn'altro modo d'Inuentione, qual'è, quando due parti seranno fatte per contrario moto, come è quella di sopra; ma le dette parti non serueranno l'ordine di riga in ispatio, ò per il contrario; anzi vna serà in riga, & l'altra in ispatio. Et alle volte i Compositori sogliono mutar le parti; ciò è se il Soprano nel principiar l'Inuentione discenderà, nel replicar-la poi ascenderà. Et tal ordine da Pietro Pontio fù osseruato nel Motet-to. Lamentabatur Iacob. & nel Motetto. Quemadmodum desiderat Ceruus ad fontes aquarum. Ambiduoi posti nel suo terzo libro de Mo-tetti à cinque voci. Il medesimo seruò Pietro Vinci nel suo primo libro de' Motetti à quattro voci. Il qual modo potranno benissimo vedere in questo poco d'essempio.
Si trouar vn'altro modo d'Inuentione, qual'è, quando due parti seranno fatte per contrario moto, come è quella di sopra; ma le dette parti non serueranno l'ordine di riga in ispatio, ò per il contrario; anzi vna serà in riga, & l'altra in ispatio. Et alle volte i Compositori sogliono mutar le parti; ciò è se il Soprano nel principiar l'Inuentione discenderà, nel replicar-la poi ascenderà. Et tal ordine da Pietro Pontio fù osseruato nel Motet-to. Lamentabatur Iacob. & nel Motetto. Quemadmodum desiderat Ceruus ad fontes aquarum. Ambiduoi posti nel suo terzo libro de Mo-tetti à cinque voci. Il medesimo seruò Pietro Vinci nel suo primo libro de' Motetti à quattro voci. Il qual modo potranno benissimo vedere in questo poco d'essempio.
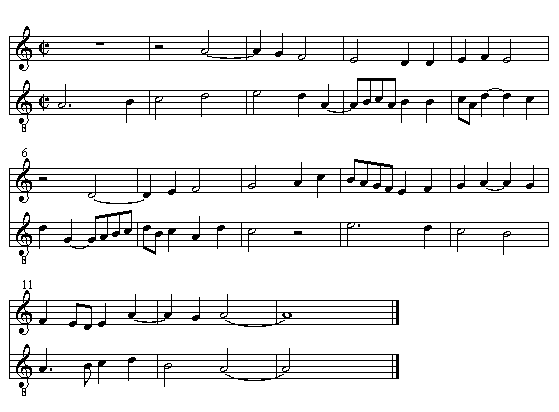 page 52Quì si vede, come le parti hanno mutate l'Inuentioni. E modo molto ingegnoso, & da osseruarsi. Che poi, piacendo al Compositore di far det-te Inuentioni, nelli modi mostrati, serà in suo piacere farle, hora di Breue, & hora di Semibreue, non essendo obligato in questo à cosa alcuna, se non quanto porta il suo capriccio. Credo già à sufficienza hauer detto sopra le varie Inuentioni, che si sogliono fare; e mostrato quel, che con-uiene hauer vna Inuentione, che veramente si possi chiamar reale; e parimente le conditioni, che sono necessarie à quella, che si habbi à chiamar bella, e vaga. G. Credo che habbiamo inteso molto bene tutto ciò, in che V. S. chi hà fauoriti di discorrere sopra questo particolare. Et fra tutto quello, che deue osseruare nelle inuentioni il Compositore (per quanto ho potuto intendere) il principal è, che siano fatte secondo il Tuono, & ap-propriate à quello, & che siano modulate con legitimi interualli. A. Così conuiene, altrimente farebbe nulla, come già dissi. G. Voglio però, che passiamo più auanti co 'l nostro ragionamento; & desidero sapere, se il Compositore, facendo diuersi Motetti del primo Tuono, ouer d'altri, conuer-rà, che faccia vna sola Inuentione; ouero che sijno variate fra di loro, ma però siano secondo il Tuono, che egli propone di fare. A. Gli conuiene senza dubio, che faccia tante varie Inuentioni, quanti sono i Motetti, che ei vuol fare. Ne deuono dubitar punto, perche ve lo mostraranno le compositioni de' Musici periti, come si può vedere nel libro quarto del Palestina, detto la Cantica, del Pontio nel secondo libro de' suoi Motetti, di Iachetto ne' suoi Motetti del fiore, & di altri Autori i quali per non esser prolisso tralascio, fra quali è Gomberto. Vero è, che questa non è le-ge determinata, ne commandamento espresso; perche sogliono ancora i Compositori cominciare vna sua compositione, come di quattro parti insieme, senza punto obligarsi all'Inuentione; ma la maggior parte suole osseruar tal ordine. Et con questo dà saggio di se, & fa conoscere, che possiede diuerse Inuentioni con la Idea sua, & finalmente mostra hauer fatto studio assai nel componere. G. Hora conosco, che questa prattica del comporre non è di cosi poca consideratione, come noi la credeuamo; anzi confesso esser necessario, che il compositore sia di grandissimo giudi-cio per trouare diuerse Inuentioni differenti l'vna dall'altra in vno istesso soggetto, ò Tuono (come dir vogliamo) & habbia vedute opre assai de' Compositori; e fra tutto parmi, che deggia hauer buona memoria, acciò non faccia egli il medesimo nelle sue Inuentioni, che haurà fatto vn'altro. Ilche tengo per cosa difficile; posciache hormai (cosi credo) ogni cosa (intendendomi di Musica) deue essere stata fatta dalli Compositori di Musica. A. Anzi difficilissima si deue giudicare; e pur conuiene farlo, che altrimenti saria riputato di poco valore, come dissi. M. Potrà V. S. page 53passar' al secondo capo, non hauendo sopra di questo altra difficultà. La seconda causa, che fa venire variatione fra' Compositori, è il modo di comporre, ò vogliamo dire lo stile, il qual di vno serà più vago, & har-monioso d'vn'altro. M. Mostrici, la prego, quando si potrà chiamar vno stile più vago, & harmonioso dell'altro; & in che consista questa sua vaghezza, & harmonia. A. Questo stile consiste nel saper accommodar le parti, accio non vi sia interuallo, che cantar non si possa. Di più nel fare, che le parti vadino più, che sia possibile, per mouimenti congion-ti; perche ciò rende commodo nel cantare, & al cantore diletto, e fà la compositione harmoniosa. Di più anco nel far che le parti fra di loro siano talmente vnite, & accommodate, che non si senta interualli, che offenda. All'hora adunque da' Cantori (essendo poste per parti insieme, come hò detto) serà cantata quella compositione con mirabile diletta-tione: & impossibile serà, che nel cantare faccino errore, essendo, che vna parte (per modo di dire) chiamarà l'altra. Mà, se in altro modo se-ranno le dette parti poste, si sentiranno quelle parti dalli Cantori esser pronontiate per forza; & alli Ascoltanti renderanno poco diletto, e dolcezza. Et, quando vna parte si poserà con alquante pause, conuerrà, che il Cantore sia diligente, & auuertito nel tener conto d'esse pause, acciò non faccia errore; perche quella parte darà principio con poco diletto, e sodisfattione, di chi l'ascolterà, & di chi canterà detta canti-lena. Tutto questo accaderà, perche detta parte farà principio fuor di proposito, e senza ragione. Il che non auuerrà, quando le parti seranno poste con bell'ordine, come già hò detto. Anzi posto tal ordine se 'l Cantore non tenesse memoria delle pause, venendo l'occasione di dar principio alla parte, che canta, ancor che non volesse (per così dire) serà sforzato darli principio per le parti, che vanno modulando; perche quella, che tace, dalle altre è chiamata, à cominciar'anco essa, come cantando l'opre de' Musici eccellentissimi, si possono rendere certe, di quanto hò ragionato. M. Di questo son sicuro; perche alle volte hò sen-tita vna compositione da buoni Cantori esser cantata, con tutto ciò (e questo non sia per mio giudicio, che potrei far errore; mà per parer d'al-tri) essa rendea poco diletto alli Ascoltanti; & tutti di commune senten-za affermauano, che non hauea in se diletto alcuno; & di più si vedeua, che dalli Cantori istessi era cantata con molta loro fatica, e poco piacere. Ne perciò la causa di questo alcun mi sapea dire. A. Varie, e diuerse sono le ragioni, che puonno addursi sopra di questo.
page 52Quì si vede, come le parti hanno mutate l'Inuentioni. E modo molto ingegnoso, & da osseruarsi. Che poi, piacendo al Compositore di far det-te Inuentioni, nelli modi mostrati, serà in suo piacere farle, hora di Breue, & hora di Semibreue, non essendo obligato in questo à cosa alcuna, se non quanto porta il suo capriccio. Credo già à sufficienza hauer detto sopra le varie Inuentioni, che si sogliono fare; e mostrato quel, che con-uiene hauer vna Inuentione, che veramente si possi chiamar reale; e parimente le conditioni, che sono necessarie à quella, che si habbi à chiamar bella, e vaga. G. Credo che habbiamo inteso molto bene tutto ciò, in che V. S. chi hà fauoriti di discorrere sopra questo particolare. Et fra tutto quello, che deue osseruare nelle inuentioni il Compositore (per quanto ho potuto intendere) il principal è, che siano fatte secondo il Tuono, & ap-propriate à quello, & che siano modulate con legitimi interualli. A. Così conuiene, altrimente farebbe nulla, come già dissi. G. Voglio però, che passiamo più auanti co 'l nostro ragionamento; & desidero sapere, se il Compositore, facendo diuersi Motetti del primo Tuono, ouer d'altri, conuer-rà, che faccia vna sola Inuentione; ouero che sijno variate fra di loro, ma però siano secondo il Tuono, che egli propone di fare. A. Gli conuiene senza dubio, che faccia tante varie Inuentioni, quanti sono i Motetti, che ei vuol fare. Ne deuono dubitar punto, perche ve lo mostraranno le compositioni de' Musici periti, come si può vedere nel libro quarto del Palestina, detto la Cantica, del Pontio nel secondo libro de' suoi Motetti, di Iachetto ne' suoi Motetti del fiore, & di altri Autori i quali per non esser prolisso tralascio, fra quali è Gomberto. Vero è, che questa non è le-ge determinata, ne commandamento espresso; perche sogliono ancora i Compositori cominciare vna sua compositione, come di quattro parti insieme, senza punto obligarsi all'Inuentione; ma la maggior parte suole osseruar tal ordine. Et con questo dà saggio di se, & fa conoscere, che possiede diuerse Inuentioni con la Idea sua, & finalmente mostra hauer fatto studio assai nel componere. G. Hora conosco, che questa prattica del comporre non è di cosi poca consideratione, come noi la credeuamo; anzi confesso esser necessario, che il compositore sia di grandissimo giudi-cio per trouare diuerse Inuentioni differenti l'vna dall'altra in vno istesso soggetto, ò Tuono (come dir vogliamo) & habbia vedute opre assai de' Compositori; e fra tutto parmi, che deggia hauer buona memoria, acciò non faccia egli il medesimo nelle sue Inuentioni, che haurà fatto vn'altro. Ilche tengo per cosa difficile; posciache hormai (cosi credo) ogni cosa (intendendomi di Musica) deue essere stata fatta dalli Compositori di Musica. A. Anzi difficilissima si deue giudicare; e pur conuiene farlo, che altrimenti saria riputato di poco valore, come dissi. M. Potrà V. S. page 53passar' al secondo capo, non hauendo sopra di questo altra difficultà. La seconda causa, che fa venire variatione fra' Compositori, è il modo di comporre, ò vogliamo dire lo stile, il qual di vno serà più vago, & har-monioso d'vn'altro. M. Mostrici, la prego, quando si potrà chiamar vno stile più vago, & harmonioso dell'altro; & in che consista questa sua vaghezza, & harmonia. A. Questo stile consiste nel saper accommodar le parti, accio non vi sia interuallo, che cantar non si possa. Di più nel fare, che le parti vadino più, che sia possibile, per mouimenti congion-ti; perche ciò rende commodo nel cantare, & al cantore diletto, e fà la compositione harmoniosa. Di più anco nel far che le parti fra di loro siano talmente vnite, & accommodate, che non si senta interualli, che offenda. All'hora adunque da' Cantori (essendo poste per parti insieme, come hò detto) serà cantata quella compositione con mirabile diletta-tione: & impossibile serà, che nel cantare faccino errore, essendo, che vna parte (per modo di dire) chiamarà l'altra. Mà, se in altro modo se-ranno le dette parti poste, si sentiranno quelle parti dalli Cantori esser pronontiate per forza; & alli Ascoltanti renderanno poco diletto, e dolcezza. Et, quando vna parte si poserà con alquante pause, conuerrà, che il Cantore sia diligente, & auuertito nel tener conto d'esse pause, acciò non faccia errore; perche quella parte darà principio con poco diletto, e sodisfattione, di chi l'ascolterà, & di chi canterà detta canti-lena. Tutto questo accaderà, perche detta parte farà principio fuor di proposito, e senza ragione. Il che non auuerrà, quando le parti seranno poste con bell'ordine, come già hò detto. Anzi posto tal ordine se 'l Cantore non tenesse memoria delle pause, venendo l'occasione di dar principio alla parte, che canta, ancor che non volesse (per così dire) serà sforzato darli principio per le parti, che vanno modulando; perche quella, che tace, dalle altre è chiamata, à cominciar'anco essa, come cantando l'opre de' Musici eccellentissimi, si possono rendere certe, di quanto hò ragionato. M. Di questo son sicuro; perche alle volte hò sen-tita vna compositione da buoni Cantori esser cantata, con tutto ciò (e questo non sia per mio giudicio, che potrei far errore; mà per parer d'al-tri) essa rendea poco diletto alli Ascoltanti; & tutti di commune senten-za affermauano, che non hauea in se diletto alcuno; & di più si vedeua, che dalli Cantori istessi era cantata con molta loro fatica, e poco piacere. Ne perciò la causa di questo alcun mi sapea dire. A. Varie, e diuerse sono le ragioni, che puonno addursi sopra di questo.
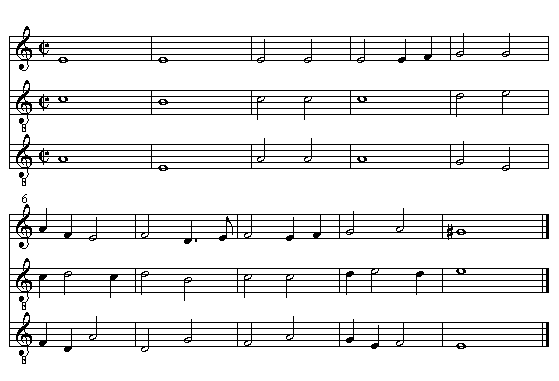 Hora veggono, come quelle parti vanno egualmente in misura per ispatio assai di tempo, il qual modo, e stile fà la compositione mesta, e senza vaghezza, e diletto alcuno. Si permette però alle volte ne' Mo-tetti, & altre compositioni per vn tempo di Semibreue, ouer di Breue al più, che le parti si possino fermar'insieme; mà, fatto questo, le Parti page 55poi cominciano à far mouimento, seruando l'ordine, e lo stile delle Compositioni de' periti Musici, come ciò ben scoprono i Motetti di Adriano, Gomberto, Finotto, & altri simili, i quali per non dilongarmi tacerò. Queste adunque sono le cause (come hanno inteso) che fanno le compositioni senza grato vdire, & di poco diletto alli Ascoltanti. M. Dalle parole, & dall'essempio proposto ben conosco, che per qualch'v-na di quelle ragioni conuiene, che la compositione dia si poco piacimen-to. Hora desidero sapere, in che modo vna parte chiami l'altra, come ha detto. A. Lo dirò. Si può dire, che vna parte chiami l'altra (commu-nemente parlando) quando vna parte haurà cominciato con queste fi-gure.
Hora veggono, come quelle parti vanno egualmente in misura per ispatio assai di tempo, il qual modo, e stile fà la compositione mesta, e senza vaghezza, e diletto alcuno. Si permette però alle volte ne' Mo-tetti, & altre compositioni per vn tempo di Semibreue, ouer di Breue al più, che le parti si possino fermar'insieme; mà, fatto questo, le Parti page 55poi cominciano à far mouimento, seruando l'ordine, e lo stile delle Compositioni de' periti Musici, come ciò ben scoprono i Motetti di Adriano, Gomberto, Finotto, & altri simili, i quali per non dilongarmi tacerò. Queste adunque sono le cause (come hanno inteso) che fanno le compositioni senza grato vdire, & di poco diletto alli Ascoltanti. M. Dalle parole, & dall'essempio proposto ben conosco, che per qualch'v-na di quelle ragioni conuiene, che la compositione dia si poco piacimen-to. Hora desidero sapere, in che modo vna parte chiami l'altra, come ha detto. A. Lo dirò. Si può dire, che vna parte chiami l'altra (commu-nemente parlando) quando vna parte haurà cominciato con queste fi-gure.
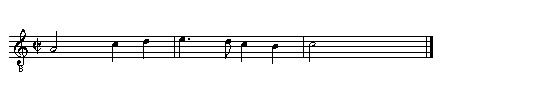 Et l'altra dirà il medemo, & cosi la terza parte. Et acciò vedino que-sto più chiaramente, per esser cosa degna da osseruarsi, mostrerò vn po-co d'essempio.
Et l'altra dirà il medemo, & cosi la terza parte. Et acciò vedino que-sto più chiaramente, per esser cosa degna da osseruarsi, mostrerò vn po-co d'essempio.
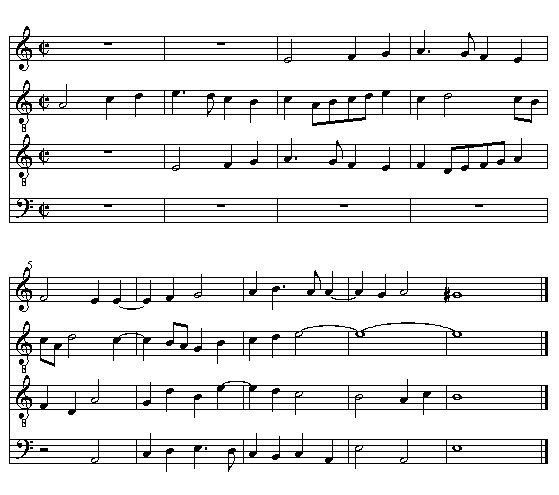 Quì si vede, come finita l'Inuentione con vna parte, l'altra comincia, oue si può dire, che vna parte chiami l'altra. A. Io lo vedo & tengo per cosa degna di memoria; mà dico, non si potrebbe far principiare il So-page 56prano, come principia il Contralto, ouer qualche altra parte? A. Questo è in arbitrio del Compositore, il qual può dar principio con quella parte, che più gli piace, purche stia nel proprio essere del tuono, e sia fatta l'In-uentione con bell'ordine Musicale, e commodo delle parti. M. Di gratia fauoriscami (se pur è sua commodità) di mostrar vn'altro essempio di tal'inuentione fatta in altro modo; acciò ne venga più capace. A. cosi fa-rò, & ecco l'essempio in vn'altro modo composto.
Quì si vede, come finita l'Inuentione con vna parte, l'altra comincia, oue si può dire, che vna parte chiami l'altra. A. Io lo vedo & tengo per cosa degna di memoria; mà dico, non si potrebbe far principiare il So-page 56prano, come principia il Contralto, ouer qualche altra parte? A. Questo è in arbitrio del Compositore, il qual può dar principio con quella parte, che più gli piace, purche stia nel proprio essere del tuono, e sia fatta l'In-uentione con bell'ordine Musicale, e commodo delle parti. M. Di gratia fauoriscami (se pur è sua commodità) di mostrar vn'altro essempio di tal'inuentione fatta in altro modo; acciò ne venga più capace. A. cosi fa-rò, & ecco l'essempio in vn'altro modo composto.
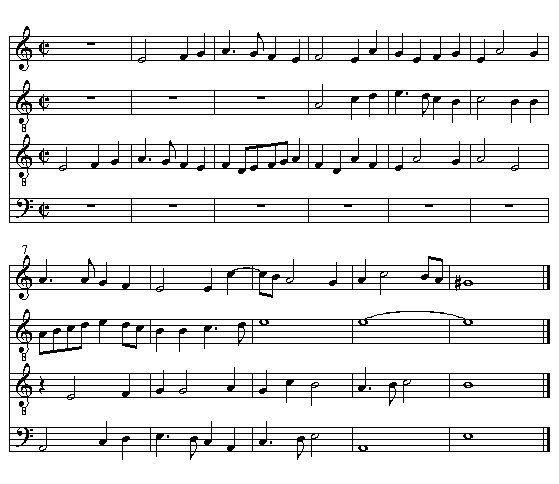 Hor si vede l'inuentione fatta ad vn'altro modo. Però gli suoi inter-ualli si trouano esser proprij del tuono: e si può anco far principiar'il can-to, seguendo poi con quella parte, che più sia commoda; non si scostan-do punto dal tuono. M. Emmi piacciuto il veder questa Inuentione fatta à duoi modi diuersi. Mà, perche mi dice, che si potrà principiare ad vn' altro modo, che serà, facendo principiar'il Soprano, però osseruandosi il tuono, come anco qualunque altra parte, che piacerà al Compositore, senza disgiongersi dal tuono, desiderarei saperne la causa. A. Questa è, che detta Inuentione hà gli interualli suoi proprij del tuono; perche và modulando per le Quinte, e per le Quarte forme di tal tuono; e facen-dosi principiar à qual più delle parti aggradirà, sempre verrassi à seruar la modulatione del tuono per le sopradette ragioni. Ilche non sarebbe vero, se altrimente fossero disposti gli interualli di detta Inuentione. E so-pra questo particolare dico di più, che iui si ricerca grandissima conside-ratione del diligente Compositore, per esser di grande importanza nelle page 57compositioni. Et questa è vn'altra causa, che produce gran varietà fra Compositori. M. Gran consolatione veramente i sento nell'esplicare, ch'ella fà queste sottili ragioni; mà maggior ne sentirei, se ella ci dicesse più oltre sopra questo, se si potrebbe far dire all'Alto, & al Basso le medesi-me figure, che dicono il Canto, e 'l Tenore. A. Non si può già negare, che non si possa far dire al Basso, & all'Alto le medesime figure; mà co-minciando il Basso nella chorda di B mi, quel mi rende dura la compo-sitione. E questo auuiene, per non hauer la sua Quinta naturalmente per-fetta, come si troua in E la mi. Talche il Compositore diligente, & auuer-tito schiffa il cadere in simili asprezze, e durezze. Quanto al Contr'alto, con facilità, & commodo si può far, che dica le medesime figure; poiche hà la sua Quinta nella parte bassa naturalmente perfetta. M. Piacemi an-cor l'hauer'intesa questa difficoltà, e sottigliezza. onde maggiormente mi cade nel pensiero, che più difficile sia la Prattica, che la Theorica, per le difficoltà, & sottigliezze, che hora mi si mostrano intorno al com-porre in Musica. Però seguiti pure al compimento di ciò, che già ci disse, ciò è, che cosa causi varietà frà Compositori, posciache della seconda causa già siamo à sufficienza istrutti. A. Io lo farò volentieri.
Hor si vede l'inuentione fatta ad vn'altro modo. Però gli suoi inter-ualli si trouano esser proprij del tuono: e si può anco far principiar'il can-to, seguendo poi con quella parte, che più sia commoda; non si scostan-do punto dal tuono. M. Emmi piacciuto il veder questa Inuentione fatta à duoi modi diuersi. Mà, perche mi dice, che si potrà principiare ad vn' altro modo, che serà, facendo principiar'il Soprano, però osseruandosi il tuono, come anco qualunque altra parte, che piacerà al Compositore, senza disgiongersi dal tuono, desiderarei saperne la causa. A. Questa è, che detta Inuentione hà gli interualli suoi proprij del tuono; perche và modulando per le Quinte, e per le Quarte forme di tal tuono; e facen-dosi principiar à qual più delle parti aggradirà, sempre verrassi à seruar la modulatione del tuono per le sopradette ragioni. Ilche non sarebbe vero, se altrimente fossero disposti gli interualli di detta Inuentione. E so-pra questo particolare dico di più, che iui si ricerca grandissima conside-ratione del diligente Compositore, per esser di grande importanza nelle page 57compositioni. Et questa è vn'altra causa, che produce gran varietà fra Compositori. M. Gran consolatione veramente i sento nell'esplicare, ch'ella fà queste sottili ragioni; mà maggior ne sentirei, se ella ci dicesse più oltre sopra questo, se si potrebbe far dire all'Alto, & al Basso le medesi-me figure, che dicono il Canto, e 'l Tenore. A. Non si può già negare, che non si possa far dire al Basso, & all'Alto le medesime figure; mà co-minciando il Basso nella chorda di B mi, quel mi rende dura la compo-sitione. E questo auuiene, per non hauer la sua Quinta naturalmente per-fetta, come si troua in E la mi. Talche il Compositore diligente, & auuer-tito schiffa il cadere in simili asprezze, e durezze. Quanto al Contr'alto, con facilità, & commodo si può far, che dica le medesime figure; poiche hà la sua Quinta nella parte bassa naturalmente perfetta. M. Piacemi an-cor l'hauer'intesa questa difficoltà, e sottigliezza. onde maggiormente mi cade nel pensiero, che più difficile sia la Prattica, che la Theorica, per le difficoltà, & sottigliezze, che hora mi si mostrano intorno al com-porre in Musica. Però seguiti pure al compimento di ciò, che già ci disse, ciò è, che cosa causi varietà frà Compositori, posciache della seconda causa già siamo à sufficienza istrutti. A. Io lo farò volentieri.
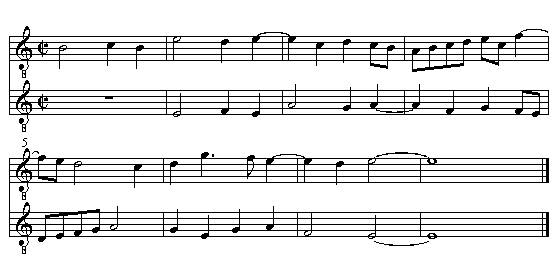 Da questo poco di essempio potranno vedere il modo, che hà da tenere il Compositore nelli suoi componimenti, nell'accommodar le parti insieme, che vengano ben vnite, senza venir fastidio al Cantore, anzi con suo diletto. E questo fia (come dissi) quando la parte modularà con veri, e legitimi interualli, & andarà con moto congionto; parimente quando passerà da vna consonanza all'altra senza incommodo alcuno. Il simile di quel, che si è visto nelle due parti, conuerrà farsi, essendo la Cantilena à quat-tro, à cinque, & à sei voci. M. Credo, che sia, come dice; mà parmi anco-ra, che difficilmente si possino accommodare quattro, e cinque parti insieme, e caminare in quel modo, che ci hà mostrato con l'essempio suo. A. Che ragione mi si può addurre in contrario? M. Questa che vna parte potrà occupare il luogo dell'altra, ò nel discendere, ò nell'ascendere in modo tale, che quelle parti non potranno andarsene, per interualli con-gionti, ma conuerrà, che vadino separati, e lontani, & alle volte non commodi. A. S'inganna; perche il Compositor prattico, e diligente antiue-de questi disordini, & incommodi; e sà, che ciascuna parte deue restar nell'esser suo, e nelli suoi termini; ne permette, che il Tenore faccia quello, che deurebbe far l'Alto, e cosi anco per il contrario. E, quando, la com-page 60positione serà à quattro, à cinque, & à sei, & vedrà, che, facendo cantare tutte le parti, ne verrebbe qualche incommodo interuallo, ouer, ch'vna parte andarà à trouar'vn'altra fuor di proposito, & senza occasione; e da ciò ne verrà qualche inconueniente, all'hora farà posare quella parte, nella quale si causarebbero simili disordini; perche meglio serà, che po-sa, che fare tali disordini ne i componimenti; poiche non fanno nel buo-na, ne harmoniosa la compositione. E di questo si possono render chia-re, essaminando l'opre de' Musici Eccellentissimi, come di Iachetto, Adriano, Cipriano, del Palestina, di Constantio Porta; & d'altri simili; ouer, vuole, che hor l'vna, hor l'altra parte faccia riposo; e questo solo, acciò non vengano simili inconuenienti, come anco fa l'istesso per trouare nuoue Inuentioni, e per dar riposo a' Cantori, i quali (cantando sempre) la compositione verrebbe noiosa. Laonde si hà dalle già dette cause, come hor l'vna, & hor l'altra parte si riposi. M. Credo veramente, che non senza qualche difficoltà sia l'accommodar bene quattro, e cinque parti insieme, si che non vi cada simile discommodo, & inconueniente. A. Porta certo difficoltà grandissima; pur'è necessario questo auuertimento, ch'al-trimente il componimento sarebbe di niun diletto alli ascoltanti, & di tedio al Cantore. M. Gratissime ci sono state tutte queste particolarità, & altrettanto ci seranno l'altre, che ella mostrarà, passando alla sesta cau-sa. A. Passerò dunque alla detta Sesta, che è causa di gran varietà fra mu-sici, facendo vno la sua compositione più dotta, & più ingegnosa dell'al-tro.Dicami (la prego) à che si conosce vna compositione più dotta, & ingegnosa dell'altra? A. A trè cose. La prima è, quando in essa si vedran-no diuerse Inuentioni, ò fughe (come dir si vuole) non sol nel principio, ma ancora nel mezo, & fine. La seconda, quando in essa si trouarà obli-gatione di Canto Plano, come si può veder nella Messa del Palestina à quattro voci nel primo libro, oue fà il Canto Plano di quella Antifona. Ecce sacerdos magnus. Ouer si trouarà obligatione di figure, come fece Iusquino nella Messa Hercules Dux Ferrariae, nel secondo libro delle sue Messe à quattro, & altroue nel primo libro di dette Messe, pigliando per soggetto queste figure la sol fa re mi. Et di tali figure si seruì anco il Pontio nel primo libro delle sue Messe à sei, le quali hanno per suo tito-lo. Missa la sol fa re mi, ouero può mostrar lo studio suo, quando sopra di esso canto Plano, & di esse figure il compositore trouarà varie inuen-tioni, come si vede nelle sopranominate Messe. Il simile possono vedere nelli Magnificat di Morales, ouer fa il Canto Plano, e poi vi sono diuerse inuentioni sopra di esso Canto Plano. La terza causa è, quando la com-positione (oltre alle altre inuentioni) haurà vna parte, ouer due, che diranno il medesimo, ò per quinta, ò per quarta, ouer per ottaua, ò per altra page 61consonanza, che farà l'altra, il qual modo si chiama Canone, ouer regola, come si possono far certe vedendo la Messa di Iosquino fatta ad fugam cosi chiamata, la messa di Morales fatta sopra Aue maris stella, la Messa del Pontio fatta sopra, In die tribulationis nel suo primo libro à cinque, quella di Iacchetto intitolata Peccata mea posta nel libro delle sue Mes-se à cinque, & d'altri. Il qual modo di comporre è dotto; & ingegnoso, quando però la compositione serà talmente ordinata, che nel cantare renda vaghezza & harmonia, & che fra le parti non si troui interuallo, che non faccia, se non buono vdire alli intendenti di Musica; & che fra esse parti non siano di quelli affronti (cosi detti volgarmente) di consonanze male ordinate, e senza regola poste, i quali non fanno nelle compositioni se non tristo effetto. M. L'hauer inteso, quando vna compositione si po-trà chiamar dotta, & ingegnosa ci è stato di grandissima sodisfattione; mà di più intiera ne sarebbe, se determinasse, quando si trouasse vna compositione fatta senza alcuna inuentione, & obligatione de' Canoni, e facesse buona harmonia, e nel cantare rendesse facilità, e diletto al Can-tore, se sarebbe questa compositione degna d'esser lodata. A. Sarebbe veramente degna di lode; mà molto più, quando vi fosse vn de' già det-ti trè modi. Deueno però saper, che alcune compositioni non ricercano in se cosa alcuna delli trè modi predetti, anzi essendouene alcuno la cantilena non saria fatta secondo il suo proprio, e non seruerebbe il suo decoro. M. Et quali sono queste tali cantilene? A. Sonoui le lettio-ni della settimana santa, gli Passi, gli Miserere, l'incarnatus est de Spiritu sancto con le seguenti sino al Crucifixus, e 'l gloria del Magnifi-cat. perche conuien, che queste compositioni siano graui, e le paro-le intese benissimo dalli Ascoltanti, acciò à loro rendino deuotio-ne. Ne si deue in simili componimenti far Inuentione alcuna, ò al-meno poche; mà solo esprimer le parole, come si vede nelle lamen-tationi di Morales, Gioanni Nasco, Gioanni Contino, nel Gloria delli Magnificat di Morales, nelle messe di Iosquino, nell'Incarnatus, & in altri simili. E solo iui si deue hauer consideratione, di far la com-positione mesta; poiche cosi ricercano le parole: e di far buona, e grata harmonia. Mà fuori delli predetti, & simili, conuiene farui del-le Inuentioni, ò Canoni; perche di quì si scopre l'intelligenza del Com-positore; e da tutti i periti di Musica serà giudicato huomo di valore, e ben fondato in quella; che, quando non vi fosser queste particolarità, sarebbe giudicato altrimente per le Cantilene fatte senza Inuentione, e si potrebbe dire, che fossero tutte ad vn modo, per non vi esser varietà. M. Vostra Signoria conchiude, che di valore, e riputa-page 62tione serà quella compositione, che haurà in se Inuentioni diuerse, ò Canoni, ouer Canti Plani, ritrouando poi diuerse Inuentioni sopra esso Canto Plano appropriate al Tuono, sopra che compone. A. Cosi stà: & se considerano le compositioni delli Eccellentissimi Compositori, si vedrà, che ciascun di loro hà posto ogni suo pensiero, e studio intor-no à nuoue Inuentioni per far nelle sue opre cose nuoue. & questo è vno de maggiori particolari, che si conuenga al Compositore, men-tre che voglia hauer nome, e buona fama fra' Musici. M. Così ten-go ancor io; però seguiti pure à quello, che già ci propose. A. Hauendo discorso assai sopra la sesta causa, si che nulla più mi ui resta à dire, passarò alla settima, la qual'è, che vno farà vna Inuentione, ouer fuga (come dir vogliamo) nel mezo della sua compositione, che dal-li Ascoltanti non serà nè considerata, nè intesa; ma vn'altro la ponerà in tal forma, che dalli Ascoltanti serà considerata, & osseruata benis-simo. M. Questo mi rende fuor di modo sospetto, come vna Inuen-tione fatta da vno non serà considerata, nè intesa; e fatta da vn'altro poi serà osseruata, & intesa. A. E cosi in vero; e, quando si sentirà la ra-gione, m'assicuro, che saremo conformi d'opinione. M. E d'intender questa à punto son grandemente desideroso. A. Auuertasi adunque che questo è di molta consideratione, & osseruatione per quelli, che nel-le lor compositioni si vogliono seruir dell'Inuentioni, le quali, quando seranno intese, & osseruate, daranno gran fama, e reputatione alli Autori; &, quando fosse altrimenti, vana sarebbe la fatica loro, poiche non sa-rebbero in veruna consideratione. Hora l'Inuentione fatta senza alcun riposo dalli Ascoltanti non potrà esser'osseruata, nè intesa. M. Facciaci di gratia più chiare queste parole. la inuentione fatta senza alcun ripo-so non si potrà osseruar, nè intendere. A. Volentieri, è in questo mo-do le dicchiaro. Trouandosi vn tenore, ò altra parte, che canti, se in quel-le figure si farà vna Inuentione con vn'altra parte, ouer con più parti, questa si fatta Inuentione non si potrà considerar, nè si potrà mettere à me-moria; si come si farebbe, se prima si facesse il riposo. M. Intendo que-sto, mà facciane gratia di mostrarci vn poco d'essempio, acciò meglio ne siamo capaci. page 63
Da questo poco di essempio potranno vedere il modo, che hà da tenere il Compositore nelli suoi componimenti, nell'accommodar le parti insieme, che vengano ben vnite, senza venir fastidio al Cantore, anzi con suo diletto. E questo fia (come dissi) quando la parte modularà con veri, e legitimi interualli, & andarà con moto congionto; parimente quando passerà da vna consonanza all'altra senza incommodo alcuno. Il simile di quel, che si è visto nelle due parti, conuerrà farsi, essendo la Cantilena à quat-tro, à cinque, & à sei voci. M. Credo, che sia, come dice; mà parmi anco-ra, che difficilmente si possino accommodare quattro, e cinque parti insieme, e caminare in quel modo, che ci hà mostrato con l'essempio suo. A. Che ragione mi si può addurre in contrario? M. Questa che vna parte potrà occupare il luogo dell'altra, ò nel discendere, ò nell'ascendere in modo tale, che quelle parti non potranno andarsene, per interualli con-gionti, ma conuerrà, che vadino separati, e lontani, & alle volte non commodi. A. S'inganna; perche il Compositor prattico, e diligente antiue-de questi disordini, & incommodi; e sà, che ciascuna parte deue restar nell'esser suo, e nelli suoi termini; ne permette, che il Tenore faccia quello, che deurebbe far l'Alto, e cosi anco per il contrario. E, quando, la com-page 60positione serà à quattro, à cinque, & à sei, & vedrà, che, facendo cantare tutte le parti, ne verrebbe qualche incommodo interuallo, ouer, ch'vna parte andarà à trouar'vn'altra fuor di proposito, & senza occasione; e da ciò ne verrà qualche inconueniente, all'hora farà posare quella parte, nella quale si causarebbero simili disordini; perche meglio serà, che po-sa, che fare tali disordini ne i componimenti; poiche non fanno nel buo-na, ne harmoniosa la compositione. E di questo si possono render chia-re, essaminando l'opre de' Musici Eccellentissimi, come di Iachetto, Adriano, Cipriano, del Palestina, di Constantio Porta; & d'altri simili; ouer, vuole, che hor l'vna, hor l'altra parte faccia riposo; e questo solo, acciò non vengano simili inconuenienti, come anco fa l'istesso per trouare nuoue Inuentioni, e per dar riposo a' Cantori, i quali (cantando sempre) la compositione verrebbe noiosa. Laonde si hà dalle già dette cause, come hor l'vna, & hor l'altra parte si riposi. M. Credo veramente, che non senza qualche difficoltà sia l'accommodar bene quattro, e cinque parti insieme, si che non vi cada simile discommodo, & inconueniente. A. Porta certo difficoltà grandissima; pur'è necessario questo auuertimento, ch'al-trimente il componimento sarebbe di niun diletto alli ascoltanti, & di tedio al Cantore. M. Gratissime ci sono state tutte queste particolarità, & altrettanto ci seranno l'altre, che ella mostrarà, passando alla sesta cau-sa. A. Passerò dunque alla detta Sesta, che è causa di gran varietà fra mu-sici, facendo vno la sua compositione più dotta, & più ingegnosa dell'al-tro.Dicami (la prego) à che si conosce vna compositione più dotta, & ingegnosa dell'altra? A. A trè cose. La prima è, quando in essa si vedran-no diuerse Inuentioni, ò fughe (come dir si vuole) non sol nel principio, ma ancora nel mezo, & fine. La seconda, quando in essa si trouarà obli-gatione di Canto Plano, come si può veder nella Messa del Palestina à quattro voci nel primo libro, oue fà il Canto Plano di quella Antifona. Ecce sacerdos magnus. Ouer si trouarà obligatione di figure, come fece Iusquino nella Messa Hercules Dux Ferrariae, nel secondo libro delle sue Messe à quattro, & altroue nel primo libro di dette Messe, pigliando per soggetto queste figure la sol fa re mi. Et di tali figure si seruì anco il Pontio nel primo libro delle sue Messe à sei, le quali hanno per suo tito-lo. Missa la sol fa re mi, ouero può mostrar lo studio suo, quando sopra di esso canto Plano, & di esse figure il compositore trouarà varie inuen-tioni, come si vede nelle sopranominate Messe. Il simile possono vedere nelli Magnificat di Morales, ouer fa il Canto Plano, e poi vi sono diuerse inuentioni sopra di esso Canto Plano. La terza causa è, quando la com-positione (oltre alle altre inuentioni) haurà vna parte, ouer due, che diranno il medesimo, ò per quinta, ò per quarta, ouer per ottaua, ò per altra page 61consonanza, che farà l'altra, il qual modo si chiama Canone, ouer regola, come si possono far certe vedendo la Messa di Iosquino fatta ad fugam cosi chiamata, la messa di Morales fatta sopra Aue maris stella, la Messa del Pontio fatta sopra, In die tribulationis nel suo primo libro à cinque, quella di Iacchetto intitolata Peccata mea posta nel libro delle sue Mes-se à cinque, & d'altri. Il qual modo di comporre è dotto; & ingegnoso, quando però la compositione serà talmente ordinata, che nel cantare renda vaghezza & harmonia, & che fra le parti non si troui interuallo, che non faccia, se non buono vdire alli intendenti di Musica; & che fra esse parti non siano di quelli affronti (cosi detti volgarmente) di consonanze male ordinate, e senza regola poste, i quali non fanno nelle compositioni se non tristo effetto. M. L'hauer inteso, quando vna compositione si po-trà chiamar dotta, & ingegnosa ci è stato di grandissima sodisfattione; mà di più intiera ne sarebbe, se determinasse, quando si trouasse vna compositione fatta senza alcuna inuentione, & obligatione de' Canoni, e facesse buona harmonia, e nel cantare rendesse facilità, e diletto al Can-tore, se sarebbe questa compositione degna d'esser lodata. A. Sarebbe veramente degna di lode; mà molto più, quando vi fosse vn de' già det-ti trè modi. Deueno però saper, che alcune compositioni non ricercano in se cosa alcuna delli trè modi predetti, anzi essendouene alcuno la cantilena non saria fatta secondo il suo proprio, e non seruerebbe il suo decoro. M. Et quali sono queste tali cantilene? A. Sonoui le lettio-ni della settimana santa, gli Passi, gli Miserere, l'incarnatus est de Spiritu sancto con le seguenti sino al Crucifixus, e 'l gloria del Magnifi-cat. perche conuien, che queste compositioni siano graui, e le paro-le intese benissimo dalli Ascoltanti, acciò à loro rendino deuotio-ne. Ne si deue in simili componimenti far Inuentione alcuna, ò al-meno poche; mà solo esprimer le parole, come si vede nelle lamen-tationi di Morales, Gioanni Nasco, Gioanni Contino, nel Gloria delli Magnificat di Morales, nelle messe di Iosquino, nell'Incarnatus, & in altri simili. E solo iui si deue hauer consideratione, di far la com-positione mesta; poiche cosi ricercano le parole: e di far buona, e grata harmonia. Mà fuori delli predetti, & simili, conuiene farui del-le Inuentioni, ò Canoni; perche di quì si scopre l'intelligenza del Com-positore; e da tutti i periti di Musica serà giudicato huomo di valore, e ben fondato in quella; che, quando non vi fosser queste particolarità, sarebbe giudicato altrimente per le Cantilene fatte senza Inuentione, e si potrebbe dire, che fossero tutte ad vn modo, per non vi esser varietà. M. Vostra Signoria conchiude, che di valore, e riputa-page 62tione serà quella compositione, che haurà in se Inuentioni diuerse, ò Canoni, ouer Canti Plani, ritrouando poi diuerse Inuentioni sopra esso Canto Plano appropriate al Tuono, sopra che compone. A. Cosi stà: & se considerano le compositioni delli Eccellentissimi Compositori, si vedrà, che ciascun di loro hà posto ogni suo pensiero, e studio intor-no à nuoue Inuentioni per far nelle sue opre cose nuoue. & questo è vno de maggiori particolari, che si conuenga al Compositore, men-tre che voglia hauer nome, e buona fama fra' Musici. M. Così ten-go ancor io; però seguiti pure à quello, che già ci propose. A. Hauendo discorso assai sopra la sesta causa, si che nulla più mi ui resta à dire, passarò alla settima, la qual'è, che vno farà vna Inuentione, ouer fuga (come dir vogliamo) nel mezo della sua compositione, che dal-li Ascoltanti non serà nè considerata, nè intesa; ma vn'altro la ponerà in tal forma, che dalli Ascoltanti serà considerata, & osseruata benis-simo. M. Questo mi rende fuor di modo sospetto, come vna Inuen-tione fatta da vno non serà considerata, nè intesa; e fatta da vn'altro poi serà osseruata, & intesa. A. E cosi in vero; e, quando si sentirà la ra-gione, m'assicuro, che saremo conformi d'opinione. M. E d'intender questa à punto son grandemente desideroso. A. Auuertasi adunque che questo è di molta consideratione, & osseruatione per quelli, che nel-le lor compositioni si vogliono seruir dell'Inuentioni, le quali, quando seranno intese, & osseruate, daranno gran fama, e reputatione alli Autori; &, quando fosse altrimenti, vana sarebbe la fatica loro, poiche non sa-rebbero in veruna consideratione. Hora l'Inuentione fatta senza alcun riposo dalli Ascoltanti non potrà esser'osseruata, nè intesa. M. Facciaci di gratia più chiare queste parole. la inuentione fatta senza alcun ripo-so non si potrà osseruar, nè intendere. A. Volentieri, è in questo mo-do le dicchiaro. Trouandosi vn tenore, ò altra parte, che canti, se in quel-le figure si farà vna Inuentione con vn'altra parte, ouer con più parti, questa si fatta Inuentione non si potrà considerar, nè si potrà mettere à me-moria; si come si farebbe, se prima si facesse il riposo. M. Intendo que-sto, mà facciane gratia di mostrarci vn poco d'essempio, acciò meglio ne siamo capaci. page 63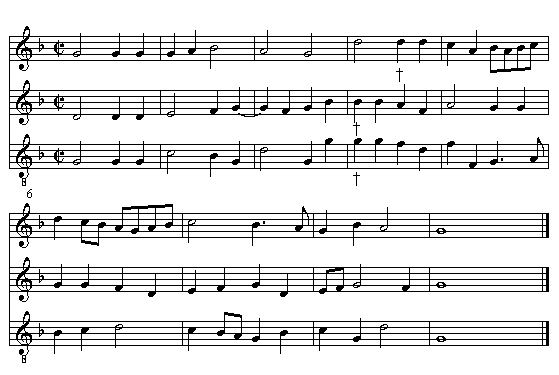 A. Se in questo poco d'essempio à tre voci fatto consideraranno le figure, oue si troua quel segno tra le parti, ce si rispondono per Inuen-tione; dal senso, conosceranno, che non sono nè vdite, ne osseruate per questa ragione; che, per il non fermarsi quelle parti, gli Acoltanti (per la maggior parte) non ponno giudicar, se quelle figure siano fatte per In-uentione, ò per far cantar le parti, ouer per esplicar le parole poste sotto le figure predette, ò più tosto per empimento (per dir cosi) delle parti, cantando sempre quelle insieme. M. Conosce esser vero quel, che mi dice; posciache tal hora non si pon cura ad altro, che al sentire l'harmo-nia delle consonanze, causata dalle parti, che cantano, e tal'hora al bell'ordine, che hà tenuto il compositore in metter le parole, che siano intese. Mà, che si deurà fare, acciò l'Inuentioni vengano sentite, & osseruate? A. Si deurà tener questo ordine, che la parte, che principiarà nuoua In-uentione, ouer replicarà la medesima, si fermi (come già dissi) per spatio d'vn tempo di breue, ò di semibreue, ò almeno d'vna pausa di Minima; perche dandosi poi principio alla parte, che già hà posato, gli Ascoltanti le porgono orecchia, e seruano nella memoria le figure, che proferisce il Cantore, onde viene dalla memoria de gli ascoltanti osseruata. M. Pia-cemi assai questa ragione. E, benche vero sia tutto ciò, che hauete detto, e per tale lo stimi; nondimeno per maggior nostra certezza, e capacità, la prego à volerci illuminar più con vn poco d'essempio. A. E per com-piacer loro, e per certificatione del tutto mi contento volentieri di far l'essempio, che è questo. page 64
A. Se in questo poco d'essempio à tre voci fatto consideraranno le figure, oue si troua quel segno tra le parti, ce si rispondono per Inuen-tione; dal senso, conosceranno, che non sono nè vdite, ne osseruate per questa ragione; che, per il non fermarsi quelle parti, gli Acoltanti (per la maggior parte) non ponno giudicar, se quelle figure siano fatte per In-uentione, ò per far cantar le parti, ouer per esplicar le parole poste sotto le figure predette, ò più tosto per empimento (per dir cosi) delle parti, cantando sempre quelle insieme. M. Conosce esser vero quel, che mi dice; posciache tal hora non si pon cura ad altro, che al sentire l'harmo-nia delle consonanze, causata dalle parti, che cantano, e tal'hora al bell'ordine, che hà tenuto il compositore in metter le parole, che siano intese. Mà, che si deurà fare, acciò l'Inuentioni vengano sentite, & osseruate? A. Si deurà tener questo ordine, che la parte, che principiarà nuoua In-uentione, ouer replicarà la medesima, si fermi (come già dissi) per spatio d'vn tempo di breue, ò di semibreue, ò almeno d'vna pausa di Minima; perche dandosi poi principio alla parte, che già hà posato, gli Ascoltanti le porgono orecchia, e seruano nella memoria le figure, che proferisce il Cantore, onde viene dalla memoria de gli ascoltanti osseruata. M. Pia-cemi assai questa ragione. E, benche vero sia tutto ciò, che hauete detto, e per tale lo stimi; nondimeno per maggior nostra certezza, e capacità, la prego à volerci illuminar più con vn poco d'essempio. A. E per com-piacer loro, e per certificatione del tutto mi contento volentieri di far l'essempio, che è questo. page 64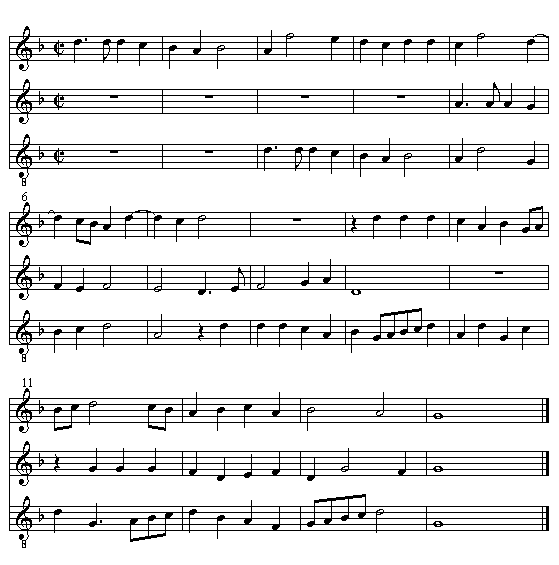 Nell'essempio scritto ben vedete, che, doppo l'hauer principiate le parti, e fatta la lor cadenza, ò riposo generale (come più piace nominarla) il Tenore, già che si è riposato per spatio d'vna pausa di minima, dà principio all'Inuentione, che dice.
Nell'essempio scritto ben vedete, che, doppo l'hauer principiate le parti, e fatta la lor cadenza, ò riposo generale (come più piace nominarla) il Tenore, già che si è riposato per spatio d'vna pausa di minima, dà principio all'Inuentione, che dice.
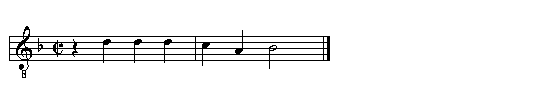 E parimente; poiche il Canto hà riposato per spatio d'vna pausa di bre-ue, dice l'istessa Inuentione per Ottaua lontano, simile di figure, di no-me, & d'interualli: e, poiche il Contralto, per lo spatio similmente d'vna pausa di Breue si è riposato, con simil figure, & interualli fa il medesimo lontano dal Tenore per Quarta; e cosi poscia tutte le parti si riducono al fine. Onde fatte di tal sorte l'inuentioni verrannno dalli Ascoltanti intese, & insieme osseruate per essersi posata ciascuna d'esse parti doppo la pri-ma cadenza, ò riposo generale. Questa dunque è la ragione, per cui l'In-uentioni vengono osseruate dalli Ascoltanti. Onde fatte in altro modo (come dissi) non sono cosi intese. ma la compositione di quell'altra page 65sorte vien'ad esser fatta con ordine, e giudicio più bello, come essaminan-do le compositioni de' periti in questo le Signorie Vostre resteranno più chiare. Vero è, ch'alle volte principiarà vna parte nuoua Inuentione: ma ciò di raro (parlando generalmente) e l'altre parti seguiranno il già detto ordine. M. Ben sono dalle ragioni dette, e dal sopra mostrato essempio restato chiaro di questa settima causa di varietà, che in altro modo non deue farsi; posciache dal cominciarsi la parte, che di già alquanto ha po-sato alli auditori viene à esser posta nella memoria assai più, che dall'ha-uer continuamente cantata. Perciò hauendone fatti di questo benissimo possessori, potrà (come la prego) passar'all'altre cause già proposte; che, se di tal'importanza seranno, di quale sono state queste, oltre che l'intenderle, come le predette ci serà di grandissima consolatione, le faremo obligati eternamente. A. Senza tanti prieghi ben il farò di buona voglia, co 'l dire, che l'ottaua causa producitrice di tanta varietà frà Compositori (di non minor'importanza, nè punto men degna d'osseruatione dell'al-tre) è l'osseruare il Tuono, doue si fà la compositione. G. Sendo (co-me dice) questa di tanto rileuo, come le passate, conseguentemente pa-re anco, che ricerchi tal'esplicatione, quale hanno hauuta le predette. Pe-rò inanzi ch'oltre si passi, la prego à dicchiararne, che cosa sia questo os-seruare il tuono. A. Il Tuono sopra ogn'altra cosa si deue osseruare nelle compositioni, altrimente il tutto sarebbe fatto senza proposito, che è il saper come i Tuoni siano formati (così volgarmente parlando) acciò si sappiano far le cadenze ne' luoghi proprij delle sue Diapente, & Diatessaron, ne si facciano fuori del Tuono. G. Facciane gratia di manifestar le Diapente, e Diatessaron di ciascun Tuono. A. Non posso mancar, poi-che me lo chiedono, & è cosa degna di memoria, e ricerca attentione. Il primo Tuono dunque hà la sua Diapente da D sol re, chorda sua fina-le, ad A la mi re posta nell'acuto: e dall'A mi re à D la sol re posta pari-mente nell'acuto, hà la sua Diatessaron. Il suo compagno; ciò è, il secondo Tuono (chiamato compagno) perche hà il suo fine nella chorda di D sol re, si come il primo hà la sua Diapente da D sol re ad A la mi re nell'acuto, cosi anco haurà il secondo. La sua Diatessaron tiene poi da D sol re ad A re posta nel graue. Et dicono i Prattici, che ambidui sono formati dalla pri-ma specie dalla Diapente, e Diatessaron. Et questi sono i luoghi delle Diapente, e Diatessaron del primo, e secondo Tuono, oue si fanno le lor cadenze, ò riposi generali. Il terzo Tuono hà la sua Diapente da E la mi, chorda sua fi-nale, à B fa b mi posta nell'acuto, e da B fa b mi ad E la mi parimente po-sta nell'acuto hà la sua Diatessaron. Il quarto Tuono, che si chiama suo compagno, hà parimente la sua Diapente da E la mi à B fa b mi posta di sopra, e da E la mi à B mi vi si troua la Diatessaron posta nel graue. E di-page 66 cono i Prattici, che si formano questi duoi Tuoni dalla seconda specie della Diapente, & Diatessaron. Il Quinto Tuono, quale hà la sua chorda finale in Fa ut, tenerà la sua Diapente da Fa ut in C sol fa ut nell'acuto, [unclear: e] la Diatessaron da C sol fa ut ad Fa ut nell'acuto parimente. Il sesto ha la sua Diapente da Fa ut à C sol fa ut nell'acuto, e la Diatessaron da Fa ut à C fa ut posta nel graue. Questi Tuoni, si tiene, che siano formati dal-la terza specie della Diapente, e Diatessaron. Il settimo Tuono ha la Dia-pente da G sol re ut (per esser chorda, oue finisce simil Tuono) a D la sol re posta di sopra ad essa chorda, e la Diatessaron da D sol re à G sol re ut posta nell'acuto. Il suo compagno, ch'è detto l'Ottauo Tuono, haurà similmente la Diapente da G sol re ut à D la sol re nell'acuto, e la Diates-saron da G sol re ut à D la sol re nel graue. Dicono i Prattici, che ambi-dui questi Tuoni si formano dalla quarta specie della Diapente, e Diates-saron. Queste dunque sono le Diapente, e le Diatessaron di ciascun Tuono, fra le quali si fanno le cadenze, ò riposi generali, acciò si osserui il Tuono. Siche non hauendo il Compositor tal cognitione può errar fa-cilmente, facendo vna cadenza, la qual non sia propria del Tuono. Laon-de la sua compositione verria fatta fuori delle regole buone; non essendo nelli termini regolati del Tuono. G. Cosi credo, e per sicuro il tengo: e però desiderarei saper, se d'altri luoghi, che delle sue Diapente, e Diates-saron, si può seruir il compositore per far le cadenze. A. Si può seruir ancora d'altri luoghi, i quali seranno, doue i Salmi fanno la sua medietà, & anco alle volte doue principiano,e nella medietà ancora della Quinta d'essi Tuoni; perche sono chorde appropriate alli Tuoni del Salmo, e se ne seruiamo alle volte nelle compositioni, come diffusamente ragionò di questo particolare Pietro Pontio nel terzo ragionamento fatto nel Ridotto dell'Illustrissimo Sig. Conte Mario Beuilacqua, come anco essaminan-do l'opre d'Eccellentissimi Compositori ne restaranno con più intiera chiarezza. E perciò non mi estenderò in mostrar loro il nome delli luo-ghi de' principij, medietà, e fini delli Salmi; perche essendo stati presen-ti al ragionamento terzo fatto nel Ridotto predetto, oue amplamente si trattò di questo, si deuono ricordar di quel, che iui si disse intorno à simili principij[unclear: ,] medietà, e fini de' Salmi, ragionandosi anco, doue si haueano à far le cadenze sì de motetti, come de' Salmi, & d'altre Compositioni. G. Ben me ne ricordo, onde non fà mestiero, che ne prenda altra fatica. Mà, se pur altro resta intorno al particolar del comporre in Musica, ci sa-rà di sommo fauore il farcelo manifesto. A. Non mi resta altro, che dire, posciache si ricordano, di quanto si ragionò nel Ridotto sodetto. Ma hora mi souuiene la nona causa producitrice di varietà fra Compositori, la cui decchiaratione proponendo in questo modo dico, che vno si serui-page 67rà d'altre cadenze fuori del Tuono, in cui fà la sua Compositione, & vn altro nò. Queste cadenze à punto vengono chiamate cadenze fuori del Tuono, & conuiene esser diligentemente in ciò auuertito; acciò, facen-dosi vna cadenza fuori del Tuono, oue si fonda la Compositione, si vada con bell'ordine di consonanze, nè si faccia fuori di proposito, e senza al-cuna gratia, altrimenti non si renderebbe grato vdire alle purgate orec-chie. G. Aggionga (la prego) questo alli altri fauori, che ci hauete fatti, & dica quali siano le cadenze che fuori del Tuono si chiamano. A. Vo-lontieri il dirò. Poniamo caso, che si faccia vn Motetto, ò altra composi-tione dell'ottauo Tuono: se iui si facesse vna cadenza in A la mi re, non è dubbio, che questa sarebbe cadenza impropria, e fuori del Tuono. G. La prego di più à mostrarne la ragione. A. La ragione è questa; perche in detta chorda d'A la mi re non è il principio della Diapente, nè della Diatessaron, nè tampoco vi è la medietà, ne il fine dell'ottauo Tuono, i quali sono i luoghi, oue si fanno le cadenze appropriate ad esso Tuono, (come gia dissi). Si che si fatta cadenza non può esser in modo alcuno appropriata ad esso Tuono; e perciò si dice cadenza impropria, e fuori del Tuono. Cosi anco è fuori del suo proprio Tuono la cadenza di G sol re ut, facendosi vna Cantilena nel sesto Tuono. Talmente che, volendosi seruire di simili cadenze, è necessaria grandissima considera-tione, e diligenza, acciò nelle compositioni si renda grato vdire. E quel tanto, che di questi duoi Tuoni hò detto, può dirsi e deue intendersi anco delli altri. Questa dunque è parimente vna causa, che genera va-rietà fra Compositori; posciache non tutti sanno seruirsi di simili caden-ze, le quali fatte con bello ordine producono buono, e leggiadro effetto. G. Credo veramente, che sia mestiero di gran diligenza è di gran pru-denza in seruirsi di simili cadenze, più, che delle proprie del Tuono. Ma perche più per causa delli essempij si viene a perfetta cognitione, di che si tratta, la prego per maggior nostra consolatione à non mancar in que-sto di qualche poco d'essempio. A. Non mancarò, & eccolo.
E parimente; poiche il Canto hà riposato per spatio d'vna pausa di bre-ue, dice l'istessa Inuentione per Ottaua lontano, simile di figure, di no-me, & d'interualli: e, poiche il Contralto, per lo spatio similmente d'vna pausa di Breue si è riposato, con simil figure, & interualli fa il medesimo lontano dal Tenore per Quarta; e cosi poscia tutte le parti si riducono al fine. Onde fatte di tal sorte l'inuentioni verrannno dalli Ascoltanti intese, & insieme osseruate per essersi posata ciascuna d'esse parti doppo la pri-ma cadenza, ò riposo generale. Questa dunque è la ragione, per cui l'In-uentioni vengono osseruate dalli Ascoltanti. Onde fatte in altro modo (come dissi) non sono cosi intese. ma la compositione di quell'altra page 65sorte vien'ad esser fatta con ordine, e giudicio più bello, come essaminan-do le compositioni de' periti in questo le Signorie Vostre resteranno più chiare. Vero è, ch'alle volte principiarà vna parte nuoua Inuentione: ma ciò di raro (parlando generalmente) e l'altre parti seguiranno il già detto ordine. M. Ben sono dalle ragioni dette, e dal sopra mostrato essempio restato chiaro di questa settima causa di varietà, che in altro modo non deue farsi; posciache dal cominciarsi la parte, che di già alquanto ha po-sato alli auditori viene à esser posta nella memoria assai più, che dall'ha-uer continuamente cantata. Perciò hauendone fatti di questo benissimo possessori, potrà (come la prego) passar'all'altre cause già proposte; che, se di tal'importanza seranno, di quale sono state queste, oltre che l'intenderle, come le predette ci serà di grandissima consolatione, le faremo obligati eternamente. A. Senza tanti prieghi ben il farò di buona voglia, co 'l dire, che l'ottaua causa producitrice di tanta varietà frà Compositori (di non minor'importanza, nè punto men degna d'osseruatione dell'al-tre) è l'osseruare il Tuono, doue si fà la compositione. G. Sendo (co-me dice) questa di tanto rileuo, come le passate, conseguentemente pa-re anco, che ricerchi tal'esplicatione, quale hanno hauuta le predette. Pe-rò inanzi ch'oltre si passi, la prego à dicchiararne, che cosa sia questo os-seruare il tuono. A. Il Tuono sopra ogn'altra cosa si deue osseruare nelle compositioni, altrimente il tutto sarebbe fatto senza proposito, che è il saper come i Tuoni siano formati (così volgarmente parlando) acciò si sappiano far le cadenze ne' luoghi proprij delle sue Diapente, & Diatessaron, ne si facciano fuori del Tuono. G. Facciane gratia di manifestar le Diapente, e Diatessaron di ciascun Tuono. A. Non posso mancar, poi-che me lo chiedono, & è cosa degna di memoria, e ricerca attentione. Il primo Tuono dunque hà la sua Diapente da D sol re, chorda sua fina-le, ad A la mi re posta nell'acuto: e dall'A mi re à D la sol re posta pari-mente nell'acuto, hà la sua Diatessaron. Il suo compagno; ciò è, il secondo Tuono (chiamato compagno) perche hà il suo fine nella chorda di D sol re, si come il primo hà la sua Diapente da D sol re ad A la mi re nell'acuto, cosi anco haurà il secondo. La sua Diatessaron tiene poi da D sol re ad A re posta nel graue. Et dicono i Prattici, che ambidui sono formati dalla pri-ma specie dalla Diapente, e Diatessaron. Et questi sono i luoghi delle Diapente, e Diatessaron del primo, e secondo Tuono, oue si fanno le lor cadenze, ò riposi generali. Il terzo Tuono hà la sua Diapente da E la mi, chorda sua fi-nale, à B fa b mi posta nell'acuto, e da B fa b mi ad E la mi parimente po-sta nell'acuto hà la sua Diatessaron. Il quarto Tuono, che si chiama suo compagno, hà parimente la sua Diapente da E la mi à B fa b mi posta di sopra, e da E la mi à B mi vi si troua la Diatessaron posta nel graue. E di-page 66 cono i Prattici, che si formano questi duoi Tuoni dalla seconda specie della Diapente, & Diatessaron. Il Quinto Tuono, quale hà la sua chorda finale in Fa ut, tenerà la sua Diapente da Fa ut in C sol fa ut nell'acuto, [unclear: e] la Diatessaron da C sol fa ut ad Fa ut nell'acuto parimente. Il sesto ha la sua Diapente da Fa ut à C sol fa ut nell'acuto, e la Diatessaron da Fa ut à C fa ut posta nel graue. Questi Tuoni, si tiene, che siano formati dal-la terza specie della Diapente, e Diatessaron. Il settimo Tuono ha la Dia-pente da G sol re ut (per esser chorda, oue finisce simil Tuono) a D la sol re posta di sopra ad essa chorda, e la Diatessaron da D sol re à G sol re ut posta nell'acuto. Il suo compagno, ch'è detto l'Ottauo Tuono, haurà similmente la Diapente da G sol re ut à D la sol re nell'acuto, e la Diates-saron da G sol re ut à D la sol re nel graue. Dicono i Prattici, che ambi-dui questi Tuoni si formano dalla quarta specie della Diapente, e Diates-saron. Queste dunque sono le Diapente, e le Diatessaron di ciascun Tuono, fra le quali si fanno le cadenze, ò riposi generali, acciò si osserui il Tuono. Siche non hauendo il Compositor tal cognitione può errar fa-cilmente, facendo vna cadenza, la qual non sia propria del Tuono. Laon-de la sua compositione verria fatta fuori delle regole buone; non essendo nelli termini regolati del Tuono. G. Cosi credo, e per sicuro il tengo: e però desiderarei saper, se d'altri luoghi, che delle sue Diapente, e Diates-saron, si può seruir il compositore per far le cadenze. A. Si può seruir ancora d'altri luoghi, i quali seranno, doue i Salmi fanno la sua medietà, & anco alle volte doue principiano,e nella medietà ancora della Quinta d'essi Tuoni; perche sono chorde appropriate alli Tuoni del Salmo, e se ne seruiamo alle volte nelle compositioni, come diffusamente ragionò di questo particolare Pietro Pontio nel terzo ragionamento fatto nel Ridotto dell'Illustrissimo Sig. Conte Mario Beuilacqua, come anco essaminan-do l'opre d'Eccellentissimi Compositori ne restaranno con più intiera chiarezza. E perciò non mi estenderò in mostrar loro il nome delli luo-ghi de' principij, medietà, e fini delli Salmi; perche essendo stati presen-ti al ragionamento terzo fatto nel Ridotto predetto, oue amplamente si trattò di questo, si deuono ricordar di quel, che iui si disse intorno à simili principij[unclear: ,] medietà, e fini de' Salmi, ragionandosi anco, doue si haueano à far le cadenze sì de motetti, come de' Salmi, & d'altre Compositioni. G. Ben me ne ricordo, onde non fà mestiero, che ne prenda altra fatica. Mà, se pur altro resta intorno al particolar del comporre in Musica, ci sa-rà di sommo fauore il farcelo manifesto. A. Non mi resta altro, che dire, posciache si ricordano, di quanto si ragionò nel Ridotto sodetto. Ma hora mi souuiene la nona causa producitrice di varietà fra Compositori, la cui decchiaratione proponendo in questo modo dico, che vno si serui-page 67rà d'altre cadenze fuori del Tuono, in cui fà la sua Compositione, & vn altro nò. Queste cadenze à punto vengono chiamate cadenze fuori del Tuono, & conuiene esser diligentemente in ciò auuertito; acciò, facen-dosi vna cadenza fuori del Tuono, oue si fonda la Compositione, si vada con bell'ordine di consonanze, nè si faccia fuori di proposito, e senza al-cuna gratia, altrimenti non si renderebbe grato vdire alle purgate orec-chie. G. Aggionga (la prego) questo alli altri fauori, che ci hauete fatti, & dica quali siano le cadenze che fuori del Tuono si chiamano. A. Vo-lontieri il dirò. Poniamo caso, che si faccia vn Motetto, ò altra composi-tione dell'ottauo Tuono: se iui si facesse vna cadenza in A la mi re, non è dubbio, che questa sarebbe cadenza impropria, e fuori del Tuono. G. La prego di più à mostrarne la ragione. A. La ragione è questa; perche in detta chorda d'A la mi re non è il principio della Diapente, nè della Diatessaron, nè tampoco vi è la medietà, ne il fine dell'ottauo Tuono, i quali sono i luoghi, oue si fanno le cadenze appropriate ad esso Tuono, (come gia dissi). Si che si fatta cadenza non può esser in modo alcuno appropriata ad esso Tuono; e perciò si dice cadenza impropria, e fuori del Tuono. Cosi anco è fuori del suo proprio Tuono la cadenza di G sol re ut, facendosi vna Cantilena nel sesto Tuono. Talmente che, volendosi seruire di simili cadenze, è necessaria grandissima considera-tione, e diligenza, acciò nelle compositioni si renda grato vdire. E quel tanto, che di questi duoi Tuoni hò detto, può dirsi e deue intendersi anco delli altri. Questa dunque è parimente vna causa, che genera va-rietà fra Compositori; posciache non tutti sanno seruirsi di simili caden-ze, le quali fatte con bello ordine producono buono, e leggiadro effetto. G. Credo veramente, che sia mestiero di gran diligenza è di gran pru-denza in seruirsi di simili cadenze, più, che delle proprie del Tuono. Ma perche più per causa delli essempij si viene a perfetta cognitione, di che si tratta, la prego per maggior nostra consolatione à non mancar in que-sto di qualche poco d'essempio. A. Non mancarò, & eccolo.
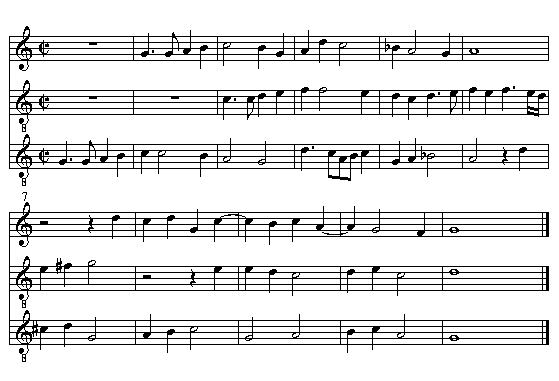 page 68 Si può co 'l giudicio dell'orecchia considerare, come quel Soprano ricerca tal cadenza in A la mi re per rispetto del fa posto per accidente nella chor-da di B fa b mi; e come poi con bell'ordine subito torna nella chorda di D la sol re mediatrice di tal Tuono, che così conuien, che faccia. Se anco desiderano vn'essempio del sesto Tuono per sentir la cadenza fatta in G sol re ut; qual'è fuori del numero delle cadenze proprie di esso Tuono, lo dicano, che tanto farò. G. Se così le piace, s'accrescerà l'obligo nostro. Lo farò volentieri, & ecco che lo scriuo.
page 68 Si può co 'l giudicio dell'orecchia considerare, come quel Soprano ricerca tal cadenza in A la mi re per rispetto del fa posto per accidente nella chor-da di B fa b mi; e come poi con bell'ordine subito torna nella chorda di D la sol re mediatrice di tal Tuono, che così conuien, che faccia. Se anco desiderano vn'essempio del sesto Tuono per sentir la cadenza fatta in G sol re ut; qual'è fuori del numero delle cadenze proprie di esso Tuono, lo dicano, che tanto farò. G. Se così le piace, s'accrescerà l'obligo nostro. Lo farò volentieri, & ecco che lo scriuo.
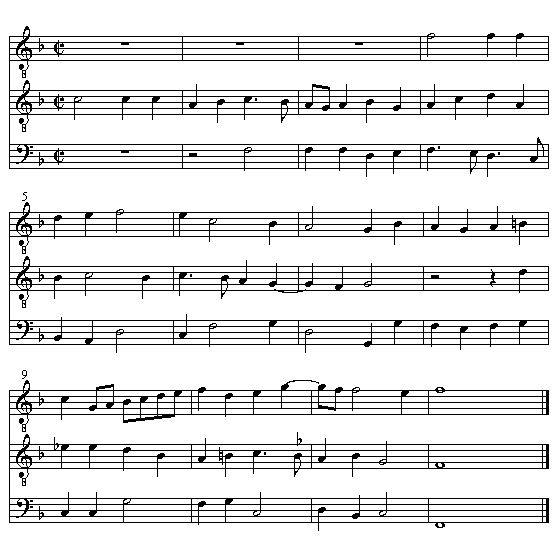 Si sente la cadenza di G sol re ut, come è di grato vdire; del che cantando si potranno benissimo certificare. G. Io lo vedo, & sento benissimo, mà non si potrebbe far la cadenza nella chorda di E la mi? A. Potreb-besi veramente, ma offenderia grandemente le purgate orecchie. G. E perche? A. La ragione è, che il mi di E la mi è in tutto contrario al se-sto Tuono, quanto al farui cadenza; e per esser in tutto all'opposto del fa di Fa ut in modo alcuno non ponno accommodarsi insieme; poiche esso manca della sua Quinta, nella parte superiore; e perciò tal cadenza si la-scia da parte, perche non può produrre effetto buono nelle Cantilene del sesto Tuono, come ne fanno fede l'opre delli Eccellentissimi Compositori, fra quali non si vede simil cadenza vsarsi da loro. Questa è dun-que la cagione. G. Vero è, che di sommo piacimento m'è stato l'haue-re intesa questa varietà; poscia che mi sarei dato ad intender, che tal ca-denza si fosse potuta far, come quella di G sol re ut, & hauesse deuuto anco render grato l'vdito; nondimeno per più mia intelligenza la prego ad vsar la solita cortesia con vn poco d'essempio. A. La voglio compiace-re, & ecco l'essempio richiestomi. page 69
Si sente la cadenza di G sol re ut, come è di grato vdire; del che cantando si potranno benissimo certificare. G. Io lo vedo, & sento benissimo, mà non si potrebbe far la cadenza nella chorda di E la mi? A. Potreb-besi veramente, ma offenderia grandemente le purgate orecchie. G. E perche? A. La ragione è, che il mi di E la mi è in tutto contrario al se-sto Tuono, quanto al farui cadenza; e per esser in tutto all'opposto del fa di Fa ut in modo alcuno non ponno accommodarsi insieme; poiche esso manca della sua Quinta, nella parte superiore; e perciò tal cadenza si la-scia da parte, perche non può produrre effetto buono nelle Cantilene del sesto Tuono, come ne fanno fede l'opre delli Eccellentissimi Compositori, fra quali non si vede simil cadenza vsarsi da loro. Questa è dun-que la cagione. G. Vero è, che di sommo piacimento m'è stato l'haue-re intesa questa varietà; poscia che mi sarei dato ad intender, che tal ca-denza si fosse potuta far, come quella di G sol re ut, & hauesse deuuto anco render grato l'vdito; nondimeno per più mia intelligenza la prego ad vsar la solita cortesia con vn poco d'essempio. A. La voglio compiace-re, & ecco l'essempio richiestomi. page 69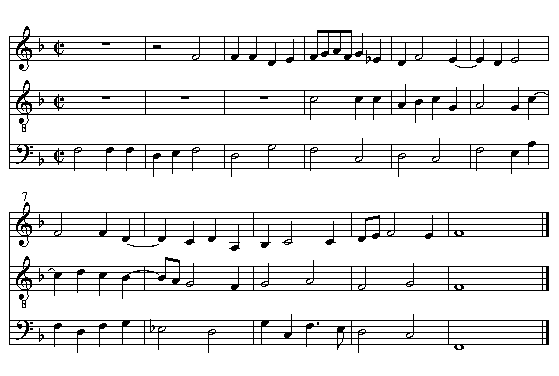 Di quella cadenza fatta in E la mi, e da V. S. desiderata. L'orecchia, come quella, che hà in ciò il Principato, farà il giudicio, alla quale anco simil-mente s'aspetta il giudicar la cadenza cosi di G sol re ut, come della D la sol re, le quali hò soggionte; perche co 'l loro intelletto cantandole, vengano in cognitione, qual d'esse tre faccia miglior effetto nelle compotioni [sic: compositioni]. G. Per quel, che l'intelletto, e l'orecchia mi detta, par di miglior' effetto quella di G sol re ut, e quell'altra di D la sol re, che quella di E la mi. A. Nè vano, anzi è verissimo il suo parere. G. Ben veggio ho-ra, che questa prattica del comporre in Musica, è (quasi dirò) piu della Theorica difficile, già che vado essaminando fra queste varietà di caden-ze la gran prudenza, e consideratione, che necessariamente cader deue nel Compositore, per saper discernere (essendo tutte cadenze fuori de' Tuoni) quale di loro sia di buono effetto nella Compositione, e quale di contrario, & di tristo effetto; e pur non conosco intorno alle consonanze cosa (per dir cosi) brutta, e che i mouimenti di tal cadenza sono fat-ti con bell'ordine di mouimenti cantabili; nè già detta cadenza in vn Tuono fà buona riuscita, se ben la fà poi in vn'altra. A. Tutto pieno è di verità ciò, che dice; perche simil cadenza può seruir nel Terzo, Quar-to, e Settimo Tuono. G. Mà che ci farà certi di questo che hora dice? A. Due ragioni loro ne faranno certi: vna è, che nel Terzo, e Quarto Tuono la chorda di E la mi è principio della Diapente, e Diatessaron, e in essa chorda si troua il suo fine d'ogni cantilena, e del settimo Tuono tal chorda è la medietà del Salmo, & i Compositori (come già altroue sco-persi) si sogliono seruir delli luoghi, doue i Salmi fanno le sue medietà in fargli le sue cadenze, & questa è la prima ragione. La seconda ragione è il giudicio dell'orecchia, qual dà certezza del buono effetto, che produce in detti Tuoni; perche essa non ne viene offesa. G. Dunque si può dire page 70in questa facoltà di comporre in Musica, che il senso dell'vdito, e non la ragione hà luoco. A. Si può dir quasi, che sia cosi; poiche per l'vdito la Musica hà hauuto il suo conoscimento, & hà fatta elettione per mezo di questo dal tristo al buono, e dal buono al migliore. G. Questo causa in me non poca marauiglia, che l'orecchia preuaglia alla ragione. A. Dal-le ragioni, e dalli essempij, che addurrò, mi rendo sicuro, che ne resteran-no chiare rimossa ogni merauiglia. G. Il vedere gli essempij, & inten-derne le ragioni certamente mi fia di sommo fauore. A. Stiano dunque attente, che quanto più attenderanno, tanto meglio il tutto capiranno. Dubbio non è, che queste consonanze in tal modo fatte, ciò è.
Di quella cadenza fatta in E la mi, e da V. S. desiderata. L'orecchia, come quella, che hà in ciò il Principato, farà il giudicio, alla quale anco simil-mente s'aspetta il giudicar la cadenza cosi di G sol re ut, come della D la sol re, le quali hò soggionte; perche co 'l loro intelletto cantandole, vengano in cognitione, qual d'esse tre faccia miglior effetto nelle compotioni [sic: compositioni]. G. Per quel, che l'intelletto, e l'orecchia mi detta, par di miglior' effetto quella di G sol re ut, e quell'altra di D la sol re, che quella di E la mi. A. Nè vano, anzi è verissimo il suo parere. G. Ben veggio ho-ra, che questa prattica del comporre in Musica, è (quasi dirò) piu della Theorica difficile, già che vado essaminando fra queste varietà di caden-ze la gran prudenza, e consideratione, che necessariamente cader deue nel Compositore, per saper discernere (essendo tutte cadenze fuori de' Tuoni) quale di loro sia di buono effetto nella Compositione, e quale di contrario, & di tristo effetto; e pur non conosco intorno alle consonanze cosa (per dir cosi) brutta, e che i mouimenti di tal cadenza sono fat-ti con bell'ordine di mouimenti cantabili; nè già detta cadenza in vn Tuono fà buona riuscita, se ben la fà poi in vn'altra. A. Tutto pieno è di verità ciò, che dice; perche simil cadenza può seruir nel Terzo, Quar-to, e Settimo Tuono. G. Mà che ci farà certi di questo che hora dice? A. Due ragioni loro ne faranno certi: vna è, che nel Terzo, e Quarto Tuono la chorda di E la mi è principio della Diapente, e Diatessaron, e in essa chorda si troua il suo fine d'ogni cantilena, e del settimo Tuono tal chorda è la medietà del Salmo, & i Compositori (come già altroue sco-persi) si sogliono seruir delli luoghi, doue i Salmi fanno le sue medietà in fargli le sue cadenze, & questa è la prima ragione. La seconda ragione è il giudicio dell'orecchia, qual dà certezza del buono effetto, che produce in detti Tuoni; perche essa non ne viene offesa. G. Dunque si può dire page 70in questa facoltà di comporre in Musica, che il senso dell'vdito, e non la ragione hà luoco. A. Si può dir quasi, che sia cosi; poiche per l'vdito la Musica hà hauuto il suo conoscimento, & hà fatta elettione per mezo di questo dal tristo al buono, e dal buono al migliore. G. Questo causa in me non poca marauiglia, che l'orecchia preuaglia alla ragione. A. Dal-le ragioni, e dalli essempij, che addurrò, mi rendo sicuro, che ne resteran-no chiare rimossa ogni merauiglia. G. Il vedere gli essempij, & inten-derne le ragioni certamente mi fia di sommo fauore. A. Stiano dunque attente, che quanto più attenderanno, tanto meglio il tutto capiranno. Dubbio non è, che queste consonanze in tal modo fatte, ciò è.
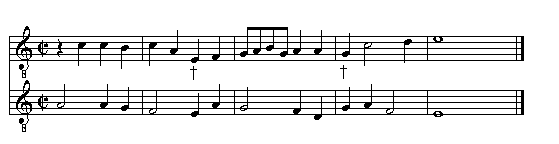 Quando si passa dalla Terza all'vnisono, e cosi dalla Quinta, all'vnisono, sono fatte con ragione, secondo i mouimenti cantabili, & conformi alle regole date, le quali dicono potersi passar dalla Terza all'vnisono, e cosi an-co dalla Quinta all'vnisono; & pur non rendono grato vdire, come nel cantar l'essempio si potranno chiarire, & anco essaminando l'opre d'Eccellentis. Musici di ciò s'accerteranno, posciache non si troua tal modo di passaggij fatto se non rarissime volte, e per qualche occasione d'inuentioni, come si disse nel secondo ragionamento fatto del Ridotto nel Sig. Conte Mario Beui-lacqua da Don Pontio, ragionandosi delli passaggij delle Terza, e Quinta. G. Vero è, che non sono di grato vdire. A. Hora mostrarò in vn altro modo l'istesse consonanze, ciò è, quella parte che và per grado congionto, anderà per salto, e cosi della Quinta, vna si mouerà, e l'altra rimarrà fer-ma, & ambedue faranno grato, & harmonioso vdire, & ecco l'essempio.
Quando si passa dalla Terza all'vnisono, e cosi dalla Quinta, all'vnisono, sono fatte con ragione, secondo i mouimenti cantabili, & conformi alle regole date, le quali dicono potersi passar dalla Terza all'vnisono, e cosi an-co dalla Quinta all'vnisono; & pur non rendono grato vdire, come nel cantar l'essempio si potranno chiarire, & anco essaminando l'opre d'Eccellentis. Musici di ciò s'accerteranno, posciache non si troua tal modo di passaggij fatto se non rarissime volte, e per qualche occasione d'inuentioni, come si disse nel secondo ragionamento fatto del Ridotto nel Sig. Conte Mario Beui-lacqua da Don Pontio, ragionandosi delli passaggij delle Terza, e Quinta. G. Vero è, che non sono di grato vdire. A. Hora mostrarò in vn altro modo l'istesse consonanze, ciò è, quella parte che và per grado congionto, anderà per salto, e cosi della Quinta, vna si mouerà, e l'altra rimarrà fer-ma, & ambedue faranno grato, & harmonioso vdire, & ecco l'essempio.
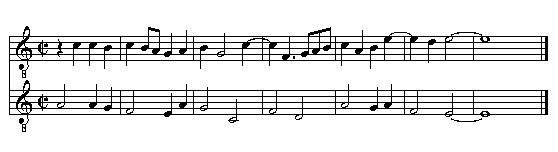 page 71G. Dice il vero. A. Dicami (la prego) non è il medesimo passare dal-la Terza all'vnisono, e cosi dalla Quinta all'vnisono? come nel primo es-sempio si troua, e solo si varia il Mouimento. G. Egli è il vero. A. Di-mando adunque, che le fà certe del miglior effetto d'vn passaggio dell'al-tro, fuorche il giudicio dell'orecchia? G. Non altro veramente, poscia-che l'hanno mostrato i duoi essempij dalla Terza all'vnisono, e cosi anco dalla Quinta all'vnisono. A. Si potrà dunque dir, che in questa prattica del comporre in Musica l'orecchia ottenga il Prencipiato nel giudicar le cose di buono, ò di reo effetto nelle compositioni. Nè già si può dire al-trimente, essendo che il passare dalla Terza all'vnisono non si può dire con verità, che stia male, ne anco dalla Quinta all'vnisono; mà non è già il primo causa di buono effetto, posto in quella maniera, quando amen-due le parti discenderanno; e cosi parlando del mouimento fatto dalla Quinta all'vnisono, vna parte ascendendo, e l'altro descendendo; e pari-mente dicasi delli altri passaggij, che fanno le parti insieme, le quali non rendono nelle Compositioni harmonia alcuna. E conseguentemente del-le cadenze sopranomate, questo è stato veramente giudicio dell'orec-chia, & è meritatamente suo questo honore, posciache ella è stata giudice dal buono al reo. G. Mi piace assai l'hauer intesa questa ragione; ne di minor piacimento mi sarebbe, se ci dicesse il modo, per cui questo senso dell'vdito, facendo il giudicio del discernere il buono dal tristo, non commetta errore alcuno. A. Diuerse cose vi concorrono. Prima necessa-ria cosa è la fatica intorno al cantar varie compositioni de' Musici Eccel-lentissimi. Vi conuiene anco l'essercitarsi nel contraponto, e passando al-la compositione comporre cose diuerse; e cantandole poi darle audienza diligentemente per saper se le consonanze poste insieme producono buona harmonia, e grato vdire, e se son poste regolatamente. Di più si deue attentamente vdire, se le parti vanno commodamente per legitimi inter-ualli, e se fra loro si sentono mouimenti, ò concenti, che offendano l'orec-chia. Onde da simili essercitij si viene à ridur l'orecchia à tal perfettio-ne, che non può patire, se non cose perfette, buone, & harmoniose. Et se d'altra sorte se le offeriscono, tosto giudica, che simili concenti non sono nè buoni, nè harmoniosi. G. Credo per vero ciò, che hà detto; mà, che anco non sia men vero, stimo, che non tosto tosto si riduca à perfettione il giudicio dell'orecchia. A. Non vi è dubbio, essendo necessario prima, che si gionga à qualche perfettione di contrapunto, & al comporre qualche cosa di buona riuscira, l'hauer fatte cose molte, e diuerse, & l'hauerne vdite altrettante de' periti di Musica. Ilche tutto porta seco e mesi, & an-ni, e fatica non poca, la quale pure necessariamente deue esser sopporta-ta, da chi intende di giongere ad vna certa meta di perfettione; ch'altri-page 72menti non si potrebbero scegliere i passaggij buoni, e non buoni. G. Ve-ramente mi dò ad intendere, che tutte le scienze richiedano studio, e fatica assai, mà più questa d'ogni altra. A. Cosi stà à punto. H. Hor ben mi comincia à cader nell'animo, che più difficoltà apporti seco la pratti-ca del comporre in Musica, che la Theorica; posciache da quel, che m'ha significato, molte ve ne scorgo prima, che si gionga à qualche perfettio-ne di comporre. A. Si pensano forsi, che vi concorrino solo quei pochi auuertimenti, che hò detto? M. Ve ne sarebbero per caso ancor delli altri? A. Si ponno quasi dir infiniti gli auuertimenti necessarij da sapersi al Compositor di Musica. M. Deh la preghiamo accresca à gli altri obli-ghi, che le teniamo ancor questo, che serà co 'l fauorirne di scoprir alcune delle rimanenti difficoltà. A. Volentieri loro compiacerò, e le propone-rò, se non in tutto (che è impossibile) almeno in parte, fra le quali stà questa; che conuiene al compositore star'auuertito per non cader in mouimenti, che cantar non si possano, ne se ne senta alcuno fra le parti, che non faccia buona relatione, e grato vdire, come dissi. Conuiene di più l'esser diligente, e proceder non senza consideratione nell'accommodar le parole sotto alle figure, ciò è, che non vi si trouino figure super-flue, e talmente siano accommodate, che vengano à conseruar la sua na-tura dell'esser breui, ò longhe. Si deue etiandio osseruare (se è possibile) ch'essendo la compositione à quattro, à cinque, & à più voci, vi si ritroui le consonanze, ciò è, la Terza, e la Quinta. Vero è, che questo non è lege inuiolabile; perche cantando quattro, ò cinque parti, e non trouandosi in esse per caso le consonanze già dette, non sarebbe errore, quando però si vedessero le parti far qualche bell'effetto d'inuentione, e dar principio à nuoua inuentione, ouer quando alcuna parte si mouesse con qualche leggiadro mouimento di semiminime, od altre figure, perche se bene non si trouasse nella compositione vna delle sopranomate consonanze, non impor-tarebbe: ma fuori di simili occasioni serà bene il trouarsi dette consonan-ze. E necessario ancora l'osseruar, che le compositioni finiscano in misu-ra, secondo il modo, ò tempo, ò prolatione, à cui seranno fatte tali com-positioni. M. Questo, c'hor essa dice, è degno di consideratione? A. Si-gnor sì; anzi è commandamento, e lege espressa. Nè si admette compo-sitione alcuna (secondo gli intelligenti di questa scienza) che non finisca in misura conforme à quello, à che serà fatta. E vedendosi vna composi-tione co 'l perfetto, ò l'imperfetto tempo; ò co 'l maggiore, ò minor modo; ouer anco con la prolatione maggior, e senza misura nel fine fatta, stima-rebbesi l'auttore poco intendente, e mal prattico di questa scienza. Hora mi persuado, che chiaro le sia, se ciò è degno di consideratione. M. E chiaro veramente; però esserciti pure la sua solita cortesia nel se-page 73guire. A. Di più conuiensi hauer intelligenza di passar da vna all'altra consonanza con l'osseruationi hoggidì solite à farsi da' Compositori moderni. M. Mi pare oscuro questo suo dire. Laonde la prego à mostrar-ne quel fauore, che sin'hor ne ha mostrato, co 'l renderlo più chiaro, poi-che di quello, che sin'hor ci ha detto siamo benissimo instrutti. A. Lo renderò più chiaro, & anco (essendo lor in piacimento) mostrarò il tutto con essempio. M. Il mostrarne gli essempij oltre le parole per mag-gior nostra intelligenza, ci serà gratia singolare. A. Farò dunque quanto loro piace; e cominciarò dalla Terza minore, auuertendo, che 'l suo pro-prio è di passar all'vnisono per principio di Misura, mouendosi amendue le parti per mouimento congionto, vna ascendente, e l'altra descendente, ouer vna descendente per grado disgiunto in eleuatione della misura, e non facendo l'altra mouimento alcuno, come con questo essempio scoprirò il tutto.
page 71G. Dice il vero. A. Dicami (la prego) non è il medesimo passare dal-la Terza all'vnisono, e cosi dalla Quinta all'vnisono? come nel primo es-sempio si troua, e solo si varia il Mouimento. G. Egli è il vero. A. Di-mando adunque, che le fà certe del miglior effetto d'vn passaggio dell'al-tro, fuorche il giudicio dell'orecchia? G. Non altro veramente, poscia-che l'hanno mostrato i duoi essempij dalla Terza all'vnisono, e cosi anco dalla Quinta all'vnisono. A. Si potrà dunque dir, che in questa prattica del comporre in Musica l'orecchia ottenga il Prencipiato nel giudicar le cose di buono, ò di reo effetto nelle compositioni. Nè già si può dire al-trimente, essendo che il passare dalla Terza all'vnisono non si può dire con verità, che stia male, ne anco dalla Quinta all'vnisono; mà non è già il primo causa di buono effetto, posto in quella maniera, quando amen-due le parti discenderanno; e cosi parlando del mouimento fatto dalla Quinta all'vnisono, vna parte ascendendo, e l'altro descendendo; e pari-mente dicasi delli altri passaggij, che fanno le parti insieme, le quali non rendono nelle Compositioni harmonia alcuna. E conseguentemente del-le cadenze sopranomate, questo è stato veramente giudicio dell'orec-chia, & è meritatamente suo questo honore, posciache ella è stata giudice dal buono al reo. G. Mi piace assai l'hauer intesa questa ragione; ne di minor piacimento mi sarebbe, se ci dicesse il modo, per cui questo senso dell'vdito, facendo il giudicio del discernere il buono dal tristo, non commetta errore alcuno. A. Diuerse cose vi concorrono. Prima necessa-ria cosa è la fatica intorno al cantar varie compositioni de' Musici Eccel-lentissimi. Vi conuiene anco l'essercitarsi nel contraponto, e passando al-la compositione comporre cose diuerse; e cantandole poi darle audienza diligentemente per saper se le consonanze poste insieme producono buona harmonia, e grato vdire, e se son poste regolatamente. Di più si deue attentamente vdire, se le parti vanno commodamente per legitimi inter-ualli, e se fra loro si sentono mouimenti, ò concenti, che offendano l'orec-chia. Onde da simili essercitij si viene à ridur l'orecchia à tal perfettio-ne, che non può patire, se non cose perfette, buone, & harmoniose. Et se d'altra sorte se le offeriscono, tosto giudica, che simili concenti non sono nè buoni, nè harmoniosi. G. Credo per vero ciò, che hà detto; mà, che anco non sia men vero, stimo, che non tosto tosto si riduca à perfettione il giudicio dell'orecchia. A. Non vi è dubbio, essendo necessario prima, che si gionga à qualche perfettione di contrapunto, & al comporre qualche cosa di buona riuscira, l'hauer fatte cose molte, e diuerse, & l'hauerne vdite altrettante de' periti di Musica. Ilche tutto porta seco e mesi, & an-ni, e fatica non poca, la quale pure necessariamente deue esser sopporta-ta, da chi intende di giongere ad vna certa meta di perfettione; ch'altri-page 72menti non si potrebbero scegliere i passaggij buoni, e non buoni. G. Ve-ramente mi dò ad intendere, che tutte le scienze richiedano studio, e fatica assai, mà più questa d'ogni altra. A. Cosi stà à punto. H. Hor ben mi comincia à cader nell'animo, che più difficoltà apporti seco la pratti-ca del comporre in Musica, che la Theorica; posciache da quel, che m'ha significato, molte ve ne scorgo prima, che si gionga à qualche perfettio-ne di comporre. A. Si pensano forsi, che vi concorrino solo quei pochi auuertimenti, che hò detto? M. Ve ne sarebbero per caso ancor delli altri? A. Si ponno quasi dir infiniti gli auuertimenti necessarij da sapersi al Compositor di Musica. M. Deh la preghiamo accresca à gli altri obli-ghi, che le teniamo ancor questo, che serà co 'l fauorirne di scoprir alcune delle rimanenti difficoltà. A. Volentieri loro compiacerò, e le propone-rò, se non in tutto (che è impossibile) almeno in parte, fra le quali stà questa; che conuiene al compositore star'auuertito per non cader in mouimenti, che cantar non si possano, ne se ne senta alcuno fra le parti, che non faccia buona relatione, e grato vdire, come dissi. Conuiene di più l'esser diligente, e proceder non senza consideratione nell'accommodar le parole sotto alle figure, ciò è, che non vi si trouino figure super-flue, e talmente siano accommodate, che vengano à conseruar la sua na-tura dell'esser breui, ò longhe. Si deue etiandio osseruare (se è possibile) ch'essendo la compositione à quattro, à cinque, & à più voci, vi si ritroui le consonanze, ciò è, la Terza, e la Quinta. Vero è, che questo non è lege inuiolabile; perche cantando quattro, ò cinque parti, e non trouandosi in esse per caso le consonanze già dette, non sarebbe errore, quando però si vedessero le parti far qualche bell'effetto d'inuentione, e dar principio à nuoua inuentione, ouer quando alcuna parte si mouesse con qualche leggiadro mouimento di semiminime, od altre figure, perche se bene non si trouasse nella compositione vna delle sopranomate consonanze, non impor-tarebbe: ma fuori di simili occasioni serà bene il trouarsi dette consonan-ze. E necessario ancora l'osseruar, che le compositioni finiscano in misu-ra, secondo il modo, ò tempo, ò prolatione, à cui seranno fatte tali com-positioni. M. Questo, c'hor essa dice, è degno di consideratione? A. Si-gnor sì; anzi è commandamento, e lege espressa. Nè si admette compo-sitione alcuna (secondo gli intelligenti di questa scienza) che non finisca in misura conforme à quello, à che serà fatta. E vedendosi vna composi-tione co 'l perfetto, ò l'imperfetto tempo; ò co 'l maggiore, ò minor modo; ouer anco con la prolatione maggior, e senza misura nel fine fatta, stima-rebbesi l'auttore poco intendente, e mal prattico di questa scienza. Hora mi persuado, che chiaro le sia, se ciò è degno di consideratione. M. E chiaro veramente; però esserciti pure la sua solita cortesia nel se-page 73guire. A. Di più conuiensi hauer intelligenza di passar da vna all'altra consonanza con l'osseruationi hoggidì solite à farsi da' Compositori moderni. M. Mi pare oscuro questo suo dire. Laonde la prego à mostrar-ne quel fauore, che sin'hor ne ha mostrato, co 'l renderlo più chiaro, poi-che di quello, che sin'hor ci ha detto siamo benissimo instrutti. A. Lo renderò più chiaro, & anco (essendo lor in piacimento) mostrarò il tutto con essempio. M. Il mostrarne gli essempij oltre le parole per mag-gior nostra intelligenza, ci serà gratia singolare. A. Farò dunque quanto loro piace; e cominciarò dalla Terza minore, auuertendo, che 'l suo pro-prio è di passar all'vnisono per principio di Misura, mouendosi amendue le parti per mouimento congionto, vna ascendente, e l'altra descendente, ouer vna descendente per grado disgiunto in eleuatione della misura, e non facendo l'altra mouimento alcuno, come con questo essempio scoprirò il tutto.
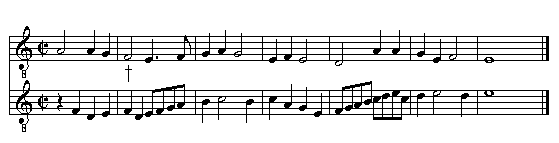 Hora soggiongo la Terza maggiore, il cui proprio serà di passare alla Quinta: facendo la Terza maggiore mouimento congionto ascendendo, e la parte bassa mouimento congionto discendendo. Si potrà ancor pas-sar dalla Terza all'Ottaua; e questo fia, quando la superiore farà, ascendendo, il mouimento congionto, e la parte bassa il mouimento disgionto, co-me ciò farà chiaro il presente essempio.
Hora soggiongo la Terza maggiore, il cui proprio serà di passare alla Quinta: facendo la Terza maggiore mouimento congionto ascendendo, e la parte bassa mouimento congionto discendendo. Si potrà ancor pas-sar dalla Terza all'Ottaua; e questo fia, quando la superiore farà, ascendendo, il mouimento congionto, e la parte bassa il mouimento disgionto, co-me ciò farà chiaro il presente essempio.
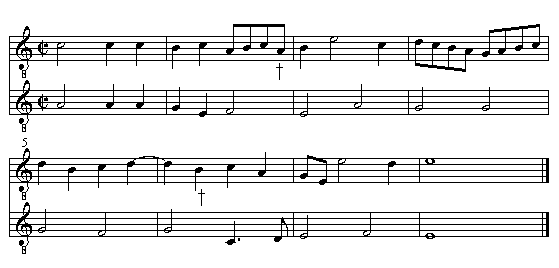 M. Dicami (la prego) per la sua vsata cortesia; perche non poss'io an-dare all'vnisono, come faccio della Terza minore con amendue le parti page 74con mouimento congionto, vna ascendente, & l'altra discendente? A. La compiacerò, di quanto mi chiede. è regola, & osseruatione gene-rale, che sempre si deue da vna consonanza passare alla sua più propin-qua. E, perche la Terza minore contiene in se vn Tuono, & vn semituo-no, è cosa ragioneuole, che si passi (come già hò detto) all'vnisono, per esser più vicino, ch'altra consonanza. La Terza maggiore poi si tro-ua hauere in se duoi Tuoni; onde conuiene andare alla Quinta, come consonanza à lei più vicina, e non all'vnisono. Questa è dunque la ra-gione, perche non si può passare dalla Terza maggiore all'vnisono in quella forma, che si fà con la Terza minore, secondo l'ordine de' moder-ni Compositori. M. Non si sdegni di gratia di dirmi, se il non poter passar ad altra consonanza, che alla Quinta, & all'Ottaua, è legge inuiola-bile. A. Signor mio nò. M. E doue si potrà passare? A. Si potrà pas-sare alla Sesta minore, & maggiore (& il simile si può far della Terza minore) come porterà l'occasione, & il mouimento delle parti, confor-me à quel, che disse Pietro Pontio, nel secondo ragionamento fatto nel Ridotto del Sig. Conte Marco Beuilacqua. M. S'è con suo commodo, non manchi (la prego) di darne vn poco d'essempio della Terza minore, come della Terza maggiore, che meglio verremo capaci del sodetto suo ragionamento. A. Eccolo per non mancar del mio solito.
M. Dicami (la prego) per la sua vsata cortesia; perche non poss'io an-dare all'vnisono, come faccio della Terza minore con amendue le parti page 74con mouimento congionto, vna ascendente, & l'altra discendente? A. La compiacerò, di quanto mi chiede. è regola, & osseruatione gene-rale, che sempre si deue da vna consonanza passare alla sua più propin-qua. E, perche la Terza minore contiene in se vn Tuono, & vn semituo-no, è cosa ragioneuole, che si passi (come già hò detto) all'vnisono, per esser più vicino, ch'altra consonanza. La Terza maggiore poi si tro-ua hauere in se duoi Tuoni; onde conuiene andare alla Quinta, come consonanza à lei più vicina, e non all'vnisono. Questa è dunque la ra-gione, perche non si può passare dalla Terza maggiore all'vnisono in quella forma, che si fà con la Terza minore, secondo l'ordine de' moder-ni Compositori. M. Non si sdegni di gratia di dirmi, se il non poter passar ad altra consonanza, che alla Quinta, & all'Ottaua, è legge inuiola-bile. A. Signor mio nò. M. E doue si potrà passare? A. Si potrà pas-sare alla Sesta minore, & maggiore (& il simile si può far della Terza minore) come porterà l'occasione, & il mouimento delle parti, confor-me à quel, che disse Pietro Pontio, nel secondo ragionamento fatto nel Ridotto del Sig. Conte Marco Beuilacqua. M. S'è con suo commodo, non manchi (la prego) di darne vn poco d'essempio della Terza minore, come della Terza maggiore, che meglio verremo capaci del sodetto suo ragionamento. A. Eccolo per non mancar del mio solito.
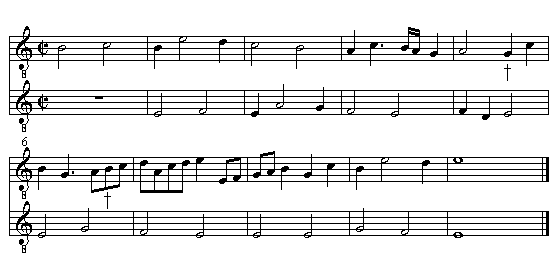 Vedono, che fatta la Terza minore si passa alla Sesta minore, e cosi pari-mente fatta la Terza maggiore alla Sesta maggiore, quali mouimento so-no e regolati, e moderni. M. Non si potrebbe andar dalla Terza mino-re alla Quinta, nel modo, che fà la Terza maggiore? A. Si potrebbe; mà non seria passaggio legitimo. M. Perche? A. La ragione è, perche il diligente cantore sentendo quella Terza diminuita d'vn semituono, la crescerà d'vn semituono per appagar l'orecchia. Ilche serà, quando doppo page 75fatta la Terza minore la susseguente figura ascenderà. M. In ciò dun-que conuiene sodisfare all'vdito, per quanto posso cauar dalle sue paro-le. A. E cosi à punto; e da lor stessi nel cantar tal mouimento se ne po-tranno render chiari. M. Il credo. Siche questa Terza minore haurà duoi moti soli, vno all'vnisono, e l'altro alla Sesta minore, e 'l passaggio d'an-dar alla Quinta si lasciarà da banda; ilche fia, quando anderà ascendente per moto congionto. Mà all'hor, che discenderà la figura, si potrà far tal passaggio? A. Signor mio sì. M. Pregola à voler compiacerne di dir qual sia la cagione, che discendendo si fà, & ascendendo si tralascia. A. Già hò detto, che ascendendo il diligente cantore l'accrescerà per contentar l'orecchia. M. Non potrebbe far il medesimo, quando la figu-ra discende? A. Questo non giamai; perche fra Compositori Eccel-lentissimi (& è conforme all'ordine de' moderni) non si permette, che sia cresciuta la figura nel discendere, mà nell'ascender solo; come essami-nando le loro compositioni si potranno assicurar di questo dubbio. Et questa è l'osseruanza di porre la Terza minore, secondo l'ordine de' Mu-sici moderni, per render nelle cantilene grato vdire, e schifar ogni errore. M. Di questa Terza son fatto assai possessore, & della ragione, perche non si conuenga l'andare alla Quinta: ma se vna parte si trouarà in ot-taua con essa Terza minore, & vna passarà alla Quinta, e l'altra all'vniso-no, come potrà farsi tal mouimento, che sia di grato effetto? A. Lo dirò. E cosa certa, che non fia d'alcun buon'effetto; poscia che vno accrescerà quella Terza, e l'altro la lasciarà nel suo primo stato; Onde ne verrebbe vn'Ottaua superflua. Ma dal diligente, & accurato Compositore farassi, che non si trouarà parte alcuna per Ottaua con detta Terza, quando ascende alla Quinta per vietarne il disordine. M. Per non esser molto istrut-to di questo, ne senteuo tra me qualche contrasto; mà hora che chiara-mente il veggio, necessaria cosa stimo l'hauer risguardo in diuerse maniere, come la compositione fia purgata d'ogni errore, & faccia buona har-monia. Però potrà (se cosi le piace) passar à quelli altri auuertimenti, che già di questi duoi con mio sommo contento son fatto capace à ba-stanza. A. Cosi farò dicendo della Sesta minore, della quale il moto proprio serà di passare alla Quinta, & alla Terza ancora con buona occa-sione. M. Non potrò io con l'occasione andar'alla Ottaua? A. A que-sto rispondo, che si troua vn passaggio, che fa lecito il passar dalla Sesta minore alla Ottaua; & questo è, quando vna parte resta ferma, e l'altra mouendosi (fatta che serà la detta Sesta) se ne và all'Ottaua; ma facen-do moto tutte le parti, e trouandosi per principio di misura in Ottaua, il passaggio non le è concesso conforme all'osseruationi de' Musici, e Compositori moderni. M. Perdonami V. S. io non la intendo in questo. però, page 76se ricorrerà secondo la solita cortesia à vn poco d'essempio, non parlarà à sordo, & io la intenderò. e quanto più facilmente, tanto più le ne serò obligato. A. Cosi farò: & ecco vn'essempio d'ambigui gli passaggij del-la Sesta minore.
Vedono, che fatta la Terza minore si passa alla Sesta minore, e cosi pari-mente fatta la Terza maggiore alla Sesta maggiore, quali mouimento so-no e regolati, e moderni. M. Non si potrebbe andar dalla Terza mino-re alla Quinta, nel modo, che fà la Terza maggiore? A. Si potrebbe; mà non seria passaggio legitimo. M. Perche? A. La ragione è, perche il diligente cantore sentendo quella Terza diminuita d'vn semituono, la crescerà d'vn semituono per appagar l'orecchia. Ilche serà, quando doppo page 75fatta la Terza minore la susseguente figura ascenderà. M. In ciò dun-que conuiene sodisfare all'vdito, per quanto posso cauar dalle sue paro-le. A. E cosi à punto; e da lor stessi nel cantar tal mouimento se ne po-tranno render chiari. M. Il credo. Siche questa Terza minore haurà duoi moti soli, vno all'vnisono, e l'altro alla Sesta minore, e 'l passaggio d'an-dar alla Quinta si lasciarà da banda; ilche fia, quando anderà ascendente per moto congionto. Mà all'hor, che discenderà la figura, si potrà far tal passaggio? A. Signor mio sì. M. Pregola à voler compiacerne di dir qual sia la cagione, che discendendo si fà, & ascendendo si tralascia. A. Già hò detto, che ascendendo il diligente cantore l'accrescerà per contentar l'orecchia. M. Non potrebbe far il medesimo, quando la figu-ra discende? A. Questo non giamai; perche fra Compositori Eccel-lentissimi (& è conforme all'ordine de' moderni) non si permette, che sia cresciuta la figura nel discendere, mà nell'ascender solo; come essami-nando le loro compositioni si potranno assicurar di questo dubbio. Et questa è l'osseruanza di porre la Terza minore, secondo l'ordine de' Mu-sici moderni, per render nelle cantilene grato vdire, e schifar ogni errore. M. Di questa Terza son fatto assai possessore, & della ragione, perche non si conuenga l'andare alla Quinta: ma se vna parte si trouarà in ot-taua con essa Terza minore, & vna passarà alla Quinta, e l'altra all'vniso-no, come potrà farsi tal mouimento, che sia di grato effetto? A. Lo dirò. E cosa certa, che non fia d'alcun buon'effetto; poscia che vno accrescerà quella Terza, e l'altro la lasciarà nel suo primo stato; Onde ne verrebbe vn'Ottaua superflua. Ma dal diligente, & accurato Compositore farassi, che non si trouarà parte alcuna per Ottaua con detta Terza, quando ascende alla Quinta per vietarne il disordine. M. Per non esser molto istrut-to di questo, ne senteuo tra me qualche contrasto; mà hora che chiara-mente il veggio, necessaria cosa stimo l'hauer risguardo in diuerse maniere, come la compositione fia purgata d'ogni errore, & faccia buona har-monia. Però potrà (se cosi le piace) passar à quelli altri auuertimenti, che già di questi duoi con mio sommo contento son fatto capace à ba-stanza. A. Cosi farò dicendo della Sesta minore, della quale il moto proprio serà di passare alla Quinta, & alla Terza ancora con buona occa-sione. M. Non potrò io con l'occasione andar'alla Ottaua? A. A que-sto rispondo, che si troua vn passaggio, che fa lecito il passar dalla Sesta minore alla Ottaua; & questo è, quando vna parte resta ferma, e l'altra mouendosi (fatta che serà la detta Sesta) se ne và all'Ottaua; ma facen-do moto tutte le parti, e trouandosi per principio di misura in Ottaua, il passaggio non le è concesso conforme all'osseruationi de' Musici, e Compositori moderni. M. Perdonami V. S. io non la intendo in questo. però, page 76se ricorrerà secondo la solita cortesia à vn poco d'essempio, non parlarà à sordo, & io la intenderò. e quanto più facilmente, tanto più le ne serò obligato. A. Cosi farò: & ecco vn'essempio d'ambigui gli passaggij del-la Sesta minore.
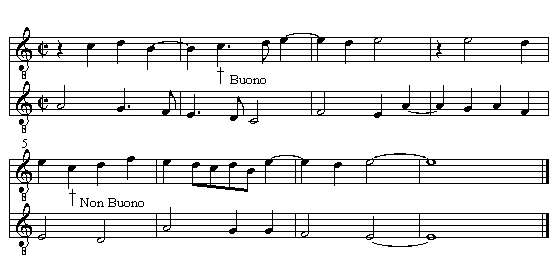 Eccoui il primo modo, con che si può andar dalla Sesta alla Ottaua. Ma il secondo modo è quello, che non le viene concesso secondo i Compositori moderni, come nell'essaminar le lor compositioni s'accertaranno di quanto hò detto. Già hanno intesa, e veduta la cagione, perche non si per-mette, che fatta la Sesta si passi all'ottaua, essendo le parti per principio di misura. Hor breuemente dirò della Sesta maggiore, il cui proprio serà di passare all'Ottaua, vna ascendendo, & l'altra discendendo. Ilche serà secondo la regola de' moderni. M. Dicami di gratia, non potrà far'altro passaggio? A. Potrà pigliar alcuni di quelli passaggij, come accade alla Terza, & alla Quinta, per fare qualche varietà d'inuentione, come si dis-se, da Pietro Pontio, nel secondo ragionamento nel Ridotto del Sig. Con-te Mario Beuilacqua. Et questi sono i passaggij, che regolatamente si potranno far della Sesta maggiore con le sopradette consonanze. Vero è, ch'alcuni non permettono, che doppo l'istessa Sesta si passi alla Quinta. Con tutto ciò (quanto à me) non gli farei difficoltà alcuna; mentre con buona occasione facesse tal mouimento, e rendesse vaga, e diletteuo-le la Compositione. Mà per passar ad altri auuertimenti, hora scoprirò, come si deue hauer consideratione nel ponere il b ritondo nelle compo-sitioni, e parimente queste virgolette
Eccoui il primo modo, con che si può andar dalla Sesta alla Ottaua. Ma il secondo modo è quello, che non le viene concesso secondo i Compositori moderni, come nell'essaminar le lor compositioni s'accertaranno di quanto hò detto. Già hanno intesa, e veduta la cagione, perche non si per-mette, che fatta la Sesta si passi all'ottaua, essendo le parti per principio di misura. Hor breuemente dirò della Sesta maggiore, il cui proprio serà di passare all'Ottaua, vna ascendendo, & l'altra discendendo. Ilche serà secondo la regola de' moderni. M. Dicami di gratia, non potrà far'altro passaggio? A. Potrà pigliar alcuni di quelli passaggij, come accade alla Terza, & alla Quinta, per fare qualche varietà d'inuentione, come si dis-se, da Pietro Pontio, nel secondo ragionamento nel Ridotto del Sig. Con-te Mario Beuilacqua. Et questi sono i passaggij, che regolatamente si potranno far della Sesta maggiore con le sopradette consonanze. Vero è, ch'alcuni non permettono, che doppo l'istessa Sesta si passi alla Quinta. Con tutto ciò (quanto à me) non gli farei difficoltà alcuna; mentre con buona occasione facesse tal mouimento, e rendesse vaga, e diletteuo-le la Compositione. Mà per passar ad altri auuertimenti, hora scoprirò, come si deue hauer consideratione nel ponere il b ritondo nelle compo-sitioni, e parimente queste virgolette  chiamate volgarmente diesis. M. Di gratia, le ne supplico. A. Si pone il b ritondo nella chorda di B fa b mi per accidente, essendo la Cantilena per
chiamate volgarmente diesis. M. Di gratia, le ne supplico. A. Si pone il b ritondo nella chorda di B fa b mi per accidente, essendo la Cantilena per  quadro, & ancora nella chorda di E la mi, essendo la Cantilena per b molle, auuertendo, che doppo il b ritondo, quella figura, che lo segue, conuiene, che di-scenda, & non altrimente. Il contrario poi s'osserua,, [sic: ,] essendo poste ne page 77compositione quelle virgole
quadro, & ancora nella chorda di E la mi, essendo la Cantilena per b molle, auuertendo, che doppo il b ritondo, quella figura, che lo segue, conuiene, che di-scenda, & non altrimente. Il contrario poi s'osserua,, [sic: ,] essendo poste ne page 77compositione quelle virgole  sotto à qualche figura; perche conuiene che quella figura, che le segue, vada ascendendo, altrimente non ser-uarebbesi l'ordine del comporre regolatamente, e giudiciosamente. M. Di sommo contento ci sarebbe il sapere la cagione, perche nel b ritondo conuiene, che la figura, che le segue, discenda, & nelle virgole la seguente figura ascenda. A. Altra non è la cagione, che il commodo del cantore, & ancora; perche cosi ricerca il modo del comporre giudicio-samente. Hanno di già visto, quante considerationi sono necessarie, per-che la compositione sia regolata, e faccia buona harmonia, e le diuerse cause producitrice di varietà fra Compositori. M. Veramente conosco, che conuiene l'esser'in molte cose auuertito; e l'assicuro, che l'hauer'inteso le cause della varietà fra Compositori ci è stato di grandissima consola-tione. Ma dicami i Sig. Giordano la causa; perche il Sig. Conte nostro non hà fatta mentione della consonanza Quarta, hauendo nominate tutte l'altre consonanze. G. Credo perche non è consonanza. M. Come nò? E, & mi perdoni in errore; &, che sia il vero, Boetio nel secondo li-bro della Arithmetica nel cap. 48. La chiama la principale delle conso-nanze, e nel libro primo della sua Musica nel cap. decimo, e decimosesto la pone fra le consonanze. Vitruuio nel libro Quinto al Quarto capo numera la Quarta fra le consonanze. Franchino parimente nel libro in-titolato Angelicum, & diuinum opus, nel secondo Trattato nel capitolo sesto la chiama consonanza. E parimente esso Franchino nella sua Theo-rica nel primo libro all'ottauo capo la connumera fra le consonanze. Nè si discosto il Zarlino da questa opinione nella Terza parte delle institu-tioni al capitolo Quinto, e nel capitolo decimoquarto, & anco nel capitolo quadragesimo settimo; che la pose fra le consonanze. Et altri Scritto-ri hanno fatto il simile, i quali (per non l'annoiare) tralascio. Può ben hor veder, come assai è in errore, se pensa, ò stima altrimenti. G. Per l'auttorita de' Scrittori famosi, e degni di fede tanto antichi, quanto moderni V. S. ha mostrato, che la Quarta è consonanze; & io per l'auttorità delli stessi, & altri degni scrittori, e per le ragioni, che addurrò, le farò ve-der, ch'ella è dissonanza; fra quali scrittori è Franchino nel Quarto trat-tato del libro, ch'essa m'ha allegato nel secondo capitolo, oue dice queste parole.
sotto à qualche figura; perche conuiene che quella figura, che le segue, vada ascendendo, altrimente non ser-uarebbesi l'ordine del comporre regolatamente, e giudiciosamente. M. Di sommo contento ci sarebbe il sapere la cagione, perche nel b ritondo conuiene, che la figura, che le segue, discenda, & nelle virgole la seguente figura ascenda. A. Altra non è la cagione, che il commodo del cantore, & ancora; perche cosi ricerca il modo del comporre giudicio-samente. Hanno di già visto, quante considerationi sono necessarie, per-che la compositione sia regolata, e faccia buona harmonia, e le diuerse cause producitrice di varietà fra Compositori. M. Veramente conosco, che conuiene l'esser'in molte cose auuertito; e l'assicuro, che l'hauer'inteso le cause della varietà fra Compositori ci è stato di grandissima consola-tione. Ma dicami i Sig. Giordano la causa; perche il Sig. Conte nostro non hà fatta mentione della consonanza Quarta, hauendo nominate tutte l'altre consonanze. G. Credo perche non è consonanza. M. Come nò? E, & mi perdoni in errore; &, che sia il vero, Boetio nel secondo li-bro della Arithmetica nel cap. 48. La chiama la principale delle conso-nanze, e nel libro primo della sua Musica nel cap. decimo, e decimosesto la pone fra le consonanze. Vitruuio nel libro Quinto al Quarto capo numera la Quarta fra le consonanze. Franchino parimente nel libro in-titolato Angelicum, & diuinum opus, nel secondo Trattato nel capitolo sesto la chiama consonanza. E parimente esso Franchino nella sua Theo-rica nel primo libro all'ottauo capo la connumera fra le consonanze. Nè si discosto il Zarlino da questa opinione nella Terza parte delle institu-tioni al capitolo Quinto, e nel capitolo decimoquarto, & anco nel capitolo quadragesimo settimo; che la pose fra le consonanze. Et altri Scritto-ri hanno fatto il simile, i quali (per non l'annoiare) tralascio. Può ben hor veder, come assai è in errore, se pensa, ò stima altrimenti. G. Per l'auttorita de' Scrittori famosi, e degni di fede tanto antichi, quanto moderni V. S. ha mostrato, che la Quarta è consonanze; & io per l'auttorità delli stessi, & altri degni scrittori, e per le ragioni, che addurrò, le farò ve-der, ch'ella è dissonanza; fra quali scrittori è Franchino nel Quarto trat-tato del libro, ch'essa m'ha allegato nel secondo capitolo, oue dice queste parole. eccetto la Quarta, le cui estreme parti discordano.e nel libro se-condo della sua Theorica nel Capitolo Quinto, oue dice.
Non igitur au-ribus consonat Diapason cum Diatessaron,intendendo doppo, e non fra l'ottaua, e nel libro terzo della sua prattica al secondo capitolo, dice, che ponendola sola (ciò è) facendola con due parti sole è dissonante. Il Zarlino nella terza parte delle institutioni nel capitolo 42. à carte 197. La pone tra le dissonanze; e nel capitolo 66. nella terza parte di esse institutioni à page 78carte 263, la chiama dissonanza; e parimente nel capitolo 32. della Quarta parte, parlando, come si deue far la compositione à compiacenza delle parole, dice, che, quando le parole significheranno durezza, asprezza, crudeltà, si potrà vsare la Quarta, & ancora la Settima, si che per queste pa-role inferisce la Quarta esser dissonanza co 'l farla simile alla settima. Da Pietro Aron nel secondo libro della sua Musica intitolato il Toscanello nel capitolo decimoterzo non si vede in alcun modo nominata la Quar-ta. Gio. Maria Lanfranchi nella quarta parte delle scintille, oue ragiona delle dissonanze, vi connumera la Quarta Vicenzo Galilei nel Dialogo di Fronimio, & Deumario oue tratta dell'intauolatura del Leutto à carte 195, dice la Quarta esser dissonanza. Et, se fosse consonanza, i Composi-tori nelle lor Compositioni, se ne seruirebbero. Altri Auttori sonoui an-co di questo parere, i quali taccio per breuità. Siche si vede da questi Scrittori la Quarta esser posta fra le dissonanze. Mà quel, che più mi fà credere, che sia dissonanza, è, ch'io non la veggio postra fra le compositioni, come la Terza, la Quinta, la Sesta, & l'Ottaua. M. V. S. hà il torto in dire, che non è posta fra le compositioni. G. Veda V. S. (e mi perdoni) che non intende il mio ragionamento. Voglio dire che, quando serà fatta la Terza si passerà hora alla Quinta, hora alla Sesta, & hora all'Ottaua, & alle volte con mouimento congionto, & alle volte con mouimento separato, e tal'hora ascendendo, e tal'hora discendendo, come tornarà più commodo al Compositore; e cosi anco il simile si vede delle altre consonanze. Di più si vedono le so-pradette nelle compositioni fatte hora con figura di Breue, hora con figura di Longa, & di Massima, come porta l'occasione: ma questa, che V. S. e molti altri dicono essere consonanza, non vedo fra le compositioni de' Musici tanto antichi, come moderni posta, come le nominate di sopra, ciò è, con figura di Breue, ò di Longa; e pur volentieri saperei la cagio-ne, perche detta Quarta (poiche V. S. la dice consonanza) da' Composi-tori non è posta fra le loro compositioni, come l'altre. Et, che il vero ciò sia, potrà essaminare V. S. le compositioni di Iosquino, di Giamoton, di Adriano, Cipriano, Iacchetto, del Palestina, e d'altri infiniti, che non ve-drà mai detta Quarta posta fra le compositioni con figura di Breue, ouer di Longa, mà solo con figura di Semibreue, ouer di Miinma [sic: Minima], posta in eleuatione della misura accompagnata prima in vna medesima riga, ouero spatio con vna consonanza, e poi fatta detta Quarta venirle subito vn' altra consonanza, hora la Terza, hora la Quinta, & hora la Sesta, e conuiene, che la figura susseguente vadi per mouimento congionto, e che discenda, come si fa nelle altre dissonanze. E questo è commandamento espres-so, come dalle compositioni de' Musici si può vedere, & il Zarlino nella terza parte delle Institutioni di Musica nel capitolo 53 à carte 224. in tal page 79modo la fece, ilche non si vede questo commandamento nelle altre con-sonanze; perche le figure, che dopò loro sono hor vanno ascendendo, & hor discendendo, cosi per grado congionto, come separato, si come torna commodo al Compositore; ma quella figura, che viene doppo la Quar-ta, sempre discende con mouimento congionto. M. V. S. ha addotte autorità de' Scrittori dignissimi per mostrarmi, che la Quarta non è con-sonanza; ma però s'altro, che l'auttorità non mi hauesse addotto (ancor-che esse meritino approbatione) sarei ancora nella mia prima opinione. Però dicendomi, che li compositori degni al par delli già nominati da me, non fanno questa Quarta con figura di Breue, nè tampoco con figura di longa, come si può vedere nelle lor compositioni: e, che vanno hor per grado congionto, hor separato, & così hora ascendendo, & hora discendendo quelle figure, che doppo le consonanze vengono; ma quella che doppo la Quarta segue, conuiene, che sempre discenda con mouimento congionto. Et, che questo è commandamento espresso; questa sua con-chiusione mi fà alquanto da quella prima opinione rimouere, & dubita-re, che non sia consonanza. Laonde fra me stesso rimango confuso, essen-do da quelli Filosofi, e Theorici posta fra le consonanze: e poi d'alcuni di lor essendo detto, che non fà concordanza alcuna, e posta nel numero delle dissonanze, e di tal maniera resto sbigottito, che non sò, che mi dire. Perilche grandissimo fauore, & vtile mi fia l'intendere dal Signor Conte Alessandro, come si possino accordare queste opinioni contrarie. A. poi-che così le piace, lo farò, auuertendole, ch'i non son per dar più ad vno, che all'altro il torto; posciache le Signorie Vostre hanno sostentato il ve-ro con le buone ragioni, e fondamenti addotti; ma ben (con lor pace) dirò, che non hanno inteso il modo del ragionar delli sopra nominati Auttori. M. S'ella ci farà intendere, come non gli habbiamo intesi, à noi sarà gratissima cosa, mostrandoci il nostro errore. A. Et io son per far questo prontissimo. Deuono adunque auuertire, che, quando essi Scrittori hanno posta questa Quarta fra le consonanze, hanno parlato secondo la Theorica, e non secondo la Prattica, fra quali fù Pithagora (come dili-gentissimo inuestigatore, & osseruatore de' numeri, e conseguentemente de' generi delle proportioni, e loro specie). Tolomeo, Aristosseno, Boe-tio, & altri seguaci di detti Filosofi, furono d'opinione, che niun gene-re potesse esser capace delle consonanze, fuorche il Moltiplice, & il Superparticolare, e si fondarono co 'l dire, che questi duoi Generi erano puri, e semplici; e che alcun'altro numero non gli potea misurare, se non l'vnità. E, perche detta Quarta si trouaua hauere la sua vera forma nella proportione Sesquiterza, seconda specie del Genere superparticolare, la nomi-narono fra le consonanze. Di più considerarono, che nel numero Senario page 80(qual'è numero perfetto) si conteneuano tutte le consonanze, e trouan-dosi detta Quarta compresa in questo numero Senario, la chiamarono consonanza. Onde non è marauiglia, se questo numero Senario fu diman-dato segnacolo del mondo; poiche in esso si troua ogni consonanza, con ogni perfettione delle cose del mondo; & non hà in se cosa, che sia su-perflua, nè tampoco diminuta; ilche fu tenuto tale appresso Pithagora, & altri Filosofi. Siche questa Quarta da lor fù chiamata Tetrachordo, & in tanta veneratione tenuta, che l'assimigliarono alle quattro varietà de' Tempi, & ancora alli quattro Elementi, i quali sono necessarij alla vita humana; perche stimarono; che da lei venisse ogni varietà nella Musica. Per questa cominciarono à diuidere il Tuono in diuersi modi. Aristide diuise il Tuono in quattro diesis minori: dell'istesso parere fu Baccheo. Altri poi, come fù Pithagora, Boetio, Franchino, Macrobio, & molti altri, lo diuisero in due parti, facendo d'esso vna parte semituono maggiore, quale contiene in se cinque come, & vn semituono minore, ch'è formato di quattro come; poiche esso Tuono ha la sua vera forma nella pro-portione Sesquiottaua. E parimente giudicarono, che 'l Tuono non si po-tesse per modo alcuno diuidere in due parti vguali, come alcuni haueua-no opinione. Qual'opinione di diuisione del Tuono fu da quelli accetta-ta, & all'hora, & anco al presente osseruata. G. Non le sia à dispiacere il dirci ancora perche sia affaticauano questi tali in far tante diuisioni di questo Tuono. A. Non per altro, se non per hauer diuerse diuisioni di questo Tetrachordo. G. Et à che fine poi se ne seruiuano? A. Non ad altro, che à trouare ciascuno secondo la sua opinione diuerse specie del Genere Diatonico; e così del Genere Chromatico, & Enharmonico. G, Fù varietà fra di lor di questi Generi? A. Non fu varietà di nome, ma fu gran varietà nelle diuisioni di detto Tetrachordo, la quale causò, che Tolomeo hebbe due varietà del Genere Diatonico, vn detto molle, e l'altro incitatiuo; e cosi altri Filosofi hebbero il medesimo parere. G. La prego à compiacermi di dire, chi giudicò fra le tante diuisioni fatte da i già detti Filosofi, quali fossero le migliori. A. L'orecchia sola ne fece il giudicio. G. E con che ragione? A. Perche miglior consonanza le rendeua all'vdito, & cosi da quelli Musici fù accettato, & abbracciato quel, che l'era di maggior soauità, e maggior commodo nel cantare. Mà, perche queste varietà de' Generi fà poco à nostro proposito del saper quel, che da loro si cerca, non passarò più auanti, lasciando questo ragio-namento, in cui sono intrato, per mostrar, quanto in pregio haueuano quellli antichi Filosofi questo Tetrachordo. Siche per conchiusione dirò, che i Filosofi già nomati per le ragioni predette chiamarono la Quarta, consonanza, stando ancora, che nelle loro Cantilene non si vedeuano page 81(come à tempi nostri si vede) trè, e quattro parti insieme modulando, ma vi era vn solo Musico con vn'istromento, co 'l quale accompagnaua la sua voce, esplicando il suo concetto, e cantando con diuersità di Poe-sia, e per esser solo non si poteua discernere alcuna consonanza, nè dissonan-za. Mà, poiche si cominciò modulare insieme due, trè, & quattro parti, conobbero i Musici dalla longa isperienza, che la Quarta non era conso-nanza, come la Terza, e la Quinta, & altre; e ponendola, come la Terza, la Sesta, & le altre, conobbero, che rendeua aspra, e dure la compositio-ne, & offendeua grauemente l'vdito: e volendosi di lei seruire gli conue-niua accompagnarla con vna figura di Semibreue, posta in eleuatione della misura, nella quale la prima parte d'essa figura fosse consonanza, e l'altra poi fosse la Quarta, doppo la quale venisse vna figura, che fosse consonanza, e che temprasse quella asprezza; e detta figura fosse in ele-uatione della misura, & la sequente poi discendesse, come si fà della Setti-ma, e della Seconda. Qual verità fù con tempo, & isperienza longa conosciuta; onde i compositori nelle loro opre cominciarono seruirsi in tal modo di lei: siche vedendo il buono effetto, che faceua seguiro-no tal modo, come faceuano delle altre dissonanze, & al presente cosi i Musici se ne vagliono: e per questa isperienza fu posta fra le disso-nanze da loro, e come dissonanze se ne seruono. M. Questa isperien-za come fù fatta? A. Co 'l giudicio della purgata orecchia. M. Fù dunque il giudicio dell'orecchia, e non altro? A. Non fù altro; come ancora nelli mouimenti delle parti, e parimente nel passare da vna con-sonanza all'altra; & in quello, che fa buono, e reo effetto non si sarebbe mai potuto discernere il vero. Ilche mostrò il Zarlino nel primo capo della prima parte delle sue institutioni di Musica, oue disse, che dall'vdi-to (come più necessario delli altri sentimenti) la scienza della Musica hà hauuta la sua perfettione; posciache per essa hà conosciuto il buono dal reo, & hà fatto vn retto, & ottimo giudicio delle cose pertinenti alla grata harmonia. M. Grandissimo contento hò sentito nell'ispiegarmi (come hà fatto) per qual causa i Filosofi la connumerauano fra le con-sonanze, e per qual causa poi da Musici è stata tenuta nel numero delle dissonanze, & vsata nelle compositioni al par dell'altre dissonanze; & come questa certezza è stata fatta co 'l giudicio della purgata orecchia. A. Cosi è stato à punto. Di più lor voglio dire, che gli Antichi Musici (stando, che niuno altro genere, che il Moltiplice, e Superparticolare, non poteua dar consonanza veruna, ouero altro numero, che 'l numero Senario) haueuano con questo suo fondamento priuata la Sesta mag-page 82giore, & minore del nome, e commercio delle consonanze, nè mai di lo-ro fecero mentione alcuna per non trouarsi dette Seste nelli sopranomati Generi, e cosi nel numero Senario. Mà i Musici prattici le hanno poste nel numero delle consonanze. G. Non le sia di gratia à tedio, come ci serà fauore, il dirne per qual ragione il fecero. A. Per due ragio-ni. La prima è, che percuotendo dette Seste, non discordauano, ma sotisfaceuano al senso dell'vdito, & erano di grato vdire nelle com-positioni. L'altra è, che, se bene non si trouauano in que' duoi Ge-eri già nomati, nè tampoco attualmente nel numero Senari; si tro-uauano però in potenza, perche si forma la Sesta maggiore da vna Quarta, & da vna terza maggiore.
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 20 | 12 | Sesta maggiore |
| 4 | 3 | |
| 6 | 5 | |
| 24 | 15 | Sesta minore |
DIALOGO DI MVSICA, INTERLOCVTORI, Il Sig. Conte Giordano Sarego. Il Sig. Conte Alessandro Beuilacqua, & il Sig. Conte Marco Verità. Terza Parte.
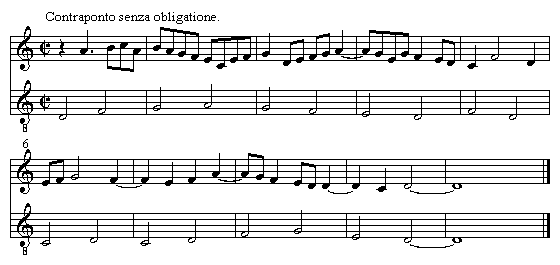 Qual contraponto è degno di consideratione, & osseruatione, sì per esser vago, e fatto con bell'ordine di consonanze, e dissonanze, come anche per non hauer difetto di mouimenti incantabili, e discommodo alcuno, & altre qualità, che si conuengano al contrapunto; de' quali non dirò parola, già che nel quarto ragionamento, che si fece nel Ridotto del Sig. Conte Mario Beuilacqua di ciò fù trattato diffusamente da Pietro Pontio; mà passarò ad vn'altro modo di Contraponto solito à farsi tal'hora da' Con-trapontisti per loro diletto, oue non si troua la Consonanza ottaua, che è presente.
Qual contraponto è degno di consideratione, & osseruatione, sì per esser vago, e fatto con bell'ordine di consonanze, e dissonanze, come anche per non hauer difetto di mouimenti incantabili, e discommodo alcuno, & altre qualità, che si conuengano al contrapunto; de' quali non dirò parola, già che nel quarto ragionamento, che si fece nel Ridotto del Sig. Conte Mario Beuilacqua di ciò fù trattato diffusamente da Pietro Pontio; mà passarò ad vn'altro modo di Contraponto solito à farsi tal'hora da' Con-trapontisti per loro diletto, oue non si troua la Consonanza ottaua, che è presente.
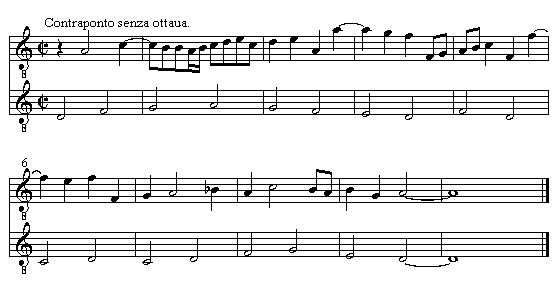 page 87Et questo si potrà dir vna osseruatione fatta cosi per capriccio. Sogliono pur ancor farne vn'altro variato dal sopradetto, in cui non si troua la Consonanza Quinta, come da questo essempio si potrà conoscere.
page 87Et questo si potrà dir vna osseruatione fatta cosi per capriccio. Sogliono pur ancor farne vn'altro variato dal sopradetto, in cui non si troua la Consonanza Quinta, come da questo essempio si potrà conoscere.
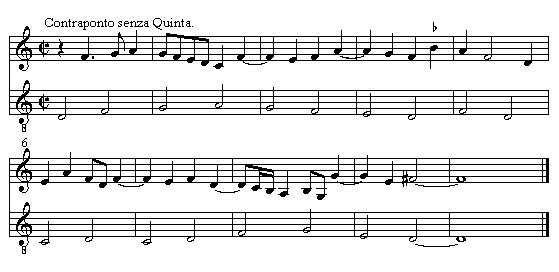 Già hanno veduta la varietà de i predetti duoi Contraponti: hora vedranno la terza diuersità, che fia priuando il Contraponto della consonanza terza, cosi maggiore, come minore, per variarlo dalli sopradetti: & ecco l'essempio.
Già hanno veduta la varietà de i predetti duoi Contraponti: hora vedranno la terza diuersità, che fia priuando il Contraponto della consonanza terza, cosi maggiore, come minore, per variarlo dalli sopradetti: & ecco l'essempio.
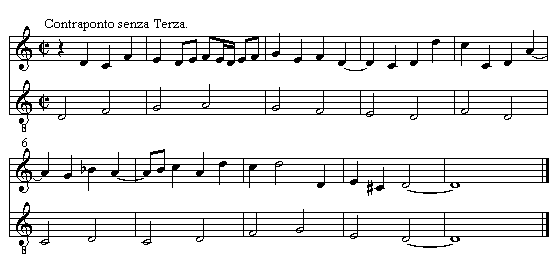 Quì veggono nuoua varietà di Contraponti. M. Di sommo piacer m'è il veder questi capriccij cosi, come mi sarà; se V. S. si degnarà di seguire il page 88suo ragionamento. A. Cosi farò. Altri poi formaranno vn Contrapon-to, oue non si trouarà Sesta cosi maggiore, come minore per dimostrarlo vario dalli già detti, come è il presente.
Quì veggono nuoua varietà di Contraponti. M. Di sommo piacer m'è il veder questi capriccij cosi, come mi sarà; se V. S. si degnarà di seguire il page 88suo ragionamento. A. Cosi farò. Altri poi formaranno vn Contrapon-to, oue non si trouarà Sesta cosi maggiore, come minore per dimostrarlo vario dalli già detti, come è il presente.
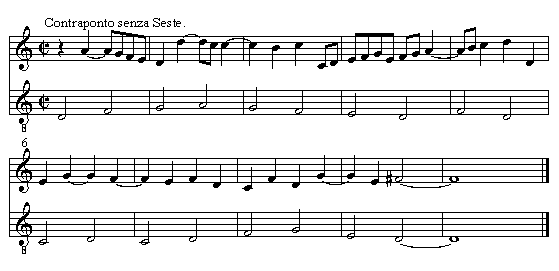 Altri poscia per lor diletto (acciò non si conformi con li predetti) non faranno nel contraponto dissonanza alcuna, come quiui.
Altri poscia per lor diletto (acciò non si conformi con li predetti) non faranno nel contraponto dissonanza alcuna, come quiui.
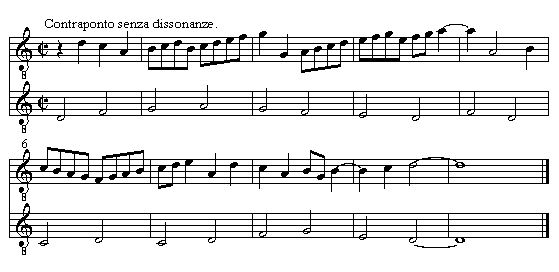 Questo si vede pur vario dalli predetti. Altri ancora faranno per diuer-sità vn solo passaggio di figure sopra del canto Plano, come in questo essempio. page 89
Questo si vede pur vario dalli predetti. Altri ancora faranno per diuer-sità vn solo passaggio di figure sopra del canto Plano, come in questo essempio. page 89 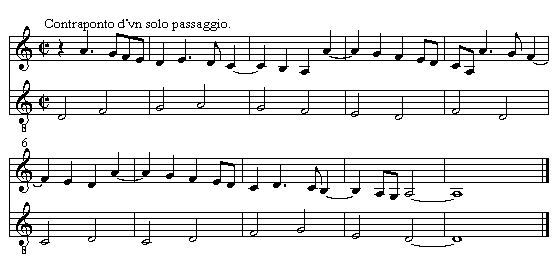 Quest'altro poscia similmente serà d'vn passaggio solo; mà fatto ad vn' altro modo di figure.
Quest'altro poscia similmente serà d'vn passaggio solo; mà fatto ad vn' altro modo di figure.
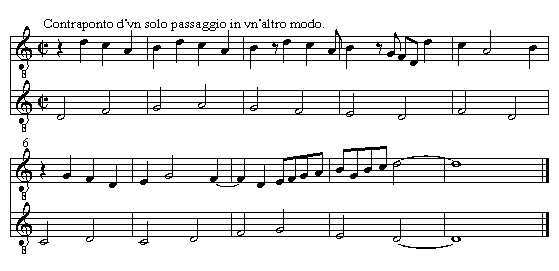 Hanno di già veduti questi duoi passaggi variati sopra vn'istesso Canto Plano, i quali modi di contrapunto, veramente richiedono osseruationi per esser fatti con bell'ordine di consonanze, e dissonanze, e per hauer in se legitimi interualli, non sentendosi mouimento, che offenda l'orecchia; e se pur vi fosse qualche interuallo discommodo, deurebbe sopportarsi per l'obligatione osseruata dal Contrapontista; mà essendo il Contraponto commodo, e fatto con ragione, fia degno di maggior lode per esser ingegno-so, e dotto. Et in simili Contraponti fia lecito due, e tre volte far vn'istes-page 90 so passaggio simile di figure, e d'interualli per adempire l'obligatione delle figure; mà, rimossa poi tal'occasione, sarebbe da gli intendenti di questa scienza stimato pouero d'inuentioni. Altri similmente (per va-riar'i Contraponti) faranno vna parte tutta di figure di semibreui poste per principio di misura sopra d'vn canto figurato, come quì.
Hanno di già veduti questi duoi passaggi variati sopra vn'istesso Canto Plano, i quali modi di contrapunto, veramente richiedono osseruationi per esser fatti con bell'ordine di consonanze, e dissonanze, e per hauer in se legitimi interualli, non sentendosi mouimento, che offenda l'orecchia; e se pur vi fosse qualche interuallo discommodo, deurebbe sopportarsi per l'obligatione osseruata dal Contrapontista; mà essendo il Contraponto commodo, e fatto con ragione, fia degno di maggior lode per esser ingegno-so, e dotto. Et in simili Contraponti fia lecito due, e tre volte far vn'istes-page 90 so passaggio simile di figure, e d'interualli per adempire l'obligatione delle figure; mà, rimossa poi tal'occasione, sarebbe da gli intendenti di questa scienza stimato pouero d'inuentioni. Altri similmente (per va-riar'i Contraponti) faranno vna parte tutta di figure di semibreui poste per principio di misura sopra d'vn canto figurato, come quì.
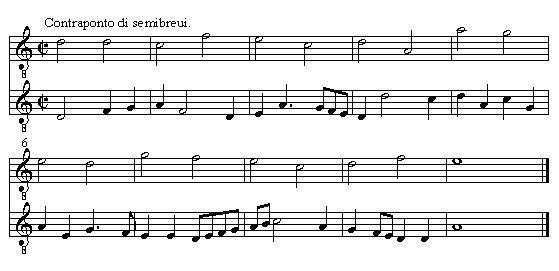 Alcuni altri ancora faranno vn Contraponto fatto di figure di Semibreui in eleuatione della misura sopra il Canto figurato, meriteuole per certo di consideratione, come mostrarò con questo essempio.
Alcuni altri ancora faranno vn Contraponto fatto di figure di Semibreui in eleuatione della misura sopra il Canto figurato, meriteuole per certo di consideratione, come mostrarò con questo essempio.
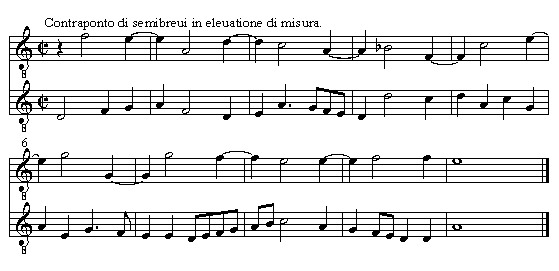 Certa cose è, che in simili obligationi non si può far modulare il Contra-ponto cosi per interualli leggiadri, e commodi, come si fà essendo priuo page 91di simili obligationi, e perciò il Contrapontista fia degno di scusa, se vi si trouaranno alcuni incommodi. In oltre si obligaranno à far vn sol pas-saggio di figure sopra il Canto figurato. E questo è vn modo ingegno-so, e degno di osseruatione, poiche è dotto, e bello, come già dissi, ragio-nando di tal obligatione sopra il Canto Plano, & anche ne mostrarò al-cuni essempij.
Certa cose è, che in simili obligationi non si può far modulare il Contra-ponto cosi per interualli leggiadri, e commodi, come si fà essendo priuo page 91di simili obligationi, e perciò il Contrapontista fia degno di scusa, se vi si trouaranno alcuni incommodi. In oltre si obligaranno à far vn sol pas-saggio di figure sopra il Canto figurato. E questo è vn modo ingegno-so, e degno di osseruatione, poiche è dotto, e bello, come già dissi, ragio-nando di tal obligatione sopra il Canto Plano, & anche ne mostrarò al-cuni essempij.
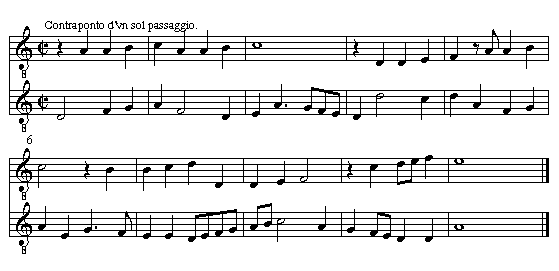
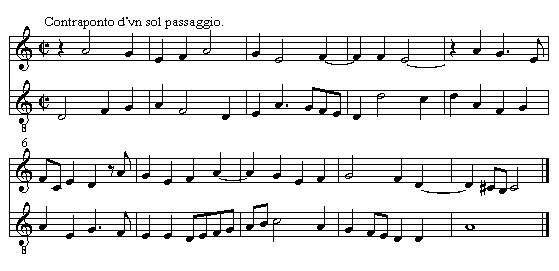 Da questi duoi Contraponti si scoprono duoi variati passaggi; mà alle volte per incommodità dell'obligo non si può fare il proposto soggetto, ò passaggio, come dir vogliamo. Et acciò il Contraponto non si riposi ol-tre di modo; poiche mancarebbe del giudicioso il sentir modular vna Cantilena sola senza compagnia per spatio di vno, ouer duoi tempi di Semibreue: Perciò conuiene far modulare altre figure, che non siano del proprio soggetto, per non cadere in questo errore. Si può variar di più in questa maniera, facendo vn contraponto sopra il Canto Plano, ò figu-rato, oue si pronuntiano tre minime all'incontro di due, detta proportio-ne Sesquialtra, la quale non è altro, che tre minime, ouer tre semibreui all'incontro di due, come mostra questo essempio. page 92
Da questi duoi Contraponti si scoprono duoi variati passaggi; mà alle volte per incommodità dell'obligo non si può fare il proposto soggetto, ò passaggio, come dir vogliamo. Et acciò il Contraponto non si riposi ol-tre di modo; poiche mancarebbe del giudicioso il sentir modular vna Cantilena sola senza compagnia per spatio di vno, ouer duoi tempi di Semibreue: Perciò conuiene far modulare altre figure, che non siano del proprio soggetto, per non cadere in questo errore. Si può variar di più in questa maniera, facendo vn contraponto sopra il Canto Plano, ò figu-rato, oue si pronuntiano tre minime all'incontro di due, detta proportio-ne Sesquialtra, la quale non è altro, che tre minime, ouer tre semibreui all'incontro di due, come mostra questo essempio. page 92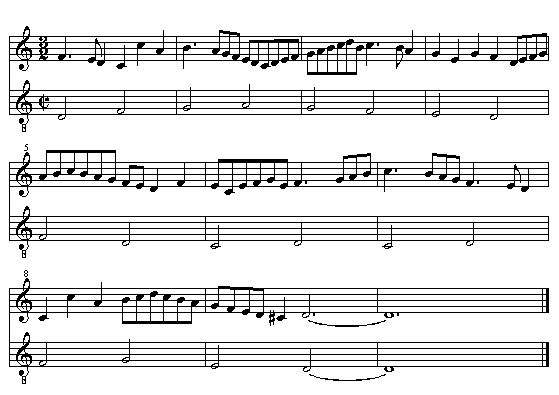 Queste sono le variationi, che per suo diletto sogliono fare i Contrapon-tisti sopra il Canto Plano, e sopra il Figurato. G. Molta varietà per cer-to hò visto in questi Contrapunti tutti ingegnosi, e degni di memoria sì, che conosco, e parmi, che questa prattica di Musica sia di grandissimo valore, e di molto più, che non è la Theorica, come V. S. mi disse. A. Cre-de forsi V. S. che sia quì il fine, e che non vi resti altra varietà sopra questi Contraponti? G. Ve ne sono dunque dell'altre? A. Anzi sì, che ve ne rimangono molte. G. Ci fauorisca dunque V. S. in mostrarmi queste altre varietà; che crescendo i suoi fauori verso di noi, cresceranno anche gli oblighi nostri verso di lei. A. Farollo volentieri, mà con attentione di ciascun di loro darò qualche essempio. Si farà tal'hora vn Contra-ponto, che potrà modularsi sotto, e sopra del suo proprio principio, oue sarà formato per Ottaua lontano, come il presente.
Queste sono le variationi, che per suo diletto sogliono fare i Contrapon-tisti sopra il Canto Plano, e sopra il Figurato. G. Molta varietà per cer-to hò visto in questi Contrapunti tutti ingegnosi, e degni di memoria sì, che conosco, e parmi, che questa prattica di Musica sia di grandissimo valore, e di molto più, che non è la Theorica, come V. S. mi disse. A. Cre-de forsi V. S. che sia quì il fine, e che non vi resti altra varietà sopra questi Contraponti? G. Ve ne sono dunque dell'altre? A. Anzi sì, che ve ne rimangono molte. G. Ci fauorisca dunque V. S. in mostrarmi queste altre varietà; che crescendo i suoi fauori verso di noi, cresceranno anche gli oblighi nostri verso di lei. A. Farollo volentieri, mà con attentione di ciascun di loro darò qualche essempio. Si farà tal'hora vn Contra-ponto, che potrà modularsi sotto, e sopra del suo proprio principio, oue sarà formato per Ottaua lontano, come il presente.
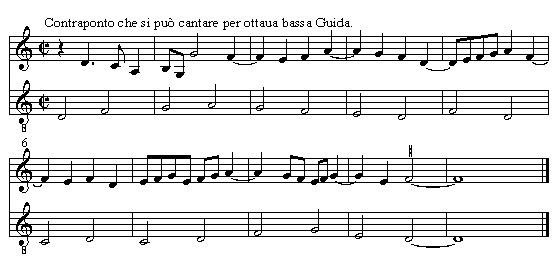 page 93
page 93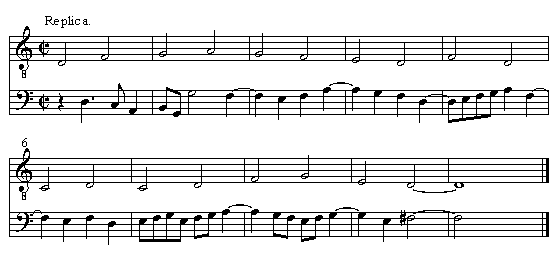 G. Ben veggio cosi ingegnosa varietà. Ma di sommo piacere mi fia, (come anche credo, che sarà al al [sic: al] Sig. Conte Marco) il saper il modo da osseruarsi per far vn simil Contraponto. A. A questo fine pur anco darò le regole, & le osseruationi, senza le quali giamai non si potrebbe far tal modo di Contraponto, che fosse buono. Volendosi far vn simil Contra-ponto, conuerrà osseruar questa regola, che non vi sia la consonanza Quinta per alcun modo; mà ben si potrà seruire della Duodecima, & dell'al-tre consonanze, e dissonanze à suo piacere: e 'l tutto riuscirà bene, co-me certificarà il predetto essempio. E questa serà vna varietà di Contra-ponto. M. V. S. ci vieta la Quinta, e poi ne concede la Duodecima, non sono forsi elle vna stessa consonanza? A. E vero; ma fra d'esse si troua la distanza, la qual causa, che il Contraponto poi venga in Quinta sopra il Canto Plano; e la Quinta venga nella replica sopra il predetto Canto Plano Quarta; oue si può dire, che sia fatto senza regola, & ordine sì, che non deue farsi la consonanza Quinta; come potranno chiarirsene del farne la proua. M. Mà V. S. mi dica: potrò io con questa regola creare per principal vn Contraponto nella parte Bassa, e poi farlo modulare per Ottaua lontano dal suo principio; ouero mi si conuiene osseruar'altra rego-la. A. L'istessa regola; & osseruatione serue, cosi per far il Contraponto nella parte Bassa, come nell'Alta. Basta solo l'hauer risguardo; che, facen-dosi il Contraponto nella parte Bassa, non si faccino due terze seguenti: non già, perche non possino stare; mà, perche, modulando poi il Con-traponto per Ottaua lontano, quelle Terze vengono Seste, e rendono il Contraponto alquanto duro, & aspro. E perche egli sia più soaue, più dolce, e più purgato, serà bene il lasciar di far due terze seguenti. M. Hò page 94di già intesa la ragione. Potrà dunque V. S. seguire à suo piacere. A. Si troua ancora vn'altra varietà di Contraponto, qual si potrà modular per decima sotto al principale, come si scoprirà da questo essempio.
G. Ben veggio cosi ingegnosa varietà. Ma di sommo piacere mi fia, (come anche credo, che sarà al al [sic: al] Sig. Conte Marco) il saper il modo da osseruarsi per far vn simil Contraponto. A. A questo fine pur anco darò le regole, & le osseruationi, senza le quali giamai non si potrebbe far tal modo di Contraponto, che fosse buono. Volendosi far vn simil Contra-ponto, conuerrà osseruar questa regola, che non vi sia la consonanza Quinta per alcun modo; mà ben si potrà seruire della Duodecima, & dell'al-tre consonanze, e dissonanze à suo piacere: e 'l tutto riuscirà bene, co-me certificarà il predetto essempio. E questa serà vna varietà di Contra-ponto. M. V. S. ci vieta la Quinta, e poi ne concede la Duodecima, non sono forsi elle vna stessa consonanza? A. E vero; ma fra d'esse si troua la distanza, la qual causa, che il Contraponto poi venga in Quinta sopra il Canto Plano; e la Quinta venga nella replica sopra il predetto Canto Plano Quarta; oue si può dire, che sia fatto senza regola, & ordine sì, che non deue farsi la consonanza Quinta; come potranno chiarirsene del farne la proua. M. Mà V. S. mi dica: potrò io con questa regola creare per principal vn Contraponto nella parte Bassa, e poi farlo modulare per Ottaua lontano dal suo principio; ouero mi si conuiene osseruar'altra rego-la. A. L'istessa regola; & osseruatione serue, cosi per far il Contraponto nella parte Bassa, come nell'Alta. Basta solo l'hauer risguardo; che, facen-dosi il Contraponto nella parte Bassa, non si faccino due terze seguenti: non già, perche non possino stare; mà, perche, modulando poi il Con-traponto per Ottaua lontano, quelle Terze vengono Seste, e rendono il Contraponto alquanto duro, & aspro. E perche egli sia più soaue, più dolce, e più purgato, serà bene il lasciar di far due terze seguenti. M. Hò page 94di già intesa la ragione. Potrà dunque V. S. seguire à suo piacere. A. Si troua ancora vn'altra varietà di Contraponto, qual si potrà modular per decima sotto al principale, come si scoprirà da questo essempio.
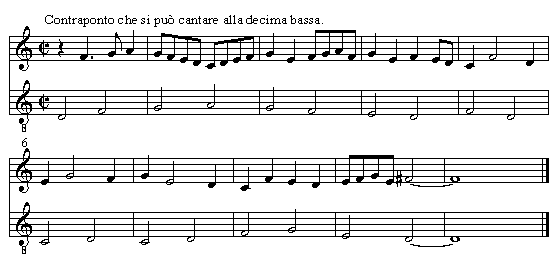
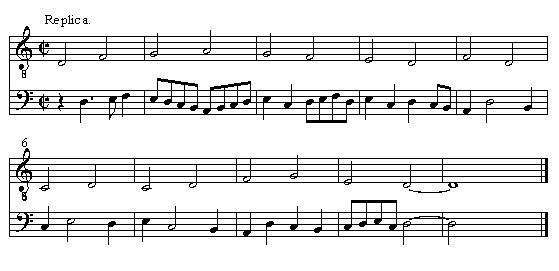 E volendosi porre in esecutione questo modo di Contraponto, non bisogna seruirsi di due Terze seguenti; poiche sono duoi vnisoni nella repli-ca, e bisogna parimente lasciar di far due seste; perche verrebbero due Quinte nella replica. Conuiene similmente priuarsi del passaggio dalla Quinta in eleuatione della misura alla Terza per principio di misura: e questo sarà all'hora, che ambedue le parti discenderanno; perche, facendosi tal mouimento, si và nella replica dalla Sesta alla Ottaua per moui-mento separato, il qual'è senza gratia, e di niun valore. Si possono ser-uire delle dissonanze d'ogni sorte. E ben vero, che sarà bene lasciar la settima; poiche nella replica, che si fà per Decima, si salua la Quarta con la Quinta: cosi facendo la Quarta nella replica viene la seconda, e poi page 95l'Vnisono, auuertendo, che prima della Quarta ci vuole la Quinta, e non la Terza; perche non tornarebbe bene nella replica: e facendosi la No-na riesce bene nella replica; poiche vien la seconda saluata con la Terza; nondimeno per vietare ogni durezza si potrà lasciare la Settima, e la Quarta, che serà più soaue il Contraponto; mi rimetto però sempre al loro giudicio. E sappino ancora, che detto Contraponto si potrà modulare insie-me con tutti duoi i Contraponti sopra, e sotto; e ne risulterà soaue har-monia. Volendosi poi formare il principale di questo Contraponto nella parte Bassa, conuerrà lasciar la Seconda, quando la figura del Canto Plano discende; poiche non può star per Decima nella replica. Ma, quando il Canto predetto haurà la figura, ch'ascenda, si potrà seruirsene degnamente, e seruirsi anche della Settima, e delle consonanze, cosi perfette, come imperfette, guardandosi di non far due terze seguenti, ne due Seste, come fù detto in quel, che si fà nella parte acuta. Già hanno l'osseruationi d'ambiduoi i modi, e perciò seguirò in mostrar vn'altro modo di Contrapon-to sopra il Canto Plano, ò Figurato, che potrà modularsi per Decima, e Duodecima sopra l'vno, e l'altro Canto: e ciò farò con questo essempio.
E volendosi porre in esecutione questo modo di Contraponto, non bisogna seruirsi di due Terze seguenti; poiche sono duoi vnisoni nella repli-ca, e bisogna parimente lasciar di far due seste; perche verrebbero due Quinte nella replica. Conuiene similmente priuarsi del passaggio dalla Quinta in eleuatione della misura alla Terza per principio di misura: e questo sarà all'hora, che ambedue le parti discenderanno; perche, facendosi tal mouimento, si và nella replica dalla Sesta alla Ottaua per moui-mento separato, il qual'è senza gratia, e di niun valore. Si possono ser-uire delle dissonanze d'ogni sorte. E ben vero, che sarà bene lasciar la settima; poiche nella replica, che si fà per Decima, si salua la Quarta con la Quinta: cosi facendo la Quarta nella replica viene la seconda, e poi page 95l'Vnisono, auuertendo, che prima della Quarta ci vuole la Quinta, e non la Terza; perche non tornarebbe bene nella replica: e facendosi la No-na riesce bene nella replica; poiche vien la seconda saluata con la Terza; nondimeno per vietare ogni durezza si potrà lasciare la Settima, e la Quarta, che serà più soaue il Contraponto; mi rimetto però sempre al loro giudicio. E sappino ancora, che detto Contraponto si potrà modulare insie-me con tutti duoi i Contraponti sopra, e sotto; e ne risulterà soaue har-monia. Volendosi poi formare il principale di questo Contraponto nella parte Bassa, conuerrà lasciar la Seconda, quando la figura del Canto Plano discende; poiche non può star per Decima nella replica. Ma, quando il Canto predetto haurà la figura, ch'ascenda, si potrà seruirsene degnamente, e seruirsi anche della Settima, e delle consonanze, cosi perfette, come imperfette, guardandosi di non far due terze seguenti, ne due Seste, come fù detto in quel, che si fà nella parte acuta. Già hanno l'osseruationi d'ambiduoi i modi, e perciò seguirò in mostrar vn'altro modo di Contrapon-to sopra il Canto Plano, ò Figurato, che potrà modularsi per Decima, e Duodecima sopra l'vno, e l'altro Canto: e ciò farò con questo essempio.
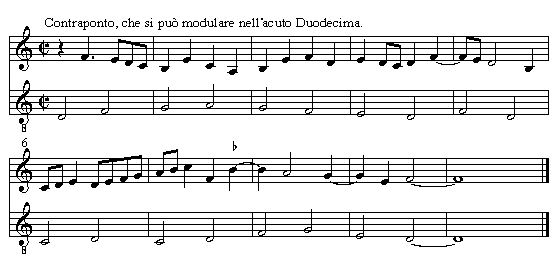
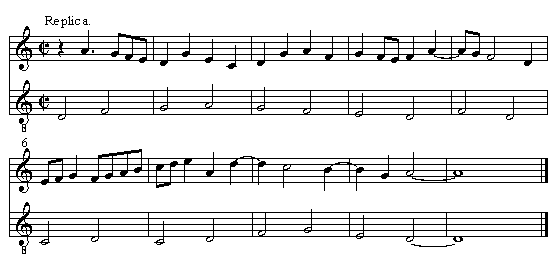 page 96E lecito etiandio modulare ambiduoi i Contraponti co 'l Canto Plane, e seranno di buono effetto. M. Gran contento per certo hò dal veder queste belle varietà, & altrettanto ne hauerei dal saper da V. S. (piacendole) la regola per farne vn simile. A. Si deue osseruar di non far Quinta, nè Settima in questo Contraponto; perche non ponno stare nella replica, se-condo le buone regole. Ben vi si concede il seruirsi della Quarta; auuer-tendoui però, che la segua la Terza, come è solito, e doppo quella segua la Sesta, che altrimente il passaggio non sarebbe buono nella replica, co-me da loro stessi potranno considerare, & anco poranno far la Nona, & farà buono effetto. Et queste sono l'osseruationi, e regole da tenersi in formar tal Contraponto, che si possa modular per Decima, e Duodecima sopra i duoi Canti predetti (come dissi) formando il principale per Deci-ma nell'acuto. M. Hò inteso il tutto si che ella potrà (volendo) seguir' ad altri nuoui Contraponti. A. Ne mostrarò vn'altra sorte, che si mo-dularà per Duodecima, lontano dal suo principale nella parte Bassa. E, perche sò, che desiderano di saper l'osseruationi di ciascun Contraponto, di cui ragiono, farò conoscere l'osseruationi di questo, che seranno tali, che non si deue far la Sesta; perche nasce la Settima nella replica; & si potranno seruir di tutto il resto delle consonanze, rendendo grato vdire; & an-cora di queste dissonanze, ciò è della Quarta, à cui segua la Terza descendendo per mouimento congionto, come è solito. Della settima similmen-te si potranno seruire, mentre che le succeda la Quinta per mouimento pur congionto d'ambedue le parti. Della Nona ancora; ma meglio fia il lasciarla; poiche ne viene la Quarta nella replica saluata con la Quinta; acciò il Contraponto resti purgato d'ogni macchia. Nè conuiensi far Quintadecima per principio di misura; conciò sia, che nella replica nasce la Quarta fatta fuori d'ogni regola. Queste dunque sono l'osseruationi conuenienti ad vn simil Contraponto; e questo ancora fia l'essempio, che loro assicurerà del tutto.
page 96E lecito etiandio modulare ambiduoi i Contraponti co 'l Canto Plane, e seranno di buono effetto. M. Gran contento per certo hò dal veder queste belle varietà, & altrettanto ne hauerei dal saper da V. S. (piacendole) la regola per farne vn simile. A. Si deue osseruar di non far Quinta, nè Settima in questo Contraponto; perche non ponno stare nella replica, se-condo le buone regole. Ben vi si concede il seruirsi della Quarta; auuer-tendoui però, che la segua la Terza, come è solito, e doppo quella segua la Sesta, che altrimente il passaggio non sarebbe buono nella replica, co-me da loro stessi potranno considerare, & anco poranno far la Nona, & farà buono effetto. Et queste sono l'osseruationi, e regole da tenersi in formar tal Contraponto, che si possa modular per Decima, e Duodecima sopra i duoi Canti predetti (come dissi) formando il principale per Deci-ma nell'acuto. M. Hò inteso il tutto si che ella potrà (volendo) seguir' ad altri nuoui Contraponti. A. Ne mostrarò vn'altra sorte, che si mo-dularà per Duodecima, lontano dal suo principale nella parte Bassa. E, perche sò, che desiderano di saper l'osseruationi di ciascun Contraponto, di cui ragiono, farò conoscere l'osseruationi di questo, che seranno tali, che non si deue far la Sesta; perche nasce la Settima nella replica; & si potranno seruir di tutto il resto delle consonanze, rendendo grato vdire; & an-cora di queste dissonanze, ciò è della Quarta, à cui segua la Terza descendendo per mouimento congionto, come è solito. Della settima similmen-te si potranno seruire, mentre che le succeda la Quinta per mouimento pur congionto d'ambedue le parti. Della Nona ancora; ma meglio fia il lasciarla; poiche ne viene la Quarta nella replica saluata con la Quinta; acciò il Contraponto resti purgato d'ogni macchia. Nè conuiensi far Quintadecima per principio di misura; conciò sia, che nella replica nasce la Quarta fatta fuori d'ogni regola. Queste dunque sono l'osseruationi conuenienti ad vn simil Contraponto; e questo ancora fia l'essempio, che loro assicurerà del tutto.
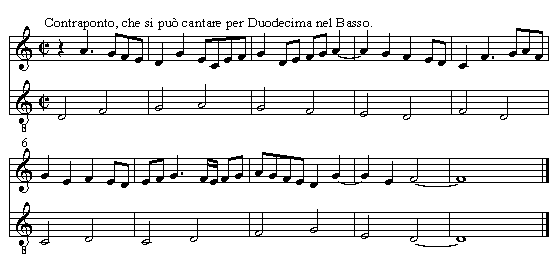 page 97
page 97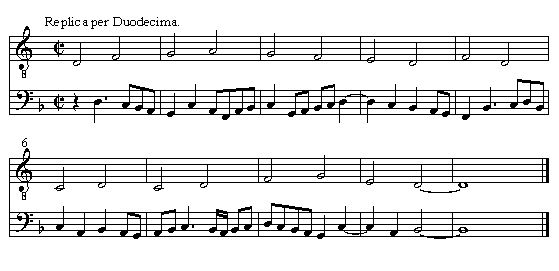 Auuertendo, che non si permette, che tal Contraponto nelle sue estremi-tadi ecceda più, che dodeci voci; e fatto, & adempito tutto ciò, egli serà tutto vago, leggiadro, e cantabile; e per accrescergli maggior leggiadria, e scemargli ogni asprezza, che vi si potesse sentire, si lasciarà di far la set-tima, & anche la Nona; perche nella replica la Quarta vien saluata con la Quinta (come già dissi); e si potrà (piacendo) formarlo cosi pur an-cor nella parte Bassa, non si partendo dall'istesse regole. Volendo poscia far vn Contraponto variato dal sopradetto, ciò è, che si possa cantare per Decima, & Duodecima, lontano dal principale nella parte Bassa, fà di mestieri lasciar la consonanza sesta; nè vsar due terze seguenti, l'vna doppo l'altra; nè tampoco alcuna dissonanza: e 'l tutto serà di buona riuscita, co-me potranno conoscere in questo essempio.
Auuertendo, che non si permette, che tal Contraponto nelle sue estremi-tadi ecceda più, che dodeci voci; e fatto, & adempito tutto ciò, egli serà tutto vago, leggiadro, e cantabile; e per accrescergli maggior leggiadria, e scemargli ogni asprezza, che vi si potesse sentire, si lasciarà di far la set-tima, & anche la Nona; perche nella replica la Quarta vien saluata con la Quinta (come già dissi); e si potrà (piacendo) formarlo cosi pur an-cor nella parte Bassa, non si partendo dall'istesse regole. Volendo poscia far vn Contraponto variato dal sopradetto, ciò è, che si possa cantare per Decima, & Duodecima, lontano dal principale nella parte Bassa, fà di mestieri lasciar la consonanza sesta; nè vsar due terze seguenti, l'vna doppo l'altra; nè tampoco alcuna dissonanza: e 'l tutto serà di buona riuscita, co-me potranno conoscere in questo essempio.
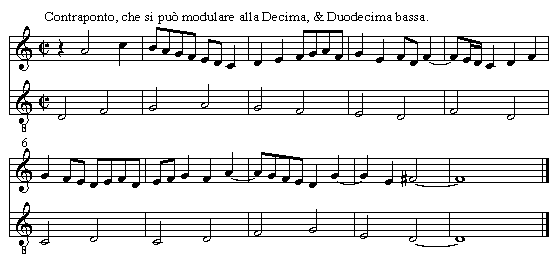
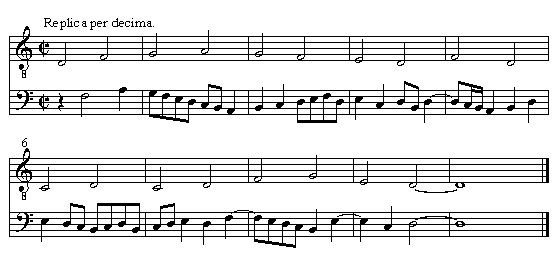
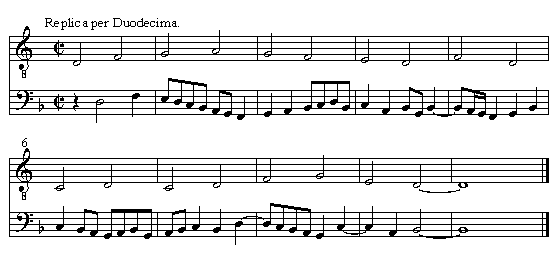 page 98Dubbio non è, che tal'hora cadono nelle repliche alcune relationi di consonanze, onde non è la modulatione di quella soauità, & dolcezza, che si richiederebbe; nondimeno si deuono ammettere in tal occasione per l'obligo del Contraponto. Il che non sarebbe tolerato fuori di questo obligo. Ne mancarò già di mostrar vn Contraponto, che si modulerà per Ottaua, per Decima, e per Duodecima in acuto, lontano dal suo prin-cipale, & lo mostrarò con questo essempio.
page 98Dubbio non è, che tal'hora cadono nelle repliche alcune relationi di consonanze, onde non è la modulatione di quella soauità, & dolcezza, che si richiederebbe; nondimeno si deuono ammettere in tal occasione per l'obligo del Contraponto. Il che non sarebbe tolerato fuori di questo obligo. Ne mancarò già di mostrar vn Contraponto, che si modulerà per Ottaua, per Decima, e per Duodecima in acuto, lontano dal suo prin-cipale, & lo mostrarò con questo essempio.
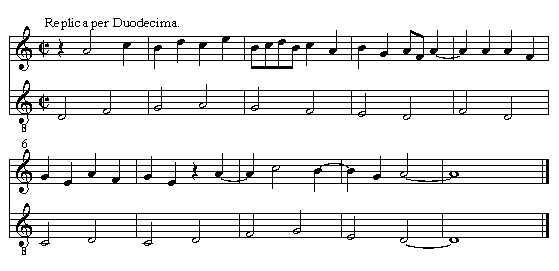
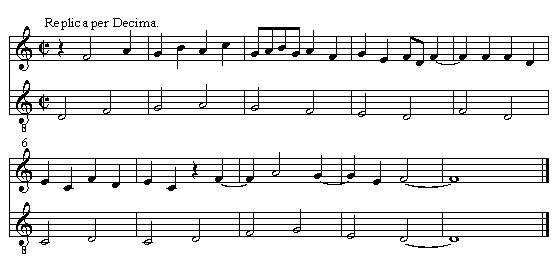
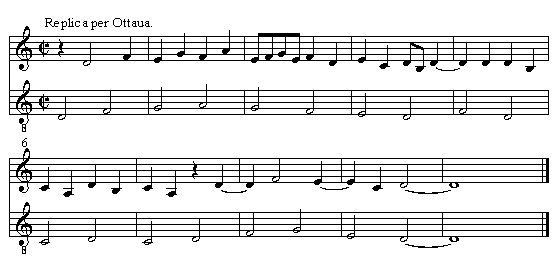 page 99
page 99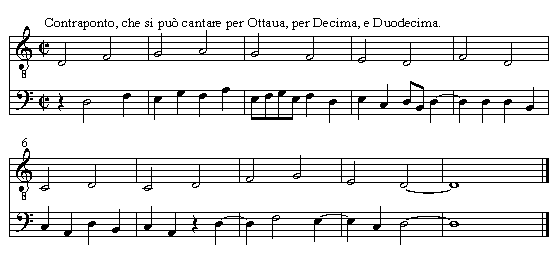 Auuertendo però di non far consonanza, ne dissonanza nel principale sopra l'vno, ò l'altro Canto, già che nella replica, che si canta alla Duo-decima, nasce delle dissonanze, essendo fatto il detto Contraponto con la parte Bassa; & auuertendo, che in esso principale per niun mo-do si troua Quinta, nè Sesta, nè due Terze seguenti, nè Quarta, nè Settima; mà fia lecito vsar la dissonanza seconda, e l'altre, come è stato concesso nell'essempio già mostrato. G. Vorrei che Vostra Signoria ci aggiongessi questo altro fauore à mille fattici, che è se l'os-seruationi mostrateci, seruiranno facendo questo Contraponto con la parte superiore. A. Signor mio nò. G. Vi vogliono dunque altre osseruationi? A. Anzi sì; poiche nel Contraponto fatto nella parte Bassa già mostrato non si concede per alcun modo il far la Quinta, e in quel, che si fà per Soprano, si può ben seruire della Duodecima (non già della Quinta) e cosi della dissonanza Nona, e dell'Vndeci-ma. E ben vero, che nella replica fatta per Duodecima dopò la Quar-ta succede la Quinta; ma nel resto rimangono ferme l'osseruationi pre-dette del primo, che si fà con la parte Bassa osseruandosi di non far quintadecima, & cosi nell'altro. G. Vorrei pur anco sapere, perche in questo, che si fà per Soprano, si può fare la Duodecima, e si vie-ta la Quinta nella parte Bassa. A. Perche, facendosi la Quinta nella parte bassa; nasce la Quarta fuori di regola nella replica, che si fà per Ottaua, come la proua dimostrerà. Et à questo fine porgo l'es-sempio. page 100
Auuertendo però di non far consonanza, ne dissonanza nel principale sopra l'vno, ò l'altro Canto, già che nella replica, che si canta alla Duo-decima, nasce delle dissonanze, essendo fatto il detto Contraponto con la parte Bassa; & auuertendo, che in esso principale per niun mo-do si troua Quinta, nè Sesta, nè due Terze seguenti, nè Quarta, nè Settima; mà fia lecito vsar la dissonanza seconda, e l'altre, come è stato concesso nell'essempio già mostrato. G. Vorrei che Vostra Signoria ci aggiongessi questo altro fauore à mille fattici, che è se l'os-seruationi mostrateci, seruiranno facendo questo Contraponto con la parte superiore. A. Signor mio nò. G. Vi vogliono dunque altre osseruationi? A. Anzi sì; poiche nel Contraponto fatto nella parte Bassa già mostrato non si concede per alcun modo il far la Quinta, e in quel, che si fà per Soprano, si può ben seruire della Duodecima (non già della Quinta) e cosi della dissonanza Nona, e dell'Vndeci-ma. E ben vero, che nella replica fatta per Duodecima dopò la Quar-ta succede la Quinta; ma nel resto rimangono ferme l'osseruationi pre-dette del primo, che si fà con la parte Bassa osseruandosi di non far quintadecima, & cosi nell'altro. G. Vorrei pur anco sapere, perche in questo, che si fà per Soprano, si può fare la Duodecima, e si vie-ta la Quinta nella parte Bassa. A. Perche, facendosi la Quinta nella parte bassa; nasce la Quarta fuori di regola nella replica, che si fà per Ottaua, come la proua dimostrerà. Et à questo fine porgo l'es-sempio. page 100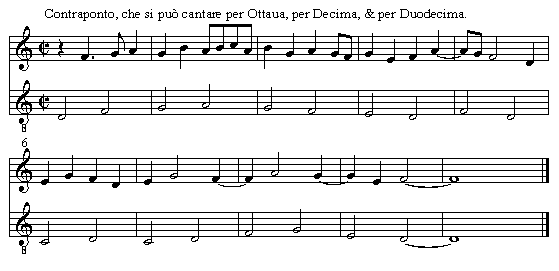
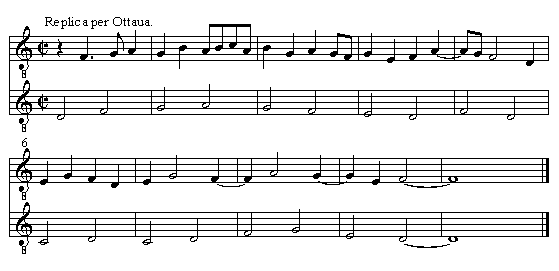
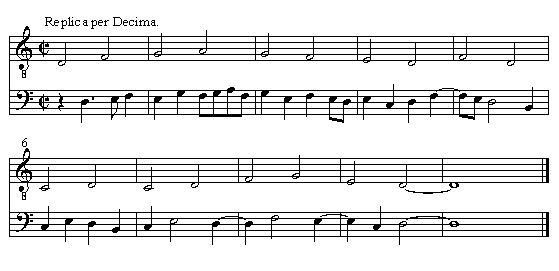
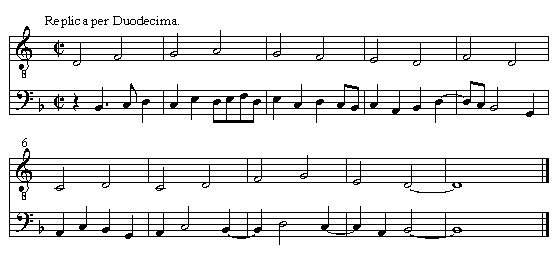 Io veggio chiaramente, che vi è varietà dal primo Contraponto, facendo il principale nel graue à quello, che si troua fatto nell'acuto. Ma chi cau-sa questa varietà? A. I mouimenti della parte acuta; posciache rimane sopra il Canto Plano, e quella del graue sotto d'esso canto. E questa è la causa, che le osseruationi non ponno sodisfar à pieno all'vno, & all'altro Contraponto, come hanno veduto. G. Mi compiaccia V. S. ancora in questo di dirmi, se le osseruationi di quelli altri Contraponti già mostrati potranno seruir cosi nel graue, come nell'acuto. A. Alcune d'esse serui-ranno all'vno, & all'altro. E cominciando dal Contraponto, che si può modular per Ottaua, e seguendo per ordine (acciò habbiano notitia di page 101
PARTEtutte l'osseruationi di ciascun Contraponto) mostrarò, quali seruiranno ad ambiduoi. E primieramente parlando di quel Contraponto, che può modularsi per Ottaua in acuto dal suo principale fatto nella parte Bassa, non vi si troua differenza alcuna: e l'istessa regola si può vsar, & all'vno, & all'altro, come dissi, e come potranno comprendere da questo essempio.
Io veggio chiaramente, che vi è varietà dal primo Contraponto, facendo il principale nel graue à quello, che si troua fatto nell'acuto. Ma chi cau-sa questa varietà? A. I mouimenti della parte acuta; posciache rimane sopra il Canto Plano, e quella del graue sotto d'esso canto. E questa è la causa, che le osseruationi non ponno sodisfar à pieno all'vno, & all'altro Contraponto, come hanno veduto. G. Mi compiaccia V. S. ancora in questo di dirmi, se le osseruationi di quelli altri Contraponti già mostrati potranno seruir cosi nel graue, come nell'acuto. A. Alcune d'esse serui-ranno all'vno, & all'altro. E cominciando dal Contraponto, che si può modular per Ottaua, e seguendo per ordine (acciò habbiano notitia di page 101
PARTEtutte l'osseruationi di ciascun Contraponto) mostrarò, quali seruiranno ad ambiduoi. E primieramente parlando di quel Contraponto, che può modularsi per Ottaua in acuto dal suo principale fatto nella parte Bassa, non vi si troua differenza alcuna: e l'istessa regola si può vsar, & all'vno, & all'altro, come dissi, e come potranno comprendere da questo essempio.
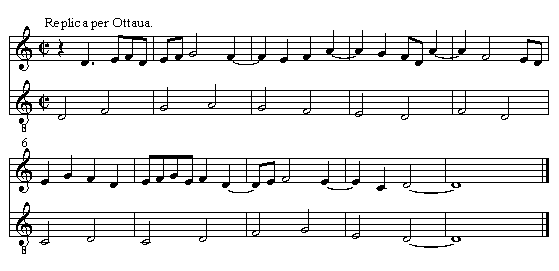
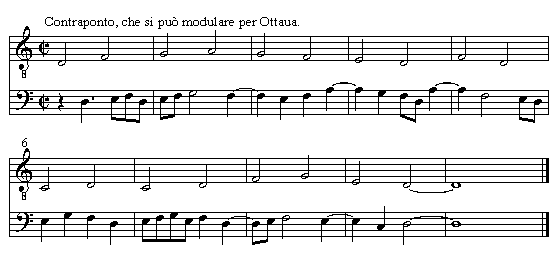 Di quì si manifesta, che l'istessa regola serue cosi nell'acuto, come nel graue; benche questo non sia simile al primo, ch'io mostrai in acuto. G. Ve-ramente è cosi, come ella per sua cortesia ne ha dimostrato. Il che ci è sta-to di gran contento, e d'altre tanto ci serà il dir (piacendo à V. S.) se nel-li altri Contraponti si troua l'istessa regola, & osseruationi, che seruano cosi nel graue come nell'acuto. A. Così farò. E per dar loro sodisfat-tione, seguirò ordinatamente. E perciò volendo formare vn Contrapon-to, che modular si possa per Decima lontano dal suo principale, ò sia for-mato nella parte graue, ò nella parte acuta, l'istesse regole, & osseruatio-ni seruiranno ad ambedue, come accertarà la proua. La onde non fatica-rò me, nè stancarò loro con altro essempio, che con l'vltimo dato, per cui del tutto s'assicuraranno. G. Potrà dunque V. S. seguirsene alli altri per ordine. A. Me ne passo al Contraponto, che si può modular per Duodecima, oue l'istessa regola, che si vsò nel crearlo nella parte acuta, aiutata anche totalmente nella parte Bassa. E per non vi esser differenza alcuna, non dirò altro sopra ciò; ma seguendo al Contraponto, che si può modular per Decima, e Duodecima, (in cui non cade altra nuoua regola: es-sendo concesso il poter vsar l'istesse osseruationi in farlo nella parte bassa, page 102come l'isperienza può mostrar nell'essempio già dato) auuertirò que-sto, che, facendosi il suo principal nel Graue, si hà da schifare ogni moui-mento sopra il Canto Plano, ò figurato: perche nella replica, che si fa al-la Duodecima, gli vengono molte dissonanze fuori d'ogni regola. Ne trouandosi differenza alcuna dalla prima regola de' predetti Contrapon-ti, fuorche di questo, che si può modular per Ottaua, per Decima, e per Duodecima; come all'hora, che ne parlai, già dissi farò fine. G. Hab-biamo visto vna sol regola per li duoi antecedenti Contraponti fatti, vno nel graue, e l'altro nell'acuto, come anche per gli altri, che di già hà mo-strato, composti in diuersi modi; onde da cotal varietà più mi si confer-ma l'opinione, che la prattica del comporre in Musica sia maggiore in se stessa, e di maggior valore, che la Theorica. A. E, perche le Sig. Vostre non si persuadessero, che quì fosse il fine d'ogni varietà fra Contrapon-ti, ne mostrarò alcuni altri, che si ponno modulare e sotto, e sopra, mu-tando le parti, ciò è, facendo il Basso Soprano, e 'l Soprano Basso, & alzan-dosi la parte Bassa per interuallo d'otto voci, distante dal suo originale, & abbassando l'acuta dal suo primo stato per Quinta, come mostrarò ho-ra con l'essempio.
Di quì si manifesta, che l'istessa regola serue cosi nell'acuto, come nel graue; benche questo non sia simile al primo, ch'io mostrai in acuto. G. Ve-ramente è cosi, come ella per sua cortesia ne ha dimostrato. Il che ci è sta-to di gran contento, e d'altre tanto ci serà il dir (piacendo à V. S.) se nel-li altri Contraponti si troua l'istessa regola, & osseruationi, che seruano cosi nel graue come nell'acuto. A. Così farò. E per dar loro sodisfat-tione, seguirò ordinatamente. E perciò volendo formare vn Contrapon-to, che modular si possa per Decima lontano dal suo principale, ò sia for-mato nella parte graue, ò nella parte acuta, l'istesse regole, & osseruatio-ni seruiranno ad ambedue, come accertarà la proua. La onde non fatica-rò me, nè stancarò loro con altro essempio, che con l'vltimo dato, per cui del tutto s'assicuraranno. G. Potrà dunque V. S. seguirsene alli altri per ordine. A. Me ne passo al Contraponto, che si può modular per Duodecima, oue l'istessa regola, che si vsò nel crearlo nella parte acuta, aiutata anche totalmente nella parte Bassa. E per non vi esser differenza alcuna, non dirò altro sopra ciò; ma seguendo al Contraponto, che si può modular per Decima, e Duodecima, (in cui non cade altra nuoua regola: es-sendo concesso il poter vsar l'istesse osseruationi in farlo nella parte bassa, page 102come l'isperienza può mostrar nell'essempio già dato) auuertirò que-sto, che, facendosi il suo principal nel Graue, si hà da schifare ogni moui-mento sopra il Canto Plano, ò figurato: perche nella replica, che si fa al-la Duodecima, gli vengono molte dissonanze fuori d'ogni regola. Ne trouandosi differenza alcuna dalla prima regola de' predetti Contrapon-ti, fuorche di questo, che si può modular per Ottaua, per Decima, e per Duodecima; come all'hora, che ne parlai, già dissi farò fine. G. Hab-biamo visto vna sol regola per li duoi antecedenti Contraponti fatti, vno nel graue, e l'altro nell'acuto, come anche per gli altri, che di già hà mo-strato, composti in diuersi modi; onde da cotal varietà più mi si confer-ma l'opinione, che la prattica del comporre in Musica sia maggiore in se stessa, e di maggior valore, che la Theorica. A. E, perche le Sig. Vostre non si persuadessero, che quì fosse il fine d'ogni varietà fra Contrapon-ti, ne mostrarò alcuni altri, che si ponno modulare e sotto, e sopra, mu-tando le parti, ciò è, facendo il Basso Soprano, e 'l Soprano Basso, & alzan-dosi la parte Bassa per interuallo d'otto voci, distante dal suo originale, & abbassando l'acuta dal suo primo stato per Quinta, come mostrarò ho-ra con l'essempio.
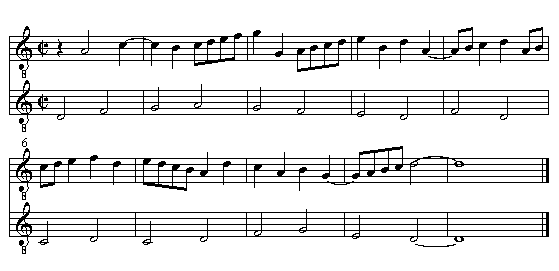 page 103
page 103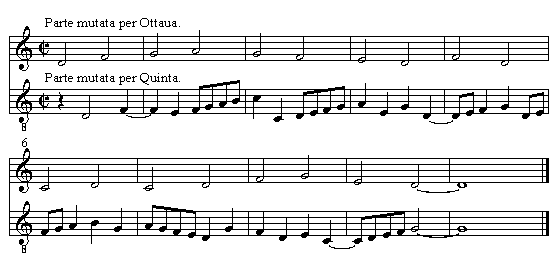 Di quì, mutate le parti, si scopre il Contraponto leggiadro, e bello. G. Poiche è piacciuto à V. S. di instruirci delli altri, non si sdegni anche di darci la regola da osseruarsi in far questo Contraponto, che questo sa-rà sua maggior cortesia, e più nostra perfettione, & obligo verso di lei. A. Si dè priuarsi della Consonanza Sesta, e della Dissonanza Settima, e Seconda. La Dissonanza Quarta poi, e l'altre Consonanze, si potran-no vsar à piacimento. G. Fauoriscaci Vostra Signoria di dir la cagio-ne, per cui si lasciano la Sesta, e quelle dissonanze. A. Si lasciano, perche, mutandosi le parti al modo, che si fa, ne sorgerebbero delle dissonanze fuori d'ogni regola, & ordine. G. Già, che hò intesa la causa, potrà V. S. à suo piacere farsene passaggio ad altri Contraponti. A. Scoprirò hora vn'altro Contraponto, che si può modular, alzando la parte Bassa per Quinta, e la superiore resterà ferma, come quì.
Di quì, mutate le parti, si scopre il Contraponto leggiadro, e bello. G. Poiche è piacciuto à V. S. di instruirci delli altri, non si sdegni anche di darci la regola da osseruarsi in far questo Contraponto, che questo sa-rà sua maggior cortesia, e più nostra perfettione, & obligo verso di lei. A. Si dè priuarsi della Consonanza Sesta, e della Dissonanza Settima, e Seconda. La Dissonanza Quarta poi, e l'altre Consonanze, si potran-no vsar à piacimento. G. Fauoriscaci Vostra Signoria di dir la cagio-ne, per cui si lasciano la Sesta, e quelle dissonanze. A. Si lasciano, perche, mutandosi le parti al modo, che si fa, ne sorgerebbero delle dissonanze fuori d'ogni regola, & ordine. G. Già, che hò intesa la causa, potrà V. S. à suo piacere farsene passaggio ad altri Contraponti. A. Scoprirò hora vn'altro Contraponto, che si può modular, alzando la parte Bassa per Quinta, e la superiore resterà ferma, come quì.
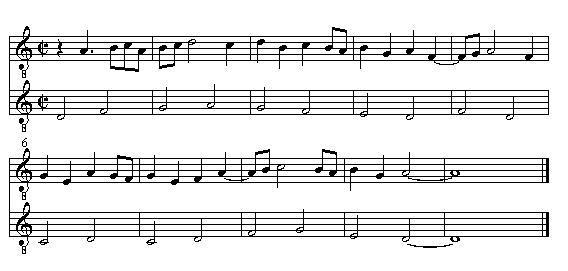
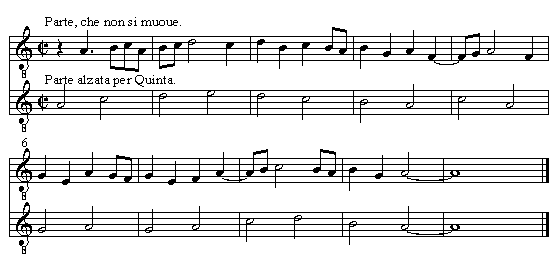 page 104G. Veggiò ciò con ogni chiarezza possibile; mà, se V. S. non vuol lasciar l'ordine incominciato nell'esercitar la sua cortesia, ci darà il modo di farne vn simile. A. Il farò volentieri. Leuisi la Consonanza Ottaua, la Se-sta, e la Settima: vi si concede poi l'vsar la dissonanza Quarta, e tutte le altre consonanze. Auuertendo però, che il Contraponto non vada sot-to il Canto Plano, ò figurato, quando si crea detto Contraponto; ma stia sopra; che cosi fia di buona riuscita. Desiderendo poscia il far vn'altro variato Contraponto, che si possi alzar la parte Bassa per vna Quinta, & abbassar la Superiore per vna Terza dal suo primo stato, non bisogna far due Terze, nè Sesta; nè Vnisono, nè Ottaua, nè Settima. E ben lecito il seruirsi della Quarta, mà più lodeuole è il lasciarla; posciache nella par-te, che si muoue per terza, vien saluata la Quarta con la Quinta; stando però, che non ecceda più d'otto voci tra i suoi estremi; e, che 'l Contra-ponto non vada sotto il Canto Plano; mà tuttauia sopra, & ecco l'es-sempio.
page 104G. Veggiò ciò con ogni chiarezza possibile; mà, se V. S. non vuol lasciar l'ordine incominciato nell'esercitar la sua cortesia, ci darà il modo di farne vn simile. A. Il farò volentieri. Leuisi la Consonanza Ottaua, la Se-sta, e la Settima: vi si concede poi l'vsar la dissonanza Quarta, e tutte le altre consonanze. Auuertendo però, che il Contraponto non vada sot-to il Canto Plano, ò figurato, quando si crea detto Contraponto; ma stia sopra; che cosi fia di buona riuscita. Desiderendo poscia il far vn'altro variato Contraponto, che si possi alzar la parte Bassa per vna Quinta, & abbassar la Superiore per vna Terza dal suo primo stato, non bisogna far due Terze, nè Sesta; nè Vnisono, nè Ottaua, nè Settima. E ben lecito il seruirsi della Quarta, mà più lodeuole è il lasciarla; posciache nella par-te, che si muoue per terza, vien saluata la Quarta con la Quinta; stando però, che non ecceda più d'otto voci tra i suoi estremi; e, che 'l Contra-ponto non vada sotto il Canto Plano; mà tuttauia sopra, & ecco l'es-sempio.
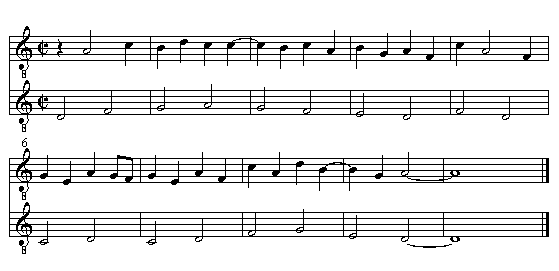
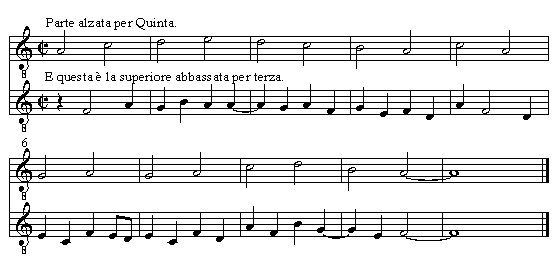 Hora porgerò vn'altro Contraponto, oue la parte superiore si potrà mu-tare per Ottaua, e la inferiore per Quinta in acuto dal suo originale, e ne dò l'essempio, ch'è questo. page 105
Hora porgerò vn'altro Contraponto, oue la parte superiore si potrà mu-tare per Ottaua, e la inferiore per Quinta in acuto dal suo originale, e ne dò l'essempio, ch'è questo. page 105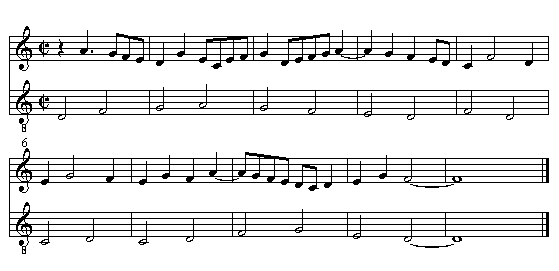
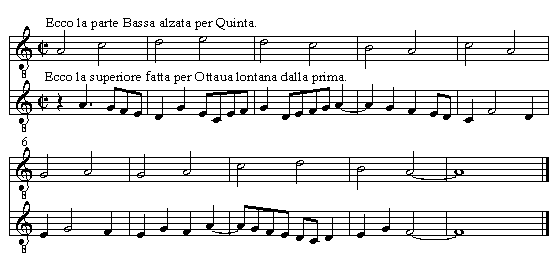 M. E cosa veramente ingegnosa; mà ci compiaccia V. S. in dar il modo per farne vn simile, conforme à quel, che ha fatto nelli passati. A. Si dè vietar la Settima, la Quintadecima, e la Sesta; adoprar poi si potrà la Dis-sonanza Quarta, e tutte l'altre consonanze. E ben vero, che l'obligo to-glie parte di quella varietà, e leggiadria, che si conuerrebbe; mà l'istesso ancora porra seco scusa, e consideratione. E per esser homai gionto al fi-ne di quanto poteuo dir sopra di questo, me ne passarò ad altri particola-ri piacendo d'vdirmi. G. Il tutto ci sarà di fauore. Ma pria, che passi ad altro di special gratia ci sarà intendere à che fine siano state ritrouate page 106le pause, & il loro effetto; poiche di quelle si seruono i Compositori in tutte le sue compositioni. A. Sono state trouate, e l'vsano i Composito-ri, mossi da più ragioni, e per varij effetti: e prima per dar riposo al Cantore tal volta, che fora impossibile il gionger continuamente al fin della Cantilena senza suo grande incommodo, e stanchezza della voce. Di più per far nuoue inuentioni, & anche per replicarle; e perche siano intese, & osseruate dalli ascoltanti. Se ne seruono ancora per la Conchiusione delle parole; & anche per render la Compositione più ornata, e vaga. G. Hò già intese le cause; mà, passando più oltre, saprei volentieri, qual sia il meglio di questi duoi, e qual più ingegnoso; quel, che cominciarà le parti per inuentione del Canto Plano, ò per altra inuentione, e poi darà principio ad esso Canto: ò chi lo cominciarà prìma [sic: prima], ouer vna parte con il detto Canto, e seguirà poscia alle altre parti fecendole similmente per in-uentioni. A. Fia meglio fuor d'ogni dubbio il cominciar prima il Canto Plano, secondo il mio parere, ouer vna parte insieme con l'istesso Canto, e seguir poi all'altre parti ordinatamente per inuentione; ò sia l'inuentio-ne simile al Canto Plano, ò sia d'altra sorte, che ciò nulla importa. E que-sto istesso modo hanno osseruato gli Eccellentissimi Compositori; come si può veder nella Messa di Costanzo Porta à sei voci, fatta sopra queste figure la, sol, fa, re, mi; e nella Messa del Palestina à quattro voci fatto so-pra l'Antifona. Ecce sacerdos magnus: e nelli Magnificat di Morales; e final-mente nelle Compositioni d'altri fatte sopra i Canti fermi. E tanto meglio sarà, quanto più l'inuentioni si estenderanno in longo, e maggiormente, se fossero le inuentioni obligate. G. E, perche io intenda questo più chiaro, non si sdegni V. S. di dirne, che cosa sia fuga obligata, & fuga sciol-ta. A. Fuga obligata fia quella, in che vna parte seguirà l'altra da principio sino al fine con gli medesimi interualli, e figure dalli Musici chiama-ta Guida. Fuga sciolta, ò non obligata fia poi quella, che seguirà vna parte per alquante figure, & interualli, ma non già sino alla fine. G. Hò benissimo intesa la differenza, che è tra la fuga sciolta,e l'obligata; e ciò ci è stato di tanto fauore, di quanto ci sarà anche il saper la differenza, che si troua fra la fuga, e l'imitatione; se piacerà à V. S. di dirmela. A. L'imi-tatione sarà questa, che imitarà vn Motetto, Madrigale, ò Canzone con gli istessi mouimenti; mà non seruarà il valore delle figure del Motetto, ò Madrigale, od altra cosa, che si sia; nè tampoco alle volte gli stessi Tuoni, & Semituoni. Questo modo adunque si dirà imitatione; e questa è la differenza, che si troua tra la fuga, & l'imitatione. G. Volentieri per re-star meglio instrutto di quanto V. S. mi hà detto della fuga cosi sciolta, come obligata, e dell'imitatione (piacendole) vedrei vn poco d'essempio. A. Lo farò veder quiui. page 107
M. E cosa veramente ingegnosa; mà ci compiaccia V. S. in dar il modo per farne vn simile, conforme à quel, che ha fatto nelli passati. A. Si dè vietar la Settima, la Quintadecima, e la Sesta; adoprar poi si potrà la Dis-sonanza Quarta, e tutte l'altre consonanze. E ben vero, che l'obligo to-glie parte di quella varietà, e leggiadria, che si conuerrebbe; mà l'istesso ancora porra seco scusa, e consideratione. E per esser homai gionto al fi-ne di quanto poteuo dir sopra di questo, me ne passarò ad altri particola-ri piacendo d'vdirmi. G. Il tutto ci sarà di fauore. Ma pria, che passi ad altro di special gratia ci sarà intendere à che fine siano state ritrouate page 106le pause, & il loro effetto; poiche di quelle si seruono i Compositori in tutte le sue compositioni. A. Sono state trouate, e l'vsano i Composito-ri, mossi da più ragioni, e per varij effetti: e prima per dar riposo al Cantore tal volta, che fora impossibile il gionger continuamente al fin della Cantilena senza suo grande incommodo, e stanchezza della voce. Di più per far nuoue inuentioni, & anche per replicarle; e perche siano intese, & osseruate dalli ascoltanti. Se ne seruono ancora per la Conchiusione delle parole; & anche per render la Compositione più ornata, e vaga. G. Hò già intese le cause; mà, passando più oltre, saprei volentieri, qual sia il meglio di questi duoi, e qual più ingegnoso; quel, che cominciarà le parti per inuentione del Canto Plano, ò per altra inuentione, e poi darà principio ad esso Canto: ò chi lo cominciarà prìma [sic: prima], ouer vna parte con il detto Canto, e seguirà poscia alle altre parti fecendole similmente per in-uentioni. A. Fia meglio fuor d'ogni dubbio il cominciar prima il Canto Plano, secondo il mio parere, ouer vna parte insieme con l'istesso Canto, e seguir poi all'altre parti ordinatamente per inuentione; ò sia l'inuentio-ne simile al Canto Plano, ò sia d'altra sorte, che ciò nulla importa. E que-sto istesso modo hanno osseruato gli Eccellentissimi Compositori; come si può veder nella Messa di Costanzo Porta à sei voci, fatta sopra queste figure la, sol, fa, re, mi; e nella Messa del Palestina à quattro voci fatto so-pra l'Antifona. Ecce sacerdos magnus: e nelli Magnificat di Morales; e final-mente nelle Compositioni d'altri fatte sopra i Canti fermi. E tanto meglio sarà, quanto più l'inuentioni si estenderanno in longo, e maggiormente, se fossero le inuentioni obligate. G. E, perche io intenda questo più chiaro, non si sdegni V. S. di dirne, che cosa sia fuga obligata, & fuga sciol-ta. A. Fuga obligata fia quella, in che vna parte seguirà l'altra da principio sino al fine con gli medesimi interualli, e figure dalli Musici chiama-ta Guida. Fuga sciolta, ò non obligata fia poi quella, che seguirà vna parte per alquante figure, & interualli, ma non già sino alla fine. G. Hò benissimo intesa la differenza, che è tra la fuga sciolta,e l'obligata; e ciò ci è stato di tanto fauore, di quanto ci sarà anche il saper la differenza, che si troua fra la fuga, e l'imitatione; se piacerà à V. S. di dirmela. A. L'imi-tatione sarà questa, che imitarà vn Motetto, Madrigale, ò Canzone con gli istessi mouimenti; mà non seruarà il valore delle figure del Motetto, ò Madrigale, od altra cosa, che si sia; nè tampoco alle volte gli stessi Tuoni, & Semituoni. Questo modo adunque si dirà imitatione; e questa è la differenza, che si troua tra la fuga, & l'imitatione. G. Volentieri per re-star meglio instrutto di quanto V. S. mi hà detto della fuga cosi sciolta, come obligata, e dell'imitatione (piacendole) vedrei vn poco d'essempio. A. Lo farò veder quiui. page 107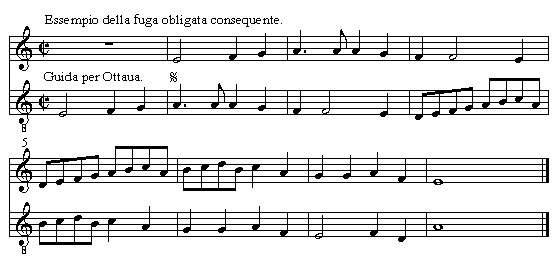
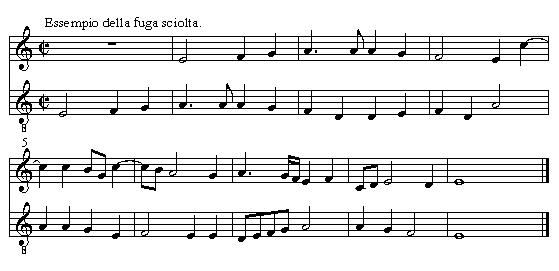
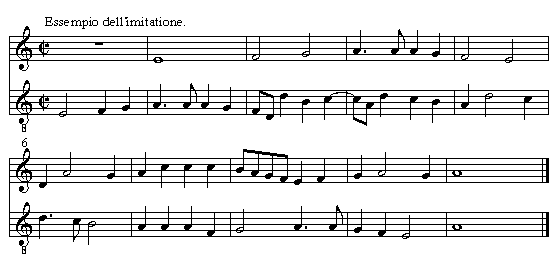 Hora da questi essempij potranno conoscer la differenza, che giace fra l'vna, & l'altra. G. Hò benissimo conosciuta la varietà. Laonde per passar più oltre, prego V. S. à volermi compiacer ancora di dir se si possa fa-re vna Cantilena senza interpositione di pause, che accrescendone gli fa-uori, maggiormente gli saremo obligati. A. E vero, che si potrebbe fare; mà dubbio non è, che la Cantilena non saria di buona riuscita; poiche al-cune inuentioni non se gli ponno fare senza il mezo del riposo; e, se pur page 108se gli fanno, riescono confuse, e male intese dalli Ascoltanti; e 'l Cantore non può (se non con grandissima fatica, e difficultà, come già dissi) sup-plir con la voce sino alla fine. G. Hora ci sarebbe necessario il saper, co-me s'habbia à finir vn Contraponto, hauendo di già inteso, come si possi formare; poiche non sappiamo, se si habbi à finir vn Contraponto, ò vna Compositione di due voci per altra consonanza, che per l'vnisono, ouer Ottaua. Onde aspettiamo questo dalla cortesia di V. S. non le sendo in-commodo. A. Non mi sarà mai incommodo (purche possa) il sodisfar ad ogni loro desiderio. E perciò in questo dico, che il Contraponto di due voci, e la Compositione d'altretante, ò di trè voci, si deuono finire per Ottaua, sendo quella la più nobile, e prima consonanza creata dalli numeri, che danno le consonanze; ouero per Vnisone, come porta l'occasione della Cantilena. Si potrà pur anche per piacer del Compositore finire in Decima, ouer in Terza; ma fia meglio per Ottaua, ò per Vniso-no, come è stato osseruato dalli Musici Antichi, e Moderni, e specialmen-te nelle compositioni di due, e tre voci. G. Perche dalli Contraponti si passa poi alle Compositioni, di fauor non picciolo ci sarebbe il saper qualche altra cosa sopra di loro; e prima, se, facendo vna Compositione di quattro voci, e mancandole qualche consonanza, come la Terza, ouer la Quinta, si potrebbe chiamar error del Musico, ò si permeterebbe. A. Tal hora fia lecito il priuarsi di quelle Consonanze, ciò è, quando si principiarà qualche inuentione; che allhora per l'obligo, che si tiene, si concederà il priuarsene, acciò le parti vadino cantando con più bel modo, e più legitimi interualli. E ciò si permette ancora nel far qualche cadenza, ouer terminatione; come si può veder nelle compositioni di Cipriano, del Palestina, di Morales, e d'altri Autori; mà vieterassi fuori di tali occa-sioni, perche la Cantilena non resti pouera. M. E per metter insieme quattro, ò cinque parti, che cantino conformi l'osseruationi delli Eccellenti Musici, euui regola, ò modo alcuno da osseruarsi? A. Vi sono alcune regole formate da qualche Autore, tra quali fù Pietro Aron nel Capitolo vigesimo primo della seconda parte dell'opra sua intitolata il Toscanel-lo, & altri; mà veramente (per quanto io mi giudico) non vi si può trouar regola terminata; poiche tal'hora si trouarà il Tenore per vnisono con la parte Bassa, e tal'hora per Quinta, & anche per Ottaua, doue conuerrà mutar l'altre parti. E perciò non si può dar regola certa per accop-piare insieme le Consonaoze [sic: Consonanze]. M. Chi causa questo? A. Il modular, che fanno le parti, & ancora le inuentioni, che si fanno fra le Composi-tioni. Siche (come dissi) per mio giudicio non si può darsi regola ferma. Si darà ben questa, che il Compositore auuertisca, che le parti vadino più, che sia possibile, per mouimenti congionti; perche siano più facili, e page 109più commodi al Cantore da cantarsi. Che parimente dopò vna conso-nanza perfetta segua vna imperfetta, per far la Compositione regolata, e con qualche varietà. Si deue ancora osseruare di procedere da vna Con-sonanza all'altra, con la più propinqua, che si troua. Queste sono come regole, e commandamenti infallibili, nè di sicura altra per mio giudicio, se ne ritroua. M. Le ragioni addotte da V. S. supra di ciò sono cosi reali, che necessariamente si dè conchiuder seco, & perciò non vi si troua altra regola ferma; onde parimente si deue affermare, che cotesta prattica ec-ceda, e superi di gran longa la Theorica, per le tante diuersità, che in quella si scorgono, e per le molte differenti maniere, che quotidianamente si scoprono nelle Compositioni, che non si ponno intender bene, e, meno possedere senza molta fatica, e studio, fuori de' quali non si concede l'acquistar cotesta prattica del comporre. A. Ne io tengo punto di dub-bio in questo, che le Signorie Vostre siano per giudicare altrimente: anzi mi prometto, che maggiormente lo stimarono allhora, che haurò mostrare le tante varietà delli Canoni, che si trouano, e si veggono posti ogni giorno dalli Compositori fra le loro Cantilene. E, perche il tempo me 'l concede (se loro dandomi grate orecchie il permetteranno) seguirò in mostrarne qualch'vno. G. Grandissima sarà l'vtilità, che noi ne tra-remo; sommo il fauore, che la ci farà, & infinito l'obligo, che le terre-mo. A. Persuadansi adunque, che due sono le varietà delli Canoni, vno fatto conforme all'idea, & all'intelletto del Compositore, che sarà hora à due, hora à trè voci; e tal volta ancora saranno accompagnate à tal Ca-none, due, e tre parti sciolte, e più, come più piace al Compositore: l'al-tro tutto diuerso dal precedente vien fatto con alcune osseruationi. Pri-ma farò principio da quei Canoni, che sono fatti à due voci dal Compositore, secondo il suo genio, e poi me ne verrò à questo vltimo. Gli Com-positori fanno questi Canoni hora all'Vnisono, hora alla Seconda, hora alla Terza, hora alla Quinta, come più gli piace. Siche infinite sono que-ste variationi de' Canoni; e 'l volerle mostrar tutte, richiederebbe vn ra-gionamento fuori di modo longo. G. Vietando dunque à V. S. il poco tempo, che ci resta, il far questo, lo differisca ad vn'altro giorno, che più le sia di commodità. A. Mi dò bene ad intendere, che ci auanzi tanto tempo ancora prima, che vengano questi Signori, che ne vederemo la maggior parte. G. Se cosi le piace, seguiti dunque à sua voglia. A. Se-guirò. Sono alcuni Canoni, che si fanno con due parti; & sono accom-pagnati poi da due, e da tre parti sciolti, come si vede nella Messa di Iosquino. Aue maris stella. In quella di Morales à cinque voci fatta pure anche sopra l'istesso Hinno. Aue Maris Stella. Nel Palestina sopra la Mes-sa, Ad Coenam agni prouidi, Hinno della Resurrettione, & in altri Scrit-page 110tori, quali tralasciò [sic: tralascio]. Altrimente poi vi sono, che si fanno à due voci, & altri à trè, & à quattro, cantando tutte le parti sopra vna sol parte. Alcuni altri poi si faranno sopra vna parte, che andranno due parti per contrario delle altre due. Altri compositori faranno due parti per Cano-ne, & altre due ancora similmente per Canone. Siche diuersi sono i Ca-noni predetti, che si fanno. G. Non mi neghi Vostra Signoria (la prego) di dirci, se questi Canoni sono sempre per Vnisono, ò per Quarta, ò per Quinta, ò se si ponno fare, come piace al Compositore. A. Si fan-no sempre secondo il voler di chi gli forma, come già dissi. G. Mi com-piaccio sommamente d'esserle perpetuamente obligato. Laonde non mi sgomento, se per nuoui fauori, che continuamente ella mi fà, si accresco-no gli oblighi. Perciò confidatomi nella sua infinita cortesia più sempre ardisco di chiederle (come così hora le chiedo) nuoua gratia, ciò è, che ella ci mostri, doue si possino fare questi Canoni, cominciando dall'Vni-sono, e seguendo per ordine. A. Haurò pur sempre io in somma gratia ogni occasione di compiacer loro, per dimostrare l'animo, che hò di ser-uirle; e per confermarmi nell'amor, che mi portano. Perilche venendo al particolar, che V. S. mi chiede, prima, che me ne passi più oltre, scoprirò duoi modi principali per far Canoni, de' quali vno è sciolto, l'altro è obligato, come dissi. Lo sciolto fia allhora, che si potrà seruir d'ogni con-sonanza, e dissonanza; l'altro all'hora serà, quando il Compositore si pri-uarà d'alcuna d'esse. Prima dunque mostrarò quei fatti à due voci senza obligo veruno, cominciando per Vnisono, e seguendo sino all'Ottaua, come si desidera, e questo primo fia per Vnisono.
Hora da questi essempij potranno conoscer la differenza, che giace fra l'vna, & l'altra. G. Hò benissimo conosciuta la varietà. Laonde per passar più oltre, prego V. S. à volermi compiacer ancora di dir se si possa fa-re vna Cantilena senza interpositione di pause, che accrescendone gli fa-uori, maggiormente gli saremo obligati. A. E vero, che si potrebbe fare; mà dubbio non è, che la Cantilena non saria di buona riuscita; poiche al-cune inuentioni non se gli ponno fare senza il mezo del riposo; e, se pur page 108se gli fanno, riescono confuse, e male intese dalli Ascoltanti; e 'l Cantore non può (se non con grandissima fatica, e difficultà, come già dissi) sup-plir con la voce sino alla fine. G. Hora ci sarebbe necessario il saper, co-me s'habbia à finir vn Contraponto, hauendo di già inteso, come si possi formare; poiche non sappiamo, se si habbi à finir vn Contraponto, ò vna Compositione di due voci per altra consonanza, che per l'vnisono, ouer Ottaua. Onde aspettiamo questo dalla cortesia di V. S. non le sendo in-commodo. A. Non mi sarà mai incommodo (purche possa) il sodisfar ad ogni loro desiderio. E perciò in questo dico, che il Contraponto di due voci, e la Compositione d'altretante, ò di trè voci, si deuono finire per Ottaua, sendo quella la più nobile, e prima consonanza creata dalli numeri, che danno le consonanze; ouero per Vnisone, come porta l'occasione della Cantilena. Si potrà pur anche per piacer del Compositore finire in Decima, ouer in Terza; ma fia meglio per Ottaua, ò per Vniso-no, come è stato osseruato dalli Musici Antichi, e Moderni, e specialmen-te nelle compositioni di due, e tre voci. G. Perche dalli Contraponti si passa poi alle Compositioni, di fauor non picciolo ci sarebbe il saper qualche altra cosa sopra di loro; e prima, se, facendo vna Compositione di quattro voci, e mancandole qualche consonanza, come la Terza, ouer la Quinta, si potrebbe chiamar error del Musico, ò si permeterebbe. A. Tal hora fia lecito il priuarsi di quelle Consonanze, ciò è, quando si principiarà qualche inuentione; che allhora per l'obligo, che si tiene, si concederà il priuarsene, acciò le parti vadino cantando con più bel modo, e più legitimi interualli. E ciò si permette ancora nel far qualche cadenza, ouer terminatione; come si può veder nelle compositioni di Cipriano, del Palestina, di Morales, e d'altri Autori; mà vieterassi fuori di tali occa-sioni, perche la Cantilena non resti pouera. M. E per metter insieme quattro, ò cinque parti, che cantino conformi l'osseruationi delli Eccellenti Musici, euui regola, ò modo alcuno da osseruarsi? A. Vi sono alcune regole formate da qualche Autore, tra quali fù Pietro Aron nel Capitolo vigesimo primo della seconda parte dell'opra sua intitolata il Toscanel-lo, & altri; mà veramente (per quanto io mi giudico) non vi si può trouar regola terminata; poiche tal'hora si trouarà il Tenore per vnisono con la parte Bassa, e tal'hora per Quinta, & anche per Ottaua, doue conuerrà mutar l'altre parti. E perciò non si può dar regola certa per accop-piare insieme le Consonaoze [sic: Consonanze]. M. Chi causa questo? A. Il modular, che fanno le parti, & ancora le inuentioni, che si fanno fra le Composi-tioni. Siche (come dissi) per mio giudicio non si può darsi regola ferma. Si darà ben questa, che il Compositore auuertisca, che le parti vadino più, che sia possibile, per mouimenti congionti; perche siano più facili, e page 109più commodi al Cantore da cantarsi. Che parimente dopò vna conso-nanza perfetta segua vna imperfetta, per far la Compositione regolata, e con qualche varietà. Si deue ancora osseruare di procedere da vna Con-sonanza all'altra, con la più propinqua, che si troua. Queste sono come regole, e commandamenti infallibili, nè di sicura altra per mio giudicio, se ne ritroua. M. Le ragioni addotte da V. S. supra di ciò sono cosi reali, che necessariamente si dè conchiuder seco, & perciò non vi si troua altra regola ferma; onde parimente si deue affermare, che cotesta prattica ec-ceda, e superi di gran longa la Theorica, per le tante diuersità, che in quella si scorgono, e per le molte differenti maniere, che quotidianamente si scoprono nelle Compositioni, che non si ponno intender bene, e, meno possedere senza molta fatica, e studio, fuori de' quali non si concede l'acquistar cotesta prattica del comporre. A. Ne io tengo punto di dub-bio in questo, che le Signorie Vostre siano per giudicare altrimente: anzi mi prometto, che maggiormente lo stimarono allhora, che haurò mostrare le tante varietà delli Canoni, che si trouano, e si veggono posti ogni giorno dalli Compositori fra le loro Cantilene. E, perche il tempo me 'l concede (se loro dandomi grate orecchie il permetteranno) seguirò in mostrarne qualch'vno. G. Grandissima sarà l'vtilità, che noi ne tra-remo; sommo il fauore, che la ci farà, & infinito l'obligo, che le terre-mo. A. Persuadansi adunque, che due sono le varietà delli Canoni, vno fatto conforme all'idea, & all'intelletto del Compositore, che sarà hora à due, hora à trè voci; e tal volta ancora saranno accompagnate à tal Ca-none, due, e tre parti sciolte, e più, come più piace al Compositore: l'al-tro tutto diuerso dal precedente vien fatto con alcune osseruationi. Pri-ma farò principio da quei Canoni, che sono fatti à due voci dal Compositore, secondo il suo genio, e poi me ne verrò à questo vltimo. Gli Com-positori fanno questi Canoni hora all'Vnisono, hora alla Seconda, hora alla Terza, hora alla Quinta, come più gli piace. Siche infinite sono que-ste variationi de' Canoni; e 'l volerle mostrar tutte, richiederebbe vn ra-gionamento fuori di modo longo. G. Vietando dunque à V. S. il poco tempo, che ci resta, il far questo, lo differisca ad vn'altro giorno, che più le sia di commodità. A. Mi dò bene ad intendere, che ci auanzi tanto tempo ancora prima, che vengano questi Signori, che ne vederemo la maggior parte. G. Se cosi le piace, seguiti dunque à sua voglia. A. Se-guirò. Sono alcuni Canoni, che si fanno con due parti; & sono accom-pagnati poi da due, e da tre parti sciolti, come si vede nella Messa di Iosquino. Aue maris stella. In quella di Morales à cinque voci fatta pure anche sopra l'istesso Hinno. Aue Maris Stella. Nel Palestina sopra la Mes-sa, Ad Coenam agni prouidi, Hinno della Resurrettione, & in altri Scrit-page 110tori, quali tralasciò [sic: tralascio]. Altrimente poi vi sono, che si fanno à due voci, & altri à trè, & à quattro, cantando tutte le parti sopra vna sol parte. Alcuni altri poi si faranno sopra vna parte, che andranno due parti per contrario delle altre due. Altri compositori faranno due parti per Cano-ne, & altre due ancora similmente per Canone. Siche diuersi sono i Ca-noni predetti, che si fanno. G. Non mi neghi Vostra Signoria (la prego) di dirci, se questi Canoni sono sempre per Vnisono, ò per Quarta, ò per Quinta, ò se si ponno fare, come piace al Compositore. A. Si fan-no sempre secondo il voler di chi gli forma, come già dissi. G. Mi com-piaccio sommamente d'esserle perpetuamente obligato. Laonde non mi sgomento, se per nuoui fauori, che continuamente ella mi fà, si accresco-no gli oblighi. Perciò confidatomi nella sua infinita cortesia più sempre ardisco di chiederle (come così hora le chiedo) nuoua gratia, ciò è, che ella ci mostri, doue si possino fare questi Canoni, cominciando dall'Vni-sono, e seguendo per ordine. A. Haurò pur sempre io in somma gratia ogni occasione di compiacer loro, per dimostrare l'animo, che hò di ser-uirle; e per confermarmi nell'amor, che mi portano. Perilche venendo al particolar, che V. S. mi chiede, prima, che me ne passi più oltre, scoprirò duoi modi principali per far Canoni, de' quali vno è sciolto, l'altro è obligato, come dissi. Lo sciolto fia allhora, che si potrà seruir d'ogni con-sonanza, e dissonanza; l'altro all'hora serà, quando il Compositore si pri-uarà d'alcuna d'esse. Prima dunque mostrarò quei fatti à due voci senza obligo veruno, cominciando per Vnisono, e seguendo sino all'Ottaua, come si desidera, e questo primo fia per Vnisono.
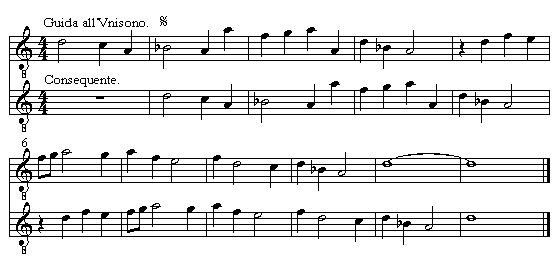 Auuertiscasi però, che, oue saranno questi segni [[mus.sigcon]] nel primo d'essi, si co-minciarà, e si finirà nel secondo; come possono considerar nel Sopra dato essempio. Hora ne formo il secondo fatto per seconda; & ecco l'essempio. page 111
Auuertiscasi però, che, oue saranno questi segni [[mus.sigcon]] nel primo d'essi, si co-minciarà, e si finirà nel secondo; come possono considerar nel Sopra dato essempio. Hora ne formo il secondo fatto per seconda; & ecco l'essempio. page 111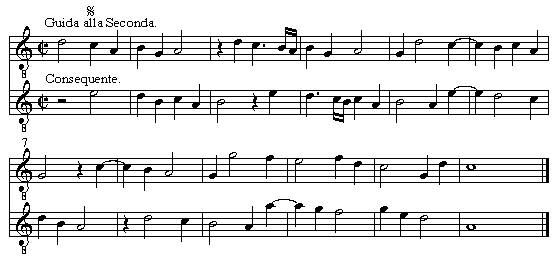 Questo altro, di cui dò l'essempio, sarà per Terza minore, come dal considerarlo s'accertaranno,
Questo altro, di cui dò l'essempio, sarà per Terza minore, come dal considerarlo s'accertaranno,
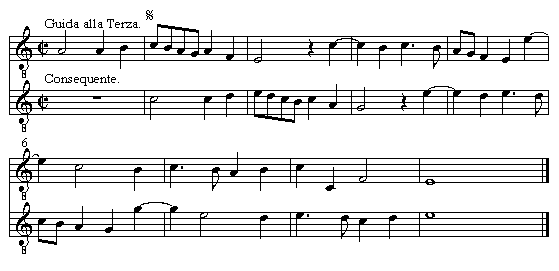 Questo poi vien fatto per Quarta.
Questo poi vien fatto per Quarta.
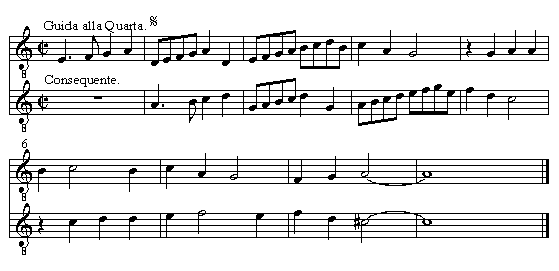 page 112Questo sopraposto chiaramente si mostra lonta no [sic: lontano] dalla Guida per Quarta; ma quel, che segue fia lontano dalla Guida per Quinta.
page 112Questo sopraposto chiaramente si mostra lonta no [sic: lontano] dalla Guida per Quarta; ma quel, che segue fia lontano dalla Guida per Quinta.
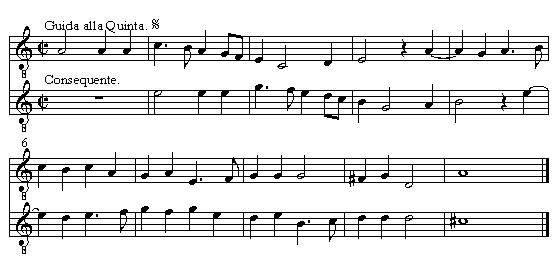 Quest'altro fatto per Sesta minore, vien detto Essacordo minore.
Quest'altro fatto per Sesta minore, vien detto Essacordo minore.
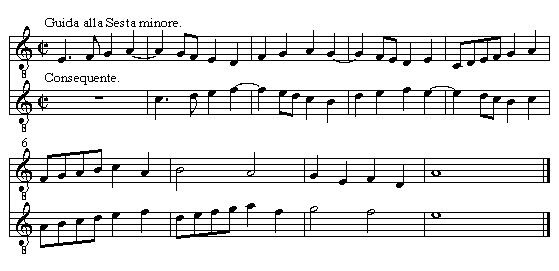 Dal seguente essempio si dà à conoscere quel che è fatto per Settima detto Eptacordo, che altro non significa, che Settima.
Dal seguente essempio si dà à conoscere quel che è fatto per Settima detto Eptacordo, che altro non significa, che Settima.
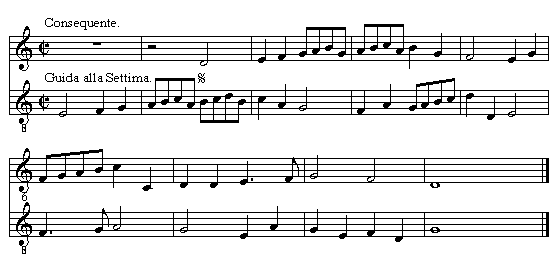 page 113Mi resta il formar l'vltimo fatto per Ottaua, & qui sarà il fine delli Canoni sciolti; dell'vltimo adunque porgo tal essempio.
page 113Mi resta il formar l'vltimo fatto per Ottaua, & qui sarà il fine delli Canoni sciolti; dell'vltimo adunque porgo tal essempio.
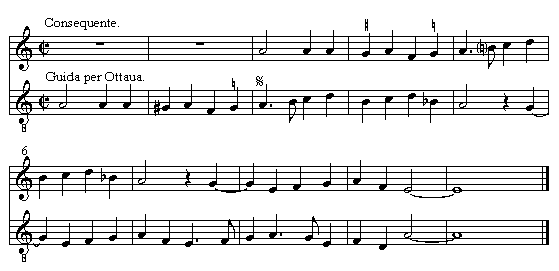 Farò passaggio al mostrarne alcuni altri fatti à due voci per Vnisono, e per altra consonanza ancora con alcune osseruationi, che non più sciolti, ma obligati saranno. E primieramente all'Vnisono verrò, doue vna par-te dirà l'istesse figure, non seruando però i medesimi Tuoni, e Semituoni per esser fatto per contrarij moti, di cui offerisco l'essempio presente.
Farò passaggio al mostrarne alcuni altri fatti à due voci per Vnisono, e per altra consonanza ancora con alcune osseruationi, che non più sciolti, ma obligati saranno. E primieramente all'Vnisono verrò, doue vna par-te dirà l'istesse figure, non seruando però i medesimi Tuoni, e Semituoni per esser fatto per contrarij moti, di cui offerisco l'essempio presente.
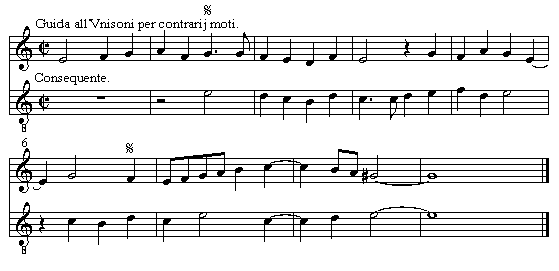 Potrassi mutar in questo Canone il principale, e far cominciar il Tenore, e dar le pause al Soprano, come nel presente essempio si vede.
Potrassi mutar in questo Canone il principale, e far cominciar il Tenore, e dar le pause al Soprano, come nel presente essempio si vede.
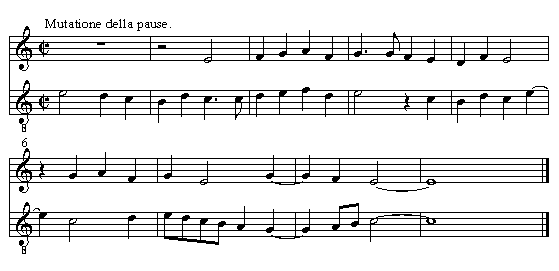 page 114Ne formarò adesso vn'altro per Seconda, perche si veda la loro varietà.
page 114Ne formarò adesso vn'altro per Seconda, perche si veda la loro varietà.
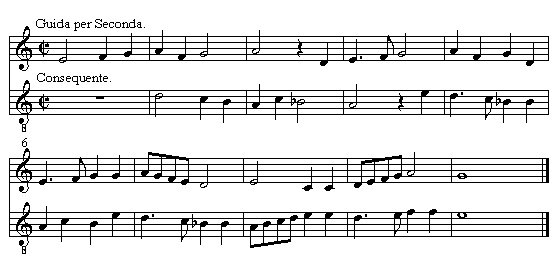 Volendo poi, che il Contralto principia, daransi le pause al Soprano, conforme à questo essempio.
Volendo poi, che il Contralto principia, daransi le pause al Soprano, conforme à questo essempio.
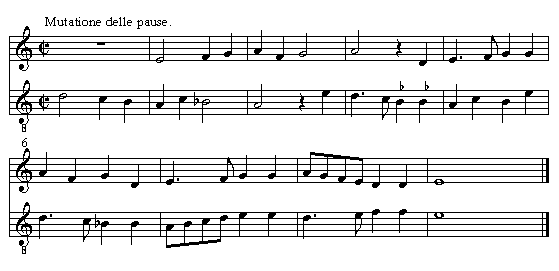 Dò l'essempio ancora d'vn formato alla Terza, e d'vn'altro alla Quarta; acciò del tutto restino benissimo possessori.
Dò l'essempio ancora d'vn formato alla Terza, e d'vn'altro alla Quarta; acciò del tutto restino benissimo possessori.
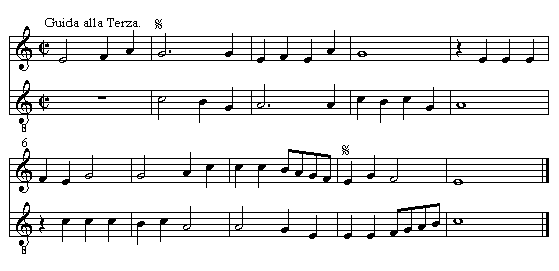 page 115
page 115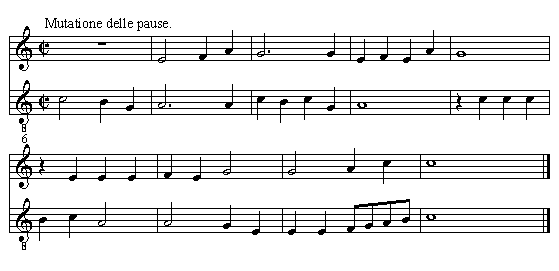
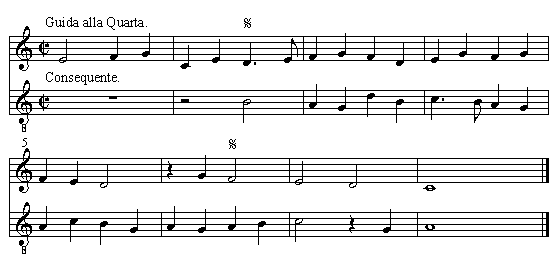
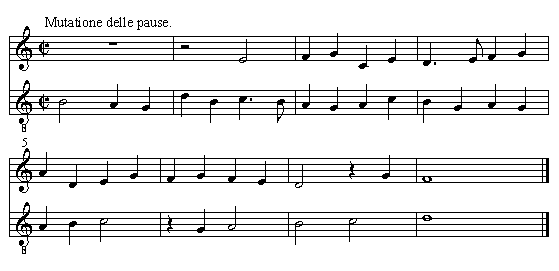 Io non procacciarò à me stesso nuoua fatica, & alle Signorie Vostre noia co 'l formar altri essempij, per dimostrar, che i principij di queste altri si ponno mutare; poscia che l'istesso modo osseruato nelli duoi primi per sempre seruirà. M. Già; che habbiamo hauuti da lei le regole; & le os-seruationi per far questi primi Canoni, che ci mostrò, & essendo questi secondi di meno valore delli altri, ci fauorisca di darne pur anco le sue osseruationi, che ci sarà di sommo fauore. A. Così farò. La regola per far simili Canoni è facilissima; prima bisogna procedere per moto con-page 116. trario del principale[unclear: ,] & hauer riguardo, che non vi cadino alcune Quin-te imperfette fatte senza regola; e non vsar'altro, che le consonanze per-fette, & imperfette, lasciando da parte ogni sorte di dissonanze, che nulla vi fanno à proposito. Il che, se essaminaranno, potranno da lor stesse conoscer perfettamente li sopradetti Canoni. M. Degna è veramente di stima, per esser ingegnosa, è la sua osseruatione facile, sopra la quale non occorre, ch'altro dica per nostra intelligenza: e perciò potrà ridursi ad altre varietà. A. Cosi farò, mostrandone vno pur à due voci, che può modularsi per Quinta, e per Quarta sopra, e sotto il principale di cui for-mo questo essempio.
Io non procacciarò à me stesso nuoua fatica, & alle Signorie Vostre noia co 'l formar altri essempij, per dimostrar, che i principij di queste altri si ponno mutare; poscia che l'istesso modo osseruato nelli duoi primi per sempre seruirà. M. Già; che habbiamo hauuti da lei le regole; & le os-seruationi per far questi primi Canoni, che ci mostrò, & essendo questi secondi di meno valore delli altri, ci fauorisca di darne pur anco le sue osseruationi, che ci sarà di sommo fauore. A. Così farò. La regola per far simili Canoni è facilissima; prima bisogna procedere per moto con-page 116. trario del principale[unclear: ,] & hauer riguardo, che non vi cadino alcune Quin-te imperfette fatte senza regola; e non vsar'altro, che le consonanze per-fette, & imperfette, lasciando da parte ogni sorte di dissonanze, che nulla vi fanno à proposito. Il che, se essaminaranno, potranno da lor stesse conoscer perfettamente li sopradetti Canoni. M. Degna è veramente di stima, per esser ingegnosa, è la sua osseruatione facile, sopra la quale non occorre, ch'altro dica per nostra intelligenza: e perciò potrà ridursi ad altre varietà. A. Cosi farò, mostrandone vno pur à due voci, che può modularsi per Quinta, e per Quarta sopra, e sotto il principale di cui for-mo questo essempio.
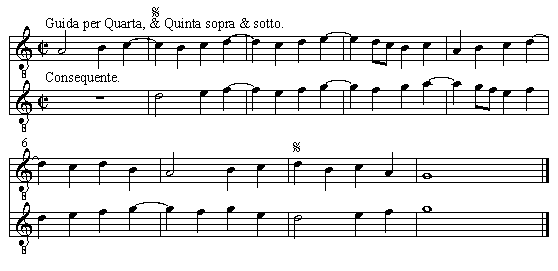
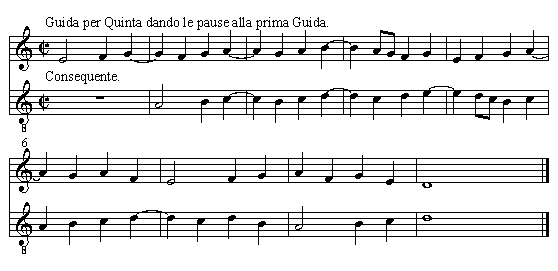 Habbino però in consideratione, che, volendosi far il Canone per Quinta, (che, come veggono è per Quarta) fia di mestieri, che le due pause di Semibreue vi siano, le quali all'hora si daranno al principale, onde il tutto riuscirà bene. M. Habbiamo visto ciò, che ci hà mostrato. Resta solo, che V. S. (piacendole) ci mostri con l'essempio, come ne fia lecito fare, che questo Canone moduli per Quarta, & Quinta sotto il principale. A. Ecco l'essempio.
Habbino però in consideratione, che, volendosi far il Canone per Quinta, (che, come veggono è per Quarta) fia di mestieri, che le due pause di Semibreue vi siano, le quali all'hora si daranno al principale, onde il tutto riuscirà bene. M. Habbiamo visto ciò, che ci hà mostrato. Resta solo, che V. S. (piacendole) ci mostri con l'essempio, come ne fia lecito fare, che questo Canone moduli per Quarta, & Quinta sotto il principale. A. Ecco l'essempio.
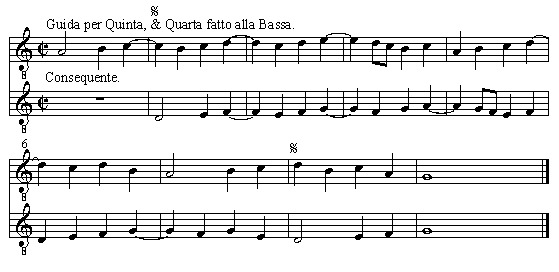 page 117
page 117
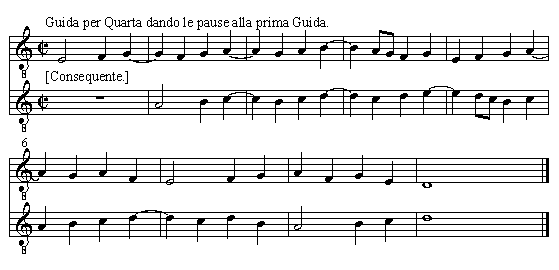 Di quì scorgono, che volendosi il Canone per Quarta, si dà la pausa di Breue al principale. Et, per non mi partire dall'ordine già cominciato, (e credo, che à loro fia caro) mostrarò la maniera di farne vn simile, la qual per se stessa è cosa facilissima; nè vi si ricerca altro, che 'l priuar il Canone d'vna consonanza perfetta, qual fia la Quinta, volendolo far per Quarta, ouer per Quinta; & et si potrà modular e sotto, e sopra per l'i-stesse figure, mentre che si diano le pause, à che verranno, come hanno visto. M. Grandissime osseruationi mi prometteuo io in questo Canone, già che mi si mostrauano quelle parti modulate hora alla Quarta, hora alla Quinta, tanto sopra, quanto sotto, onde da ciascuna d'esse vsciua buona relatione, ma adesso, conoscendo; che 'l tutto prouiene, e si fà solo per la priuatione d'vna Consonanza perfetta, la merauiglia già concetta in me, si è quasi ridotta in riso; pure stimo ciò per cosa notabile, e degna di memoria. A. Come dice à punto, saputa la regola par cosa di niun mo-mento, e ridicolosa; conciosia che da vna sola consonanza nasce tanta varietà. M. Mi dò ad intendere, che resti ancora à Vostra Signoria molto da mostrarci di queste varietà tanto ingegnose, e meriteuoli di ranto [sic: tanto] studio particolare; e però potrà seguire à suo piacere, che, & l'inten-derle ci sarà di grandissimo fauore, e di sommo vtile. A. Per hauer sin hor ragionato di quei Canoni, che son fatti à due voci, dirò di quelli, che si fanno à trè voci, parlando prima delli sciolti. Siche sarà il mio principio (come per l'adietro) all'Vnisono, di cui porgo questo es-sempio. page 118
Di quì scorgono, che volendosi il Canone per Quarta, si dà la pausa di Breue al principale. Et, per non mi partire dall'ordine già cominciato, (e credo, che à loro fia caro) mostrarò la maniera di farne vn simile, la qual per se stessa è cosa facilissima; nè vi si ricerca altro, che 'l priuar il Canone d'vna consonanza perfetta, qual fia la Quinta, volendolo far per Quarta, ouer per Quinta; & et si potrà modular e sotto, e sopra per l'i-stesse figure, mentre che si diano le pause, à che verranno, come hanno visto. M. Grandissime osseruationi mi prometteuo io in questo Canone, già che mi si mostrauano quelle parti modulate hora alla Quarta, hora alla Quinta, tanto sopra, quanto sotto, onde da ciascuna d'esse vsciua buona relatione, ma adesso, conoscendo; che 'l tutto prouiene, e si fà solo per la priuatione d'vna Consonanza perfetta, la merauiglia già concetta in me, si è quasi ridotta in riso; pure stimo ciò per cosa notabile, e degna di memoria. A. Come dice à punto, saputa la regola par cosa di niun mo-mento, e ridicolosa; conciosia che da vna sola consonanza nasce tanta varietà. M. Mi dò ad intendere, che resti ancora à Vostra Signoria molto da mostrarci di queste varietà tanto ingegnose, e meriteuoli di ranto [sic: tanto] studio particolare; e però potrà seguire à suo piacere, che, & l'inten-derle ci sarà di grandissimo fauore, e di sommo vtile. A. Per hauer sin hor ragionato di quei Canoni, che son fatti à due voci, dirò di quelli, che si fanno à trè voci, parlando prima delli sciolti. Siche sarà il mio principio (come per l'adietro) all'Vnisono, di cui porgo questo es-sempio. page 118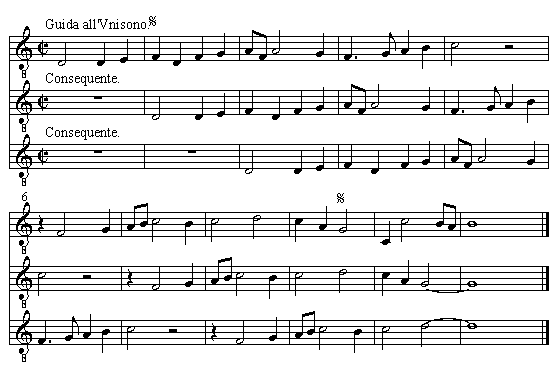 Questo è fatto per Vnisono; quest'altro, che formo è per Terza.
Questo è fatto per Vnisono; quest'altro, che formo è per Terza.
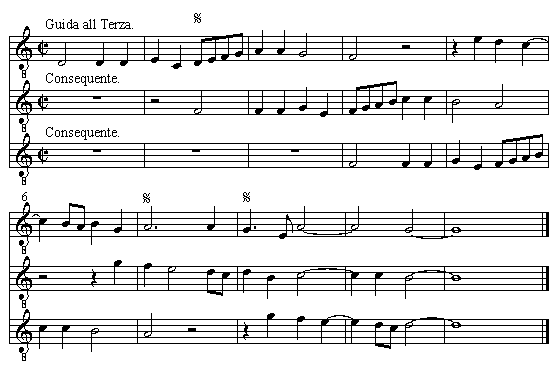 Hora mostrarò vno per Quinta, & vn'altro per Ottaua à tre voci. Nè al-tro dirò sopra simili Canoni, essendo in potestà del Compositore il for-margli da se stesso. page 119
Hora mostrarò vno per Quinta, & vn'altro per Ottaua à tre voci. Nè al-tro dirò sopra simili Canoni, essendo in potestà del Compositore il for-margli da se stesso. page 119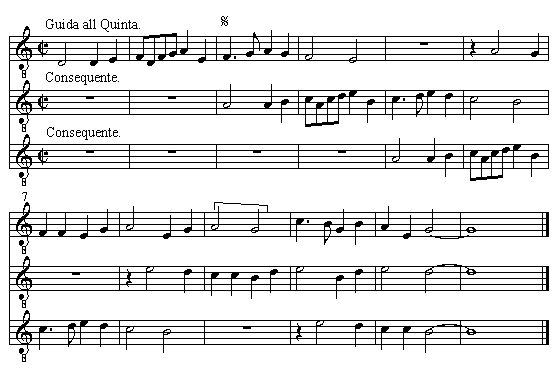
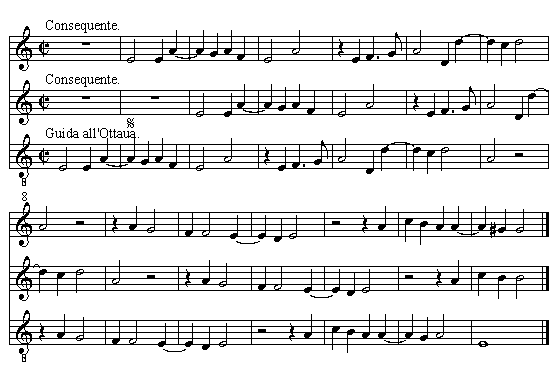 Nè già voglio mancar di mostrar altri Canoni fatti con alcune osseruationi di consonanze, e dissonanze à tre voci, che ponno cantarsi vn Tuono, e duoi più alti, e più bassi dalla sua guida, ponendo altretante pause alla seconda rissolutione, quante si trouaranno nella prima, & ecco l'essem-pio. page 120
Nè già voglio mancar di mostrar altri Canoni fatti con alcune osseruationi di consonanze, e dissonanze à tre voci, che ponno cantarsi vn Tuono, e duoi più alti, e più bassi dalla sua guida, ponendo altretante pause alla seconda rissolutione, quante si trouaranno nella prima, & ecco l'essem-pio. page 120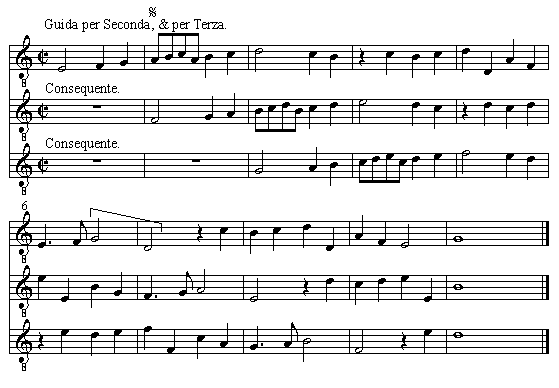 Hora ne scoprirò vn'altro simile, oue si potrà modular la prima rissolu-tione con la seconda, e tutte l'altre poi insieme co 'l principale, & egli fia contrario al primo in questo, che verrà modulato vn Tuono più basso del suo principale, come nell'essempio potranno vedere.
Hora ne scoprirò vn'altro simile, oue si potrà modular la prima rissolu-tione con la seconda, e tutte l'altre poi insieme co 'l principale, & egli fia contrario al primo in questo, che verrà modulato vn Tuono più basso del suo principale, come nell'essempio potranno vedere.
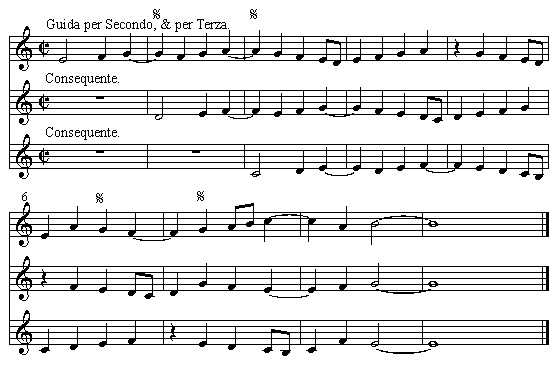 page 121Credo, che hora sia manifesto, come questo Canone si può modulare per Seconda, e per Terza dal suo principale, discendendo sempre vna vo-ce dal suo originale; e come anche fia lecito modular le rissolutioni in-sieme; e 'l pigliar ancora la Guida, e tutte trè le parti. Il che si concede etiando nel primo Canone, oue crescono le parti vn Tuono più alto del-la sua guida, vero è, che nasce per obligatione alla volte alcune relationi non grate alla purgata orecchia. G. Io lo credo, ma veggio questo esser in tutto contrario all'altro. M. Cosi è, poiche il primo ascende, & que-sto discende. Ma in tutto ciò à noi cessarà ogni vtilità, se in V. S. cessarà la solita cortesia non ci dando la regola per farlo, come hà data per l'adietro. A. Dò questa regola. Vi si ricerca ogni studio possibile, perche le parti vengano vnite, cantando con bel modo, e non eccedano il principa-le nelle sue estremità al più di otto voci, & se non passarà più di sei voci sarà meglio; mentre però non venga causato disordine alcuno dalle par-ti. Si deue auuertir di più, che non vi cadino salti inconuenienti, ne quinte imperfette fatte fuori d'pogni ordine; e che la Quarta sia fatta con la regola, e secondo le buone osseruationi del comporre; e che si lasci la set-tima, e la nona. Le consonanze poi si permettono, poiche di loro non si fà riserua alcuna. G. Questa regola nell'esser facile corrisponde all'al-tre. A. Per passar più oltre mostrarò vn'altro Canone, le cui parti modu-laranno lontane dal principale per Terza crescendo l'vna dall'altra, ag-giongendo l'istesse pause all'altra parte, che haurà la prima rissolutione; come quì.
page 121Credo, che hora sia manifesto, come questo Canone si può modulare per Seconda, e per Terza dal suo principale, discendendo sempre vna vo-ce dal suo originale; e come anche fia lecito modular le rissolutioni in-sieme; e 'l pigliar ancora la Guida, e tutte trè le parti. Il che si concede etiando nel primo Canone, oue crescono le parti vn Tuono più alto del-la sua guida, vero è, che nasce per obligatione alla volte alcune relationi non grate alla purgata orecchia. G. Io lo credo, ma veggio questo esser in tutto contrario all'altro. M. Cosi è, poiche il primo ascende, & que-sto discende. Ma in tutto ciò à noi cessarà ogni vtilità, se in V. S. cessarà la solita cortesia non ci dando la regola per farlo, come hà data per l'adietro. A. Dò questa regola. Vi si ricerca ogni studio possibile, perche le parti vengano vnite, cantando con bel modo, e non eccedano il principa-le nelle sue estremità al più di otto voci, & se non passarà più di sei voci sarà meglio; mentre però non venga causato disordine alcuno dalle par-ti. Si deue auuertir di più, che non vi cadino salti inconuenienti, ne quinte imperfette fatte fuori d'pogni ordine; e che la Quarta sia fatta con la regola, e secondo le buone osseruationi del comporre; e che si lasci la set-tima, e la nona. Le consonanze poi si permettono, poiche di loro non si fà riserua alcuna. G. Questa regola nell'esser facile corrisponde all'al-tre. A. Per passar più oltre mostrarò vn'altro Canone, le cui parti modu-laranno lontane dal principale per Terza crescendo l'vna dall'altra, ag-giongendo l'istesse pause all'altra parte, che haurà la prima rissolutione; come quì.
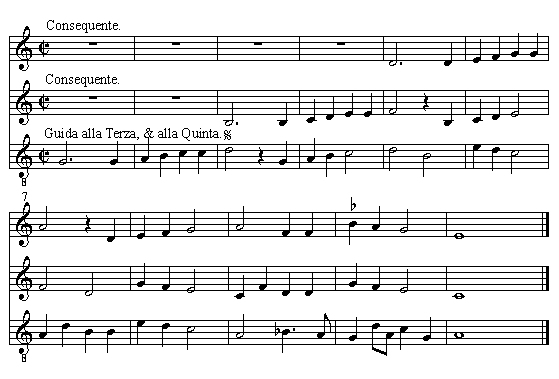 page 122Quì veggono, come esse parti van sempre crescendo per Terza, oue, (piacendoui) potranno modular ancora le due rissolutioni insieme con il principale. Si troua vn'altra sorte di Canone, le cui parti si modularan-no per Terza, sempre declinando dal suo principale, del qual Canone dò questo essempio.
page 122Quì veggono, come esse parti van sempre crescendo per Terza, oue, (piacendoui) potranno modular ancora le due rissolutioni insieme con il principale. Si troua vn'altra sorte di Canone, le cui parti si modularan-no per Terza, sempre declinando dal suo principale, del qual Canone dò questo essempio.
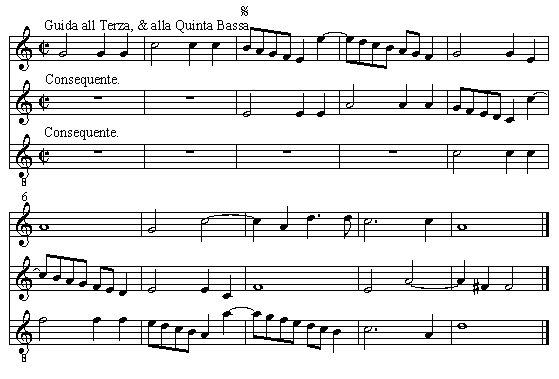 Questo và modulando per il contrario del primo, e di dette parti due si ponno cantare, & ancor tutte tre insieme con esso principale. E 'l tutto fia di buona riuscita. Di più dico, che è lecito il modular vna sola, ouer due altre parti con il principale, & il medesimo fare per Vnisono con vna di quelle rissolutioni. Ilche fia chiaro considerando le predette rissolutioni della parti. Vn sol riguardo fia di mestier, che s'habbia, cioè, ch'alla par-te, che và prima (parlando delle rissolutioni) si aggiongano alcune figure per dar compimento al fine della Cantilena, come conuiene, e perche meglio il possedimo farò questi essempij.
Questo và modulando per il contrario del primo, e di dette parti due si ponno cantare, & ancor tutte tre insieme con esso principale. E 'l tutto fia di buona riuscita. Di più dico, che è lecito il modular vna sola, ouer due altre parti con il principale, & il medesimo fare per Vnisono con vna di quelle rissolutioni. Ilche fia chiaro considerando le predette rissolutioni della parti. Vn sol riguardo fia di mestier, che s'habbia, cioè, ch'alla par-te, che và prima (parlando delle rissolutioni) si aggiongano alcune figure per dar compimento al fine della Cantilena, come conuiene, e perche meglio il possedimo farò questi essempij.
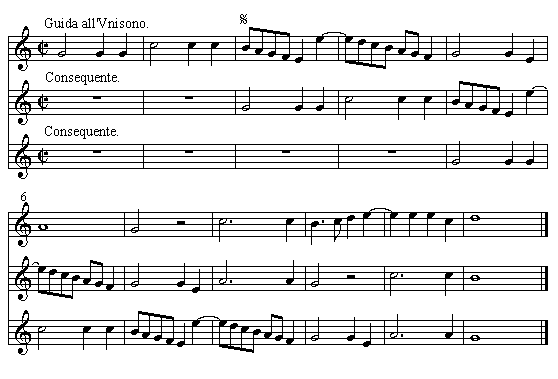 page 123La seconda risolutione sia questa.
page 123La seconda risolutione sia questa.
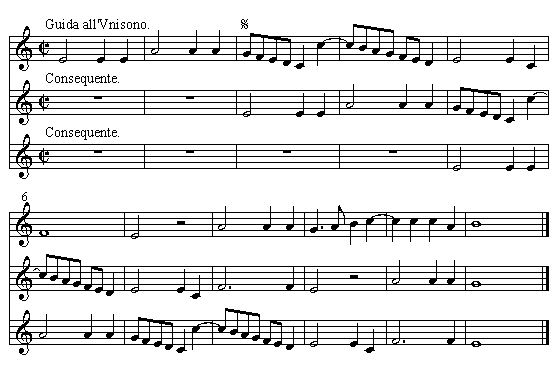 Ecco la terza rissolutione.
Ecco la terza rissolutione.
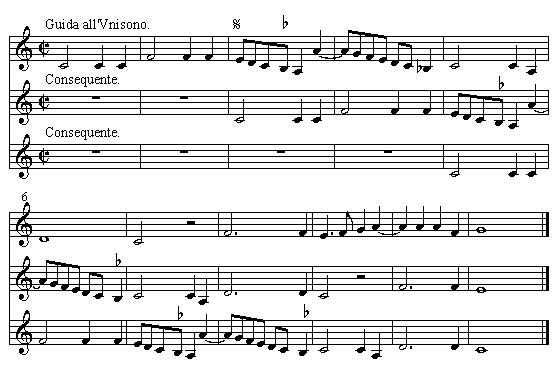 page 124Conoscono di quì chiaramente, che i Canoni fatti per Vnisono sono di buona riuscita, aggionte alcune figure alla parte principale per finirgli; come si richiede. G. Habbiamo di già visto con nostro sommo piacere questa sì bella varietà; e d'altretanto ci sarebbe il saper, se il medesimo si farà nell'altro Canone fatto per Terza, oue le parti ascendono per Ter-za, che si fà in questo, ciò è, il modular il principale, & le rissolutioni in-sieme per Vnisono, & ancor l'istesse rissolutioni da se per il medesimo Vnisono. A. Signor mio nò: perche bisogna seruar la regola, che si os-serua in questo, il qual discende per Terza. G. V. S. dunque non mi si mostri men fauoreuole dell'ordinario per darne il modo da tenersi in farne vn simile, che si possa modular per Terza ascendendo; posciache non si può cantar in questo il principale, nè le rissolutioni parimente per Vnisono; e per darne ancor poi la regola, che osseruar si conuenga in far questi altri, le cui rissolutioni tutte si possono cantar all'Vnisono, come nelli essempij. A. Volendosi far vn Canone, che si canti per Tera, cre-scendo le parti lontane per Terza dal principale, si può vsar ogni conso-nanza cosi perfetta, come imperfetta, & altretanto s'intende delle disso-nanze, auertendo, che nelle sue estremità non ecceda più di sei ouer d'ot-to voci, mentre non vi venga disordine. Questo fia adunque il modo da tenersi nel fare il primo, il quale non sarà buono, mentre che si voglia can-tar le rissolutioni per Vnisono. Ma desiderandosi farne vno, che habbia le parti lontane per Terza dal principale, ò guida, (come dir ci piace) ascendendo, ò discendendo le parti, & che si possino modulare le risso-lutioni per Vnisono fia di bisogno l'astringersi à questa regola. Che in detta parte principale, con l'altra creata per Terza lontana non cadino due Terze seguenti l'vna dopo l'altra; nè meno la Quinta in eleuatione della misura, quando l'altra parte hà già cominciato; già che facendosi poi le rissolutioni per Vnisono vi nascono molti inconuenienti. Conuie-ne ancora il legarsi sotto quest'altra regola. Che non vi sia dissonanza alcuna; & lasciare la Sesta acciò non produca qualche disordine; e nelle sue estremità per il più, che sia, non ecceda l'Ottaua. Il che è, quanto si hà d'adempire nella seconda richiesta. G. Aspettauo per certo altre osser-uationi; poiche vi si vede tanta varietà. A. E cosa veramente facilissi-ma; e però mi trasferirò ad vn'altro, le cui rissolutioni saranno lontane per Quinta l'vna dall'altra, siche vna fia per Quinta, e l'altra Nona co 'l principale; e si potranno anche cantar da se stesse le rissolutioni, come quiui. page 125
page 124Conoscono di quì chiaramente, che i Canoni fatti per Vnisono sono di buona riuscita, aggionte alcune figure alla parte principale per finirgli; come si richiede. G. Habbiamo di già visto con nostro sommo piacere questa sì bella varietà; e d'altretanto ci sarebbe il saper, se il medesimo si farà nell'altro Canone fatto per Terza, oue le parti ascendono per Ter-za, che si fà in questo, ciò è, il modular il principale, & le rissolutioni in-sieme per Vnisono, & ancor l'istesse rissolutioni da se per il medesimo Vnisono. A. Signor mio nò: perche bisogna seruar la regola, che si os-serua in questo, il qual discende per Terza. G. V. S. dunque non mi si mostri men fauoreuole dell'ordinario per darne il modo da tenersi in farne vn simile, che si possa modular per Terza ascendendo; posciache non si può cantar in questo il principale, nè le rissolutioni parimente per Vnisono; e per darne ancor poi la regola, che osseruar si conuenga in far questi altri, le cui rissolutioni tutte si possono cantar all'Vnisono, come nelli essempij. A. Volendosi far vn Canone, che si canti per Tera, cre-scendo le parti lontane per Terza dal principale, si può vsar ogni conso-nanza cosi perfetta, come imperfetta, & altretanto s'intende delle disso-nanze, auertendo, che nelle sue estremità non ecceda più di sei ouer d'ot-to voci, mentre non vi venga disordine. Questo fia adunque il modo da tenersi nel fare il primo, il quale non sarà buono, mentre che si voglia can-tar le rissolutioni per Vnisono. Ma desiderandosi farne vno, che habbia le parti lontane per Terza dal principale, ò guida, (come dir ci piace) ascendendo, ò discendendo le parti, & che si possino modulare le risso-lutioni per Vnisono fia di bisogno l'astringersi à questa regola. Che in detta parte principale, con l'altra creata per Terza lontana non cadino due Terze seguenti l'vna dopo l'altra; nè meno la Quinta in eleuatione della misura, quando l'altra parte hà già cominciato; già che facendosi poi le rissolutioni per Vnisono vi nascono molti inconuenienti. Conuie-ne ancora il legarsi sotto quest'altra regola. Che non vi sia dissonanza alcuna; & lasciare la Sesta acciò non produca qualche disordine; e nelle sue estremità per il più, che sia, non ecceda l'Ottaua. Il che è, quanto si hà d'adempire nella seconda richiesta. G. Aspettauo per certo altre osser-uationi; poiche vi si vede tanta varietà. A. E cosa veramente facilissi-ma; e però mi trasferirò ad vn'altro, le cui rissolutioni saranno lontane per Quinta l'vna dall'altra, siche vna fia per Quinta, e l'altra Nona co 'l principale; e si potranno anche cantar da se stesse le rissolutioni, come quiui. page 125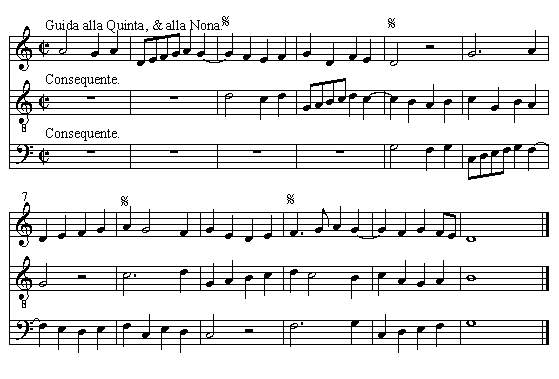 Dal precedente essempio hanno conosciuto tutto ciò. G. Nè già per questo mi posso appagare, per non saper la norma da seguirsi in farne vn simile. A. Questa nell'esser facile eccede tutte l'altre; poiche iui si con-cede ogni consonanza, e dissonanza, e solo si vieta la settima, & nella sua estremità non vada, se non sei voci, ò poco più, & questo sarà nella guida, E perche sin hora hanno visti i Canoni fatti à tre voci, me ne passarò alli altri pure à tre voci, accompagnati però con vna parte sciolta in questo modo.
Dal precedente essempio hanno conosciuto tutto ciò. G. Nè già per questo mi posso appagare, per non saper la norma da seguirsi in farne vn simile. A. Questa nell'esser facile eccede tutte l'altre; poiche iui si con-cede ogni consonanza, e dissonanza, e solo si vieta la settima, & nella sua estremità non vada, se non sei voci, ò poco più, & questo sarà nella guida, E perche sin hora hanno visti i Canoni fatti à tre voci, me ne passarò alli altri pure à tre voci, accompagnati però con vna parte sciolta in questo modo.
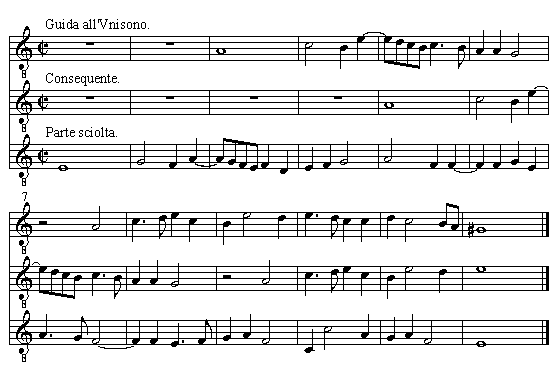 page 126In questo non è osseruationi alcuna, nè delle consonanze perfette, & im-perfette, ne pur anche delle dissonanze. Solo basta l'accommodar quel-le parti, che faccino grato vdire, e producano buona harmonia, come s'accertaranno con gli essempij, che son per darle. Et, perche inten-dano il tutto, ne mostrarò alcuni altri fatti hora alla Terza, hora alla Quarta, & in diuersi modi. Dalche ne traranno il modo, che nel farne delli simili si deue osseruare.
page 126In questo non è osseruationi alcuna, nè delle consonanze perfette, & im-perfette, ne pur anche delle dissonanze. Solo basta l'accommodar quel-le parti, che faccino grato vdire, e producano buona harmonia, come s'accertaranno con gli essempij, che son per darle. Et, perche inten-dano il tutto, ne mostrarò alcuni altri fatti hora alla Terza, hora alla Quarta, & in diuersi modi. Dalche ne traranno il modo, che nel farne delli simili si deue osseruare.
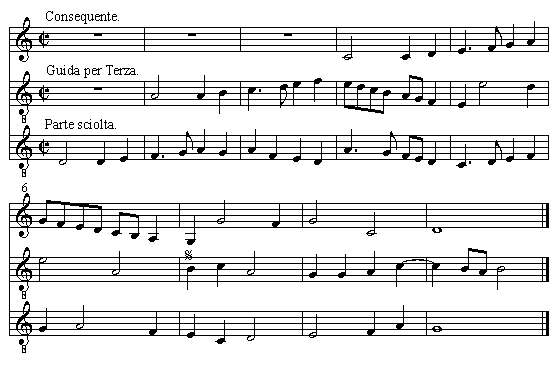 Questo altro è fatto per Quarta.
Questo altro è fatto per Quarta.
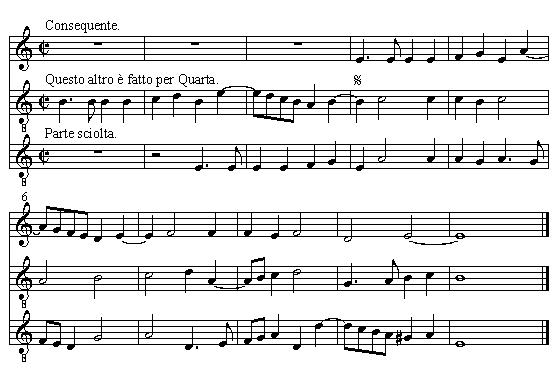 page 127E questo seguente per Quinta.
page 127E questo seguente per Quinta.
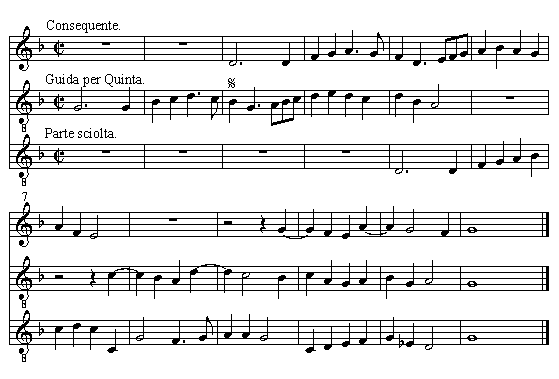 E, perche sono già finiti questi pochi Canoni à tre voci, i quali hò scoper-ti solo, perche l'istesso ordine l'introducano ad altri, come alla Seconda, e più inanzi, se le piace; hora mostrarò, come si formi vn Canone con due parti sciolte, e poscia con trè, per dar à conoscere il modo, e la norma, con cui si deue in simili procedere; perche (hauuta la notitia di questi) po-[unclear: t]ranno aggiongerli trè, e quattro parti sciolte, e più à loro piacere. Et à questo effetto farò questi duoi Canoni, nell'vno de quali due parti, e nel-l'altro trè saranno sciolte.
E, perche sono già finiti questi pochi Canoni à tre voci, i quali hò scoper-ti solo, perche l'istesso ordine l'introducano ad altri, come alla Seconda, e più inanzi, se le piace; hora mostrarò, come si formi vn Canone con due parti sciolte, e poscia con trè, per dar à conoscere il modo, e la norma, con cui si deue in simili procedere; perche (hauuta la notitia di questi) po-[unclear: t]ranno aggiongerli trè, e quattro parti sciolte, e più à loro piacere. Et à questo effetto farò questi duoi Canoni, nell'vno de quali due parti, e nel-l'altro trè saranno sciolte.
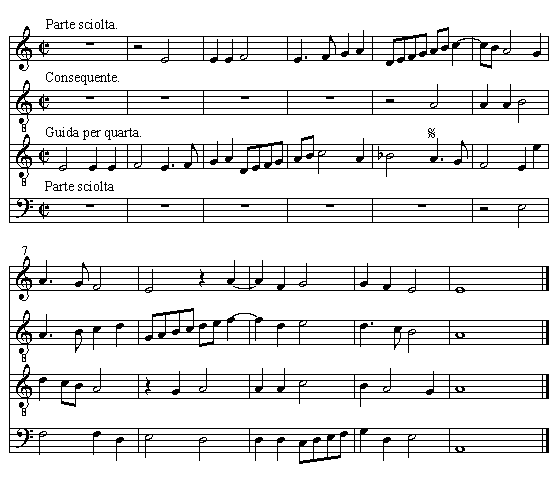 page 128In questo essempio hanno viste due parti obligate, fatte per Canoni, & altretante sciolte: & in questo altro trè fiano le sciolte, & due l'obligate.
page 128In questo essempio hanno viste due parti obligate, fatte per Canoni, & altretante sciolte: & in questo altro trè fiano le sciolte, & due l'obligate.
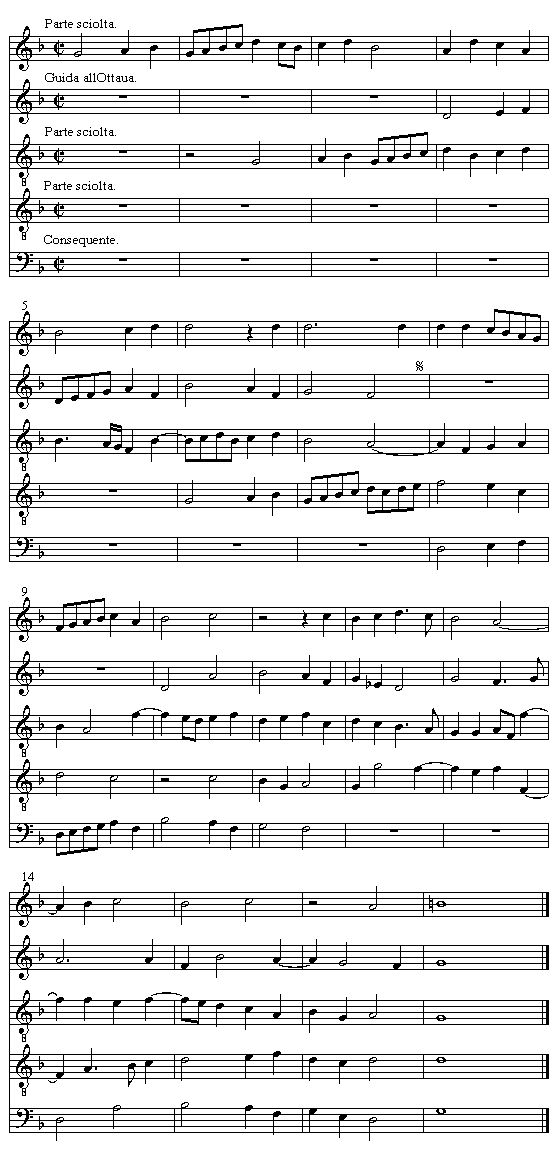 page 129Dalli duoi predetti essempij si è dato à conoscer il modo, e la via che dè tenersi nel formar vn Canone con vna, con due, e con trè parti sciolte, e con più se cosi piacerà. Il che solo consiste nella facoltà del giudicio, & nell'intelletto del Compositore, già che non si fa eccettione nè di conso-nanze, ne di dissonanze; e solo si deue hauer riguardo, che le parti mo-dulino con leggiadri, e legitimi interualli; e non vi cadino mouimenti, che cantar non si possino; nè vi sia alcuno altro disordine, conforme à quanto si richiede alle ottime, e d'ogni errore purgate compositioni. Conciosia che sin hora si è vista la varietà sì de' Contraponti, come de' Canoni à due voci, e sciolte, & obligate; & à tre fatti in diuerse maniere; e co-me ancora si può à due parti, che cantano in conseguenza, accompagnar due, e tre altre, e più parti ad arbitrio del Compositore, mi resta hora il mostrar i Canoni fatti à quattro voci, i quali son fatti da due parti ad vn page 130modo, e da due altre in vn'altro; e le scoprirò di più, che sopra vna parte sola se ne possino modular trè altre in conseguenza in diuerse maniere. G. Si prometta pur V. S. che di tanta sua cortesia gli restaremo obligati perpetuamente. M. E ben ragione, che, se V. S. hora da se stessa, & ho-ra à nostra richiesta, non hà hauuto riguardo à fatica, & incommodo (per grande, che sia stato) in compiacerne mostrandoci tante varietà di questa si nobil scienza, e porgendone (per renderci meglio possessori) infinità d'essempij, i quali tutti ci sono stimoli, e sproni pungenti à maggior fati-ca, & studio, di quanto sin hora habbiamo fatto; è ben ragione dico, che le restiamo perpetuamente obligati. A. Si possono ben accertar, che, doue s'impiegheranno i loro affetti (pur che tant'oltre si estendino le mie forze) fatica non sarà, che non mi paia piaceuole, & impresa che non mi si mostri facile. Che tutto ciò mi causa il gran desiderio, che hò di lor seruire, e perche ne restino più sicure, seguirò in mostrar vn Canone fat-to à quattro voci con due parti in conseguenza per Vnisono, di cui scri-uo questo essempio.
page 129Dalli duoi predetti essempij si è dato à conoscer il modo, e la via che dè tenersi nel formar vn Canone con vna, con due, e con trè parti sciolte, e con più se cosi piacerà. Il che solo consiste nella facoltà del giudicio, & nell'intelletto del Compositore, già che non si fa eccettione nè di conso-nanze, ne di dissonanze; e solo si deue hauer riguardo, che le parti mo-dulino con leggiadri, e legitimi interualli; e non vi cadino mouimenti, che cantar non si possino; nè vi sia alcuno altro disordine, conforme à quanto si richiede alle ottime, e d'ogni errore purgate compositioni. Conciosia che sin hora si è vista la varietà sì de' Contraponti, come de' Canoni à due voci, e sciolte, & obligate; & à tre fatti in diuerse maniere; e co-me ancora si può à due parti, che cantano in conseguenza, accompagnar due, e tre altre, e più parti ad arbitrio del Compositore, mi resta hora il mostrar i Canoni fatti à quattro voci, i quali son fatti da due parti ad vn page 130modo, e da due altre in vn'altro; e le scoprirò di più, che sopra vna parte sola se ne possino modular trè altre in conseguenza in diuerse maniere. G. Si prometta pur V. S. che di tanta sua cortesia gli restaremo obligati perpetuamente. M. E ben ragione, che, se V. S. hora da se stessa, & ho-ra à nostra richiesta, non hà hauuto riguardo à fatica, & incommodo (per grande, che sia stato) in compiacerne mostrandoci tante varietà di questa si nobil scienza, e porgendone (per renderci meglio possessori) infinità d'essempij, i quali tutti ci sono stimoli, e sproni pungenti à maggior fati-ca, & studio, di quanto sin hora habbiamo fatto; è ben ragione dico, che le restiamo perpetuamente obligati. A. Si possono ben accertar, che, doue s'impiegheranno i loro affetti (pur che tant'oltre si estendino le mie forze) fatica non sarà, che non mi paia piaceuole, & impresa che non mi si mostri facile. Che tutto ciò mi causa il gran desiderio, che hò di lor seruire, e perche ne restino più sicure, seguirò in mostrar vn Canone fat-to à quattro voci con due parti in conseguenza per Vnisono, di cui scri-uo questo essempio.
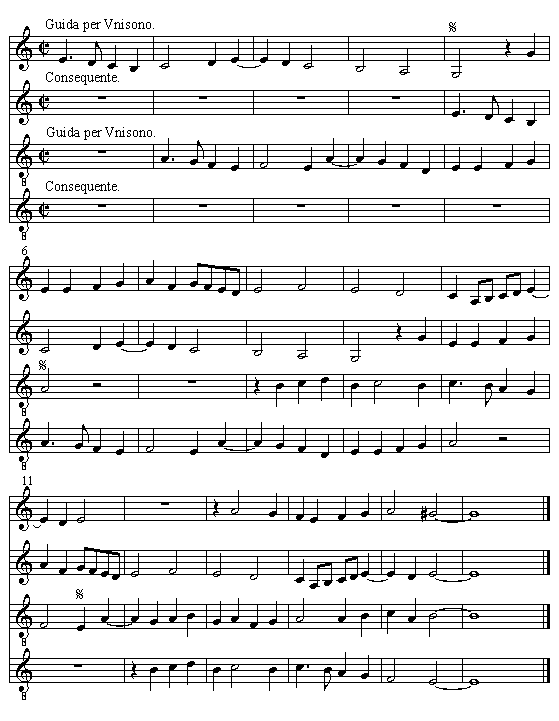 page 131D'vn'altro pur anche fatto per Terza, oue si fanno due parti in Canone, come nel sottoscritto darò questo essempio.
page 131D'vn'altro pur anche fatto per Terza, oue si fanno due parti in Canone, come nel sottoscritto darò questo essempio.
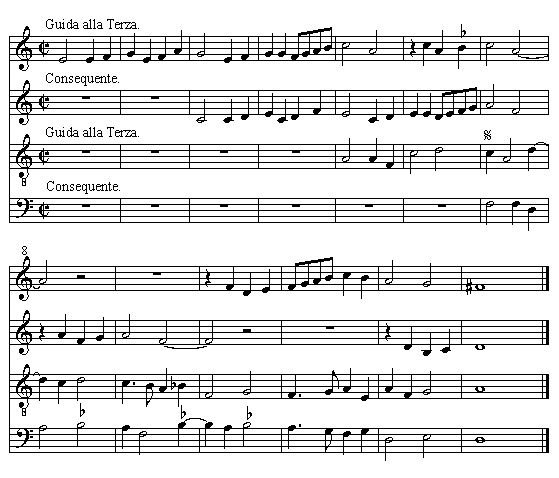 page 132Il Terzo Canone fatto per Quarta si può veder quiui.
page 132Il Terzo Canone fatto per Quarta si può veder quiui.
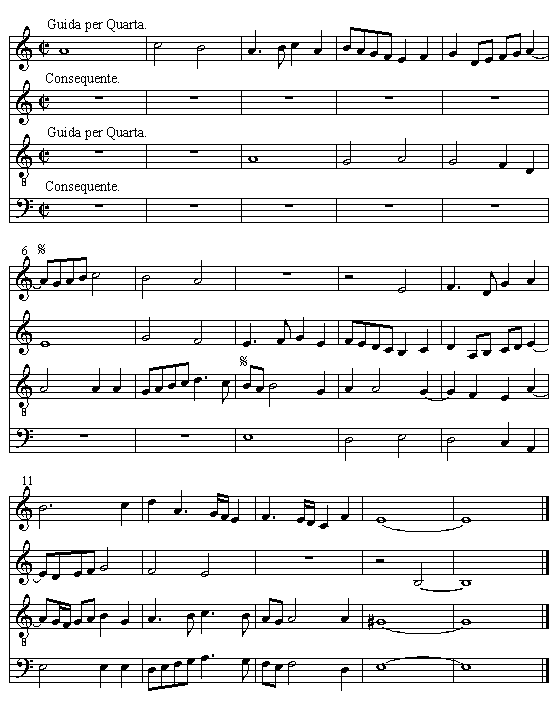 Ma ne passo al Quarto Canone fatto in questa forma con due parti in conseguenza lontana vna dall'altra per Quinta, il qual è di questa sorte.
Ma ne passo al Quarto Canone fatto in questa forma con due parti in conseguenza lontana vna dall'altra per Quinta, il qual è di questa sorte.
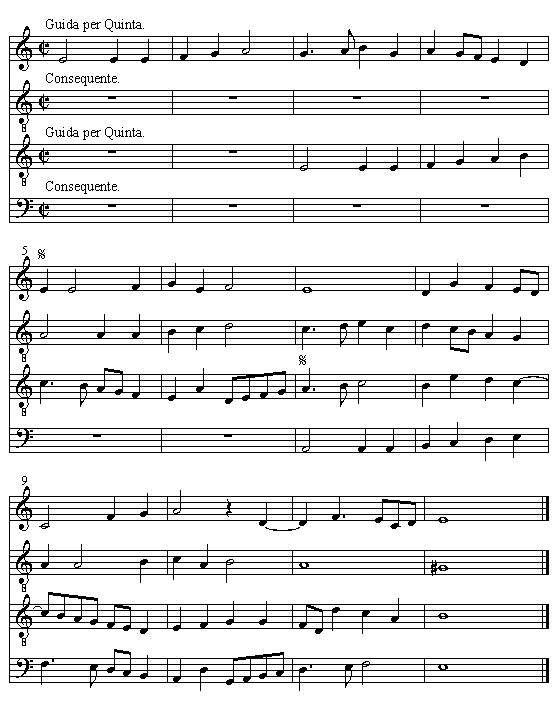 page 133
Il quinto Canone fatto con le parti per conseguenza in Ottaua sarà con quel modo istesso delli sopradetti, ciò è, due parti in conseguenza, & fia questo l'essempio.
page 133
Il quinto Canone fatto con le parti per conseguenza in Ottaua sarà con quel modo istesso delli sopradetti, ciò è, due parti in conseguenza, & fia questo l'essempio.
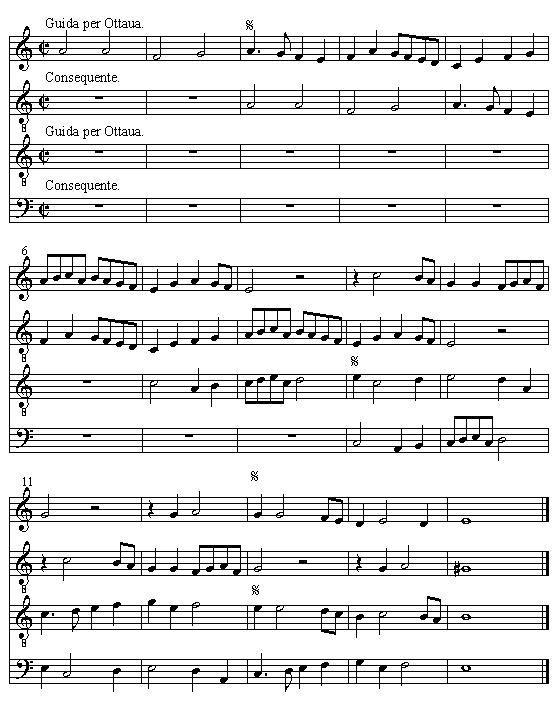 page 134Ne mostrarò pur anche vn'altro, delle cui parti due si trouaranno per Quarta, & altre due per Quinta tutte in conseguenza; perche conoscano vn'altra varietà dalli altri, & ecco l'essempio.
page 134Ne mostrarò pur anche vn'altro, delle cui parti due si trouaranno per Quarta, & altre due per Quinta tutte in conseguenza; perche conoscano vn'altra varietà dalli altri, & ecco l'essempio.
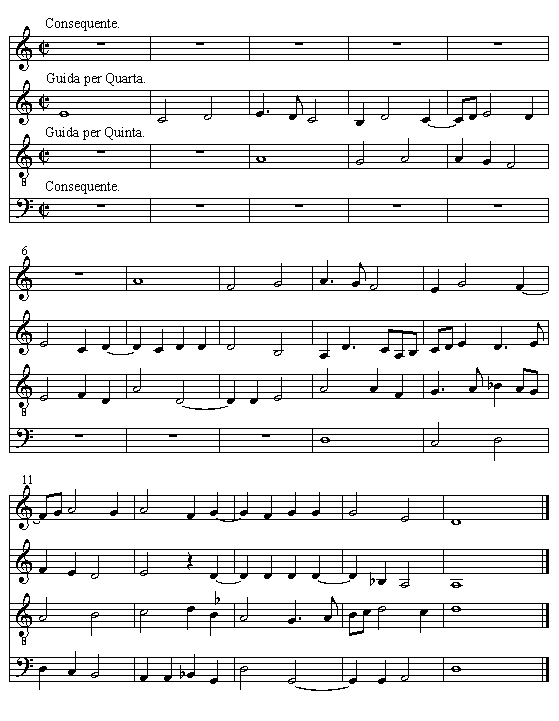 page 135Quì veggono due parti, che sono fugate per Quarta, e due per Quinta. Questo Canone hò voluto proponere acciò sappino come è lecito il far questi Canoni à quattro voci per diuersi modi. Laonde se ne può fare anche uno, oue due per Ottaua, e due altre andranno per Quinta, come è questo.
page 135Quì veggono due parti, che sono fugate per Quarta, e due per Quinta. Questo Canone hò voluto proponere acciò sappino come è lecito il far questi Canoni à quattro voci per diuersi modi. Laonde se ne può fare anche uno, oue due per Ottaua, e due altre andranno per Quinta, come è questo.
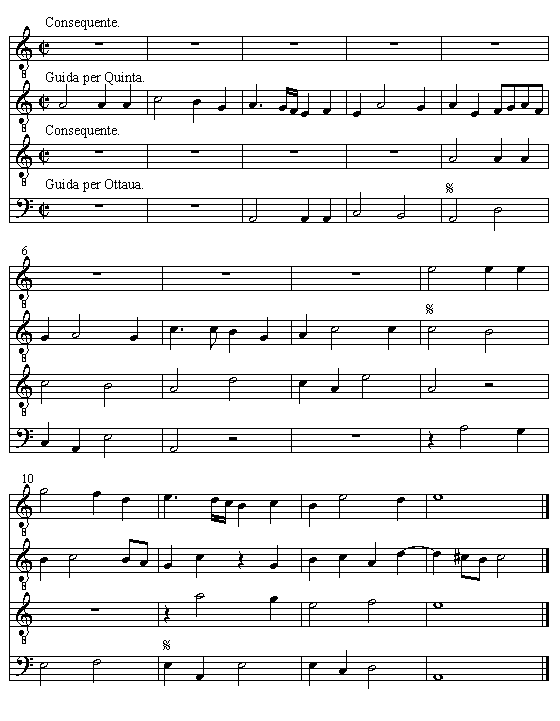 Se desiderano poscia altre varietà, se le possono fare da se stesse. Mi rimarrebbe il dir come si possano fare altri Canoni per Seconda, ouer per Settima, per dar qualche notitia di quei, che sono fatti per dissonanza; ma, per non deuiar punto dall'ordine, che hò seruato per l'adietro, prima, che passi più oltre, mostrarò la regola, conforme à cui ne faranno delli simili à quelli, di che si sono dati gli essempij. M. Questo sarà pur vn confer-mar, che la sua cortesia è infinita; e questo pur ci apportarà sommo vti-le, e diletto. A. per farne dunque vn simile, deuono far prima, ch'vna parte sola comincij (qual più piace) e moduli per lo spatio d'vno, ò due tempi di Breue, e di più anco conforme al volere di chi compone; mà il page 136meglio fia per duoi tempi soli; & che principij poi vn'altra parte, & ambe-due modulino insieme, sinche le piace: indi segua la Terza, e poi la Quarta parte, la quale poserà tanto doppo, che hauerà cominciato la Terza, quanto la Seconda dopò 'l principio della Prima. Come per essempio, se la Seconda haurà fatto pausa di duoi tempi, dopò che haurà principiato la prima per duoi tempi ancora posarà la Quarta dopò il cominciar del-la Terza, come si può veder dalli essempij che hò dati di sopra, oue dissi del primo fatto all'Vnisono; nel quale principia il Contralto, e poscia il Tenore per spatio d'vn tempo di Breue, e vanno modulando insieme per alquanti tempi pur ancor di Breue; & indi hà principio l'altro Contral-to, à cui segue l'altro Tenore, che hà posato vn tempo di Breue etiandio dal principio del secondo Contralto, che tanto haueua fatto il primo Tenore, come mostrarono gli essempij. Con tal regola dunque potranno far simili Canoni. Nè vi sono altre osseruationi, sendo in potere del Com-positore l'vsar ogni consonanza, e dissonanza, auuertendoui (se possibil fia) che non gli cadino salti, che cantar non si possino, che tuttauia per l'obligo si scusarebbero pur anche. G. Poiche habbiamo inteso, che cosa si ricerca per far simili Canoni, V. S. potrà (piacendole) passar più ol-tre alli Canoni fatti per Dissonanza, come ci hauea proposto. A. Cosi fa-ro; e ne formarò vno alla Seconda, che è questo.
Se desiderano poscia altre varietà, se le possono fare da se stesse. Mi rimarrebbe il dir come si possano fare altri Canoni per Seconda, ouer per Settima, per dar qualche notitia di quei, che sono fatti per dissonanza; ma, per non deuiar punto dall'ordine, che hò seruato per l'adietro, prima, che passi più oltre, mostrarò la regola, conforme à cui ne faranno delli simili à quelli, di che si sono dati gli essempij. M. Questo sarà pur vn confer-mar, che la sua cortesia è infinita; e questo pur ci apportarà sommo vti-le, e diletto. A. per farne dunque vn simile, deuono far prima, ch'vna parte sola comincij (qual più piace) e moduli per lo spatio d'vno, ò due tempi di Breue, e di più anco conforme al volere di chi compone; mà il page 136meglio fia per duoi tempi soli; & che principij poi vn'altra parte, & ambe-due modulino insieme, sinche le piace: indi segua la Terza, e poi la Quarta parte, la quale poserà tanto doppo, che hauerà cominciato la Terza, quanto la Seconda dopò 'l principio della Prima. Come per essempio, se la Seconda haurà fatto pausa di duoi tempi, dopò che haurà principiato la prima per duoi tempi ancora posarà la Quarta dopò il cominciar del-la Terza, come si può veder dalli essempij che hò dati di sopra, oue dissi del primo fatto all'Vnisono; nel quale principia il Contralto, e poscia il Tenore per spatio d'vn tempo di Breue, e vanno modulando insieme per alquanti tempi pur ancor di Breue; & indi hà principio l'altro Contral-to, à cui segue l'altro Tenore, che hà posato vn tempo di Breue etiandio dal principio del secondo Contralto, che tanto haueua fatto il primo Tenore, come mostrarono gli essempij. Con tal regola dunque potranno far simili Canoni. Nè vi sono altre osseruationi, sendo in potere del Com-positore l'vsar ogni consonanza, e dissonanza, auuertendoui (se possibil fia) che non gli cadino salti, che cantar non si possino, che tuttauia per l'obligo si scusarebbero pur anche. G. Poiche habbiamo inteso, che cosa si ricerca per far simili Canoni, V. S. potrà (piacendole) passar più ol-tre alli Canoni fatti per Dissonanza, come ci hauea proposto. A. Cosi fa-ro; e ne formarò vno alla Seconda, che è questo.
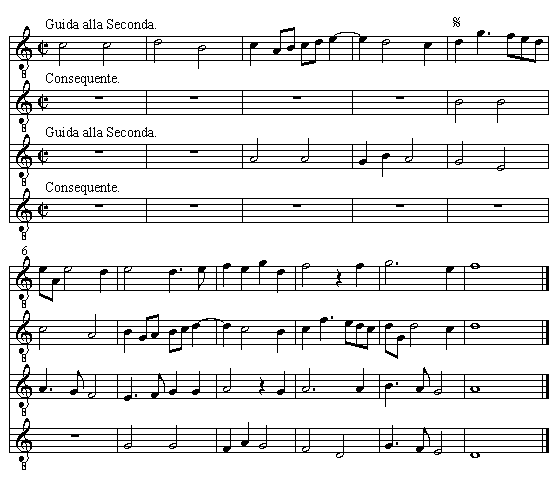 page 137Ne mostro pur anche vn'altro per Settima, il che fia con questo essempio.
page 137Ne mostro pur anche vn'altro per Settima, il che fia con questo essempio.
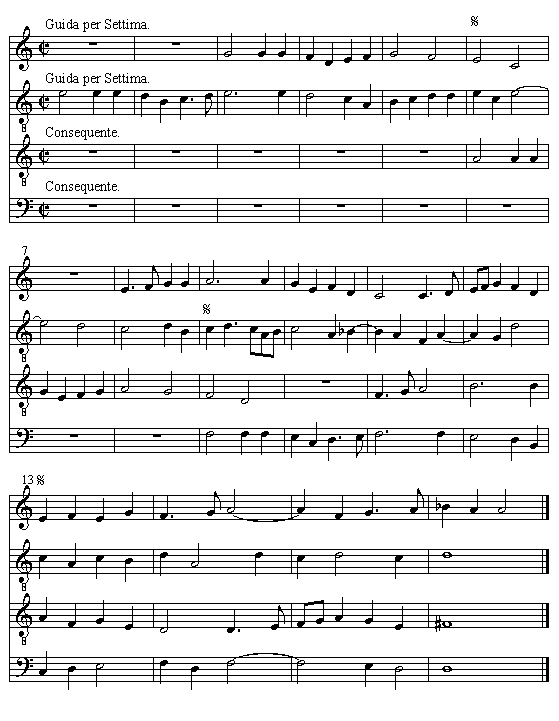 L'essempio mostra, che 'l Canone è fatto per Settima lontano dal suo ori-ginale, come promisi. Hora mi accingo ad insegnarne alcuni altri fatti à quattro voci, in vno de' quali due parti modularanno per fuga per con-trario moto, e due altre similmente per moto contrario, ma dissimili pe-rò di figure, di mouimenti, & d'interualli, dalle due prime parti. Dipoi farò conoscere vn'altro Canone, in cui sopra vna parte sola modularanno page 138due parti per Ottaua, & altre due per Terza, ouer per Quinta per con-trario moto. In oltre ne mostrarò vn'altro sopra vna parte sola, oue le altre tre modularanno per fuga, hora lontane per Quarta, & hora per Quinta, come l'occasione, e 'l voler del Compositore chiederanno. G. Sia-mi benigna V. S. non men, che per l'adietro sia stata in darmi prima la norma, secondo la quale mi fia lecito farne vno. Darò l'istessa norma pure, quanto al far principiar le parti, che hà luogo anche in questi mo-strati per hora, come nelli predetti vltimi Canoni si vede. Delle conso-nanze, e dissonanze poi si seruiranno à lor piacere in quel, ch'è fatto per Seconda; ma nell'altro, ch'è per Settima lasciaranno tutte le dissonanze nell'obligatione del Canone. Del resto poi corrisponde, e si conferma alli altri. Onde me ne andrò ad vna modulatione à quattro voci, due de' quali modularanno per fuga alla Terza, & altre due parimente alla Ter-za tutte per contrario moto, di cui dò questo essempio.
L'essempio mostra, che 'l Canone è fatto per Settima lontano dal suo ori-ginale, come promisi. Hora mi accingo ad insegnarne alcuni altri fatti à quattro voci, in vno de' quali due parti modularanno per fuga per con-trario moto, e due altre similmente per moto contrario, ma dissimili pe-rò di figure, di mouimenti, & d'interualli, dalle due prime parti. Dipoi farò conoscere vn'altro Canone, in cui sopra vna parte sola modularanno page 138due parti per Ottaua, & altre due per Terza, ouer per Quinta per con-trario moto. In oltre ne mostrarò vn'altro sopra vna parte sola, oue le altre tre modularanno per fuga, hora lontane per Quarta, & hora per Quinta, come l'occasione, e 'l voler del Compositore chiederanno. G. Sia-mi benigna V. S. non men, che per l'adietro sia stata in darmi prima la norma, secondo la quale mi fia lecito farne vno. Darò l'istessa norma pure, quanto al far principiar le parti, che hà luogo anche in questi mo-strati per hora, come nelli predetti vltimi Canoni si vede. Delle conso-nanze, e dissonanze poi si seruiranno à lor piacere in quel, ch'è fatto per Seconda; ma nell'altro, ch'è per Settima lasciaranno tutte le dissonanze nell'obligatione del Canone. Del resto poi corrisponde, e si conferma alli altri. Onde me ne andrò ad vna modulatione à quattro voci, due de' quali modularanno per fuga alla Terza, & altre due parimente alla Ter-za tutte per contrario moto, di cui dò questo essempio.
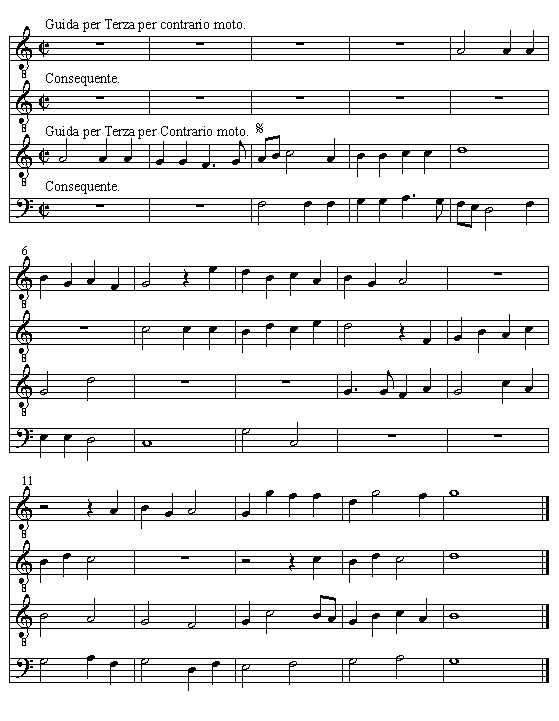 page 139Da questo altro essempio ne haueranno vn'altro, in cui le parti saran lon-tane dal suo originale per Quarta seguendosi per contrario moto.
page 139Da questo altro essempio ne haueranno vn'altro, in cui le parti saran lon-tane dal suo originale per Quarta seguendosi per contrario moto.
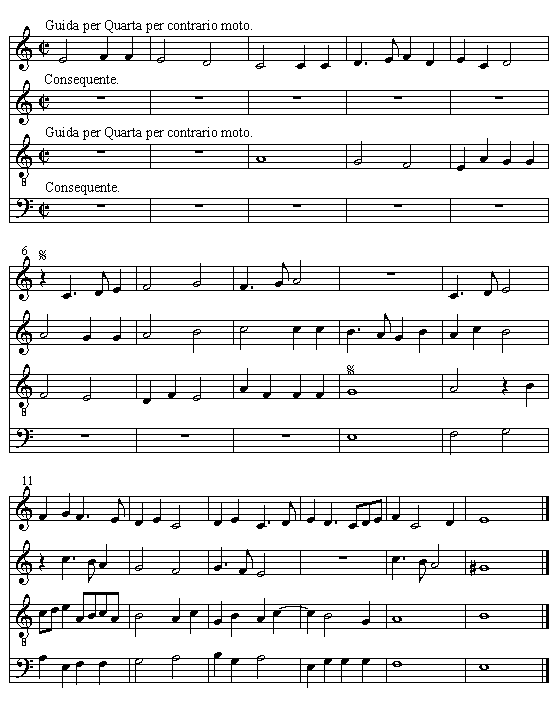 Quest'altro fia per Quarta.
Quest'altro fia per Quarta. 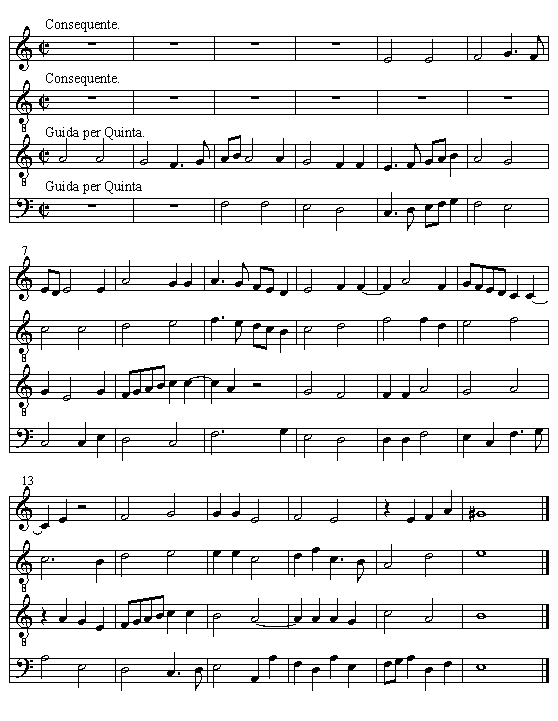 page 140Deuono però sapere, che in simili Canoni non si può veramente far mo-dular le parti con leggiadri mouimenti, come si farebbe, sendo sciolta la Cantilena da questi oblighi fatti per contrarij mouimenti. G. Il credo. Et, ancorche non vi si troui quella vaghezza, e leggiadria, desidero però, che V. S. non si scosti dall'ordinario suo; e ci dia ad intendere il mo-do di fargli. A. Si osserua, che fra i Canoni non venga dissonanza alcu-na; & anche (se fia possibile, accioche non vi nasca disordine) che non si troui Quarta tra il Soprano, & Contralto; e di più ancora, che la parte del principale, ciò è, quella, che và prima, non ecceda al più di otto voci nelle sue estremità; e questo solo, mentre che essa parte modularà per obligo, che cessato poi questo potrà allargarsi à suo piacere, purche si guardi, che le parti vadano per legitimi interualli, e con mouimenti seguenti, quanto si possi; perche riesca la Cantilena più facile al Cantore, e più soaue, e dolce. E questo è quanto vi si ricerca. Ne darò dunque vn'al-tro fatto per mouimenti contrarij, oue vna parte modularà per Nona, & vn'altra per Terza; come in questo essempio. page 141
page 140Deuono però sapere, che in simili Canoni non si può veramente far mo-dular le parti con leggiadri mouimenti, come si farebbe, sendo sciolta la Cantilena da questi oblighi fatti per contrarij mouimenti. G. Il credo. Et, ancorche non vi si troui quella vaghezza, e leggiadria, desidero però, che V. S. non si scosti dall'ordinario suo; e ci dia ad intendere il mo-do di fargli. A. Si osserua, che fra i Canoni non venga dissonanza alcu-na; & anche (se fia possibile, accioche non vi nasca disordine) che non si troui Quarta tra il Soprano, & Contralto; e di più ancora, che la parte del principale, ciò è, quella, che và prima, non ecceda al più di otto voci nelle sue estremità; e questo solo, mentre che essa parte modularà per obligo, che cessato poi questo potrà allargarsi à suo piacere, purche si guardi, che le parti vadano per legitimi interualli, e con mouimenti seguenti, quanto si possi; perche riesca la Cantilena più facile al Cantore, e più soaue, e dolce. E questo è quanto vi si ricerca. Ne darò dunque vn'al-tro fatto per mouimenti contrarij, oue vna parte modularà per Nona, & vn'altra per Terza; come in questo essempio. page 141 La Natura di questo Canone è tale, che si può far cominciare il Tenore, e poscia il Basso, & indi porre le pause del Tenore al Contralto, e quelle del Basso al Soprano. E lecito etiandio far cominciar il Soprano, e dar le pause di quello al Tenore, e quelle del Tenore al Basso, e quelle del Basso finalmente al Contralto. e 'l tutto è di buona riuscita. Vero è, che si mo-stra impossibile l'osseruare il Tuono per le contrarietà de mouimenti, page 142 che fanno le parti. E per farne vn simile, l'istesse regole già mostrate han luogo. G. Mi piace estremamente questa varietà; ma ci fauorisca V. S. di dir, se il simile si potrà far nelli altri predetti. A. Signor mio nò, per gli interualli, che fanno le parti, come l'isperienza, che faranno, loro accertarà. Saria ben concesso nel Canone fatto per Quinta il dar princi-pio con la parte Bassa, e supporre poscia il Soprano, & indi far seguire il Contralto; mà il Tenore non si può far cantar per alcun modo. Siche non si può far delli altri, come di questo. Mi resta pur ancora il dar al-cuni altri Canoni fatti sopra vna parte, in cui vna parte fugarà per Otta-ua, e due poi per Decima per moti contrarij, e di questo loro offro l'es-sempio.
La Natura di questo Canone è tale, che si può far cominciare il Tenore, e poscia il Basso, & indi porre le pause del Tenore al Contralto, e quelle del Basso al Soprano. E lecito etiandio far cominciar il Soprano, e dar le pause di quello al Tenore, e quelle del Tenore al Basso, e quelle del Basso finalmente al Contralto. e 'l tutto è di buona riuscita. Vero è, che si mo-stra impossibile l'osseruare il Tuono per le contrarietà de mouimenti, page 142 che fanno le parti. E per farne vn simile, l'istesse regole già mostrate han luogo. G. Mi piace estremamente questa varietà; ma ci fauorisca V. S. di dir, se il simile si potrà far nelli altri predetti. A. Signor mio nò, per gli interualli, che fanno le parti, come l'isperienza, che faranno, loro accertarà. Saria ben concesso nel Canone fatto per Quinta il dar princi-pio con la parte Bassa, e supporre poscia il Soprano, & indi far seguire il Contralto; mà il Tenore non si può far cantar per alcun modo. Siche non si può far delli altri, come di questo. Mi resta pur ancora il dar al-cuni altri Canoni fatti sopra vna parte, in cui vna parte fugarà per Otta-ua, e due poi per Decima per moti contrarij, e di questo loro offro l'es-sempio.
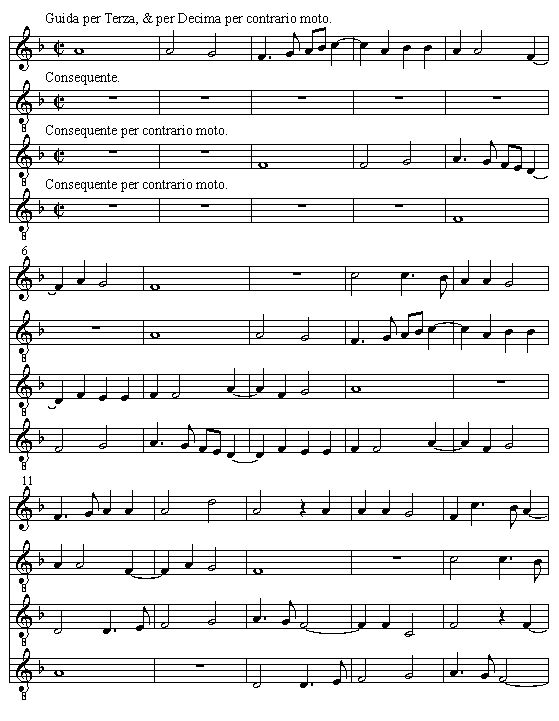 page 143Quiui vna parte fuga sopra il principale per Ottaua, e due altre per Decima lontane per moti contrarij. Se vi piacciono poi altre varietà, si darà principio al Contralto, e poi ad vn Tenore, fraposti dall'vno all'altro dui tempi di Breue, e seguirà vn'altro Tenore seruato l'istesso silentio, & indi succederà il Soprano dopò sei tempi pur di Breue dal principio del Con-tralto, che fia guida. E non contenti di questo cominciaranno con vn Tenore, e dopò duoi tempi ancor di Breue seguiranno co 'l Contralto, & hauendone interposti quattro, soggiongeranno il Soprano, à cui succede-rà l'altro Tenore premesso il riposo di sei tempi simili. E, perche meglio il tutto si affaciliti, porgerò questi essempij.
page 143Quiui vna parte fuga sopra il principale per Ottaua, e due altre per Decima lontane per moti contrarij. Se vi piacciono poi altre varietà, si darà principio al Contralto, e poi ad vn Tenore, fraposti dall'vno all'altro dui tempi di Breue, e seguirà vn'altro Tenore seruato l'istesso silentio, & indi succederà il Soprano dopò sei tempi pur di Breue dal principio del Con-tralto, che fia guida. E non contenti di questo cominciaranno con vn Tenore, e dopò duoi tempi ancor di Breue seguiranno co 'l Contralto, & hauendone interposti quattro, soggiongeranno il Soprano, à cui succede-rà l'altro Tenore premesso il riposo di sei tempi simili. E, perche meglio il tutto si affaciliti, porgerò questi essempij.
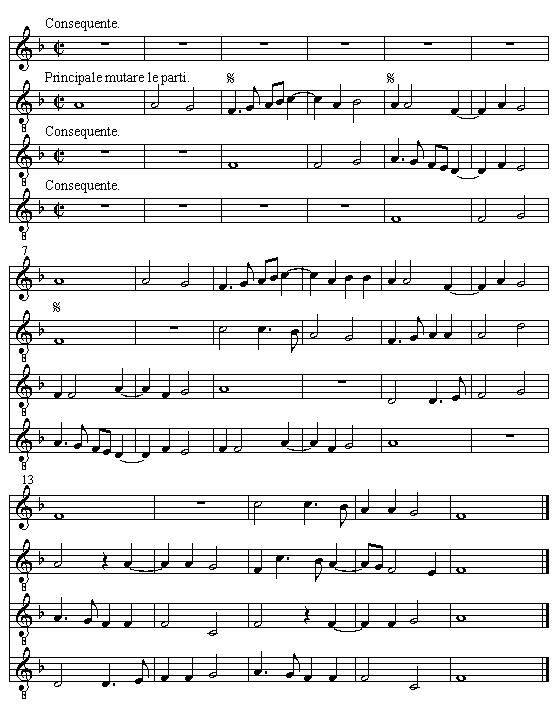 page 144Ecco l'altro variato.
page 144Ecco l'altro variato.
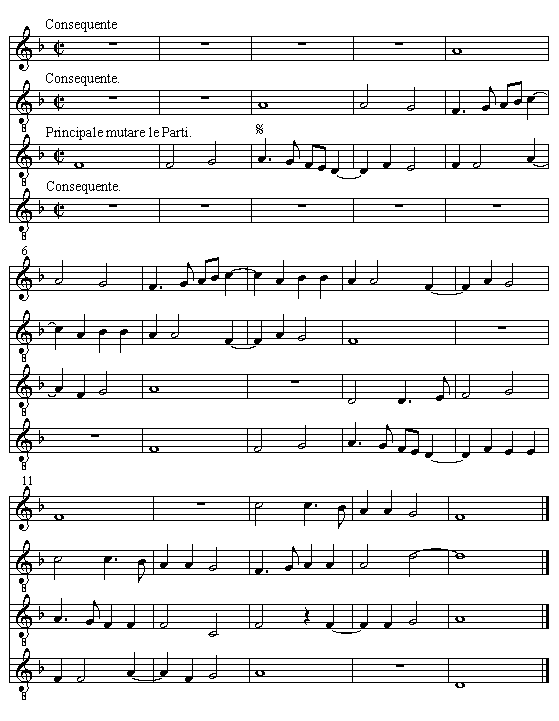 Hora mostrarò, come due parti si cantaranno per Ottaua, e due per Quinta per contrario moto in quest'altro essempio, che hora formarò.
Hora mostrarò, come due parti si cantaranno per Ottaua, e due per Quinta per contrario moto in quest'altro essempio, che hora formarò.
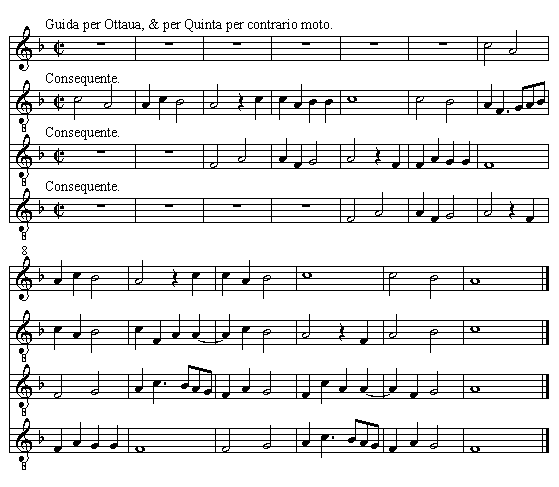 page 145Si concederà pur anche (à loro piacere) il far cominciare il Soprano, e soggionta la pausa di due tempi di Breue, seguire il Tenore, & indi, adempita l'istessa distanza, l'altro Tenore, e finalmente doppo lo scorso di sei tempi tali il Contralto, come quiui.
page 145Si concederà pur anche (à loro piacere) il far cominciare il Soprano, e soggionta la pausa di due tempi di Breue, seguire il Tenore, & indi, adempita l'istessa distanza, l'altro Tenore, e finalmente doppo lo scorso di sei tempi tali il Contralto, come quiui.
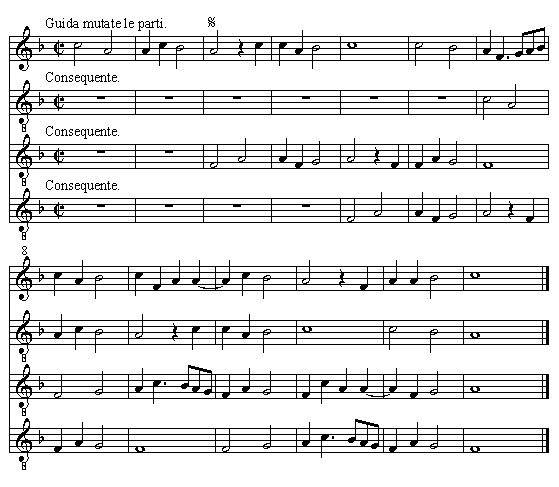 Nè già si vietarà (per far acquisto di varietà nuoua) il far principio con vn Tenore, succedendogli il Contralto non prima di duoi tempi di Bre-page 146ue, & indi allo spatio di quattro tempi si sopporrà il Soprano, che prece-derà l'altro Tenore di sei tempi dell'istessa sorte. Ilche si appresenta loro questo essempio.
Nè già si vietarà (per far acquisto di varietà nuoua) il far principio con vn Tenore, succedendogli il Contralto non prima di duoi tempi di Bre-page 146ue, & indi allo spatio di quattro tempi si sopporrà il Soprano, che prece-derà l'altro Tenore di sei tempi dell'istessa sorte. Ilche si appresenta loro questo essempio.
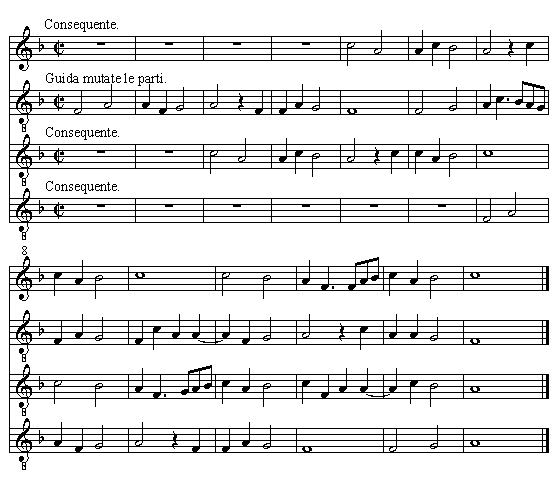 Tre varietà si sono scoperte in questo Canone da tre varij principij, che se gli sono dati. Vn'altra varietà ancora si permette, ciò è, che si comin-ci da vn Tenore, e passati duoi tempi pur ancor di Breue, vi segua l'altro, & poi il Contralto in quattro simili, à cui succeda il Soprano dal finir di sei tempi dell'istessa sorte, non meno, che in questo essempio si fa.
Tre varietà si sono scoperte in questo Canone da tre varij principij, che se gli sono dati. Vn'altra varietà ancora si permette, ciò è, che si comin-ci da vn Tenore, e passati duoi tempi pur ancor di Breue, vi segua l'altro, & poi il Contralto in quattro simili, à cui succeda il Soprano dal finir di sei tempi dell'istessa sorte, non meno, che in questo essempio si fa.
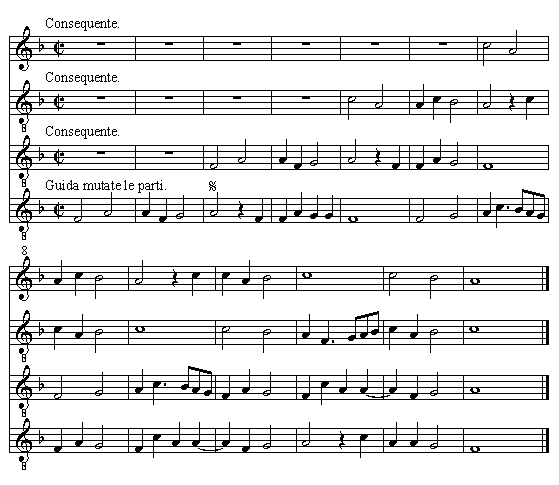 page 147
Onde quattro sono le differenze tra i principij del predetto Canone, nel quale per l'obligo, che in simili ci astringe, manca qualche parte della leggiadria, e gratia, che si conuerrebbe. E perciò il possibile deue sodisfare. Hauendo adunque io dati gli esempij, è ben ragione, che (per non lasciar l'incominciato ordine) appresti il modo per farne delli simili, & è questo. Si lascia ogni dissonanza, e la consonanza sesta, che sa-rebbe di disordine non picciolo. Si auuerta, che 'l principale, ò guida non ecceda nelle sue estremità più di otto voci, mercè delle due parti, che vanno per contrario moto; acciò siano commodi al Cantore. Et an-co auuertiscasi che essa guida vada con mouimenti cantabili più, che fia possibile. Ilche è ciò, che posso dir in questo. G. perche (al mio pare-re) son fatto benissimo possessore di queste osseruationi che sono facilis-sime alla memoria, V. S. potrà andarsene più oltre sopra questo Canoni, se le piacerà. A. Cosi farò con l'additarne vn'altro, in cui tre parti mo-dularanno sopra vna sola, e tutte diranno l'istesse figure, e cantaranno con i medemi interualli, tanto nell'ascendere, quanto nel discendere, cosa ve-ramente bella, & ingegnosa, che à loro sarà (per quanto giudico) di sommo contento. G. Ben se lo può permettere V. S. perche le desideriamo tali; e tali solo escono dalla sua bocca. A. Ecco dunque l'essempio. page 148
page 147
Onde quattro sono le differenze tra i principij del predetto Canone, nel quale per l'obligo, che in simili ci astringe, manca qualche parte della leggiadria, e gratia, che si conuerrebbe. E perciò il possibile deue sodisfare. Hauendo adunque io dati gli esempij, è ben ragione, che (per non lasciar l'incominciato ordine) appresti il modo per farne delli simili, & è questo. Si lascia ogni dissonanza, e la consonanza sesta, che sa-rebbe di disordine non picciolo. Si auuerta, che 'l principale, ò guida non ecceda nelle sue estremità più di otto voci, mercè delle due parti, che vanno per contrario moto; acciò siano commodi al Cantore. Et an-co auuertiscasi che essa guida vada con mouimenti cantabili più, che fia possibile. Ilche è ciò, che posso dir in questo. G. perche (al mio pare-re) son fatto benissimo possessore di queste osseruationi che sono facilis-sime alla memoria, V. S. potrà andarsene più oltre sopra questo Canoni, se le piacerà. A. Cosi farò con l'additarne vn'altro, in cui tre parti mo-dularanno sopra vna sola, e tutte diranno l'istesse figure, e cantaranno con i medemi interualli, tanto nell'ascendere, quanto nel discendere, cosa ve-ramente bella, & ingegnosa, che à loro sarà (per quanto giudico) di sommo contento. G. Ben se lo può permettere V. S. perche le desideriamo tali; e tali solo escono dalla sua bocca. A. Ecco dunque l'essempio. page 148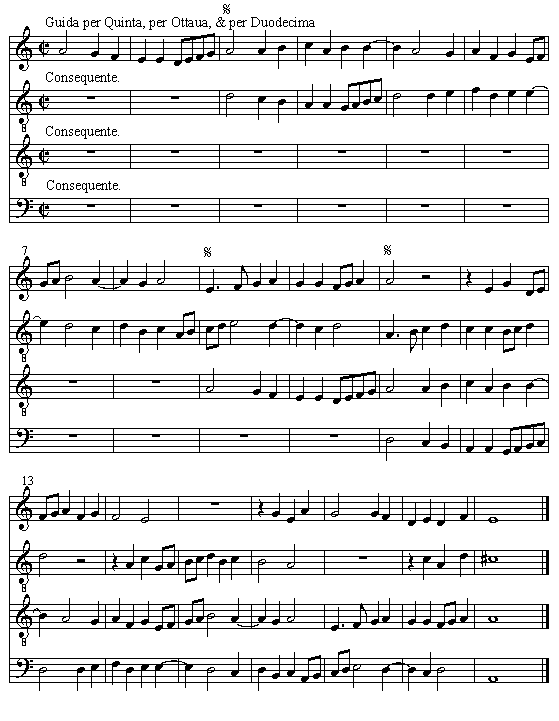 Qui comincia il Contralto per Quinta, il Tenore per Ottaua, & il Basso per Duodecima. In questo poi, che son per dar loro, principiarà il Con-tralto per Quarta, il Tenore per Ottaua, e 'l Basso per Vndecima. page 149
Qui comincia il Contralto per Quinta, il Tenore per Ottaua, & il Basso per Duodecima. In questo poi, che son per dar loro, principiarà il Con-tralto per Quarta, il Tenore per Ottaua, e 'l Basso per Vndecima. page 149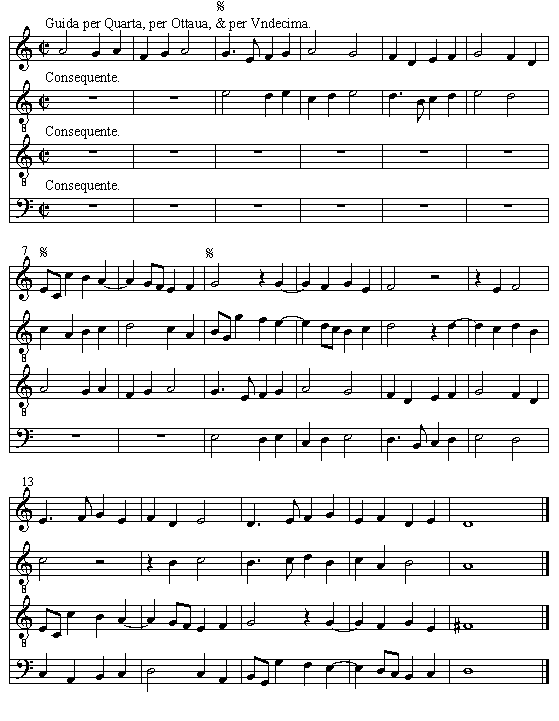 Ma in quest'altro s'haurà il principio da vn'altra parte; acciò si dia noti-tia, che si può far caminar la parte, che più al Compositore piace. page 150
Ma in quest'altro s'haurà il principio da vn'altra parte; acciò si dia noti-tia, che si può far caminar la parte, che più al Compositore piace. page 150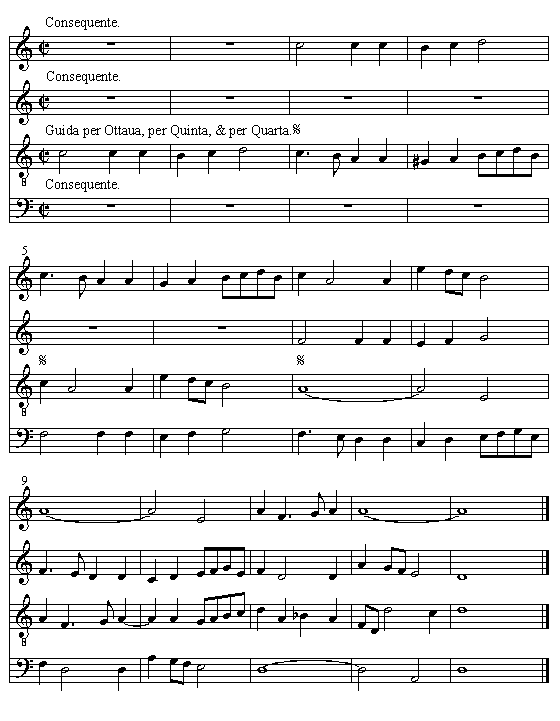 Per guida, e principale hassi il Tenore, & per formarne vn simile, basta, che le due prime parti modulino, quanto piace, e poi cominci la Terza, & indi la Quarta, seruando però vn'istessa pausa tra la prima, e la secon-da, e tra la terza, e l'vltima, come si scorge, considerando gli essempij, che hò dati. E lecito vsar la sesta, (cessando ogni disordine) e la dissonanza quarta, e la settima, e tutte l'altre parimente, non si scostando punto in metterle dall'ordine, che si tiene nelle compositioni. E ben vero, che que-sti oblighi impossibili è il non far digresso dal bel modo di cantare, e d'accomodare le consonanze. Che per ciò tal hora per far il fine con qual-che vago ordine di procedere, vi cadono delli passaggij non eleganti in page 151tutto. Ilche (rimossa tal causa) per alcun modo non si ammetterebbe, e 'l Compositore, che vi errasse, sarebbe giudicato (e con ragione) di poco giudicio e di niun valore; poiche il tutto solo si concede, & ottiene per simili oblighi. G. Il veggio per la varietà delli mouimenti, che fanno le parti fra di loro. A. E cosi veramente. E, perche non mi souuiene per adesso altra regola per far Canoni diuersi da quei, che hò mostrati, senza estendermi più sopra di loro, stimando d'hauer à bastanza cosi mostrati gli essempij suoi, come date le regola, & osseruationi, farò fine à questo mio ragionamento; posciache da quello le Signorie Vostre per lor stesse (essaminando il tutto à lor piacere) conosceranno la differenza, che è fra la Theorica, e la Prattica; e quanta maggior difficoltà si troui in questa, che in quella; e come sia pur ella scienza dignissima, ancorche hoggidì sia cosi poco stimata, & hauuta in vile consideratione. G. Ben il cono-sco, e non meno di quel, che deue vn cieco, à chi gli dona il lume delli occhi (onde sicuramente senza duce, e timore alcuno se ne può andare in qual si voglia luogo, fruire il bello, il vago, & i colori di que-sta machina mondiale) sarò per sempre obligato à Vostra Signoria, che mi hà illuminato in questa scienza, in cui dianzi mi poteuo dir cieco, & hora contemplo, ammiro, e possiedo, tanti, e cosi dotti auuertimenti, e precetti, mercè dell'infinita cortesia di Vostra Signoria, alla quale (se il render la pariglia fosse concesso in parole) mai non potrei rispondere: ancorche hauessi e bocche mille, e lingue mille; mà (doue, e di parole, e più di fatti mi si niega il farlo) procurarò, e sforzarommi di suppli-re con l'affetto interno del cuore. M. E pure ancor io, che quasi inu-tile, e sterile pianta fui per l'adietro nel colto giardino di scienza così nobile, & hora mi par d'esser diuenuto seconda, e fruttifera alle ruggia-de delle dolcissime parole, al Zefiro soaue dell'immensa benignità, & à i raggi del chiarissimo intelletto di Vostra Signoria, sarò tenuto in eterno ad ascriuere à lei, e da quella riconoscere l'honore d'ogni frutto, che son per farci, non già per ricompensa, (che questo sarebbe vn pre-scriuer fine à chi ne manca, e restringer l'acque tutte del mare in vrna breuissima) mà si bene per memoria delli oblighi, che le tengo in tanto numero, che pria l'alma mi si può scioglier dal nodo corporeo, che dal minimo di quelli mi liberi. A. Miei gli oblighi, miei gli rin-gratiamenti, e mie deuriano essere le scuse; poiche con tanta attentio-ne, & humanità, spogliati d'ogni noia, mi hanno prestate le orec-chie gratissime; e si sono degnate d'essercitar l'amor, che lor porto, e maggiormente dimostrarlo, co 'l chiedermi cose, ancorche picciole à paragone del desiderio, che ne tengo. Per terminar, e sopir adunque page 152 vna tanta lite di gratitudine (se cosi le piace) altro non sia giudi-ce, altro non ci sia premio, altro non ci sia obligo, che vn'amore immortale, che tutti trè ci annodi vicendeuolmente d'vna catena per sempre indissolubìle [sic: indissolubile]. G. Sia lege inuio-labile ciò, che ella propone. M. Mi ac-queto pure anch'io in tutto, e per tutto alle sue voglie.
Per guida, e principale hassi il Tenore, & per formarne vn simile, basta, che le due prime parti modulino, quanto piace, e poi cominci la Terza, & indi la Quarta, seruando però vn'istessa pausa tra la prima, e la secon-da, e tra la terza, e l'vltima, come si scorge, considerando gli essempij, che hò dati. E lecito vsar la sesta, (cessando ogni disordine) e la dissonanza quarta, e la settima, e tutte l'altre parimente, non si scostando punto in metterle dall'ordine, che si tiene nelle compositioni. E ben vero, che que-sti oblighi impossibili è il non far digresso dal bel modo di cantare, e d'accomodare le consonanze. Che per ciò tal hora per far il fine con qual-che vago ordine di procedere, vi cadono delli passaggij non eleganti in page 151tutto. Ilche (rimossa tal causa) per alcun modo non si ammetterebbe, e 'l Compositore, che vi errasse, sarebbe giudicato (e con ragione) di poco giudicio e di niun valore; poiche il tutto solo si concede, & ottiene per simili oblighi. G. Il veggio per la varietà delli mouimenti, che fanno le parti fra di loro. A. E cosi veramente. E, perche non mi souuiene per adesso altra regola per far Canoni diuersi da quei, che hò mostrati, senza estendermi più sopra di loro, stimando d'hauer à bastanza cosi mostrati gli essempij suoi, come date le regola, & osseruationi, farò fine à questo mio ragionamento; posciache da quello le Signorie Vostre per lor stesse (essaminando il tutto à lor piacere) conosceranno la differenza, che è fra la Theorica, e la Prattica; e quanta maggior difficoltà si troui in questa, che in quella; e come sia pur ella scienza dignissima, ancorche hoggidì sia cosi poco stimata, & hauuta in vile consideratione. G. Ben il cono-sco, e non meno di quel, che deue vn cieco, à chi gli dona il lume delli occhi (onde sicuramente senza duce, e timore alcuno se ne può andare in qual si voglia luogo, fruire il bello, il vago, & i colori di que-sta machina mondiale) sarò per sempre obligato à Vostra Signoria, che mi hà illuminato in questa scienza, in cui dianzi mi poteuo dir cieco, & hora contemplo, ammiro, e possiedo, tanti, e cosi dotti auuertimenti, e precetti, mercè dell'infinita cortesia di Vostra Signoria, alla quale (se il render la pariglia fosse concesso in parole) mai non potrei rispondere: ancorche hauessi e bocche mille, e lingue mille; mà (doue, e di parole, e più di fatti mi si niega il farlo) procurarò, e sforzarommi di suppli-re con l'affetto interno del cuore. M. E pure ancor io, che quasi inu-tile, e sterile pianta fui per l'adietro nel colto giardino di scienza così nobile, & hora mi par d'esser diuenuto seconda, e fruttifera alle ruggia-de delle dolcissime parole, al Zefiro soaue dell'immensa benignità, & à i raggi del chiarissimo intelletto di Vostra Signoria, sarò tenuto in eterno ad ascriuere à lei, e da quella riconoscere l'honore d'ogni frutto, che son per farci, non già per ricompensa, (che questo sarebbe vn pre-scriuer fine à chi ne manca, e restringer l'acque tutte del mare in vrna breuissima) mà si bene per memoria delli oblighi, che le tengo in tanto numero, che pria l'alma mi si può scioglier dal nodo corporeo, che dal minimo di quelli mi liberi. A. Miei gli oblighi, miei gli rin-gratiamenti, e mie deuriano essere le scuse; poiche con tanta attentio-ne, & humanità, spogliati d'ogni noia, mi hanno prestate le orec-chie gratissime; e si sono degnate d'essercitar l'amor, che lor porto, e maggiormente dimostrarlo, co 'l chiedermi cose, ancorche picciole à paragone del desiderio, che ne tengo. Per terminar, e sopir adunque page 152 vna tanta lite di gratitudine (se cosi le piace) altro non sia giudi-ce, altro non ci sia premio, altro non ci sia obligo, che vn'amore immortale, che tutti trè ci annodi vicendeuolmente d'vna catena per sempre indissolubìle [sic: indissolubile]. G. Sia lege inuio-labile ciò, che ella propone. M. Mi ac-queto pure anch'io in tutto, e per tutto alle sue voglie.