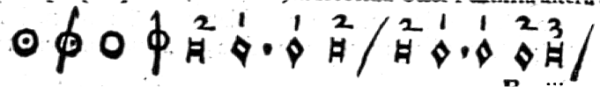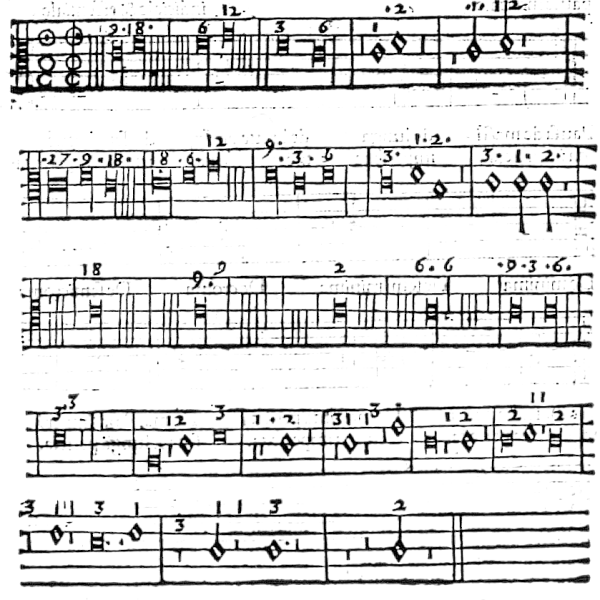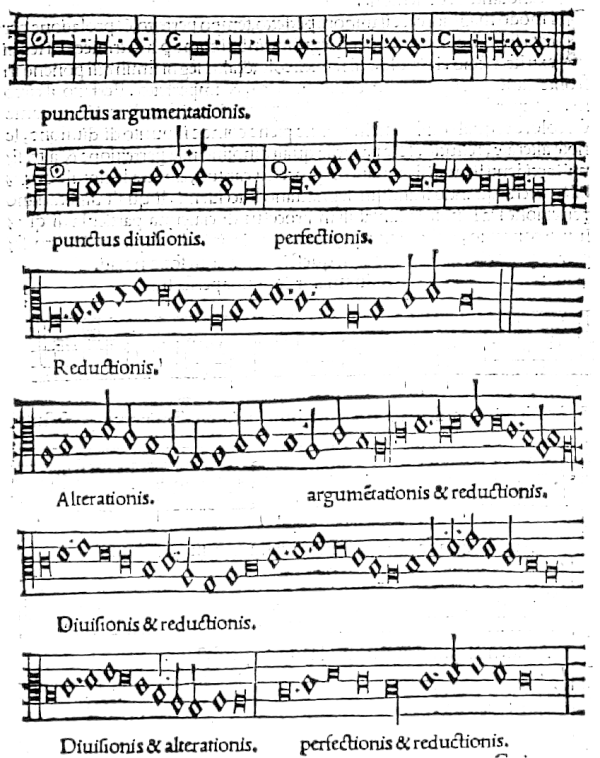Title: Breve introduttione di musica misurata
Author: Del Lago, Giovanni
Publication: (Venice, 1540)
Principal editor: Paloma Otaola
Edition: 2002
Department of Information and Computing Sciences Utrecht University P.O. Box 80.089 3508 TB Utrecht Netherlands Ex praelo Brandini & Octaviani Scoti fratrum habentur excussae. VENETIIS. M. D. XXXX.page 2page 3
Ex praelo Brandini & Octaviani Scoti fratrum habentur excussae. VENETIIS. M. D. XXXX.page 2page 3AL MAGNIFICO LORENZO MORESINO PATRICIO Venetiano del Magnifico Bartholomeo figliolo.
¶Ad Lectorem Gregorii Oldovini Carmen.
Si placet Harmonici discors concordia cantus:
Hoc breve Ioannis perlege lector opus
Δὼριον hic, phrygiumque docet, lydiumque libellus:
Nec non multiplici ἰωνικὸν arte melos,
Ἔνθεον ἦ γλαφυρὸν, σεμνὸν, καὶ βακχικὸν εἴδος
Δείκνυσι, καὶ γλυκερὴς πᾶν γένος ἁρμονίης,
Non hic ambages, non hic enigmata cernes:
Sed patulos, faciles artis amice modos,
Consona dissimili currit symphonia ductu:
Obice, nec scrupulo sit mora tarda tibi,
En breviter, nitideque monet, cognosce camaenam
Multiplicem, variam pectine, & arte gravem,
Orpheus hac sylvas traxit, delphinas Arion:
David & hac Saulem daemone atroce ferum,
Hac Iovis exhilarant Musae convivia magni.
Quum binae cantant, pulsat Apollo chelyn,
Divinum certe mortali Musica donum:
Qua nihil est homini gratius orbe datum,
Disce igitur studio coelestia munera disce:
Oblectaque animum nocte, dieque tuum.
DELLA INTRODUTTIONE DE LA Mano secondo Guido Monacho Aretino.
 C, D, E, F, G. A,
C, D, E, F, G. A,  C, D, E,
de le quali le prime sette sono dette gravi, per esser le più basse. Le altre sette acute. Le sei ultime sopra acute, & queste venti lettere si dividono anchora in due parti, cioè dieci in riga, & dieci in spatio, come appar qui sotto
in essa Mano.
C, D, E,
de le quali le prime sette sono dette gravi, per esser le più basse. Le altre sette acute. Le sei ultime sopra acute, & queste venti lettere si dividono anchora in due parti, cioè dieci in riga, & dieci in spatio, come appar qui sotto
in essa Mano.

Introductorium Musices.
 , fa
, fa  mi. C, sol fa ut. D, la sol, re E
la mi. F, fa ut. G, sol re ut. A, la mi re.
mi. C, sol fa ut. D, la sol, re E
la mi. F, fa ut. G, sol re ut. A, la mi re.  , fa
, fa  mi. C, sol fa.
D, la sol. E la. & così discendendo cioè dicendo, E, la. D, la sol. C, sol fa &c. Et sappiate che la prima nota si comincia in riga, & la seconda in spacio, & così gradatim
una in riga & l'altra in spacio insino alla fine, poste sopra le giunture de i diti de
la mano sinistra, cominciando nella summità del dito grosso, & così per ordine per
infino alla summità del dito medio, dicendo così. Γ, ut ha una lettera & una
nota. Γ è la lettera, ut è la nota. Ut se canta per
mi. C, sol fa.
D, la sol. E la. & così discendendo cioè dicendo, E, la. D, la sol. C, sol fa &c. Et sappiate che la prima nota si comincia in riga, & la seconda in spacio, & così gradatim
una in riga & l'altra in spacio insino alla fine, poste sopra le giunture de i diti de
la mano sinistra, cominciando nella summità del dito grosso, & così per ordine per
infino alla summità del dito medio, dicendo così. Γ, ut ha una lettera & una
nota. Γ è la lettera, ut è la nota. Ut se canta per  quadro grave, & se regge da sé medesimo, dicendo ut. A re, ha una lettera, & una nota. A è la lettera, re, è la nota, re se canta per
quadro grave, & se regge da sé medesimo, dicendo ut. A re, ha una lettera, & una nota. A è la lettera, re, è la nota, re se canta per  quadro grave, & si regge da lo ut, de Γ,
ut dicendo, ut re, re ut. B, mi, ha una lettera, & una nota. B, è la lettera,
mi è la nota. mi se canta per
quadro grave, & si regge da lo ut, de Γ,
ut dicendo, ut re, re ut. B, mi, ha una lettera, & una nota. B, è la lettera,
mi è la nota. mi se canta per  quadro grave, & si regge da lo ut de Γ, ut dicendo, ut re mi, mi re ut. C, fa ut, ha una lettera, & due note. C, è la lettera, fa ut, sono le note, fa se canta per
quadro grave, & si regge da lo ut de Γ, ut dicendo, ut re mi, mi re ut. C, fa ut, ha una lettera, & due note. C, è la lettera, fa ut, sono le note, fa se canta per  quadro grave, & si regge da lo ut
de Γ, ut, dicendo ut re mi fa, fa mi re ut, & ut si canta per natura grave, &
si regge da sé medesimo dicendo ut. D, sol re, ha una lettera & due note. D,
è la lettera sol re sono le note, sol si canta per
quadro grave, & si regge da lo ut
de Γ, ut, dicendo ut re mi fa, fa mi re ut, & ut si canta per natura grave, &
si regge da sé medesimo dicendo ut. D, sol re, ha una lettera & due note. D,
è la lettera sol re sono le note, sol si canta per  quadro grave & si regge da lo
ut de Γ, ut. dicendo ut re mi fa sol, sol fa mi re ut. il re si canta per natura
grave, e si regge da lo ut, de C, fa ut, dicendo ut re, re ut. E la mi, ha una
lettera & due note. E, è la lettera, la mi sono le note, la si canta per
quadro grave & si regge da lo
ut de Γ, ut. dicendo ut re mi fa sol, sol fa mi re ut. il re si canta per natura
grave, e si regge da lo ut, de C, fa ut, dicendo ut re, re ut. E la mi, ha una
lettera & due note. E, è la lettera, la mi sono le note, la si canta per  quadro
grave & si regge da lo ut de Γ, ut dicendo ut re mi fa sol la, la sol fa mi re ut, il
mi si canta per natura grave, & si regge da lo ut de C fa ut, dicendo, ut re mi, mi re
ut. F fa ut, ha una lettera & due note. F, è la lettera & fa ut, sono le note. fa si canta
per natura grave, & si regge da lo ut di C fa ut dicendo, ut re mi fa. fa mi re ut, &
ut si canta per
quadro
grave & si regge da lo ut de Γ, ut dicendo ut re mi fa sol la, la sol fa mi re ut, il
mi si canta per natura grave, & si regge da lo ut de C fa ut, dicendo, ut re mi, mi re
ut. F fa ut, ha una lettera & due note. F, è la lettera & fa ut, sono le note. fa si canta
per natura grave, & si regge da lo ut di C fa ut dicendo, ut re mi fa. fa mi re ut, &
ut si canta per  molle grave, & si regge da sé medesimo dicendo ut. G sol re ut ha
una lettera & tre note. G è la lettera, sol re ut, sono le note. sol si canta per natura
grave, & si regge da lo ut di C fa ut dicendo, ut re mi fa sol, sol fa mi re ut. il re
si canta per
molle grave, & si regge da sé medesimo dicendo ut. G sol re ut ha
una lettera & tre note. G è la lettera, sol re ut, sono le note. sol si canta per natura
grave, & si regge da lo ut di C fa ut dicendo, ut re mi fa sol, sol fa mi re ut. il re
si canta per  molle grave & si regge da lo ut de F fa ut dicendo, ut re, re ut,
& ut si canta per
molle grave & si regge da lo ut de F fa ut dicendo, ut re, re ut,
& ut si canta per  quadro acuto, & si regge da sé medesimo dicendo, ut. A la mi re, ha una lettera & tre note. A è la lettera, la mi re sono le note, la si canta per natura grave, & si regge da lo ut de C fa ut dicendo, ut re mi fa sol la.
la sol fa mi re ut. il mi si canta per
quadro acuto, & si regge da sé medesimo dicendo, ut. A la mi re, ha una lettera & tre note. A è la lettera, la mi re sono le note, la si canta per natura grave, & si regge da lo ut de C fa ut dicendo, ut re mi fa sol la.
la sol fa mi re ut. il mi si canta per  molle grave, & si regge da lo ut di F, fa
ut dicendo ut re mi. mi re ut. il re si canta per
molle grave, & si regge da lo ut di F, fa
ut dicendo ut re mi. mi re ut. il re si canta per  quadro acuto & si regge de
lo ut de G sol re ut, dicendo, ut re. re ut.
quadro acuto & si regge de
lo ut de G sol re ut, dicendo, ut re. re ut.  fa
fa  mi ha due lettere & due note
mi ha due lettere & due note 
 sono le lettere, & fa mi le note. fa si canta per
sono le lettere, & fa mi le note. fa si canta per  molle grave, & si page 6regge da lo ut, di F fa ut dicendo, ut re mi fa. fa mi re ut. il mi si canta per
molle grave, & si page 6regge da lo ut, di F fa ut dicendo, ut re mi fa. fa mi re ut. il mi si canta per  quadro acuto, & si regge da lo ut de G sol re ut, dicendo, ut re mi. mi re ut.
& così seguitarete questo ordine per infino alla fine. Anchora notate questa
nostra regola utilissima si circa il saper de le note quali sono in riga, over in
spacio, come per sapere perché le si cantino. Prima tu dei sapere che si una
lettera grave sarà in riga, quella medesima in le sopr'acute sarà in riga. ma
in le acute in spacio. Ma se la lettera grave sarà in spacio, quella medesima
in le sopr'acute sarà in spacio. & l'acuta in riga Le lettere principali sono sette, cioè, Γ, A, B, C, D, E, F, & comenciasi da Γ greca, laquale è G latina,
& subsequenter seguitando reiterando quelle per infino alla fine, come appare nella prescritta mano. Ma le lettere familiari sono tre cioè C F & G in le
quali le deduttioni hanno principio. Le deduttioni over ordini de la mano
sono sette. La prima ha origine over comincia in Γ ut. la seconda in C fa ut
la terza in F fa ut grave. la quarta in G sol re ut acuto. la quinta in C sol fa
ut. la sesta in F fa ut acuto. & la settima in G sol re ut sopr'acuto. La dedutione è una naturale progressione de' sei sillabe cioè ut re mi fa sol la: le quali in musica se dimandino voci. Il modo & ordine di pronunciare queste sei
sillabe over voci, è tale che tra la prima & la seconda cioè, ut re, se ascende
la voce una distantia di tuono. così anchora da re al mi. ma da mi al fa un
intervallo di un semituono minore da la nota fa, al sol un tuono; & similmente dal sol al la & così discendendo.
quadro acuto, & si regge da lo ut de G sol re ut, dicendo, ut re mi. mi re ut.
& così seguitarete questo ordine per infino alla fine. Anchora notate questa
nostra regola utilissima si circa il saper de le note quali sono in riga, over in
spacio, come per sapere perché le si cantino. Prima tu dei sapere che si una
lettera grave sarà in riga, quella medesima in le sopr'acute sarà in riga. ma
in le acute in spacio. Ma se la lettera grave sarà in spacio, quella medesima
in le sopr'acute sarà in spacio. & l'acuta in riga Le lettere principali sono sette, cioè, Γ, A, B, C, D, E, F, & comenciasi da Γ greca, laquale è G latina,
& subsequenter seguitando reiterando quelle per infino alla fine, come appare nella prescritta mano. Ma le lettere familiari sono tre cioè C F & G in le
quali le deduttioni hanno principio. Le deduttioni over ordini de la mano
sono sette. La prima ha origine over comincia in Γ ut. la seconda in C fa ut
la terza in F fa ut grave. la quarta in G sol re ut acuto. la quinta in C sol fa
ut. la sesta in F fa ut acuto. & la settima in G sol re ut sopr'acuto. La dedutione è una naturale progressione de' sei sillabe cioè ut re mi fa sol la: le quali in musica se dimandino voci. Il modo & ordine di pronunciare queste sei
sillabe over voci, è tale che tra la prima & la seconda cioè, ut re, se ascende
la voce una distantia di tuono. così anchora da re al mi. ma da mi al fa un
intervallo di un semituono minore da la nota fa, al sol un tuono; & similmente dal sol al la & così discendendo.
 molle, & l'altra di
molle, & l'altra di  duro, & cognoscesi a questo che ogni ut in C si canta per natura, ogni
ut in F si canta per
duro, & cognoscesi a questo che ogni ut in C si canta per natura, ogni
ut in F si canta per  molle, & ogni ut in G si canta per
molle, & ogni ut in G si canta per  duro come appare
per questo verso el quale dice così
duro come appare
per questo verso el quale dice così
C naturam dat f,  , molle. G quoque
, molle. G quoque  durum,
durum,
cioè el C dimostra natura F  molle, el G
molle, el G  duro, & notate che quello che è detto che ogni ut in C si canta per natura &c. Si intende etiam de li suditi suoi compagni, & perché ogni ut ha sotto di sé, re mi fa sol la, verbi gratia lo ut di C fa ut si canta per natura perché ogni ut in C si canta per natura,
seguita adonque che re in D sol re. mi in E la mi. fa in F fa ut. sol in G sol re
ut. & la in A la mi re. tutti si cantino per natura, & così è di tutti gli altri. E
sono dui segni, uno di
duro, & notate che quello che è detto che ogni ut in C si canta per natura &c. Si intende etiam de li suditi suoi compagni, & perché ogni ut ha sotto di sé, re mi fa sol la, verbi gratia lo ut di C fa ut si canta per natura perché ogni ut in C si canta per natura,
seguita adonque che re in D sol re. mi in E la mi. fa in F fa ut. sol in G sol re
ut. & la in A la mi re. tutti si cantino per natura, & così è di tutti gli altri. E
sono dui segni, uno di  molle el quale è questo
molle el quale è questo  , e dove è posto tal segno
o sia in riga, over in spacio se dice sempre fa. quia ubi
, e dove è posto tal segno
o sia in riga, over in spacio se dice sempre fa. quia ubi  ibi fa, ma non se deve cantare per
ibi fa, ma non se deve cantare per  molle se nol se vedi segnado o per necessità. L'altro segno si è de
molle se nol se vedi segnado o per necessità. L'altro segno si è de  duro, & è questo
duro, & è questo  over questo
over questo  & dove è posto tal segno
si dice sempre mi. Le chiavi del canto sono due principalmente, cioè una page 7di natura grave & l'altra di
& dove è posto tal segno
si dice sempre mi. Le chiavi del canto sono due principalmente, cioè una page 7di natura grave & l'altra di  duro acuto. La chiave di natura
grave è figurata di tre note, & è posta in F fa ut, primo, a questo modo
duro acuto. La chiave di natura
grave è figurata di tre note, & è posta in F fa ut, primo, a questo modo 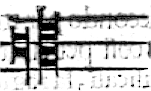 & la chiave di
& la chiave di  duro acuto è figurata di due note, & è posta in C sol fa ut, come è qui
duro acuto è figurata di due note, & è posta in C sol fa ut, come è qui 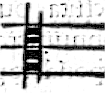 & l'una da
l'altra è distante per quinta, & sempre la chiave si pone in riga. ma antiquamente nel canto ecclesiastico se usava alla chiave de natura la riga rossa, & a
quella de
& l'una da
l'altra è distante per quinta, & sempre la chiave si pone in riga. ma antiquamente nel canto ecclesiastico se usava alla chiave de natura la riga rossa, & a
quella de  duro la riga gialla. Dapoi è stato aggiunto la terza chiave, la quale è figurata de le preditte due note posta in C sol fa ut, con additione del
duro la riga gialla. Dapoi è stato aggiunto la terza chiave, la quale è figurata de le preditte due note posta in C sol fa ut, con additione del  rotundo nel inferior spacio di sotto la linea de la
chiave così segnata.
rotundo nel inferior spacio di sotto la linea de la
chiave così segnata. 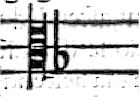 & nota che sempre dove è la chiave lì è sempre fa, salvo se per il
& nota che sempre dove è la chiave lì è sempre fa, salvo se per il  rotundo over molle non vien impedito, perché allhora si dice sol. Ma alcuna volta, e questo accade nel canto figurato per l'ascender
suo in luogo di chiave usiamo, questa lettera G la qual dinota G sol re ut sopr'acuto. Anchora notate questo verso per le mutationi el quale dice così,
rotundo over molle non vien impedito, perché allhora si dice sol. Ma alcuna volta, e questo accade nel canto figurato per l'ascender
suo in luogo di chiave usiamo, questa lettera G la qual dinota G sol re ut sopr'acuto. Anchora notate questo verso per le mutationi el quale dice così,
(Ut re mi scandunt, fa sol la quoque descendunt.)
cioè che ogni volta che l'è necessità far mutatione da proprietà in proprietà vedi dove vi troviate cioè in
qual luogo de la mano, & se'l canto ascende bisogna dir o ut, o re, over mi,
& se'l descende bisogna dir o fa, o sol, over la, secondo el luogo dove vi trovevate. Dove è una sola nota over voce, non si fa mutatione, come
è in Γ ut. in A re. in B mi. in tutti duoi  fa
fa  mi, & in E la, perché mutatione altro non è che mutare una proprietà in un'altra, & per consequente una voce in l'altra in uno medesimo suono. Anchora che le siano diverse
di nome per esser di diverse proprietà. Dove sono due voci sono due mutationi come è, in C fa ut. D sol re. E la mi. F fa ut. C sol fa, & D la sol. Lo
essemplo in C fa ut, fa in ut, ascendendo di
mi, & in E la, perché mutatione altro non è che mutare una proprietà in un'altra, & per consequente una voce in l'altra in uno medesimo suono. Anchora che le siano diverse
di nome per esser di diverse proprietà. Dove sono due voci sono due mutationi come è, in C fa ut. D sol re. E la mi. F fa ut. C sol fa, & D la sol. Lo
essemplo in C fa ut, fa in ut, ascendendo di  quadro in natura ut in fa
descendendo de natura in
quadro in natura ut in fa
descendendo de natura in  quadro, ma questa regola falisce in
quadro, ma questa regola falisce in  fa
fa  mi. Anchora che in
mi. Anchora che in  fa
fa  mi gli siano due proprietati, & per consequente
due voci non si può però far mutatione, perché quelle due voci non si può
proferire in uno medesimo suono per esser el mi distante dal fa, uno semituono maggiore, & perché mutatione altro non è che mutare il nome de la
voce, over de la nota in un'altro nome di nota che sia in un medesimo luogo, & suono, intrando de una in l'altra proprietà, over qualità, come disopra ho detto. Dove dovete sapere che quello semituono maggiore si causa per virtù del
mi gli siano due proprietati, & per consequente
due voci non si può però far mutatione, perché quelle due voci non si può
proferire in uno medesimo suono per esser el mi distante dal fa, uno semituono maggiore, & perché mutatione altro non è che mutare il nome de la
voce, over de la nota in un'altro nome di nota che sia in un medesimo luogo, & suono, intrando de una in l'altra proprietà, over qualità, come disopra ho detto. Dove dovete sapere che quello semituono maggiore si causa per virtù del  molle, il quale è accidentale, perché el può esser messo e non
messo, & fu trovato per tre cause. Prima, per tor la durezza del tritono per
poter procedere per il modo diatonico cioè per tuono, & tuono & semituopage 8no over per semituono tuono & tuono. Secondo per meglior sonorità. Tertio per necessità, over colorata musica. & così per esser accidentale, e non
dè esser connumerato nelle sette lettere musicali, la ragione è perché el non
può corrispondere per diapason, over ottava, né con le gravi, né con le acute. Con le gravi il diapason è diminuto con le sopra acute l'è superfluo. Dove concludo non esser in computo, ma esser accidentale. Dove sono tre note, over voci si fa sei mutationi, come in G sol re ut. A la mi re. C sol fa ut, &
D la sol re. Lo essemplo in G sol re ut, sol in ut, ascendendo de natura grave in
molle, il quale è accidentale, perché el può esser messo e non
messo, & fu trovato per tre cause. Prima, per tor la durezza del tritono per
poter procedere per il modo diatonico cioè per tuono, & tuono & semituopage 8no over per semituono tuono & tuono. Secondo per meglior sonorità. Tertio per necessità, over colorata musica. & così per esser accidentale, e non
dè esser connumerato nelle sette lettere musicali, la ragione è perché el non
può corrispondere per diapason, over ottava, né con le gravi, né con le acute. Con le gravi il diapason è diminuto con le sopra acute l'è superfluo. Dove concludo non esser in computo, ma esser accidentale. Dove sono tre note, over voci si fa sei mutationi, come in G sol re ut. A la mi re. C sol fa ut, &
D la sol re. Lo essemplo in G sol re ut, sol in ut, ascendendo de natura grave in
 acuto, & tal mutatione si domanda mutatione ascendente, ut in sol descendendo de
acuto, & tal mutatione si domanda mutatione ascendente, ut in sol descendendo de  quadro in natura, la quale si dimanda descendente. sol in re, ascendendo di natura grave in
quadro in natura, la quale si dimanda descendente. sol in re, ascendendo di natura grave in  molle grave. re in sol, descendendo di natura in
molle grave. re in sol, descendendo di natura in  molle, ut in re ascendendo di
molle, ut in re ascendendo di  quadro in
quadro in  molle, re in ut ascendendo di
molle, re in ut ascendendo di  molle in
molle in  quadro & similmente procederite ne li altri luoghi. Egli è manifesto per tre cagioni bisognar farsi la mutatione. Primo acciò che & sopra, &
sotto ciascuno esacordo esse voci commodulato transito, & concinna prolatione si possino in acuto intendere, & in grave rimettere, & sbassare. Secondo per cagion di concipere el transito di più soave & dolce canto. Tertio per
cagione di più facile transito di consonanti figure, cioè diatessaron & diapente. Disopra vi ho detto che in G sol re ut si fanno sei mutationi. La prima
mutatione si fa quando mutamo la prima sillaba, over nota. In la seconda
cioè da sol in re ascendendo da natura in
quadro & similmente procederite ne li altri luoghi. Egli è manifesto per tre cagioni bisognar farsi la mutatione. Primo acciò che & sopra, &
sotto ciascuno esacordo esse voci commodulato transito, & concinna prolatione si possino in acuto intendere, & in grave rimettere, & sbassare. Secondo per cagion di concipere el transito di più soave & dolce canto. Tertio per
cagione di più facile transito di consonanti figure, cioè diatessaron & diapente. Disopra vi ho detto che in G sol re ut si fanno sei mutationi. La prima
mutatione si fa quando mutamo la prima sillaba, over nota. In la seconda
cioè da sol in re ascendendo da natura in  molle. La seconda si fa al contrario mutando la seconda sillaba in la prima cioè re in sol descendendo da
molle. La seconda si fa al contrario mutando la seconda sillaba in la prima cioè re in sol descendendo da  molle in natura. La terza mutatione si fa quando mutamo la prima sillaba
in la terza, cioè, sol in ut ascendendo da natura in
molle in natura. La terza mutatione si fa quando mutamo la prima sillaba
in la terza, cioè, sol in ut ascendendo da natura in  quadro. La quarta si fa
al contrario, ut in sol descendendo da
quadro. La quarta si fa
al contrario, ut in sol descendendo da  quadro in natura. La quinta mutatione si fa quando si muta la seconda sillaba in la terza, cioè, re in ut, per
causa di ascendere da
quadro in natura. La quinta mutatione si fa quando si muta la seconda sillaba in la terza, cioè, re in ut, per
causa di ascendere da  molle in
molle in  quadro. La sesta mutatione si fa mutando la terza sillaba in la seconda cioè ut in re per causa di ascendere da
quadro. La sesta mutatione si fa mutando la terza sillaba in la seconda cioè ut in re per causa di ascendere da  duro
in
duro
in  molle, & queste tali mutationi le chiamo dirette & regolare, è certamente
la diretta & regolare mutatione quella la quale si oppone alla precedente &
sequente unisona mutatione, cioè quando la prima si fa per causa di ascendere. La seconda di descendere. La terza di ascendere. La quarta di descendere. La quinta di ascendere. La sesta di descendere La mutatione ascendente, è, quando mutato il nome de la voce unisona, el primo moto de la
voce tende in acumine: ma la descendente è, quando el primo moto della
voce remette & abassa in gravità. Dico doversi fuggire la pluralità & molpage 9titudine delle mutationi. quando apertamente si vederà el progresso, & ordine del canto cioè con una sola mutatione esser bene & congruamente disposto. Dico anchora oltra di questo la mutatione doversi prosequire & più
tarda; & più longamente in quanto el sia possibile, ne far si deve (nisi necessitate cogente) cioè quando cantando si fa el transito oltra l'ordine de l'esacordo come è quando se ascende, over descende per sette; over otto voci, o anchora per più &c.
molle, & queste tali mutationi le chiamo dirette & regolare, è certamente
la diretta & regolare mutatione quella la quale si oppone alla precedente &
sequente unisona mutatione, cioè quando la prima si fa per causa di ascendere. La seconda di descendere. La terza di ascendere. La quarta di descendere. La quinta di ascendere. La sesta di descendere La mutatione ascendente, è, quando mutato il nome de la voce unisona, el primo moto de la
voce tende in acumine: ma la descendente è, quando el primo moto della
voce remette & abassa in gravità. Dico doversi fuggire la pluralità & molpage 9titudine delle mutationi. quando apertamente si vederà el progresso, & ordine del canto cioè con una sola mutatione esser bene & congruamente disposto. Dico anchora oltra di questo la mutatione doversi prosequire & più
tarda; & più longamente in quanto el sia possibile, ne far si deve (nisi necessitate cogente) cioè quando cantando si fa el transito oltra l'ordine de l'esacordo come è quando se ascende, over descende per sette; over otto voci, o anchora per più &c.
El luogo delle mutationi per  molle.
molle.
 molle in ascender re, cioè la mutation si fa in uno & l'altro, D, & in
G, cioè in ascendere si deve dire re: ma la, in descendere: si fa in uno & l'altro, A & in D, cioè in descendere se deve dire la come in questo essemplo.
molle in ascender re, cioè la mutation si fa in uno & l'altro, D, & in
G, cioè in ascendere si deve dire re: ma la, in descendere: si fa in uno & l'altro, A & in D, cioè in descendere se deve dire la come in questo essemplo.
La definitione del  molle.
molle.
 el quale serve l'uno & l'altro
el quale serve l'uno & l'altro  fa
fa  mi
& E la mi: in el qual luogo cioè dove è segnato sempre si dice fa.
mi
& E la mi: in el qual luogo cioè dove è segnato sempre si dice fa.
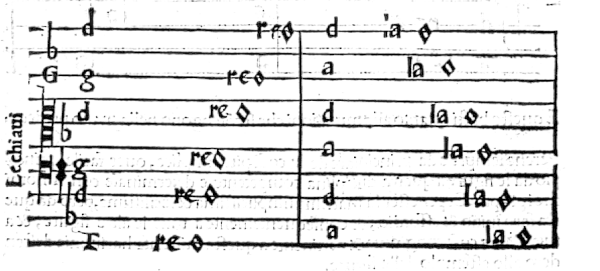
Le chiavi
La definitione di natura.
 molle, &
il
molle, &
il  quadro, perché l'è media tra l'un' & l'altro.
quadro, perché l'è media tra l'un' & l'altro. Quia omne medium de utroque
participat extremo.El luogo de le mutationi per  quadro.
quadro.
La definitione di  duro.
duro.
 duro è segno quadrato come questo
duro è segno quadrato come questo  el quale serve a tutti dui
el quale serve a tutti dui  fa
fa  mi, & transcende oltra el
mi, & transcende oltra el  molle l'intervallo de duoi diesis & uno comma,
in el quale devemo dire mi, nientedimeno in la medesima proportione possiamo dire anchora fa.
molle l'intervallo de duoi diesis & uno comma,
in el quale devemo dire mi, nientedimeno in la medesima proportione possiamo dire anchora fa.
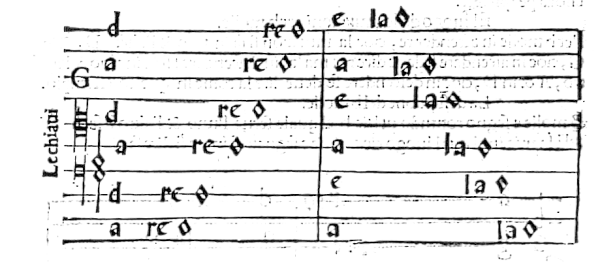
Le chiavi
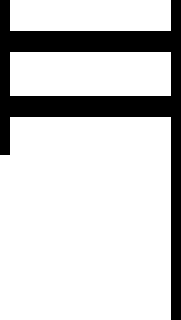
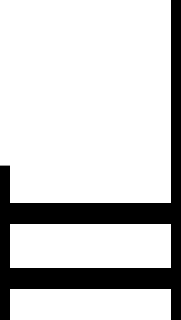 longa:
longa: 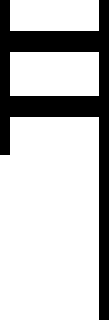
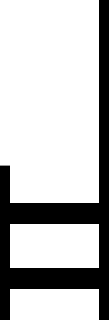 breve:
breve: 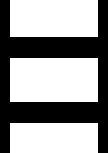 semibreve
semibreve 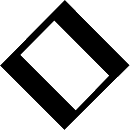 minima:
minima: 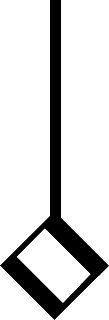
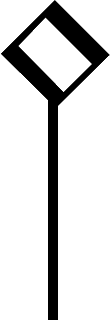 semiminima:
semiminima:
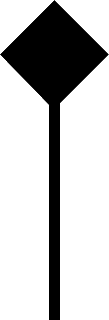 : croma:
: croma: 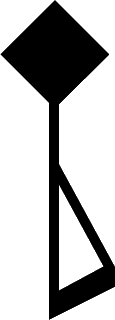
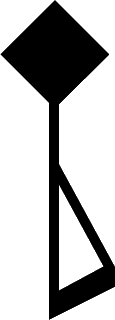 : semicroma,
: semicroma, 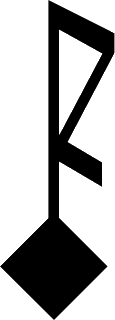
 Et notate che apresso li antiqui erano solamente quatro segni principali et cinque
essentiale figure, li segni erano maggior perfetto & imperfetto ut hic.
Et notate che apresso li antiqui erano solamente quatro segni principali et cinque
essentiale figure, li segni erano maggior perfetto & imperfetto ut hic.

 & minor perfetto &
imperfetto, ut hic:
& minor perfetto &
imperfetto, ut hic: 
 Le figure erano: Massima, lunga:
breve, semibreve, & minima. Ma
quando volevano celerar le figure nelli segni tagliavano tali segni, & similmente il negrizar de le minime celeravano le lor minime, & così la diuersità page 11del figurar di esse minime, o in duplo o in quadruplo &c. Sì che notate che
il tagliar de i segni non tolgono il nome a' segni, né la perfettione, né la imperfettione, né anchora l'alteratione, sì come le figure per il negrizar cioè
le minime non mutano il nome, ma solamente prestano celerità a esse figure, come appar in la pratica. Et però la nota minima non è divisibile in
tre equali parti, perché la saria agente e patiente, cioè che la si poria perficere & imperficere lo essemplo delle figure & pause spettante alli segni sopradetti.
Le figure erano: Massima, lunga:
breve, semibreve, & minima. Ma
quando volevano celerar le figure nelli segni tagliavano tali segni, & similmente il negrizar de le minime celeravano le lor minime, & così la diuersità page 11del figurar di esse minime, o in duplo o in quadruplo &c. Sì che notate che
il tagliar de i segni non tolgono il nome a' segni, né la perfettione, né la imperfettione, né anchora l'alteratione, sì come le figure per il negrizar cioè
le minime non mutano il nome, ma solamente prestano celerità a esse figure, come appar in la pratica. Et però la nota minima non è divisibile in
tre equali parti, perché la saria agente e patiente, cioè che la si poria perficere & imperficere lo essemplo delle figure & pause spettante alli segni sopradetti.
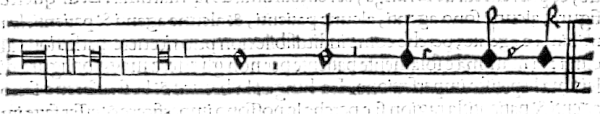
Delli Segni.
De la imperfettione delle figure.
Nam
similis a simili imperfici non potest, quia par in parem non habet imperium
né da una sua maggiore, né anchora dinanzi ad una sua simile: perché la
regola dice. Similis ante similem non potest imperfici: sì che si vorrete imperficere una figura perfetta posta dinanzi ad una sua simile la farete negra, & page 13allhora sarà imperfetta, perché ogni figura perfetta per la negrezza perde
la terza parte del suo valore. La figura perfetta si può imperficere da la sua
minore propinqua, over dal suo valore da la parte dinanzi non essendo posta però dinanzi a una sua simile & etiam da la parte di dietro, & questo che
vi ho detto disopra vi sia essemplo di ciascuna figura perfetta, & sapiate che
la similitudine de le figure se intende respetto de la forma, & non del colore,
& che se una breve perfetta, poniamo fosse inanzi une breve negra la si intenderia inanzi una sua simile per respetto de la forma. Nam forma, est que
dat esse rei. Sì che regolarmente ogni figura perfetta quando li seguita immediate la sua minore propinqua la perde la terza parte del suo valore. Et
se la breve perfetta vien posta dinanzi a due semibrevi ligate, over dinanzi
a due pause de semibrevi poste in una medesima riga sempre la resta perfetta per la virtù unita, ma se la ligatura e così le pause fussino disgiunte, cioè poste in due rige diventeria imperfetta, e'l simil farete de la massima inanzi la
ligatura de le lunghe, over de le sue pause, & similmente de la lunga avanti la ligatura de' brevi &c Et queste tali figure si possono imperficere sì dalla
parte dinanzi come di drieto, & advertite che mai si deve imperficere alcuna
figura perfetta, & così le sue parti perfette incluse in essa oltra la terza parte,
& allhora questa tal figura saria imperfetta: quo ad omnes partes eius, la ragione è acciò almeno la possi remanere in l'ultimo esser della imperfettione
cioè, se la è masssima, la resti in otto semibrevi imperfette, se lunga in quattro, & se breve in due.
De l'alteratione delle figure.

 due semibreve tra due brevi senza punto de divisione fra le ditte semibrevi, over cinque semibrevi tra due brevi per esser
la semibreve parte propinqua de la breve, la seconda over l'ultima altera.
due semibreve tra due brevi senza punto de divisione fra le ditte semibrevi, over cinque semibrevi tra due brevi per esser
la semibreve parte propinqua de la breve, la seconda over l'ultima altera.
Del punto in canto misurato.
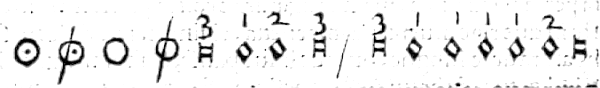
 over quando volemo imperficere una
figura perfetta quanto in sé, over quanto alle sue parti, cioè de una sola, over
più parti, over una parte perfetta, o più parti, incluse in una figura imperfetta. Et così se advertirete alla regola voi potrete formar essempli assai in tutte le figure perfette, la virtù di questo punto è grande, lui ha possanza di
escludere & includere, & redurre come facilmente potrete vedere & considerare. El punto di augmentatione si canta, & è quello che si pone appresso la figura imperfetta, & sempre l'augmenta la metà del suo valore. sì che vale la mità de la figura a chi l'è appresso posto. Dove se è appresso alla massima tale punto ha il valore di una longa, si appresso una lunga una breve,
si appresso una breve, una semibreve, & così per ordine procedendo.
over quando volemo imperficere una
figura perfetta quanto in sé, over quanto alle sue parti, cioè de una sola, over
più parti, over una parte perfetta, o più parti, incluse in una figura imperfetta. Et così se advertirete alla regola voi potrete formar essempli assai in tutte le figure perfette, la virtù di questo punto è grande, lui ha possanza di
escludere & includere, & redurre come facilmente potrete vedere & considerare. El punto di augmentatione si canta, & è quello che si pone appresso la figura imperfetta, & sempre l'augmenta la metà del suo valore. sì che vale la mità de la figura a chi l'è appresso posto. Dove se è appresso alla massima tale punto ha il valore di una longa, si appresso una lunga una breve,
si appresso una breve, una semibreve, & così per ordine procedendo.
Delle pause.
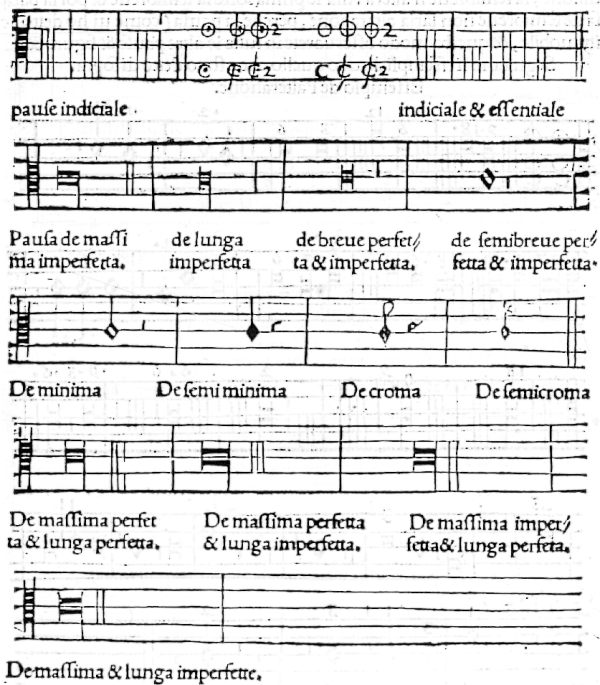
Lo essemplo de le pause.

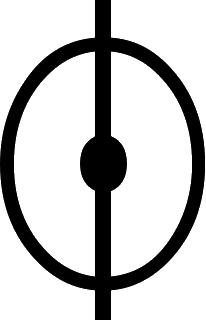

 sarà senza punto di divisione tra due pause de brevi, over
tra una breve, & una pausa di breve, sempre l'ultima semibreve altera, & similmente se fosse tra due brevi, over tra
esse pause, una pausa di semibreve, & poi una semibreve senza punto di divisione, la semibreve si altera. Ma se prima fosse la semibreve & poi la pausa de semibreve non saria alteratione, perché la pausa (come vi ho detto) è
immobile, & questo modo osservarete in tutte le altre pause & figure &c.
sarà senza punto di divisione tra due pause de brevi, over
tra una breve, & una pausa di breve, sempre l'ultima semibreve altera, & similmente se fosse tra due brevi, over tra
esse pause, una pausa di semibreve, & poi una semibreve senza punto di divisione, la semibreve si altera. Ma se prima fosse la semibreve & poi la pausa de semibreve non saria alteratione, perché la pausa (come vi ho detto) è
immobile, & questo modo osservarete in tutte le altre pause & figure &c.
De li accidenti i quali si segnano fra le notule in processu cantus dinotante la perfettione.
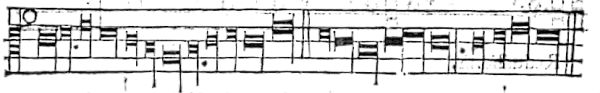
Modus maior & minor perfectus.
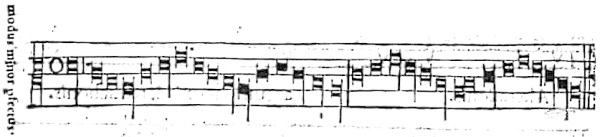
Accidentia quae denotant tam modum maiorem quam minorem perfectum.
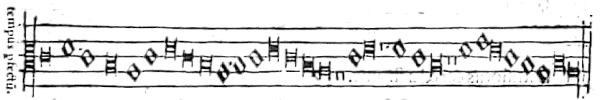
Accidentia quae denotant tempus perfectum.
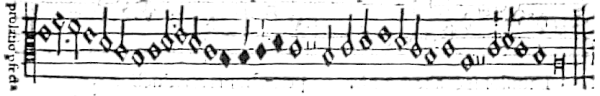
Accidentia quae denotant prolationem perfectam.
Del valore de le notule così perfette, come imperfette dimostrate per li segni, & per le pause.
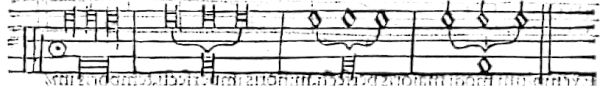
Exemplum utriusque modi, ac temporis perfecti, prolationisque perfectae.
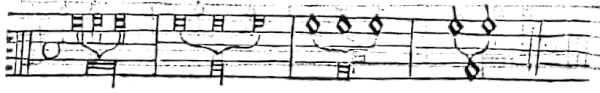
Exemplum utriusque modi, ac temporis perfecti prolationisque imperfectae.
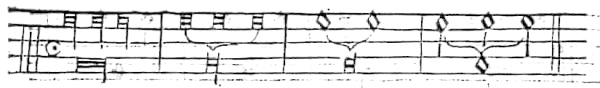
Exemplum utriusque modi perfecti, temporis imperfecti, prolationisque perfectae.
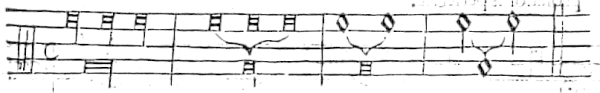
Exemplum utriusque modi perfecti, temporis imperfecti prolationisque imperfectae.

Exemplum modi maioris perfecti, minoris imperfecti temporis perfecti prolationisque perfectae
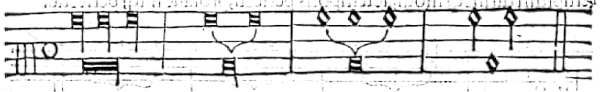
Exemplum modi maioris perfecti, minoris imperfecti, temporis perfecti, prolationisque imperfectae.

Exemplum modi maioris perfecti, minoris imperfecti, temporis imperfecti prolationis vero imperfectae.
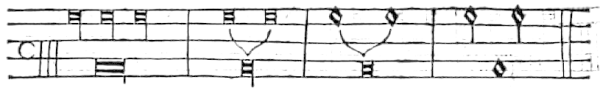
Exemplum modi maioris perfecti, minoris imperfecti, temporis ac prolationis imperfectae.
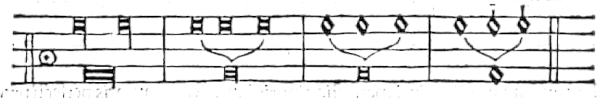
Exemplum modi maioris imperfecti, minoris perfecti, temporis ac prolationis perfectae.
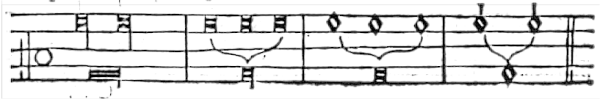
Exemplum modi maioris imperfecti, minoris perfecti, temporisque prolationis vero imperfectae.
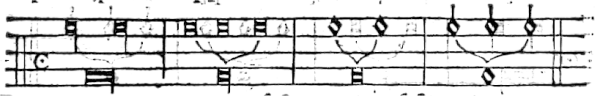
Exemplum modi maioris imperfecti, minoris perfecti, temporis imperfecti, prolationisque perfectae.
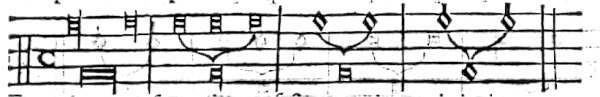
Exemplum modi maioris imperfecti, minoris perfecti, temporis ac prolationis imperfectae.
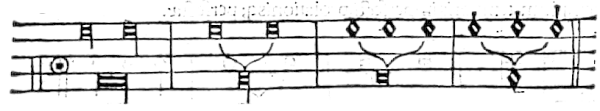
Exemplum utriusque modi imperfecti, temporis ac prolationis perfectae.
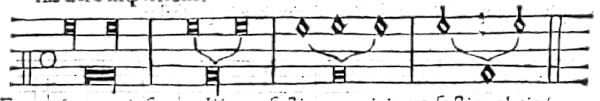
Exemplum utriusque modi imperfecti temporis imperfecti prolationis vero imperfectae.
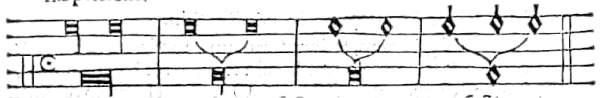
Exemplum utriusque modi imperfecti, temporis imperfecti, prolationis perfectae.
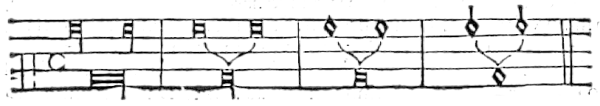
Exemplum utriusque modi imperfecti, ac temporis imperfecti, prolationis imperfectae.
Delli segni del tempo con prolatione.
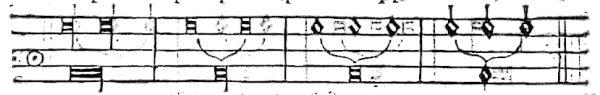
Exemplum temporis perfecti, prolationisque perfectae.
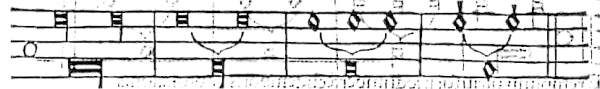
Exemplum temporis perfecti, prolationisque imperfectae.
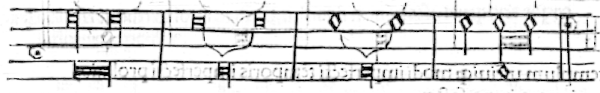
Exemplum temporis imperfecti, prolationisque perfectae.
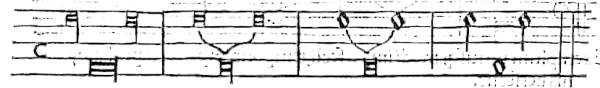
Exemplum temporis imperfecti, prolationisque imperfectae.
De li segni del modo con tempo secondo li antichi.
 3,
3,  3,
3,  2,
2,  2, el circolo & semicircolo dimostrano il modo. Ma la cifra 3, 2, dimostra il tempo,
per tanto dove sarà il circolo con la cifra ternaria ut hic,
2, el circolo & semicircolo dimostrano il modo. Ma la cifra 3, 2, dimostra il tempo,
per tanto dove sarà il circolo con la cifra ternaria ut hic,  3, ivi sarà il modo minore perfetto, & il tempo perfetto. Et dove sarà il semicircolo con la cifra ternaria come qui,
3, ivi sarà il modo minore perfetto, & il tempo perfetto. Et dove sarà il semicircolo con la cifra ternaria come qui,  3, ivi sarà el modo minore imperfetto, & il tempo
perfetto. Ma dove sarà il circolo con la cifra binaria ut hic,
3, ivi sarà el modo minore imperfetto, & il tempo
perfetto. Ma dove sarà il circolo con la cifra binaria ut hic,  2, ivi sarà il
modo minore perfetto, & il tempo imperfetto. Et dove sarà il semicircolo page 23con la cifra binaria come qui,
2, ivi sarà il
modo minore perfetto, & il tempo imperfetto. Et dove sarà il semicircolo page 23con la cifra binaria come qui,  2, ivi sarà il modo minore imperfecto, & il
tempo imperfetto come qui appar in questi essempli.
2, ivi sarà il modo minore imperfecto, & il
tempo imperfetto come qui appar in questi essempli.
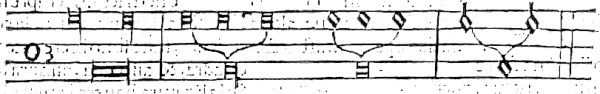
Exemplum modi minoris perfecti, ac temporis perfecti.
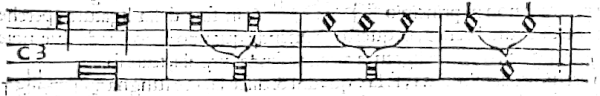
Exemplum modi minoris imperfecti, temporisque perfecti.
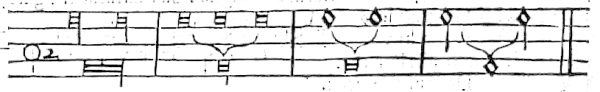
Exemplum modi minoris perfecti, ac temporis imperfecti.
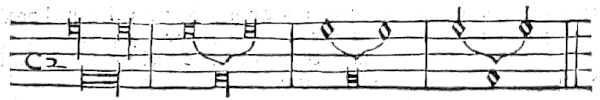
Exemplum modi minoris imperfecti, temporisque imperfecti.
Delle ligature delle notule del canto figurato.
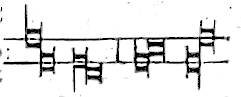 Ma sia ascendente over discendente, & habbia la virgola, over coda dalla parte sinistra ascendente sempre la prima & la seconda sono page 24semibrevi, & l'altre brevi, salvo l'ultima
se la è quadra & discenda, è lunga ut hic.
Ma sia ascendente over discendente, & habbia la virgola, over coda dalla parte sinistra ascendente sempre la prima & la seconda sono page 24semibrevi, & l'altre brevi, salvo l'ultima
se la è quadra & discenda, è lunga ut hic. 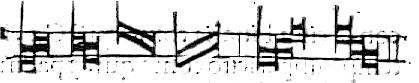 Et se queste due ligature ut hic.
Et se queste due ligature ut hic. 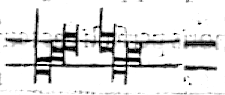 & altre simili se faranno sotto el segno di perfettione dove la breve sia perfetta come in questi segni
& altre simili se faranno sotto el segno di perfettione dove la breve sia perfetta come in questi segni 
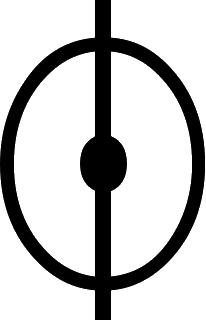

 . sempre la
seconda semibreve altera. Ma se la ligatura haverà la coda dalla parte sinistra discendente, tutte sono brevi, eccetto l'ultima se la è quadra, & discenda, allhora la
è lunga, ut hic.
. sempre la
seconda semibreve altera. Ma se la ligatura haverà la coda dalla parte sinistra discendente, tutte sono brevi, eccetto l'ultima se la è quadra, & discenda, allhora la
è lunga, ut hic. 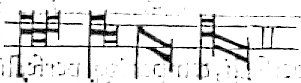 Se la ligatura haverà la virgola
dalla parte destra, o ascendente, over discendente, tutte sono lunghe, ut hic.
Se la ligatura haverà la virgola
dalla parte destra, o ascendente, over discendente, tutte sono lunghe, ut hic. 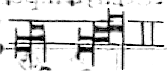 Et notate che la lunga non se deve poner se non in principio & in fine della ligatura, perché
Et notate che la lunga non se deve poner se non in principio & in fine della ligatura, perché
omnes mediae sunt breves, & questo se intende quando sono più de due note
insiemi ligate. Ma se la ligatura ascende senza virgola, tutte sono brevi, eccetto l'ultima, se la è quadra & discenda, la è lungha 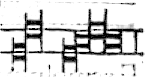 se la discenderà senza coda, o sia la prima quadra, over obliqua semper la prima è lungha, tutte le altre sono brevi, salvo l'ultima se la
è quadra, & discenda, perché allhora la è lungha. La massima in ligatura se cognosce per la grandezza della sua forma, ut hic.
se la discenderà senza coda, o sia la prima quadra, over obliqua semper la prima è lungha, tutte le altre sono brevi, salvo l'ultima se la
è quadra, & discenda, perché allhora la è lungha. La massima in ligatura se cognosce per la grandezza della sua forma, ut hic. 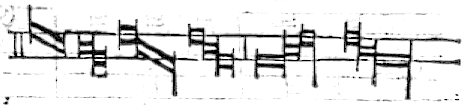 Et questo basti quanto alle ligature.
Et questo basti quanto alle ligature.
Delle proportioni.
- dui a dui 2/2
- tre a tre 3/3
- duo ad uno 2/1
- tre a due 3/2
- cinque a duo 5/2 &
- otto a tre 8/3
- dupla. 2/1 4/2
- se tre volte tripla 3/1 6/2
- se quattro volte quadrupla 4/1
- se cinque volte quintupla 5/1
- si sei volte sestupla 6/1 12/2
- si sette volte settupla 7/1
- si otto ottupla 8/1
- si nove volte nonupla. 9/1
- si dieci volte decupla, 10/1 20/2
- due volte subdupla 1/2
- si tre volte subtripla. 1/3
- sesqualtera, over emiolia, quod idem est 3/2 6/4
- se una volta ella terza parte sesquitertia. 4/3 8/6
- se una volta ella quarta parte sesquiquarta. 5/4
- se una volta e, una quinta parte sesquiquinta. 6/5
- se una volta e una sesta parte sesquisesta. 7/6
- se una parte e una settima sesquisettima. 8/7
- se una parte e una ottava sesquiottava. 9/8
- una volta e la mità sarà subsesqualtera 2/3
- se una volta e la terza parte subsesquitertia 3/4
- superbipartiens tertias 5/3 10/6
- ma se una volta e tre parti sarà supertripartiens quartas come 7/4
- se una volta e quattro parti superquadripartiens quintas 9/5
- dupla sesqualtera 5/2 10/4
- se due volte e la terza parte dupla sesquitertia 7/3
- se due volte e la quarta dupla sesquiquarta 9/4
- tripla sesquialtera 7/2 14/4
- se tre volte e la terza parte tripla sesquitertia 10/3
- ma se quattro volte e la mità quadrupla sesqualtera come qui 9/2
- se quattro volte e la terza parte quadrupla sesquitertia 13/7
- tripla superbipartiens tertias 11/3
- se quattro volte, & due parti quadrupla superbipartiens tertias. 14/3
Frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora .i. che in van si fa per più
quello, che si può far commanco, ma essendo così che la sesqualtera quel
medesimo effetto, & quella medesima possanza sortir possa, come consequisce essa emiolia, adunque inane & vana è la dispositione de la emiolia, overo la plenitudine de le notule equivalente alla habitudine della sesqualtera.
Respondo, che non senza causa li musici hanno instituita & ordinata questa
plenitudine di notule equipollente alla sesqualtera, (anzi diversi effetti conseguisce) & primo che sempre (como ho provato) presuppone perfettione.
Secondo, acciò che le parole disposte alli moduli alternatamente secondo li loro affetti correspondano, perché come appresso gli oratori tre generi, cioè tre
sorti & qualitati di dire se considerano, cioè dimostrativa, deliberativa, & giudiciale, & questo per la exigentia di diversi negotii, & di diverse facende, cose, & operationi, così appresso li musici, otto modi si considerano. per il che
poco conto far si deve di quelli compositori li quali ignorano li effetti de' mopage 29di, & de' signi & de le proportioni. Questo che è detto fin qui basterà quanto alla cognitione delle proportioni, & alla ragione, & uso di quelle.
Seguita il contrapunto.
 fa
fa  mi del settimo, & ottavo in C sol fa
ut. posto però il segno del
mi del settimo, & ottavo in C sol fa
ut. posto però il segno del  rotundo, over molle in
rotundo, over molle in  fa
fa  mi. Et questi tali tuoni sono detti irregolari, perché finiscono in altro luoco che nel suo
proprio, & determinato. Ma ciascun tuono può terminare & finire
mi. Et questi tali tuoni sono detti irregolari, perché finiscono in altro luoco che nel suo
proprio, & determinato. Ma ciascun tuono può terminare & finire in quolibet loco manus, ubi species propriae reperiri possunt. Et ciascuno de' predetti tuoni può esser perfetto, diminuto, superfluo: misto, commisto: regolare, & irregolare. I tuoni autentici perfetti sono quegli che ascendono in
fino al diapason, cioè una ottava sopra il suo regolar fine, & se ascendono
più si dimandano superflui, & se manco diminuti. I tuoni plagali perfetti
sono quegli che discendono una quarta sotto il suo regolare fine, & se discendono più si dimandano superflui, & se manco si dimandano diminuti. Ma page 30i tuoni misti veramente sono quegli che participano del ascendere, & discendere del suo socio come è il primo con il secondo, il terzo con il quarto. I tuoni
commisti sono quegli che participano del ascendere & discendere, & anchor
mediatione con altro tuono che non sia suo compagno com'è il primo, con
il terzo &c. I tuoni regolari sono quegli che finiscono ne' luoghi suoi proprii
& determinati. I tuoni irregolari sono quegli che finiscono in altro luoco
che nel suo loco proprio. Anchora notate circa la compositione de' predetti
tuoni che il primo & il secondo tuono si compongono della prima specie del
diapente, cioè, re la, & della prima specie del diatessaron, cioè, re sol, el diatessaron nel primo tuono è disopra del diapente, nel secondo è disotto. Il terzo & quarto tuono si compongono della seconda specie del diapente, cioè,
mi mi, & della seconda del diatessaron mi la, el diatessaron nel terzo tuono
è disopra del diapente, nel quarto è disotto. Il quinto & sesto tuono si compongono della terza specie del diapente, cioè fa fa. & della terza del diatessaron, ut fa, el diatessaron nel quinto tuono è disopra del diapente, nel sesto
è disotto. Il settimo & ottavo tuono si compongono della quarta specie del
diapente, cioè ut sol, & de la prima specie del diatessaron re sol, el diatessaron nel settimo tuono è disopra del diapente, nel ottavo è disotto. Tutti i tuoni plagali hanno medesimi diapente, & diatessaron come i suoi autentici, ma
sono differenti in questo, che gli autentici hanno il diatessaron sopra il diapente, & i plagali disotto, come appar qui in questo essemplo.
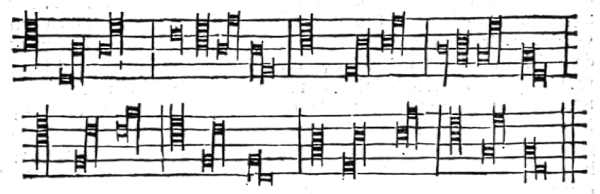
De' principii & distintioni de' tuoni.
 mi, acuti, & in C sol fa ut, & similmente le sue distintioni.
mi, acuti, & in C sol fa ut, & similmente le sue distintioni.
 mi
acuti, in C sol fa ut, & in D la sol re: similmente le sue distintioni.
mi
acuti, in C sol fa ut, & in D la sol re: similmente le sue distintioni.
Della intonatione, & mediatione de' psalmi di ciascun tuono.
 fa
fa  mi per
mi per  molle, con
queste sillabe fa mi re mi.
molle, con
queste sillabe fa mi re mi.
 fa
fa  mi, per
mi, per  molle, con queste
sillabe, fa mi, re mi.
molle, con queste
sillabe, fa mi, re mi.
Primus cum sexto fa sol la semper habeto
Tertius & octavus, ut re fa, sicque secundus,
la sol la, quartus, fa la re fa, sit
tibi quintus.
Septimus fa mi fa sol sic omnes esse recordor.
Hora per le mediationi saranno questi.
Septimus & sextus, dant fa mi re mi quoque primus.
Quintus & octavus, dant
fa sol fa sicque secundus.
Sol fa mi fa Ternus, ut re mi re dat tibi quartus.
Delle consonantie.
De la prima regola da esser osservata in la composition del contrapunto.
Seguita un'altra regola del contrapunto ad videndum.
 ,
,  ,
,  ,
,  , non puote sottogiacere a dissonantia alcuna. Ma sì ben le minime, & altre minori, la ragione è per la tardità, per la quale la dissonantia
ne offenderia, nel segno per medium sì ben. Et nel segno duplex per medium una breve. Et in el segno triplex una lunga imperfecta. Et notate per
fallentia di questa regola, che una dissonantia puole stare in principio di tempo, over misura, in sincopa perhò. Et questo perché la nota, over voce percuote l'altra nel durare che fa la voce da un moto a l'altro, El quale durare
è dal senso de l'audito compreso, come taciturnità, over sospensione di voce
la quale taciturnità è stata scritta dal mio don Franchino Gaffurio, d'ogni
dottrina scientissimo, nel tratato suo de harmonia instrumentorum nel capi .ii. del primo libro, & quale così dice,
, non puote sottogiacere a dissonantia alcuna. Ma sì ben le minime, & altre minori, la ragione è per la tardità, per la quale la dissonantia
ne offenderia, nel segno per medium sì ben. Et nel segno duplex per medium una breve. Et in el segno triplex una lunga imperfecta. Et notate per
fallentia di questa regola, che una dissonantia puole stare in principio di tempo, over misura, in sincopa perhò. Et questo perché la nota, over voce percuote l'altra nel durare che fa la voce da un moto a l'altro, El quale durare
è dal senso de l'audito compreso, come taciturnità, over sospensione di voce
la quale taciturnità è stata scritta dal mio don Franchino Gaffurio, d'ogni
dottrina scientissimo, nel tratato suo de harmonia instrumentorum nel capi .ii. del primo libro, & quale così dice, in medio enim percussionum, quae
per sonos fiunt, quaedam eveniunt taciturnitates, quibus soni ab invicem discernuntur. Et notate che quante volte voi vorrete sincopare per tertie, & seconde, & poi venire a l'unisono, over schivarlo, cioè fingendo voler andare,
farete che'l soprano principia per terza con il tenore con figure simili. Ma fate
che'l tenore faccia una pausa di minima in integra misura. Et in la non integra voi anchora el potete usare & la penultima sia minima del tenore & alhora il tenore, cioè el canto fermo sarà mobile, & figurato per la diuersità de
la figuratione delle figure. Et questo modo di sincopare operiamo discendendo tutte due le parti. Et così anchora ascendendo si forma la sincopa per sesta
& settima, ma la pausa, over suspiro (come i volgari la chiamano) tocca al page 37soprano al contrario della sincopa per terza, & seconda causante, & la penultima del soprano sarà minima, che batterà sesta con il tenore, & l'ultima darà
ottava, volendo andare a la cadentia propria, Et se qualche volta la vorrete
schivare, vi con qual parte vi parrerà più a proposito vostro, perché (come
vi ho detto) la perfettione si causa per la varietà. & notate, che se il canto fermo
ascendesse, over discendesse per quinta, & voi fussi in quinta col soprano,
cioè col tenore su la penultima nota, non ascenderete mai con diminutione,
poniamo di semiminime, né anchora discenderete per trovarvi su la seconda in quinta, perché le sariano due quinte, & non vale a dire la seconda semiminima è quarta, la terza è terza, & la quarta è seconda, & questo è per la celerità di moti, sì che l'è tanto, quanto se voi dicessi ut sol, ut sol, a dir ut sol, ut re
mi fa sol, over dire sol ut, sol fa mi re ut, & similmente advertirete in le altre
specie perfette. Anchora notate che se noi ne ritroviamo col canto fermo in ottava con il soprano, poniamo, che'l canto fermo sia in A la mi re acuto, & descenda
in G sol re ut acuto, dicendo re ut. Il soprano principia per ottava in A la mi re Et
dice per una minima, & due seminime, & poi una semibreve la sol fa sol. La minima è ottava, la prima semiminima settima, & la seconda sesta. Et poi la semibreve ottava, ch'è in G sol re ut sopracuto. Io vi dico, che per la celerità de' moti
li quali se causano in quelle semiminime, voi non dovete usarle, perché le pareriano due ottave. Sì che per queste regole sappiate usare le specie, sì perfette, come imperfette. Et quando voi vorrete andare a la cadentia perfetta sempre la penultima de' essere dissonantia in sincopa con la penultima la quale
de' essere specie imperfetta, come vi ho diachiarato in le regole soprascritte. Sì
che volendo pervenire a la cadentia de la ottava, fate che l'antepenultima sia
settima sincopa, & la penultima sesta. Intendete perhò col canto fermo, over
tenore, & tal sesta bisogna sia maggiore, perché la sesta minore non è atta a la
acuità, ma ben a la gravità. Et perhò assumate una regola generale che ogni
volta, che voi anderete ad una specie imperfetta, & poi vorrete ascendere ad
una maggiore specie d'essa, così perfetta, come imperfetta, se quella specie è
minore, fatela maggiore con il segno de la sustentatione, la quale sustentatione si dimostra con questo segno.  La ragione è, perché ogni specie
imperfetta (come ho dimostrato) est duplex, cioè maggiore, & minore, la
maggiore ha più de la minore uno apotome, cioè uno semituono maggiore. Sì che la sesta maggiore piglia più del continuo di quello, che fa la minore.
Et per consequente la è più acuta, & adunque più atta alla acuità. Et la minore
non così per assumere manco del continuo, la è meno acuta, & per consequenpage 38te più atta alla gravità. Et questa regola è generale a tutte le specie imperfette. se vorrete finire, overo far cadentia per quinta, farete l'antepenultima quarta in sincopa, & la penultima tertia. Ma se vorrete finire, over far cadentia per
unisono, farete l'antepenultima seconda in sincopa, & la penultima terza. Et
poi anchora potrete con la parte del soprano sincopare per quinta, & sesta
ascendendo.
La ragione è, perché ogni specie
imperfetta (come ho dimostrato) est duplex, cioè maggiore, & minore, la
maggiore ha più de la minore uno apotome, cioè uno semituono maggiore. Sì che la sesta maggiore piglia più del continuo di quello, che fa la minore.
Et per consequente la è più acuta, & adunque più atta alla acuità. Et la minore
non così per assumere manco del continuo, la è meno acuta, & per consequenpage 38te più atta alla gravità. Et questa regola è generale a tutte le specie imperfette. se vorrete finire, overo far cadentia per quinta, farete l'antepenultima quarta in sincopa, & la penultima tertia. Ma se vorrete finire, over far cadentia per
unisono, farete l'antepenultima seconda in sincopa, & la penultima terza. Et
poi anchora potrete con la parte del soprano sincopare per quinta, & sesta
ascendendo.Regola di comporre a tre voci.
Regola di comporre a quattro voci.
Modo, & osservatione di comporre qualunche concento.
distinctio est temporis, & sensus finitio. Subdistinctio est nec temporis, nec sensus finitio. Mora est requiem animi. Inter
distinctionem, & subdistinctionem, & moram, hoc interest, quod distinctio
perfectum sensum declarat, subdistinctio inferri aliquid significat. Mora reficit lectorem simulque sensibus lumen accommodat. Oltra questo sforzatevi di far il concento vostro che sia allegro, suave, pieno d'armonia, dolce,
risonante, grave, & facile nel cantare, cioè di consonantie usitate, come sono tertie, quarte, quinte, seste, & ottave. Ma schivatevi di porre nelle vostre
compositioni il tritono, il diapente diminuto, & il diapason superfluo, così ascendenti, come discendenti, per essere intervali distonati, & difficili
a pronuntiarli, non si debbono porre ne' concenti. Et così la settima, la nona, & la undecima, ob earum difficultatem raro accedunt in usum musicum.
Similmente non fate che'l contrabasso del vostro concento sia incommodo,
cioè che non continuano in profundum. Et avertite di non far barbarismi
nel comporre le notule sopra le parole, cioè non ponete lo accento lungo
sopra le sillabe brevi, over l'accento breve sopra le sillabe lunghe. quia est
contra regulam artis grammatice. senza la quale niuno può esser buono
musico, la quale insegna pronunciare & scrivere drittamente. Schivatevi
adunque dal barbarismo, il quale secondo Isidoro è enunciatione di parole corrota la lettera, over il suono, pertanto: osserverete li accenti grammatici, i quali hanno quantità temporale, cioè tempo lungo & breve. Benché page 41sono pochi compositori, che osservano li accenti grammatici nel comporre
le notule sopra le parole (de indoctis loquor). L'accento è certa legge, & regola
a alzare, & abassare la sillaba di ciascuna particella di oratione, & debbesi fare
causalmente nella lettera, initialmente nella sillaba, & ditionalmente nella ditione, & particolarmente nella oratione. Accento si dice quasi a' canti, cioè secondo
il canto, perché si fa conoscere le sillabe nella cantilena della voce. I greci lo
dicono prosodia, da' latini anchora si chiama tuono & tenore, perché quivi il
suono cresce & finisce. I tenori delli accenti sono tre, acuto, grave, & circunflesso. Acuto accento è detto perché acuisce & eleva la sillaba. Grave perché deprime & depone perché è contrario allo acuto il circunflesso, perché è composto dallo acuto & del grave, perché cominciando dallo acuto finisce, nel grave, & così
mentre che saglie & discende si fa circunflesso. Et lo acuto & il circunflesso sono simili, perché l'uno & l'altro inalza la sillaba. Il grave appare contrario ambeduoi, perché sempre deprime le sillabe elevandole quegli. Le figure degli accenti (le quali da' grammatici si pingino per le distintioni de parole) sono tre, cioè
acuto, grave, & circunflesso. Accento acuto è linea tendente dalla sinistra nella destra allo in sù a questo modo ´ grave è linea tendente dalla destra nella
sinistra allo ingiù in questo modo ` Il circunflesso si compone di ambeduoi
in questo modo ^ Lo accento acuto si pone sopra l'ultima, penultima, & antepenultima sillaba. Grave si pone solamente sopra la ultima, & di raro usano questi i latini. Circunflesso si pone sopra la ultima, & sopra la penultima
si trova appresso Vergilio nel sesto. Li accenti sono stati trovati o per la distintione, o per la pronunciatione, o per causa di discernere la ambiguità. Circa gli accenti nel verso vulgare sono tre modi. Primo, quando cade nella sillaba antepenultima, quale rende il suono sdruccioloso, quando cade poi sopra l'ultima sillaba, rende il suono grave, & quando cade sopra la penultima,
rende il suono temperato, se caderà lo accento sopra l'ultima in fine del verso, & che sia d'una sillaba, si può numerare per due sillabe, che verria il verso
essere di dieci sillabe, il che molto si usa. Alla formation del verso necessariamente richiede, che gli accenti caggino sopra la quarta, o sesta, o decima sillaba,
perché ogni volta che in altro luoco cadesse, non saria più verso, & che sotto
uno accento non stano più che tre sillabe, & non si pongono gli accenti se non sopra
le sillabe lunghe. Notate ultimamente questa regola, che tutti i versi vulgari di
sette sillabe sempre la penultima si tiene, & in tutti quegli di otto la terza, & la
penultima. Et in tutti quegli de undeci la sesta & la penultima, & qualche
volta la quarta, ma rare volte accade. Ma quando accadesse tenere la quarta, page 42non torrete la sesta, ma la quarta, & la penultima. E' necessario, che'l compositore habbia cognitione del metro, o verso, saper che cosa è piede, & quante
sillabe può havere, & la qualità di quelle, cioè quali sono lunghe, & quali sono brevi, & saper scandere il verso, & dove si fa la cesura, & la collisione. Et similmente sapere, dove cade la comma, & il cola nel periodo, sì nel verso come
nella prosa. BEDA comma genus distinctionis, quando post duos, vel tres
pedes superest syllaba, quae partem terminet orationis quando vero post duos
vel tres pedes nihil remanet, colum dicitur, quae tamen nomina apud oratores indifferenter ponuntur, qui integram sententiam periodon appellant.
Partem autem cola, & commata dicuntur, ut puta apud apostolum, sustinetis
enim, si quis vos in servitutem redigit, colum est, si quis devorat, colum est,
si quis accipit, colum est, si quis extollitur, & caetera usque ad plenam sententiam,
cola sunt, & commata. Plena autem sententia periodus est. Interpretatur autem
colum membrum, comma incisio, periodus clausula, sive circuitus. DONATUS
tres sunt positurae, vel distinctiones, quas thesis graeci vocant distinctio,
subdistinctio, media distinctio. Distinctio est, ubi finitur plena sententia, huius punctum ad summam litteram ponimus. Subdistinctio est, ubi non multum
superest de sententia, quod tamen necessario separatim mox inferendum sit.
Huius punctum ad imam littera ponimus. Media distinctio est, ubi fere tantum de sententia superest, quantum iam diximus, quum tamen respirandum est.
Huius punctum ad mediam litteram ponimus. In lectione tota sententia periodus dicitur, cuius partes sunt cola, & commata. Il piede nel verso è elevatione, & positione di due, o tre, o più sillabe compresa dallo spatio, over piede è
compositione di sillabe con certa osservatione di tempi ricevente la levatione, & la positione, le quali si dicano in greco arsis, & thesis, perché di una sillaba, anchora che fusse lunga, non si può fare il piede, perché si fa di due repercosse, non con dui tempi. Perché bisogna ferire due volte anchora due brevi. La cesura nel metro è una decora terminatione di voce notata nel mezo
de versi. La scansione è legitima distintione, e dimensione del metro in ciascuno piede. La collisione, che in greco si dice synalephe & eclipsis, si fa quando
finisce alcuna dittione in vocale, over in m littera, & la sequente comincia anchora da vocale, perché all'hora la prima vocale, over m con la sua vocale
si esclude. Fassi anchora nel fine del verso, quando finendo in vocale, o in m
littera suprabonda la sillaba, & il sequente verso comincia dalle vocali. Il metro è una certa connessione, & ordinatione di piedi trovata alla delettatione
de gli orechi. Medesimamente il metro è una struttura, & copulatione di vopage 43ci finita con numero, & modo, & è il medesimo, che il verso. Il quale per questo si dice così, che tanto lungamente si debba voltare in fino a che rettamente si constituisca. Metro in greco in latino si dice dimensione, perché misuriamo il verso con certi piedi. I piedi con tempi, & è differente dal rhythmo, il quale Fabio vuole che sia numero, che il metro ha certo, & finito spacio, il rhythmo né ha fine certo, né alcuna varietà nel contesto. ma perché cominciò per
la levatione, & positione scorre in fine al fine. Ma BEDA interpreta il rythmo una modulata compositione, esaminata non per metrica ragione, ma per
numero de sillabe a' giudicio de gli orecchi, come sono versi di poeti vulgari, & appare il rhythmo essere simile a' metri, & certamente per sé senza metro
non può esser, perché metro è ragione con modulatione, rhythmo modulatione senza ragione. Nondimeno el più delle volte per certo caso troverrai
anchora la ragione nel rhythmo non servata per la moderatione dello artificio, ma per suono, & essa modulatione conducente, il quale i vulgari poeti
di necessità rusticamente, dotti fanno dottamente. Ma i greci affermano il
rhythmo essere composto di arsis & thesis, & di tempo. Il che alcuni chiamavano vacuo. Aristoxeno disse, questo essere tempo diviso in ciascuno di questi che numerosamente si possono comporre. Ma secondo Nicomaco rhythmo è una ordinata compositione di tempi. Medesimamente rhythmo vulgare è uno certo genere di dettare. Dettare niente altro è, che una congrua & ordinata, o decora loquutione di qualunche cosa. Ma della struttura, o dissimile contesto non appartiene a noi definire regole o canoni a tutte le cose perché lasciamo ad essi poeti le lor cose proprie.
in Vinegia del Mese di Maggio Ne l'anno M. D. XXXX.