Title: Sopplimenti musicali
Author: Gioseffo Zarlino
Publication: Francesco de' Franceschi (Venezia, 1588)
Principal editor: Frans Wiering
Funder: Utrecht University Netherlands Organization for Scientific Research (NWO)
Edition: June 2000
Department of Information and Computing Sciences Utrecht University P.O. Box 80.089 3508 TB Utrecht Netherlandsκαὶ μὴ διδόντος οὐδὲν ἰσχύει πόνος.
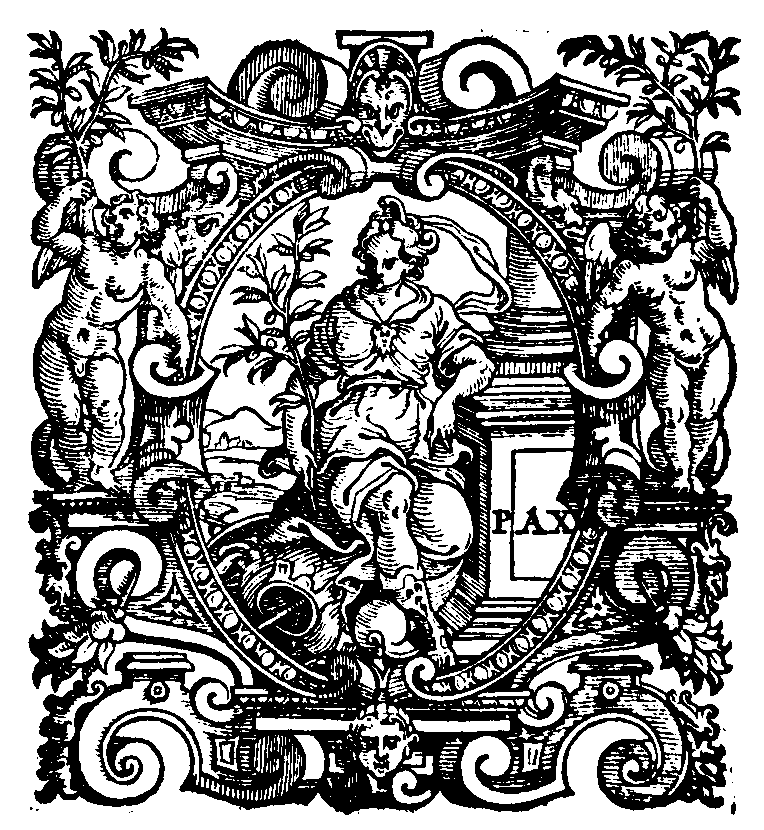
AL SANTISSIMO ET BEATISSIMO NOSTRO SIG. PAPA SISTO QVINTO TERMASSIMO PONTEFICE. Gioseffo Zarlino da Chioggia prega lunga vita, & FELICITA'.
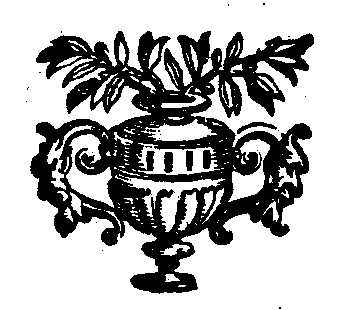
Pasce oues meas,& la terza disse:
Pasce agnos meos;le sono Coagiutori. La seconda ragione è il Secondo grado, De transla. episc. c. Quanto. Iohan. 27. De crim. fal. minori c. Quam graui. che ella tiene per la Giustitia incontaminata di Padre uniuersale, Massimo difensore, & solecito uendicatore contra l'Ingiusto; purga le nebbie delle Heretiche prauità, che si contrapongono al lume dello Spirito santo. Benefattore de buoni; Consolatore de' oppressi; Premiatore di quelli, che uirtuosamente si hanno affaticato, & si affaticano. La terza ragione è il terzo Grado, che in molte cose si distende; prima nella Massima cura dimostrata in molti modi del Culto diuino, donando à i popoli Christiani molte, & opportune fiate, doni spirituali, & l'altre cose ben à tutti manifeste: nella Massima Charità in erigere Statue, & Sepolchri à Pontefici infinitamente benemeriti di santa Chiesa, cosi nella Liberalità uerso la patria, uerso gli amici, & suoi benemeriti; & nella Magnanimità accompagnata della Massima solecitudine intorno le cose, che fanno al commodo, all'ornamento, & al decoro della Città di CHRISTO, Capo de tutto il Mondo. Il che dimostrano i Superbi edificii, & quel superbo Acquedotto dell'acqua Felice, & quel che più Imperatori à malapena con lungo tempo condussero à fine, ella in poco spatio habbia felicemente perfetto, & habbia arricchito la Città di nobilissimo luoco; hauendolo renduto habitabile col corso di tanto restoro. Et le Piramidi, & Obelischi de gli altri Imperatori, che non attentarono di toccare ad erigere, ò con infinite difficoltà l'eressero, & dedicorono per loro immortali honori V. Santità arditamente, & francamente hà eretto, & in esse essaltata la Santissima Croce; accioche sopra le pompe, & li trionfi de' persecu page v tori di CHRISTO, trionfasse, nel cospetto della Città come nel mezo della terra in Gierusalemme; Psal. 73. essendo in essa operata la nostra Salute, fu anco essaltata. Comparono etiandio hora le principali Chiese in capo à strade sontuose, ordinate dalla sua molta prouidenza, & liberalità, che inuitano il popolo à più frequenti uisite, & deuotioni; & con tutto questo non resta di esserer riccho l'Erario, quanto mai sia stato in alcun tempo, per il nuouo apparecchio contra gli Inimici di Santa Chiesa, iquali già uedendolo carico, cosi hanno à sgomentare, come la catholica Greggia à inanimirsi, & soleuar le speranze à trionfi à hinni, & canti; doue non sarà disdiceuole, che ui concorri anco per apparecchio le cose musicali. Ilperche hora hò preso ardire di consacrarle la presente Opera, nellaquale ella conoscerà da i nuoui concetti esplicati, & dalle Dimostrationi, fatte, & anco da molte altre cose ridotte dall'altre Scienze al seruitio della Musica; non da altri per quanto fin hora hò potuto sapere; state trattate, quanto tornerà à proposito per incitare ogn'uno ad intonare à Dio nuoui canti. La qual Scienza le sarà tanto più cara, quanto che ella sia Legge del Reggimento del Cielo, della Terra, girandosi però i Cieli con inesplicabili Ragioni, & con impari mouimenti, & Interualli diuersi: Iob. 38. di modo che quasi temperando il Suono acuto co 'l graue fanno un tanto mirabile concento nelle cose di Natura, che humana forza non è atta à farlo cessare. Alla cui sembianza il Principe etiandio tempera la Republica, che fa fare un come scambieuole Concerto trà gli infimi, & minimi, & tra i grandi, & massimi di essa; di modo che l'un dall'altro non discordano. La onde V. Santità si è mostrata nell'Accordare, & Accommodare con prestezza le cose disordinate di questa Santa Republica Christiana con Harmonia, à guisa d'un buono, & Eccellente Musico, che udendo in un Concerto il Canto & l'Harmonia esser disordinata, con molta prestezza ui remedia, riducendola nel primiero stato; Essendoche non cosi tosto ella le hà posto le mani, ch'hà ridotto con gran stupor d'ogn'uno le cose in tale concordia, & temperamento, che rimarranno in cotale accordo tanto che 'l Mondo per lungo tempo ne hauerà da godere, ricordarsi d'un tale non picciolo beneficio riceuuto. Par anco che l'istessa Giustitia sia tale; da quello che uuole quel Giustissimo & Santissimo Dottore di Santa Chiesa Ambrosio, tanto rispettato per la Santità della sua uita, per la mirabile sua dottrina da Teodosio Imperatore con tutto che gli hauesse interdetto l'entrar nella Chiesa, per hauer fatto tagliar à pezzi quelli di Tessalonica; Hist. Trip. lib. 9. cap. 30. lib. 2. cap. 10. percioche scriuendo à buon proposito di questa Virtù, la predica esser tale, che come da un limpidissimo, & abondantissimo Fonte, habbiano origine; & anco siano da lei illuminate, & moderate l'altre Virtù: onde la nomina VIRTV COMMVNE. De Abraham Patriarca. Perciò page vi che senza lei la Prudenza nuoce, 2. lib. c. 1. comment. super Lucam. & la Fortezza se non è da lei temperata, è fatta intolerabile Insolenza, & più tosto s'accosta al Furore, che alla Ragione; auicinandosi più al Dominio, che al Viuer libero, col diuenire più presto Tirannia, che altra cosa buona. Ma lasciando di dire dell'altre Virtù dirò solamente (secondo che dice questo Huomo Santissimo De Abraham patri. lib. 2. cap. 10. ) che la Giustitia è quella, che le abbraccia tutte; & non può star lontana della Prudenza; non essendo di questa, il Voler saper quello, che sia Giusto, ò Ingiusto; officio mediocre: massimamente perche la Giustitia uuole, & commanda, che Honestamente si uiua;1. ff. Vlpianus De Iust. & Iure. 10. che Non si offenda alcuno; che A' ciascuno sia dato quello, che gli peruiene. Laonde ne segue, che ella contenga Due parti; nella Prima delle quali è posta la difesa del Giusto, & nella seconda il Castigio del Reo. Ma in porle in essecutione, appartiene ad un Ottimo Principe, ilquale fà due cose molto lodeuoli, & utili; Vsa prima la Misericordia, & la Pietà uerso l'offeso, & dopoi la Giustitia, & la Merita punitione contra quello che offende; perciò che non può stare la Misericordia (come dice il Santo Dottore De obitu Theodosij Imperatoris. ) senza la Giustitia, nè la Giustitia senza la Misericordia; Ne per questo l'una impedisce l'altra, ne fà, che castigandosi giustamente il Reo, quell'atto sia Crudeltà, come forse alcuni credono; ma più tosto Misericordia, essendo che si uiene per tal uia à purgare il Mondo da Scelerati, & far che i Buoni uiuono in pace, & sicuramente godino le facoltà loro. Di modo che per tal uia questa Virtù uiene à conseruar con harmonia la Ciuile conuersatione; & quella Ampia autorità, date al Principe de gli Apostoli; Math. 16. Iohan. 1. & anco reuerita quella Pietra, sopra la quale il Signore hà edificato la sua Santa Chiesa; hora collocata in V. Santità, figurata in Daniele, Daniel. 2. per quella che uide Nabucdonosor in sogno; che correndo giù dall'Alto Monte fracassò quella Statua d'abominatione composta de uarii metalli, & la ridusse quasi in fauilla, & in niente; la qual Pietra diuenne poi un cosi Grande, & cosi alto Monde che empì con la sua grandezza tutta la Terra. Imperò che è pur uero, che non cosi tosto V. Santità fù soblimata à quella tanta Altezza, nella quale ella si troua, che diede opera con la sua prudenza, & autorità, che fù distrutta quella Massa de insidie palesi, & occulte d'Huomini praui Inimici delle Religione Christiana, & dalle palesi uiolenze, & incursioni de quelli, che turbauano apertamente, & senza ueruno rispetto i Popoli dello stato della Chiesa; & diede (come buon Padre di familia Math. 13. ) ottimo, & santissimo ordine, che fusse estirpata, & destrutta nello Spirituale la seminata Zizania da i scelerati Heretici, nimici di Santa Chiesa; & nel temperarle (come già si conosce page vii da i nuoui preparamenti) si rendesse pacifiche le cose di Terra, & di Mare; per inanti piene di disturbi. Et ueramente tengo per fermo, che sia stato opera d'IDDIO; Eccles. 1. poiche da lui uiene ogni Imperio, & ogni Regno; il quale preuedendo un tale Gouerno, habbia uoluto dare à Vostra Santità per salute della Christiana Republica la custodia di quelle pecorelle, che si trouano nell'Ouile di Santa Chiesa; Iohan. 10. acciò che siano da lei difese contra la rabbia, & furore di quei Lupo rapaci, che cercano di continuo diuorarle, per la qual cosa si può ben dire con quel del Santo Propheta, Musico & diuin Poeta. Psal. 44.
Quia dilexisti Iustitiam, & odisti Iniquitatem, propterea vnxit te Deus Deus tuus oleo laetitiae prae consortibus tuis.Prima come Re, dopoi come Sacerdote, alla guisa d'un nuouo Melchisedech Re di Giustitia, & Re di Salem, ò Re di Pace; Gen. 18. titoli ueramente conueneuoli à Maestà di tanto Pontefice. Quello di Re, dal reggimento, & gouerno del Popolo Christiano; del quale CHRISTO è il Principale Re de i Re, & Signor de i Signori: 1. Timo. 6. Apo. 17. & 19. 1. Tim. 2. Heb. 8. 9. & 12. 1. Iohan. 2. 1. Inst. Ciuil. In Prohemio. Et quello di Sacerdote, come Mediatore trà CHRISTO, & l'Huomo, si come il Nostro Signore è Mediatore trà l'Huomo, & Dio. Al Re, & Imperatore appartiene con le Leggi, & con l'Arme conseruar la salute, & la pace de' suoi Popoli; & al Sacerdote appartiene istruirli nelle cose Sacre, & Diuine della Nostra Religione; & con le continoue oblationi, & sacrificij fatti à Dio mondarli, & lauarli da i suoi peccati, pregando per la loro salute. Et per tal maniera la Felicissima & Santa Pietra di questo Alto Monte destruttrice d'ogni iniquità, cosi detta da quella, che è predicata dal Santo Apostolo Paolo, che è CHRISTO, si uiene ad estendere con la sua autorità per tutta la Terra, Dan. 2. 1. Cor. 10. Iohan. 1. & far conoscer Pietro denominato con la uoce di CHRISTO Cephas; dal nome Caldeo, ò Arameo [Hebrew] essere Pietra, ò Sasso; & dal Greco ἀπὸ τῆς κεφαλὴς essere Capo: come anco per il contrario; Pietro dal nome Greco Πέτρος uien detto Pietra, & dall'Hebreo [Hebrew] beth, & [Hebrew] Ros suona essere Capo di casa; Card. de Cusa. 2. De Conc. Cath. cap. 24. Matth. 7. Luc. 22. Capo della Chiesa, Casa del Signore; ben fondata sopra fermissima Pietra; alquale disse il Nostro Redentore.
Rogaui pro te, ut non deficiat fides tua.Piaccia adunque à Vostra Santità; se forse non le paresse à proposito questo mio tenue Dono; poi ch'ella adequa, & supera le Heroiche attioni de i maggior Rè della Terra; gradirla con quella Magnanimità, che gradì quel Rè Persiano Aelianus de uaria Hist. lib. 1. l'Acqua cacciata dal fiume con ambe le mani; offertagli da quel Pouero; che accettando la gradì, & della sua deuotione seruò il pouero Dono in ricco uaso. Pregherò IDDIO, che à Vostra Santità per salute della Christiana Republica dia Lunga & Felice Vita. page viii page ix
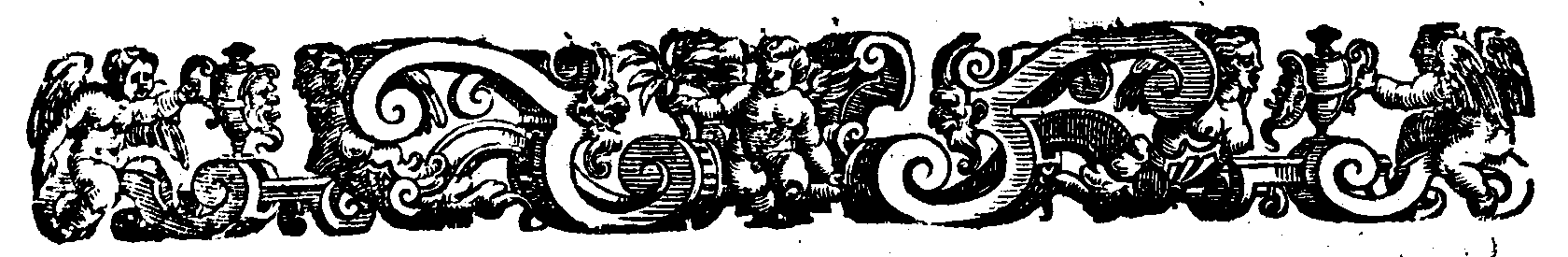
TAVOLA DI TVTTI I CAPI O MATERIE PRINCIPALI CONTENVTE NELL'OPERA.
| COme possa tallora esser facile, & tallora difficile l'apprendere il vero: & come l'Arti & le Scientie si facciano perfette; come anco dalla Inuidia & dall'Ambitione possano nascere, non solo molti mali, ma etiandio molti beni, | nel Proemio. | facciata. 1. |
| Dell'Intentione dell'Autore nel trattare & scriuere le cose della Musica. | Cap. I. | 7. |
| Delle due parti della Musica Historica & Methodica, di doue si hà la cognitione delle cose dell'Arte & della Scientia; & quello che sia l'una & l'altra: & della Materia della Musica. | Cap. II. | 10 |
| Dell'Inuentioni delle Arti, & del loro accrescimento; & in qual maniera la Musica sia stata trouata, accresciuta & ridotta ne i termini, ch'ella si troua. | Cap. III. | 17 |
| Della Differentia che si troua tra la Natura & l'Arte; tra il Naturale & l'Arteficiale; & che l'Artefice è solamente imitator della Natura. | Cap. IV. | 18 |
| Che la Natura fù prima che l'Arte; & il Naturale auanti l'Arteficiale; & per qual cagione l'Arte s'affatica intorno l'Inuentione. | Cap. V. | 21 |
| Che quello ch'è fatto secondo la Natura, non si può ben correggere col mezo di quelle cose, che sono fatte dall'Arte: & che non si può concluder bene dalle cose dell'Arte in quelle della Natura. | Cap. VI. | 23 |
| Delle sorti della Cognitione, quello che sia Arte & Scientia; & come si generino. | Cap. VII. | 24 |
| Doue habbia preso il suo nome la Mathematica; & della vtilità delle Scientie Mathematiche. | Cap. VIII. | 26 |
| Diuisione vniuersale della Mathematica nelle sue parti; & in quale sia collocata la Musica. | Cap. IX. | 28 |
| Qual sia l'Oggetto ò Proposito della Musica. | Cap. X. | 31 |
| Qual cagione potesse indurre Aristosseno, ò i suoi Seguaci almeno, à seguitar più il Senso, che la Ragione. | Cap. XI. | 32 |
| In qual Genere si debba porre la Facoltà harmonica, ouer la Musica; & la sua Scientia. | Cap. XII. | 34 page x |
| Quali siano gli Arbitri, ò Giudici, che li uogliamo dire, nella Musica; & che l'Intelligentia nasce dal Senso & dalla Memoria. | Cap. XIII. | 36 |
| Che la Intelligentia della Musica consiste nel conoscer la natura del Rimanente, ò Stabile, & del Mosso: & che bisogna prima d'ogni altra cosa assuefar l'Intelletto & il Senso nella cognitione di quelle cose, ch'appartengono alla Facoltà harmonica, in che ella consiste. | Cap. XIV. | 38 |
| Delle Sette de Musici; & di doue nacque, che gli Antichi chiamassero la Musica Canonica. | Cap. XV. | 40 |
| DELLA Voce, & d'alcuni suoi Accidenti, & della dichiaratione d'alcuni Termini usati nella Scientia. | Cap. I. | facciata. 43 |
| Del Suono in particolare, & d'alcuni suoi Accidenti. | Cap. II. | 47 |
| Della differentia che si troua tra 'l Principio & Elemento nella Musica. | Cap. III. | 48 |
| In qual maniera gli Antichi ordinassero i Suoni, ò chorde ne i loro Istrumenti; & del nome loro; & de i Tetrachordi contenuti tra esse. | Cap. IV. | 50 |
| Della differentia che faceuano gli Antichi tra i Suoni. | Cap. V. | 55 |
| Che 'l Suono si può paragonare al Punto nella Quantità dimensiua. | Cap. VI. | 57 |
| In qual maniera si faccia il suono graue & l'acuto & le loro Differentie: secondo l'opinione d'Archita Tarentino. | Cap. VII. | 57 |
| Opinione d'Aristotele del Nascimento del Graue & dell'Acuto: & che non è ueloce l'Acuto, ne tardo il Graue. | Cap. VIII. | 59 |
| Opinione di Tolomeo intorno il Nascimento del Graue & dell'Acuto. | Cap. IX. | 60 |
| In che Genere s'habbiano à porre il Suono & la Differentia del Graue & dell' Acuto, secondo la dottrina d'Aristotele. | Cap. X. | 61 |
| Opinione di Theophrasto, & che quello che scriue non è contrario à quello che scriue Aristotele. | Cap. XI. | 63 |
| Opinione di Panetio; & come il Tuono non si possa diuidere in due parti equali. | Cap. XII. | 66 |
| Opinione di Plutarcho intorno quello, di che si è ragionato di sopra; & com'anch'ei non consente, che 'l Tuono si possa partire in due parti equali. | Cap. XIII. | 68 |
| Conclusione di Tolomeo, che dimostra i Suoni & le loro Differentie esser collocati nel Genere della Quantità. | Cap. XIV. | 69 |
| Opinione di Porfirio, ilqual tiene, che non sia fuori di Ragione, il tenere; che i Suoni & le loro Differentie si ritrouano sotto due Predicamenti. | Cap. XV. | 71 |
| De gli Accidenti che accascano intorno al suono; & di quelli prima che sono considerati intorno al luogo & al Tempo. | Cap. XVI. | 74 page xi |
| Del Colore terzo accidente ò passione del Suono; & della Modulatione ò Canto; & delle sue Parti appresso i Musici antichi. | Cap. XVII. | 79 |
| QVELLO che sia Interuallo, & delle sue Specie. | Cap. I. | 82 |
| La Cagione, che indusse l'Autore à dire, & dimostrare, che 'l Diatono diatonico antichissimo non era quello, che si usa nelle Cantilene; ma il Naturale, ò Sintono di Tolomeo. | Cap. II. | 84 |
| Come le vere & naturali Forme delle Consonanze si possino arteficiosamente ritrouare, & udire in atto, col mezo del Quadrato geometrico: & che tra loro conuengono per ragioni ò proportioni de quei Numeri; che per natuale dispositione sono contenuti nel Senario. | Cap. III. | 88 |
| In qual maniera sia stato calonniata la sudetta Inuentione, & mostrato che non sia dell'Autore. | Cap. IV. | 93 |
| Che l'Ordine naturale, ò natural Sito delle Consonanze, non fù conosciuto da Pithagora ne d'alcun'altro de gli Antichi Filosofi. | Cap. V. | 97 |
| Solutioni d'alcuni Dubij fatti sopra quello che si è detto nel Capitolo precedente. | Cap. VI. | 101 |
| S'è lecito il nominar due Interualli di due diuerse forme, ò specie, con un solo nome commune. | Cap. VII. | 104 |
| Ispositione del Testo d'una delle Questioni conuiuiali di Plutarcho, intorno alla forma della Diatessaron. | Cap. VIII. | 106 |
| DE i Generi dell'Harmonie ò Cantilene, & de i lor Colori ò Specie; & prima di quelle del Diatonico. | Cap. I. | 111 |
| De i Colori, ò Specie d'Harmonia, contenute nel Genere Chromatico. | Cap. II. | 118 |
| De i Colori ò Specie contenute sotto 'l Genere d'Harmonia detto Enharmonico. | Cap. III. | 123 |
| Quello c'habbia indotto alcuni credere, che la Specie che si canta hoggi, non sia la Naturale ò Syntona diatonica: ma più tosto quella, che s'adopera ne gli Instrumenti arteficiali, & specialmente in quella da Tasti. | Cap. IV. | 130 page xii |
| In quante maniere si siano sforzati di prouare; che la Specie che si canta & si sona hoggi, non sia la Naturale diatonica ò Syntona di Tolomeo: & prima, del primo modo. | Cap. V. | 135 |
| Seconda ragione, che usano questi Speculatiui Moderni, in uoler prouare il loro capriccio. | Cap. VI. | 140 |
| Terza ragione di quelli, che non uogliono che si adoperi la Specie Naturale, ò Syntona. | Cap. VII. | 143 |
| Quarto modo, nelquale hora sottrahendo, & hora sommando insieme le proportioni de gli interualli, contenuti nel Systema massimo arteficiale, del Naturale, ò Syntono diatonico; si sforzano prouare l'opinione loro esser uera. | Cap. VIII. | 146 |
| Come ultimamente prouano col mezo de gli Istrumenti arteficiali temperati, il lor pensiero esser uero. | Cap. IX. | 149 |
| Che da gli Istrumenti arteficiali non si può concludere, che cantiamo altra Specie, che la Naturale ò Syntona. | Cap. X. | 151 |
| In qual maniera si possa acquistar molte Consonanze nell'Istrumento arteficiale, della specie Naturale ò Syntona; acciò maggiormente s'accosti à quello della Voce. | Cap. XI. | 152 |
| La cagione del Temperamento, ò Partecipatione fatta ne gli Istrumenti da Tasti; & che l'Harmonia che nasce da essi, non è Naturale & Syntona semplice: & che senza dubio ueruno ella si canti, & anco si suona in qualche sorte d'Istrumento. | Cap. XII. | 157 |
| In qual modo Aristosseno habbia constituito le sue Specie de i Generi semplici d'harmonia; & s'egli intenda diuidere l'Interuallo in parti equali & proportionali, ò nò. | Cap. XIII. | 161 |
| Il Diuidere la Differentia, ch'è tra 'l graue & l'acuto di qual si uoglia Interuallo in due parti equali; nella Magnitude ò Quantità continua, non è diuidere cotal Differentia in più equali ne i Suoni. | Cap. XIV. | 164 |
| Che nella Diuisione del Quanto continuo, le Parti non mutano alcuna qualità, se non in quella del Suono. | Cap. XV. | 165 |
| Quanto venga ben difeso Aristosseno da i suoi seguaci Moderni. | Cap. XVI. | 167 |
| Delle Oggettioni fatte da Tolomeo à gli Aristossenici; & quanto bene questi habbiano difeso Aristosseno & loro stessi insieme, contra le addotte oggettioni. | Cap. XVII. | 170 |
| Le sciocchezze c'hanno detto alcuni contra Tolomeo, come calonniatore d'Aristosseno. | Cap. XVIII. | 177 |
| Dell'uso & Necessità dell'istrumento Mesolabio, & d'altre cose, che seruono all'uso della Scientia. | Cap. XIX. | 179 |
| Come si possa trouar due Linee rette mezane proportionali, tra due datte, senza l'aiuto del Mesolabio. | Cap. XX. | 181 page xiii |
| In qual maniera si possa Molteplicare, soggiungendo, qualunque proposto Interuallo & d'alcuni Auertimenti intorno al misurare & diuidere le Quantita. | Cap. XXI. | 181 |
| Altro modo di Molteplicare, detto Preporre, qualunque Interuallo si voglia proposto. | Cap. XXII. | 185 |
| In qual maniera si possa molteplicare ò Riportar verso l'acuto, vn'Ordine d'Interualli accommodati alla loro proportione, tra i termini di qual si voglia Consonanza ò altro Interuallo. | Cap. XXIII. | 186 |
| Distributione, ò Temperatura de gli Istrumenti da Tasti; posta dal mio Discepolo per noua inuentione, & trouata da lui. | Cap. XXIV. | 189 |
| De gli Errori commessi nella sudetta Distributione. | Cap. XXV. | 192 |
| Come si possa errare nella Distributione delle Parti fatte del Comma con i Numeri; & che i Tuoni nella Distributione mostrata non siano, ne possano esser' equali & proportionali. | Cap. XXVI. | 194 |
| D'vna nuoua Distributione fatta in Dodeci Semituoni, ò parti equali, accommodata ne i Tasti posti sopra 'l manico del Liuto. | Cap. XXVII. | 197 |
| D'una Diuisione fatta della Diapason in Dodeci parti equali & proportionali, non essattamente nella Distributione de i Tasti sopra il manico del Liuto. | Cap. XXVIII. | 201 |
| Che l'essempio del Compasso, per iscusar la falsità di questa sua distributione; non è al proposito; & non hà luogo nella Mathematica. | Cap. XXIX. | 204 |
| Come si possa dirittamente diuidere la Diapason in Dodici parti, ò Semituoni equali & proportionali. | Cap. XXX. | 208 |
| In qual maniera si possa diuidere nel secondo modo la Diapason in Dodoci parti equali & proportionali. | Cap. XXXI. | 210 |
| Come si possa anco nel Terzo modo dirittamente diuidere la Diapason in Dodici parti, ò Semituoni equali & proportionali. | Cap. XXXII. | 214 |
| Della Diuisione generale de gli Instrumenti arteficiali in molte Specie, & della loro natura. | Cap. XXXIII. | 216 |
| In qual sorte d'Istrumento si possa porre in atto la Specie Naturale, ò Syntona diatonica. | Cap. XXXIV. | 218 |
| Che nelle nostre Cantilene usiamo la Specie Naturale, ò Syntona di Tolomeo; & che tra le loro Parti si cantano i suoi Interualli nelle lor vere, & naturali forme. | Cap. XXXV. | 220 |
| Che 'l si canti & Suoni la Specie naturale ò Syntona di Tolomeo, si conferma etiandio con l'essempio di due Parti, che cantino insieme. | Cap. XXXVI. | 224 |
| In qual modo si possa, & si debba essatamente udire senz'alcuno errore, ogn' Ordine d'Interualli, distribuiti sotto quelle Ragioni, ò proportioni, che si hauranno da ordinare. | Cap. XXXVII. | 226 |
| DE i Systemati ò Costitutioni, & delle loro Specie. | Cap. I. | facciata. 231 |
| Delle differentie delle Costitutioni, ò Specie delle prime consonanze. | Cap. II. | 233 |
| Delle Ragioni, ò Proportioni harmoniche; & de i Numeri che comprendono le Costitutioni consonanti. | Cap. III. | 236 |
| Che la Diapason solamente è Complessione ò Costitutione perfetta. | Cap. IV. | 237 |
| In qual modo Tolomeo dimostra, che sia stata riceuuta la Magnitudine della Diapason diatessaron per Costitutione perfetta. | Cap. V. | 238 |
| DE i Tuoni & del Numero loro. | Cap. I. | 240 |
| In qual modo i Nomi de i Suoni si pigliano, tanto per la loro Positione, quanto per la loro facoltà, ò Possanza. | Cap. II. | 244 |
| In quali delle Quindeci chorde dell'Istrumento gli Antichi accommodauano ciascun Tuono: & quanto fussero più graui, ò più acuti l'un dell'altro: & in qual maniera uengano accommodati i nostri Moderni. | Cap. III. | 246 |
| De i Tuoni, ò Modi, secondo l'opinione d'alcuni Moderni. | Cap. IV. | 251 |
| De gli Errori c'hanno commesso alcuni de Moderni, intorno il ragionar de i Tuoni. | Cap. V. | 256 |
| Che non faccia dibisogno che i Tuoni siano acuti l'uno più dell'altro per un Semituono. | Cap. VI. | 258 |
| Che bisogna, che gli estremi Suoni de Tuoni, siano finiti nella Diapason: & quanti siano in numero, secondo la mente di Tolomeo. | Cap. VII. | 259 |
| Quello che indusse Tolomeo à dire, che non ui erano più di Sette Tuoni, ò Modi. | Cap. VIII. | 262 |
| Di quello che discorrono alcuni in materia de i Tuoni, ò Modi. | Cap. IX. | 265 |
| DELLA Mutatione & delle sue Specie. | Cap. I. | 269 |
| Delle Affettioni ò Costumi dell'Animo; & quello che sia ciascuna da per sè. | Cap. II. | 270 |
| Delle Mutationi, che si dicono farsi per i Tuoni. | Cap. III. | 273 |
| QVELLO che sia Melopeia; & delli suoi Modi, & delle sue specie. | Cap. I. | 276 |
| Qual fusse appresso gli Antichi l'Harmonia, Terza parte della Melodia. | Cap. II. | 279 |
| Che gli Antichi sonauano in Consonanza; & se l'Organo nostro Istrumento sia antico, ò moderno. | Cap. III. | 285 |
| Per qual cagione si è ridotta la Massima & Perfetta harmonia in Cinque termini: & quello che s'intenda per l'Interuallo diuiso geometricamente in molte parti. | Cap. IV. | 293 |
| D'Vna noua & insolita Massima harmonia uanamente introdotta d'alcuni Moderni. | Cap. V. | 299 |
| Con quanta poca cognitione habbiano introdotta questo loro nuoua Massima harmonia. | Cap. VI. | 302 |
| Se 'l Cantare in Consonantia sia cosa impertinente; & delle cagioni che attribuiscono alla Musica moderna, che non partorisca alcuno effetto. | Cap. VII. | 305 |
| Altra cagione ch'attribuiscono & adducono, perche la Musica non faccia più miracoli. | Cap. VIII. | 309 |
| In qual maniera sia stato introdotto il modo del Cantare & del Sonare in consonanza, & di comporre più Aria insieme, secondo l'opinione d'alcuni Moderni. | Cap. IX. | 312 |
| Per qual cagione alcuni biasimano il Sonare & Cantare in consonanza, & per conseguente il modo di Comporre, facendo cantar molte Parti ò Aria insieme. | Cap. X. | 313 |
| Della Imitatione che si può far nel comporre, & recitar la Musica, ò Melopeia. | Cap. XI. | 316 |
| De i Poeti detti Melopei, quali fussero. | Cap. XII. | 320 |
| De Tre sorti d'Accento; Grammatico, Rhetorico, & Musico. | Cap. XIII. | 322 |
| Che non bisogna essere precipitosi nel giudicare alcuna cosa, auanti l'hauerla bene essaminata. | Cap. XIV. | 326 |
| 8. | 1. | Aristide Quintiliano. |
| 16. | 27. | tempi siano passati. |
| 20. | 37. | molte altre cose. |
| 20. | 44. | prodotte. |
| 21. | 1. | dall'Arteficiali. |
| 21. | 2. | posta. |
| 21. | 12. | della. |
| 24. | 19. | differenti. |
| 26. | 12. | ch'Ogni. |
| 26. | 36. | nominarono. |
| 28. | 24. | Misura. |
| 29. | 48. | per i Siti. |
| 30. | 16. | ὀργανοποιητικὴ. |
| 38. | 38. | insieme la. |
| 39. | 6. | come della Diatessaron. |
| 39. | 28. | Μελοποιΐα. |
| 41. | 47. | Agenore. |
| 50. | 1. | a. &  . .
|
| 51. | 7. | tenne. |
| 63. | 44. | alla Moltitudine. |
| 70. | 45. | detto. Queste. |
| 79. | 26. | Ευθεῖα, Prima parte: s'accommodarà sotto la Prima figura del primo essempio. Α'νακαμπλουσα, Seconda parte: sotto la Prima del secondo. περιφερὴς, Terza parte: sotto la Prima del terzo essempio, che serue à tutto quello che segue. |
| 80. | manca il Punto alla Quarta nota del secondo essempio del canto. | |
| 84. | 23. | Muti. |
| 84. | 42. | Ciò. |
| 89. | 1. | lo. |
| 95. | 35. | veramente. |
| 96. | 31. | nella fonte. |
| 104 | 17. | quelle. |
| 107. | 10. | Interualli. |
| 108. | 2. | Διὰ τριῶν. |
| 112. | 10. | Ditonico. |
| 113. | Nella Quinta specie nella Figura in luogo di Tuono leggasi. Semiditono imperfetto. | |
| 116. | Tra la Sesta, Settima, & Ottaua figura, ò nota dell'essempio, leggasi il contrario di quello ch'è scritto; cioè Tuo. minore. Tuo. maggiore. | |
| 118. | 14. | Trihemitonio. |
| 121. | 10. | Trihemituono. |
| 155. | nell'essempio i nomi de Tuoni, Semituoni & Comma, vogliono essere collocati giustamente per mezo quelle linee che diuidono le chorde del Systema l'una dall'altra. | |
| 160. | 16. | sona. |
| 163. | 3. | TVONO. |
| 207. | 34. | non si |
| 212. | 46. | pongono. |
| 259. | 36. | al numero & sito dei. |
| 259. | 45. | dee. |
| 260. | 4. | fussero; cosi anco. |
| 264. | 8. | come al. |
| 270. | 42. | Διαστηματικὸν. |
| 271. | 4. | Συσταλτικὸν. |
| 271. | 12. | Ε'μπνευστὸν. |
| 279. | 10. | Diastematico. |
| 284. | nell'essempio di Musica, nella Parte più acuta la Chiaue uuol essere posta nella Seconda riga. & nella parte piu graue in Figura uuol stare nel secondo Spacio. | |
| 285. | 38. | Herone. |
| 289. | 7. | Διαστηματικὸν. |
| 301. | 8. | auertimento. |
| 301. | 9. | grosse. |
| 326. | 6. | ne feci. |
| 326. | 44. | incompatibili. |

DE I SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
PROEMIO.
Ingenium magni liuor detrectat Homeripage 5 Alquale dopoi si può aggiungere Didimo Alessandrino, che mosso da pura inuidia, mandò fuori Sei libri, scritti contra M. Tullio Cicerone massimo Oratore latino, & fiume amplissimo & abondante di eloquentia; onde da questo fatto, tanto costui Ciceromastiga, quanto colui Homeromastiga, con degno premio della sua malignità, fù nominato. Scriue anco Seneca, Suasoriarum lib. 1. Pro Cicerone 2. che Asinio Pollione hebbe tanto in odio il nome di questo grandissimo Oratore, che non potea sopportare di udir le sue lodi; la onde una fiata recitando Sestilio Poeta questo verso.
Quisquis es, ex illo Zoile nomen habes.
Deflendus Cicero est, latiaeque silentia linguae.mosso da un'asinesca inuidia, non lo uolse udire. Il medesimo intrauenne all' Imperatore Adriano, come narra Sesto Aurelio, c'hauendo Traiano suo predecessore soggiogato all'Imperio Romano l'Armenia, l'Asia & la Mesopotamia, & hauendo fatto fabricare con grandissima spesa un bellissimo & soperbissimo Ponte sopra 'l Danubio, lo fece distruggere, & quelle prouincie ch'esso Traiano con sua somma laude hauea acquistato all'Imperio, senz'alcun proposito, donò à i Parthi. Questa sorte d'huomini è ueramente quella, che con le lor maluaggie opere danno occasione di guastare & roinare in qualche parte il Mondo, introducendo in esso pessimi essempij & scelerati costumi, che muouono gli huomini ad operar male. Ne fin'hora hò detto questo fuor di proposito; essendo che hauendo dopo un lungo tempo ch'io diedi principio, posto fine à questi miei noui Sopplimenti, secondo 'l proposito ch'io narrai di sopra, & ridotto in atto tutto quello, c'hauea nel pensiero, hauendo anco risposto à molte oggettioni, che mi poteano esser fatte, sopra quello che per auanti hò scritto; quando hebbi ultimamente deliberato, per pagare il debito già tante fiate con molte promesse contratto, di uolerli porre in luce, l'Africa nostra musicale, che di continuo partorisce & manda fuori qualche nuoua cosa, oltra gli altri fece uedere un'insolito & horribile Monstro, fatto alla guisa di quello che finge & descriue Horatio in questa maniera: In epistola de Arte. Aneol 3.
Humano capiti ceruicem pictor equinamOuero come una di quelle Arpie, che dipinge Virgilio nel suo rarissimo Poema, con queste parole: Aeneid. 3.
Iungere si velit, & varias inducere plumas,
Vndique collatis membris; vt turpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa supernè.
——— Virginei volucrum vultus, foedissima ventrisEt più oltra.
Ingluuies, vncaeque manus & pallida semper
Ora fame.
——— Et magnis quatium clangoribus alas:Il perche hauendo io ueduto un cosi nuouo parto; & considerato la qualità della Fiera, che potea apportare col tempo al Mondo qualche disconcio; mutai pensiero, & uolsi differir questo mio disegno in un'altro tempo più conueneuole; onde deliberai di scoprirla & far che 'l Mondo la conoscesse; acciò non credesse ò pigliasse una cosa per un'altra. Et per dirla come si dee, ciò feci, essendomi uenuto alle mani un Trattato di Musica, fatto da un'Autore, ilquale in una sua lettera scrittami l'Anno MDLXXVIII. sotto 'l giorno VII. di Giugno, laqual tengo appresso di me, con alquante sue altre, si manifesta essere stato mio Discepolo, con queste parole.
Diripiuntque dapes, contactuque omnia foedant
Immundo, tum vox tetrum dira inter odorem.
Molto Mag. & Reue. Sig. mio; Dopoi che l'eccellentissimo Cipriano Rore partì del seruitio di cotesta Sereniss Rep. & V. S. R. meritamente successe in suo luogo, non l'hò mai presentialmente veduta, ne anco (per non mi essere veramente occorso) gli hò scritto, come conueniua all'obligo mio, non tanto per essere stato poco auanti al sudetto tempo, suo domestichissimo Scolare & di Contrapunto, & an page 6 cora di molte cose attenenti alla Theorica; se bene in questa, & in quella, mercè della mia trascuratezza, haueuo profitato poco:Et quello che segue. Et veramente mi duole, ch'ei dica il uero, d'hauer fatto poco profitto; percioche hauendo letto & riletto il detto Trattato, compresi chiaramente quello, che à molti altri non è nascosto, che dalla dottrina insegnata in esso, egli si dichiara ueramente non essere stato mio Scolare; essendo che mai non insegnai ad alcuno quello che egli, per falso che sia, si sforza dimostrare che sia uero; dalche ogn'uno potrà comprendere, ch'egli più tosto per dimostrare il suo maligno pensiero, habbia in questo suo Trattato hauuto per fine il dir male di questo & di quello in particolare & in uniuersale, che di correggere & insegnar le cose della Musica con buona dottrina, come ne fà professione, sapendone (com'ei dimostra) assai ben poche. Il perche hauendo io questo ueduto & conosciuto, spinto dall'amore ch'io porto à questa honoreuole Scientia per il molto studio c'ho fatto in essa, dopo quello che prima scritto hauea in questa mia nuoua fatica, hauendo scoperto nel sudetto Trattato molti errori, & false dottrine, ch'egli insegna, lequali sono degne di correttione, acciò alcuno non si pensasse che da me l'hauesse imparate; deliberai d'aggiunger à quello ch'io hauea fin'allora scritto, molte dichiarationi & auertimenti, & dichiarare gli errori fatti & commessi da questo mio nuouo Discepolo, & alla fine, per beneficio commune, dare il tutto in luce; accioche per auentura alcuno Studioso non restasse ingannato da quelle false ragioni, ch'egli adduce, & non fanno al proposito. Non ho però uoluto manifestare il nome del sudetto Autore; delche niuno dee prender marauiglia, per due cagioni; prima, perche sempre hò hauuto intentione molto lontana da quello, che per la ragione c'ho detto, son'hora sforzato di fare; dopoi accioche alcuno non si pensasse, ch'io hauessi pigliato questo carico, per odio ch'io gli porti, ne per uendetta ch'io uoglia pigliare contra di lui di quanto egli habbia detto & scritto nominatamente & arrogantemente contra di me; ma si bene ho uoluto con ogni fedeltà, addurre solamente quello, ch'ei adduce contra la verità, dimostrando la falsità di quello ch'ei dice, accioche non s'introduca in questa Scientia nuoui errori: Ilche hò fatto etiandio contra alcuni di quelli, c'hanno uoluto fuor d'ogni ragione & d'ogni buona creanza & con poca intelligentia tassar le cose c'ho dichiarato & dimostrato. Ma innanti, ch'io uenga à dir cosa alcuna, secondo 'l mio proposito, dimostrerò prima, qual sia stata & sia la mia principale intentione, nello scriuere le Istitutioni & le Dimostrationi harmoniche, & questo nuouo Trattato de i Sopplimenti; dopoi (secondo che mi tornerà commodo & in proposito) andrò dichiarando di mano in mano quelle cose, lequali non mi curai di porre ne i due nominati Volumi, pensando allora, che quello c'hauea scritto, douesse esser'à sufficientia. Ilqual Trattato diuiderò in Otto libri; nel primo de i quali tratterò quelle cose, che mi pareranno esser alle cose ch'io scriuerò, communi, & che si deono sapere come Principij, & Premesse, per maggiore intelligentia di quelle, che ne gli miei libri nominati, & ne i sequenti uerrò à trattare; lequali sono considerate da i Musici come principali; come (per essempio) del Suono, dell'Interuallo, del Genere, delle Costitutioni ò uogliamo dire Ordini ò Adunationi de Suoni, del Tuono, della Mutatione, & ultimamente della Melopeia; Ilche fatto, hò buona speranza nel Datore di tutti i beni, ch'ogn'uno d'animo candido & sincero ne habbia da riportare ottimo frutto, con molta sua satisfacione; essendo ch'io troppo ben conosco, che i maligni & di trista natura non potranno à patto alcuno mai restar satisfatti di qual si uoglia buona opera, di modo che non la uoglino in qualche parte biasimare; percioche secondo il loro gusto & la loro praua dispositione, mai non si potrà trouar uiuanda tanto saporita, che non sia à loro insipida, & di poca satisfacione. page 7

Primo Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
Della Intentione dell'Autore nel trattare & scriuere le cose della Musica.Cap. 1.
Amicus Socrates & amicus Plato, magis est amica Veritas;non hò uoluto seguitar l'opinione d'alcuno, se bene alle fiate si è incontrato, ch'io habbia detto quella cosa istessa c'ha detto un'altro, ilche è proprio della Verità, ch'è una, & l'habbia molte fiate ancora confirmata con l'altrui autorità, ualendomi però d'alcuni Principij, c'hanno usato tanto gli Antichi, quanto i Moderni Scrittori. Ne fu mai ne anco è mia intentione di scriuer l'uso della Prattica secondo 'l modo de gli Antichi, ò Greci, ò Latini, se bene alle fiate la uò adombrando; ma solamente il modo di quelli, c'hanno ritrouato questa nostra maniera, nel far cantar insieme molte parti, con diuerse Modulationi, & diuerse Aria, & specialmente secondo la uia & il modo tenuto d'Adriano Vuillaert, prattico eccellentissimo, di giudicio grande, di felicissima & fecondissima memoria, & di grande, isperientia nella Musica, & nelle cose della Prattica mio Precettore. Hò uoluto etiandio anco, costretto dalla necessità, & non senza ragione, per maggior commodità & migliore & piu ragioneuole ordine, che ne uedea uscire; ordinar le Specie delle Costitutioni ò Consonanze perfette, ò uogliamo dire gli Ordini loro, & i nostri dodici Modi ò Tuoni, altramente di quello c'han fatto i Primi, ch'ordinarono in questa nostra Prattica le cose della page 10 Musica, come l'habbiamo ritrouate; ilche hò dimostrato nella Ottaua, Nona, & Decima Def. del 5. delle Dimostrationi; quantunque questo non piaccia ad alcuni de nostri Moderni Theorici, poco speculatiui. Quando adunque alcuno trouerà, ch'io tratti delle Forme delle Consonanze & de gli Interualli, che adoperiamo nelle Cantilene uocali, & d'altre cose; allora haurà da sapere; ch'io non intendo ragionar se non di quelle, che sono parti dell'istessa Natura, poste in prattica & in uso à i tempi nostri; quantunque alle fiate secondo l'occasione, ragionerò di molt'altri, ch'appresso di noi non sono in uso. Ne si pensi alcuno per alcun modo, ch'io ragioni delle cose attenenti alla prattica in cosa ueruna, come in tal maniera fussero trattate & poste in uso da gli Antichi; essendo che questo nostro modo di Cantare & di Comporre è molto differente da quello, ch' eglino usauano; se bene in qualche cosa potesse parere, c'hauessi uoluto accennare ad alcuna cosa della Musica loro, come si può uedere appresso molti Poeti & molti Historici; percioche sarebbe in errore.
Delle due parti della Musica, Historica & Methodica, di doue si hà la cognitione delle cose dell'Arte & della Scientia; & quello che sia l'una & l'altra; & della Materia della Musica.Capitolo II.
Della Inuentione delle Arti & del loro accrescimento; & in qual maniera la Musica sia stata ritrouata, accresciuta, & ridotta ne i termini, ch'ella si troua.Cap. III.
At liquidas auium uoces imitarier oreChe uogliono dire:
Ante fuit multò, quàm leuia carmina cantu
Concelebrare omnes possent, aureisque iuuare
Et Zephyri caua per calamorum sibila primùm
Agresteis docuere cauas inflare cicutas.
Inde minutatim dulceis didicere querelas,
Tibia quas fundit digitis pulsata canentum,
Auia per nemora, ac syluas, saltusque reperta,
Per loca pastorum deserta, atque ocia dia.
Sic unum quicquid paulatim protrahit aetas.
L'imitar con la bocca i dolci accentiIlche fà anco Atheneo nel cap. 13. del lib. 9. adducendo l'autorità di Chameleonte di Ponto. Laonde non è cosa da non credere, che quelli che ritrouarono prima la Musica, la usassero semplicemente, come hò detto altroue; Inst. 2. partis cap. 1. & 4. Et 3. par. cap. 79. sonando ò cantando soli, & si contentassero d'una Modulatione, ouer'Aria, che la uogliamo dire, & canto rozzo, procedendo (per modo di essempio) dal suono graue all'acuto, ò per il contrario, secondo ch'erano guidati dal Senso; Ma dopoi inuitati dalla Natura della cosa istessa, incominciassero à cantare, & insieme sonar più parti differenti l'una dall'altra per il suono graue & acuto, dalquale usciuano uariate Aria, secondo che da essa natura, con il fauore del senso erano aiutati, & formassero le Consonanze con le uoci & con i suoni ancora ne i loro canti. Et perche la cosa non era ancor fatta perfetta, però quelli che erano di più acuto ingegno, dall'istessa Natura insegnati, procedettero più oltra, facendo ultimamente cantare insieme molte parti, con Arie diuerse, fecero un sodo (dirò cosi) contenuto da tre termini ò distantie nel modo quasi ch'è contenuto il Corpo solido. Però nel cap. 4. della Prima parte delle Istitutioni, toccando un poco la parte Historica, dissi, che la Musica da principio era in tal maniera semplice, che i Rustici soleuano porgere i Voti loro à i loro Dei, in questo modo; che adunati in un Choro appresso un'altare, sopra 'l quale era una Vittima, hora spasseggiando, & hora riuolgendosi in giro, cantauano à Bacco alcune sorti de Versi al suono del Piffaro che sono à noi incogniti; & tal Piffaro non si assomigliaua à quelli c'hora usiamo; percioche in quei tempi si faceuano delle Ossa delle gambe di Grù, onde furono chiamati i Pifferi da i Latini Tibiae: essendo che cotal parte dell'animale con uoce latina è nominata Tibia, & non ui è Dittionario, nelquale non si trouino queste parole:
De gli Augelletti, fu gran tempo innanti.
Che i leggieri, soaui & dolci carmi
Potessero col canto celebrare
Gli Huomini, e insieme dilettar gli orecchi.
Et prima i Venti à i Rustici insegnaro page 14
Co 'l suon, ch'uscia da cauernose Canne
Dentro à soffiar delle Cicute caue
Dopoi di giorno in giorno à poco à poco
Dolci querele gli Huomini impararno,
Che le Tibie percosse dalle dita
De Sonatori andauan fuor spargendo
Per folti boschi, per selue & per salti,
Per luoghi de Pastori horridi e inculti;
Per quei ch'à l'ocio inuitano & al sonno.
E per tal modo l'Età à poco à poco
Seco si mena ciascheduna cosa.
Tibiae primo ex Gruum tibijs, à quibus nomen habent, tum ex arundinibus factae, unde Tibialis calamus dictus est, quem Auleticon uocant:ilche quello che scriue l'empio Luciano De Saltatione. di colui, che saltando rappresentaua Aiace infuriato; in tal maniera si compiaceua nell'imitarlo, che parea che fusse in un'estremo furore, & Aiace istesso; quando che pigliando per forza un Piffaro ò Tibia dalle mani d'un di quelli sonatori, ch'erano in Scena, in tal maniera con esso percosse il capo di colui che rappresentaua Vlisse, che lo fece cadere come morto, & se non fusse stato l'ornamento, ch'ei hauea in capo, quel colpo gli haurebbe tolto la uita; non può essere à questo c'ho detto contrario: E ben uero che 'l mio dotto Discepolo nel suo Trattato, à questo proposito dice:
Considerate se un'Istrumento fatto d'un stinco di Grue, d'Auoltore, ò d'Aquila è, atto à percuotere gli Huomini, & torgli la vita:Et in ciò non dice male; quando non fusse uero, che ogni picciola cosa può tuore la uita ad un'Huomo; come si uede ogni giorno per esperienza, perche se cotal Piffero ò Tibia fusse stata di cotal maniera, com'ei dice; bisognaua almeno, che cotal stinco fusse stato della grandezza d'uno di quei c'hanno quei animali, che chiamano Cameli ò Elefan page 15 ti ò d'altri ancora, ch'al di d'hoggi non si conoscono, se non dal parlare, che li fà differenti da i bruti. Ma io mai non parlai delle Tibie che si usauano al tempo di Luciano, & quando la Grecia & i Romani erano nel maggior colmo di grandezza, che poteano hauere; lequali tanti & tanti anni, dopo che da principio furono ritrouate, erano (com'ei dice) in uso appresso gli Antichi molte, & anco uarie, tanto nella Materia, quanto nella Forma; come si può credere. Et quello c'ho detto, che non facea di bisogno allora di maggiore Istrumento, essendo il popolo, che concorreua à luoghi simili, poco, & maggiormente dedito alla fatica & lauoro, che alle feste & à i giuochi, non hà da far con quello, ch'ei dice; che i Greci amauano grandemente la Musica, & ch'io nel cap. 35. della Seconda parte dell'Istitutioni, sia à questo di contrario parere; perche è manifesto mendacio; poiche ne in questo, ne in alcun'altro luogo, che mi ricordi, non solamente non hò detto, che non si dilettassero, ma ne anco hò ciò accennato; anzi da quello c'hò scritto in molti luoghi, & specialmente nel luogo citato, dimostro, quanto eglino si dilettassero, essendo stati Inuentori d'infinite cose. Ma uolendo anco prouare, ch'eglino attendessero & amassero grandemente la Musica, & dimostrare che non erano dediti alle fatiche, piu ch'alle feste, induce una sua Historia, senza citare l'Autore, ne qual popolo fusse, dicendo; che essendo assediati da un numeroso essercito di Serse, non tralasciarono mai alcuna delle feste publiche loro, nellequali essercitauano qual si uoglia sorte di Musica; ilche diede più uolte occasione di dubitare à Serse, sapendo egli certo, che si moriuano di disaggio, & di fame, & gli uedea & udia giorno & notte danzare, cantare & sonare. Ma questo quanto sia lontano dal uero, ogn'un lo può conoscere; percioche questo non conclude; essendo che cotali popoli poteuano per cotal uia dimostrare, & simular quello, che non era, per usar lo Stratagemma, & liberarsi dall'assedio del nemico; cosa che gli successe dopoi; come successe anco à Biante Prieneo, ch'essendo assediata Priene sua patria da Aliatte; come scriue Laertio nella sua Vita, nel primo libro; fece ingrassare due Muli, & li scacciò fuori dalla Città, nel Campo nimico; laonde hauendoli il Re ueduto, si marauigliò molto, che i Prienesi hauessero animali brutti cosi ben nutriti: Il perche hauendo deliberato di leuarsi dall'assedio, mandò prima nella Città uno ambasciatore per ispiare come andauano le cose loro: Ma Biante, hauendo conosciuto l'astutia del Re, fece coprire con grano alcuni monti grandi di sabbia, & ordinò che fussero mostrati alla Spia; il perche hauendo il Re inteso il tutto, fece pace co i Prianesi. Ma io non parlai se non de i Rustici, che allora teneuano l'istessa natura, c'hanno quelli che uiuono à i nostri tempi, iquali dopo l'hauersi bene affaticati nel lauorar la terra tutti gli altri giorni della Settimana, per non uoler domenticarsi la fatica; & per iscacciar l'otio, i giorni di festa da mezo giorno, quando il Sole si troua nel suo maggior feruore, si riducono à saltare & danzare sotto un'arbore senza mai posarsi. Percioche quanto alla sorte de gli Istrumenti che usauano, tutto si può referire à quello c'hò scritto nel cap. 1. della Seconda parte sudetta, & à quello che scriue Horatio nella sua dell'Arte poetica, ilqual parla del principio della Città di Roma, secondo che uogliono alcuni, ouero del principio che s'incominciarono, parlando in uniuersale, à edificar le Città secondo 'l parere d'altri. Però quando egli introduce l'historia di Serse, laquale ha poco da far con quello, che ei uuole inferire, commette due errori; Prima non cita (come hò detto) l'Autore della Historia, ch'è di qualche importantia appresso i Lettori, ne i popoli ch'erano assediati, ne dice qual Serse si fusse: essendone stato due almeno l'uno Quinto page 16 Re de Persiani, che regnò appresso l'Anno CCCLXXXV. auanti l'auenimento del Figliuolo di Dio in carne, & l'altro, che fu l'Ottauo, uisse intorno l'Anno CCCCXXIIII. Laonde essendo stata edificata Roma da Romolo & Remo fratelli l'Anno DCCLII. dal principio & fondatione della Città, fino al primo Serse, già erano iti CCLXVII. anni in circa, & fino al Secondo CCCXXVIII. di modo che potea ben stare, che quei popoli, ch'erano nel tempo di qual si uoglia uno di questi; essercitassero la Musica al modo ch'ei scriue. Ma che hà da far (come si dice) la Luna co i Gamberi? Che hanno da fare di gratia le Tibie, che furono ritrouate da principio, con quelle che si usauano al tempo di Luciano? che fu ne gli anni di Christo CCCV. ilqual fatto ei narra, come quello che si trouò presente. Hora per ritornare oue lasciai, dico, che hauendo i posteri à cosi debole principio; come anco si è detto dell'Architettura, aggiunto di tempo in tempo molte cose, arriuò alla Musica à tal grado; parlando però della parte del Suono, dalquale nasce l'Harmonia; che mi pare, come hò detto in più luoghi con uerità, che non si possa passar più oltra; poiche si uede, che non solo non se le può aggiungere alcuna Consonanza, ne altra cosa di nuouo; hauendo ella quella perfettione in se, che da questa parte hauer puote; ma ne anche se le può leuar cosa alcuna, che si possa dire, che le sia di souerchio. Onde hauendo gli Antichi ritrouato & aggiuntole di tempo in tempo molte cose nuoue, la ridussero prima in Arte, & al fine hauendo di essa dato tutte quelle cognitioni che dar poteano, le acquistarono il nome di Scientia perfetta; diuidendola nelle sue parti à guisa dell'Architettura, come dimostraremo. Et se bene non si troua ne i Scrittori cosa, dallaquale si possa chiaramente comprendere il modo che teneuano nel fare i loro concenti, & conoscere se erano composti di tante parti ò Arie poste insieme, nel modo che usiamo noi ne i nostri, & anco se questo nostro uso sia molto antico, da quello che potiamo hauere; tuttauia alcuni pensano, che fino à questi tempi passati intorno Anni CL. che cotali Arie s'introdussero, che per auanti gli Antichi non cantassero ne i lor concenti con tante parti insieme aggiunte; ma che cantassero semplicemente soli al suono d'un'Istrumento quell'Aria che sonauano. Questi però si potrebbono facilmente ingannare, quando intendessero, non di quella che usauano nella infantia della Musica; ma di quella, che dopo molto tempo, essendo stata accresciuta, essercitauano, essendo che non hanno ragione alcuna, ne alcuna historia, che cotal cosa manifesti, ne che dimostri il contrario; se ben si potesse dire, che non si legge, che si usasse un tal modo di cantare; poiche può ben stare, che le crudelissime guerre ciuili & esterne; che sono state nel mondo, massimamente nell'Europa, per molti & molti anni, che nella Grecia, doue fioriua la Musica, & nella Italia, per le innondationi (per dir cosi) d'infinite genti barbare, che l'hanno in diuersi tempi spogliata & rouinata, si fusse perduto un tale uso, non ne restando uestigio alcuno; come etiandio è auenuto di molte altre cose, & specialmente delle fatiche di molti Huomini illustri; come quelle di M. Tullio Cicerone, di M. Varrone, di Tito Liuio, & d'altri infiniti Historici, Filosofi, Oratori, Poeti, & simili in altre facultà; dellequali, parte sono in tutto perse, & parte imperfette, come in molte opere loro si può uedere. E' però da credere, che nel principio, quando si ritrouò la Musica come hò detto, ella non fusse in tal modo perfetta, che si usasse il concento di più parti & di più Arie insieme; ma che dopoi ella non fusse essercitata con una moltitudine de parti, questo è contrario à quello, che dice il Filosofo nella Politica. 8. cap. 5. Τὴν δὲ μουσικὴν πάντες εἶναι φαμὲν τῶν ἡδίστων καὶ ψιλὴν οὔσαν, καὶ μετὰ μελωδίας. cioè; Ma tutti confessiamo, la Musica esser una delle cose giocon page 17 dissime, sia pure ò nuda ò semplice, ouer con Melodia; percioche per nuda & semplice, si dee intendere il Canto semplice della Voce, accompagnato anco col Suono; ma con la Melodia, s'intende il Concento fatto da più cose poste insieme, come hò dichiarato nel cap. 7. & 8. della Seconda parte dell'Istitutioni, & da quello che si legge, che gli Anni di Christo DCCCLXV. essendo Conone di Tracia ottantesimoquarto Pontefice massimo, uiuea Beda Englese Sacerdote uenerabile per santità di uita & per dottrina, ilquale affirma, che nella sua età si essercitaua la Musica, Concentu, Discantu, atque Organis, com'ei scriue; cioè, col Concento, col Canto diuerso, & con gli Organi ò Istrumenti; che dire li uogliamo. Ne alcun negherà, che 'l Concento si faccia di più uoci, percioche la parola Discantus, significa molteplicità di parti, uariate di Modulatione ò Aria, come sono i Contrapunti, che si fanno con diuerse Arie, se bene alcuni Musici prattici chiamano impropriamente Discantus quella parte che nella Cantilena è più acuta di qual si uoglia altra, che uniuersalmente dalla maggior parte de Cantori è detta Soprano. Ma che l'uso dell'Organo non sia stato anco già più auanti di Nouecent'anni nella Chiesa, si può comprendere da quello, ch'è scritto dal Platina nell'Historia delle Vite de Pontefici, che Vitaliano primo ordinò il Canto nella Chiesa di Dio, & aggiunse à gli Organi la Consonanza. Et che gli Antichi non habbiano usato di cantare insieme più Arie, come faciamo al presente, non si fà buono argomento, quando si dice, che non si troua alcuna Cantilena, dallaquale potiamo confirmare questa opinione; essendo che non si troua anco uestigio alcuno di Harmonia, per ilquale potiamo sapere, qual sorte di Modulatione potessino usare. Che nel tempo di Guido Aretino non si cantasse in consonanza, come pare al mio diligente Discepolo, si può conoscere esser falso da questo; che si uede cotal modo di cantare hauer'hauuto principio auanti esso Guido: Perche da questo anco si può conoscere, ch'egli fù nel Ponteficato di Papa Benedetto Ottauo, l'Anno del Sig. MXVIII. Onde già sono iti più di DLXV. anni, & esso Guido nel Cap. 18. del Libro che egli chiama Micrologo; parlando della Diaphonia, dimostra che l'uso del cantare più Arie insieme, era già auanti i suoi tempi incominciato; per la qual cosa, quel modo di cantare, se bene era imperfetto, egli nomina Organo; scriuendo in questa maniera.
Diaphonia, uocum disiunctio sonat, quam nos Organum uocamus.Onde hauendo prima dimostrato l'uso di cotal cosa in quelli, che erano più antichi di lui, dimostra dipoi il suo, seguendo il proposito, con queste parole:
Superior nempe Diaphoniae modus durus est, noster uerò mollis.Oltra di questo si può comprendere, che quest'uso era antico, da una Epistola decretale di Papa Giouanni Ventesimo secondo,Extra. c. Docta. De Vita & hon. cler. tit. 1. nellaquale prohibisce il cantare nella Chiesa il Canto figurato: permette però, ch'alle fiate ne i giorni Festiui & solenni nelle Messe & altri Diuini officij, si possa semplicemente proferir quelle Consonanze, che fanno ò rappresentano Melodia, come di Diapason, di Diapente, di Diatessaron, & d'altre simili, sopra il Canto ecclesiastico, con queste parole:
Per hoc non intendimus prohibere, quin interdum Diebus festis praecipuè, siue solennibus in Missis & praefatijs Diuinis officijs, aliquae consonantiae, quae Melodiam sapiunt, puta Octauae, Quintae, Quartae & huiusmodi, supra Cantum ecclesiasticum simplicem proferantur; sic tamen, ut ipsius Cantus integritas illibata permaneat, & nihil ex hoc de bene morata Musica immutetur.Essendo che ei uolea, che 'l Canto ecclesiastico restasse intiero & nel suo essere. Fù questo Pontefice intorno gli Anni della nostra Salute MCCCXVI. & già ne sono passati CCLXVIII. Di più si conosce questo modo di cantare à page 18 più d'una uoce, esser più antico di quello che crede questo mio Discepolo, da un Libro scritto in carta pecora, che già molti anni tengo appresso di me, nel quale ui sono scritte & notate con buona mano alquante Cantilene, che si cantauano à due uoci solamente, & una à tre, sopra sei righe fatte di cenaprio; il qual Libro tiene scritto nella coperta in lettere mercantesche queste parole:
Al nome de Dio MCCCXCVII. che potea esser la memoria dell'Anno, che colui, del qual Libro era patrone, l'hebbe prima nelle mani; & non quello, nelquale fù scritto: & questo è segno euidente, che la lettera, con laquale fù scritto esso Libro, è molto differente da quella, ch'è sopra la detta coperta; & la coperta si uede essere più noua, che non è il Libro; & già sono passati Anni CLXXXV. Si conosce anco questa cosa da alquante Cantilene antiche notate in una carta pergamena separatamente sopra cinque righe, scritte con figure & caratteri simili à quelli, con i quali sono scritte quelle, che sono nel sudetto Libro, che mi fù mandato da Lucca l'un de gli anni passati, dal molto gentile M. Gioseffo Guammi eccellente Compositore & Sonatore soauissimo d'Organo; & sono composte à due uoci, & stimo che (da molti accidenti che ui concorrono) siano alquanto più antiche di quelle, che sono notate nel Libro nominato. Et se ben paresse ad alcuno, che l'esser fatte cotali Cantilene à due ò al più à tre uoci, ciò non fusse sufficiente à mostrare che si cantaua con molte Aria; dico, che quantunque il numero sia poco, che ciò non dimostra il contrario; percioche le parti si poteuano & possono molteplicare senza contrarietà alcuna, come uediamo farsi ne i nostri giorni; che i Compositori non contentandosi del numero di tre ò quattro, l'hanno molteplicate di modo, ch'alcuni sono arriuati alle Cinquanta uoci; dallequali ne nasce grande strepito, & gran romore, & quasi confusione.
Della Differentia che si troua tra la Natura & l'Arte, & tra il Naturale, & lo Arteficiale; & che l'Artefice è solamente imitatore della Natura.Cap. IIII.
Che la Natura fù prima che l'Arte, & il Naturale fù auanti l'Arteficiale; & per qual cagione l'Arte s'affatica intorno la Inuentione. Cap. V
Che quello ch'è fatto secondo la Natura, non si può ben correggere col mezo di quelle cose, che sono fatte dell'Arte, & che non si può concluder bene dalle cose dell'Arte in quelle della Natura. Cap. VI.
Delle sorti della Cognitione; quello che sia Arte & Scientia, & come si generino.Cap. VII.
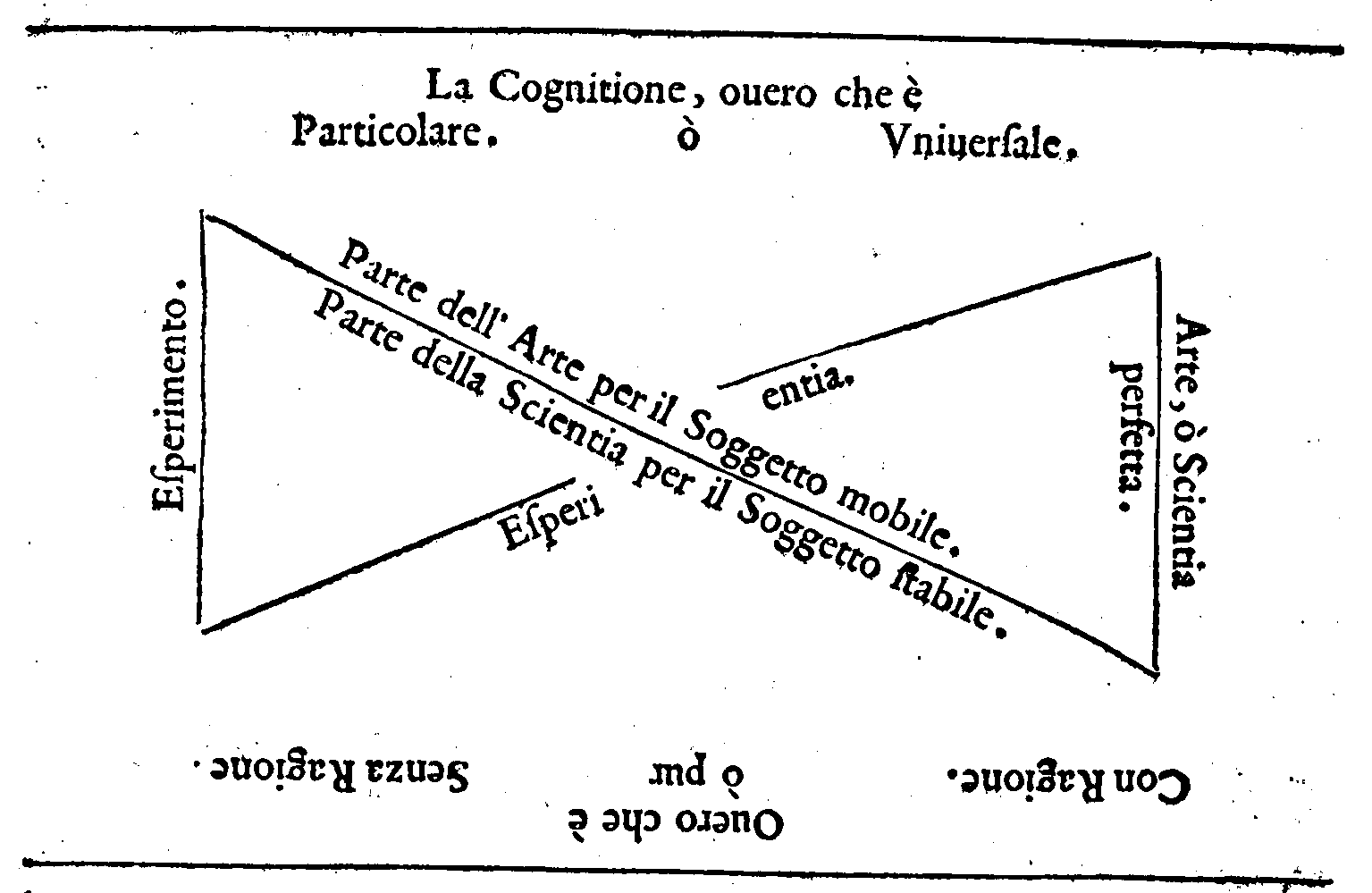
Doue habbia preso il suo nome la Mathematica, & della utilità delle Scientie mathematiche.Cap. VIII.
Diuisione uniuersale della Mathematica nelle sue parti; & in quale sia collocata la Musica.Cap. IX.
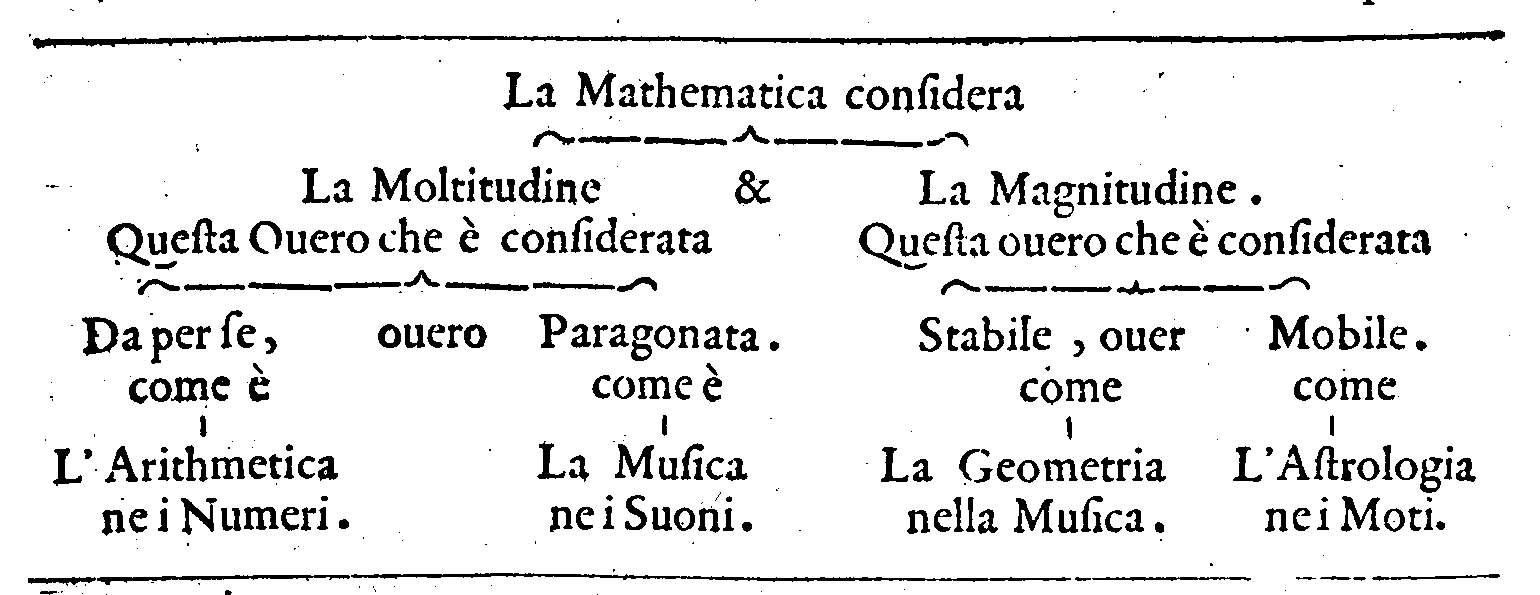
Qual sia l'Oggetto ò Proposito della Musica.Cap. X.
Qual cagione potese indurre Aristosseno, ò i suoi seguaci almeno, à seguitare più il Senso, che la Ragione.Cap. XI.
In qual Genere si debba porre la facoltà Harmonica, ouer la Musica & la sua Scientia.Cap. XII.
Quali siano gli Arbitri ò Giudici, che li vogliamo dire, nella Musica, & che l'Intelligentia nasce dal Senso & dalla Memoria.Cap. XIII.
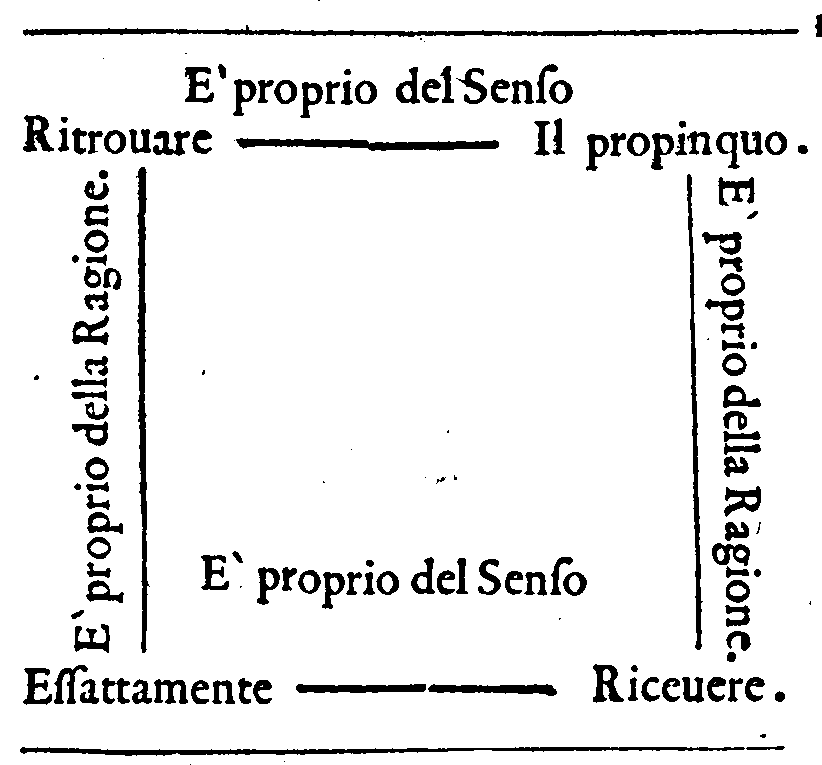
Che la Intelligentia della Musica consiste nel conoscer la natura del Rimanente ò Stabile & del Mosso; & che bisogna prima d'ogn'altra cosa assuefare l'Intelletto & il Senso nella cognitione di quelle cose, ch'appartengono alla Facoltà harmonica, in che ella consiste.Cap. XIIII.
Noi parliamo à gli Esperti,Perche ueramente è impossibile, ch'alcuno possa intendere & trattar le cose di quest'Arte & di questa Scientia; come hò detto altroue; se prima non haurà gustato tutte quelle cose, che cadono facilmente sotto la loro intelligentia, & non ne haurà di esse perfetta cognitione. page 40
E però uoi Profani
State da noi lontani.
Delle Sette de Musici; & di doue nacque, che gli Antichi chiamassero la Musica Canonica.Cap. XV.
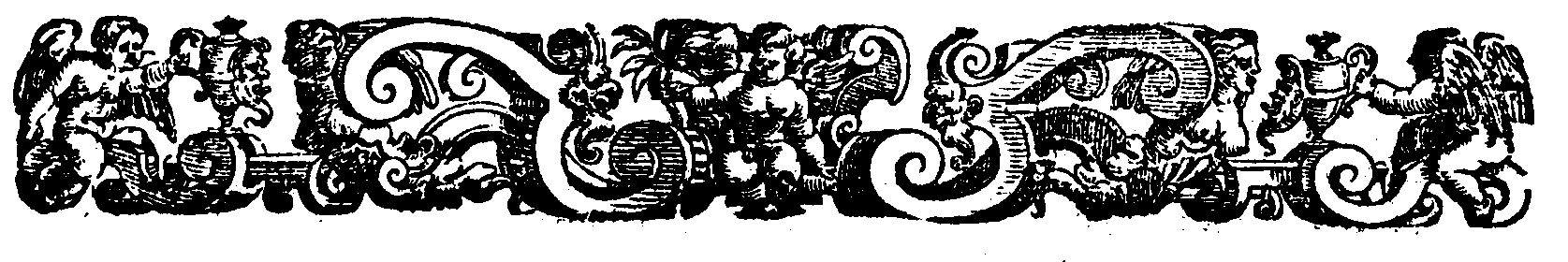
Secondo Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
Della Voce, & d'alcuni suoi Accidenti, & della dichiaratione d'alcuni Termini usati nella Scientia.Cap. I.
Del Suono in particolare, & d'alcuni suoi Accidenti. Cap. II.
Della Differentia che si troua tra il Principio & lo Elemento nella Musica.Cap. III.
In qual maniera gli Antichi ordinassero i Suoni ò Chorde ne i loro Istrumenti, & del Nome loro & de i Tetrachordi contenuti tra esse.Cap. IIII.
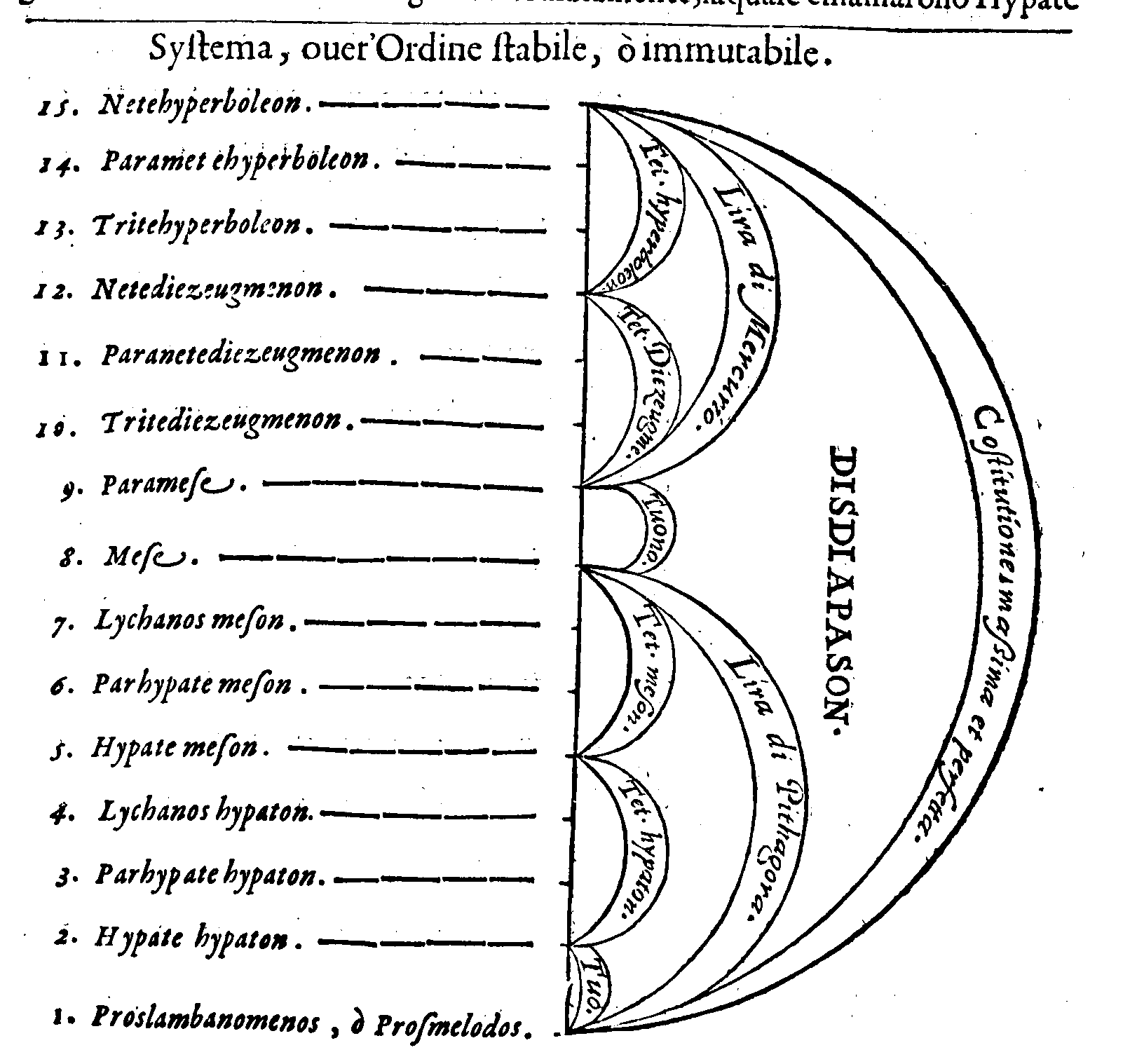
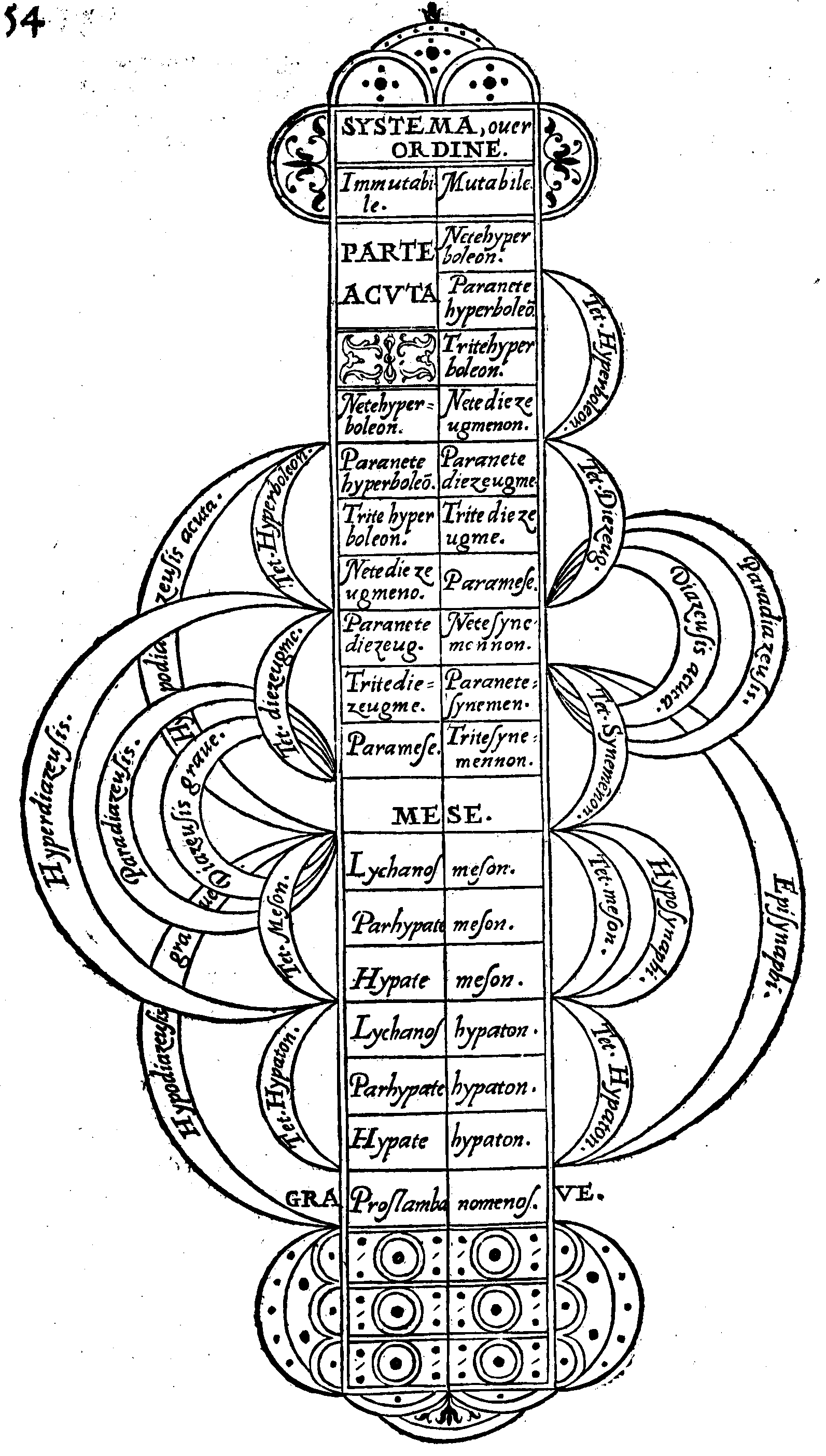
Della Differentia che faceuano gli Antichi tra i Suoni. Cap V.
Che 'l Suono si può paragonare al Punto nella Quantità dimensiua.Cap. VI.
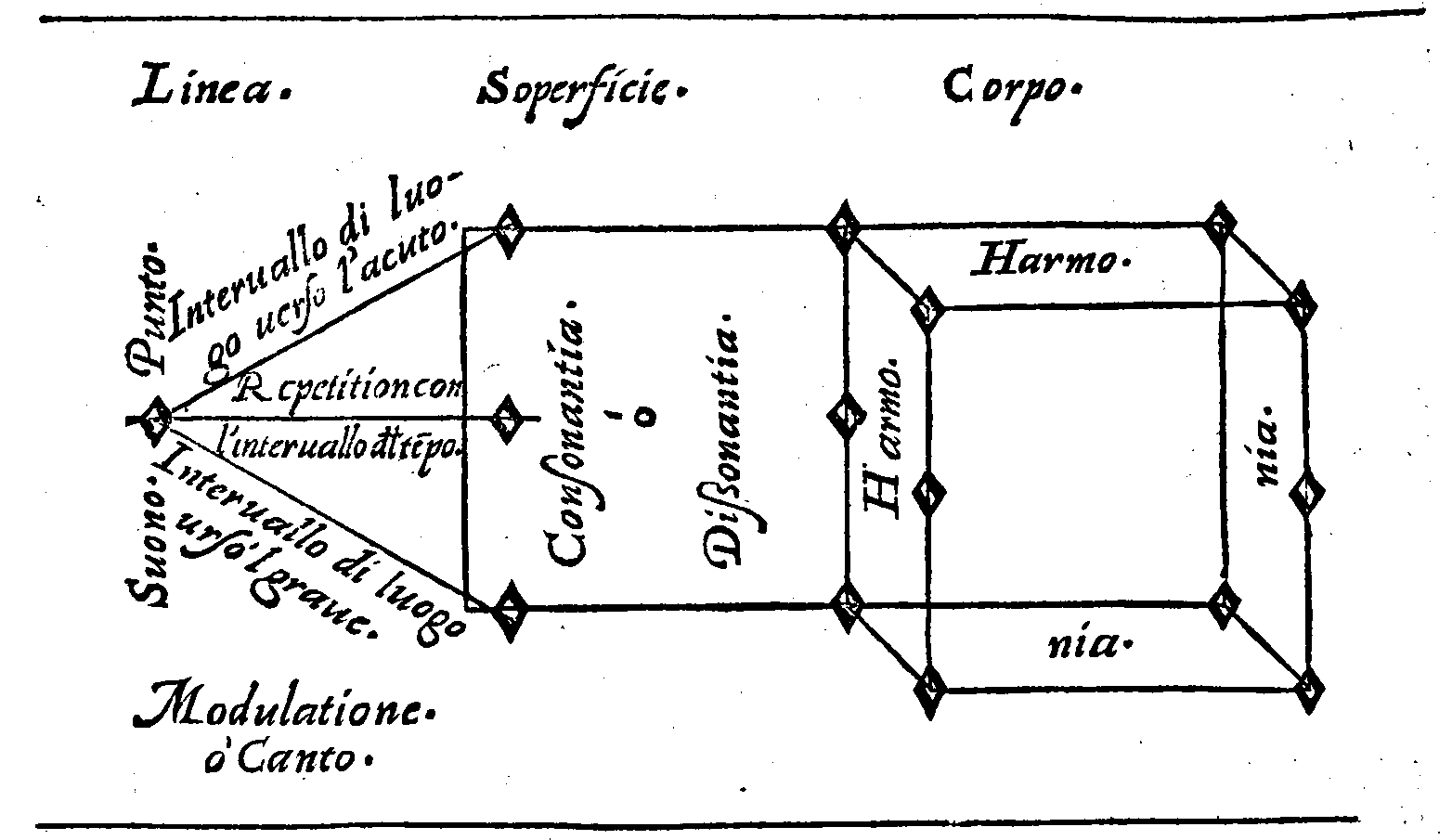
In qual maniera si faccia il Suono graue & lo Acuto & le loro Differentie, se condo l'opinione d'Archita Tarentino.Cap. VII.
Opinione di Aristotele del Nascimento del Graue & dell'Acuto, & che non è ueloce l'Acuto, ne tardo il Graue. Cap. VIII.
Opinione di Tolomeo intorno il Nascimento del Graue & dell'Acuto.Cap. IX.
In che genere si habbiano à porre il Suono & la Differentia del Graue & dello Acuto, secondo la dottrina d'Aristotele. Cap. X.
Opinione di Theophrasto, & che quello ch'ei scriue non è contrario à quello che scriue Aristotele.Cap. XI.
Opinione di Panetio; & come il Tuono non si possa diuidere in due parti equali.Cap. XII.
Opinione di Plutarcho intorno quello che si è ragionato di sopra; & come anch'ei non consente, che 'l Tuono si possa partire in due parti equali.Cap. XIII.
Conclusione di Tolomeo, che dimostra i Suoni & le loro Differentie esser collocati nel genere della Quantità.Cap. XIIII.
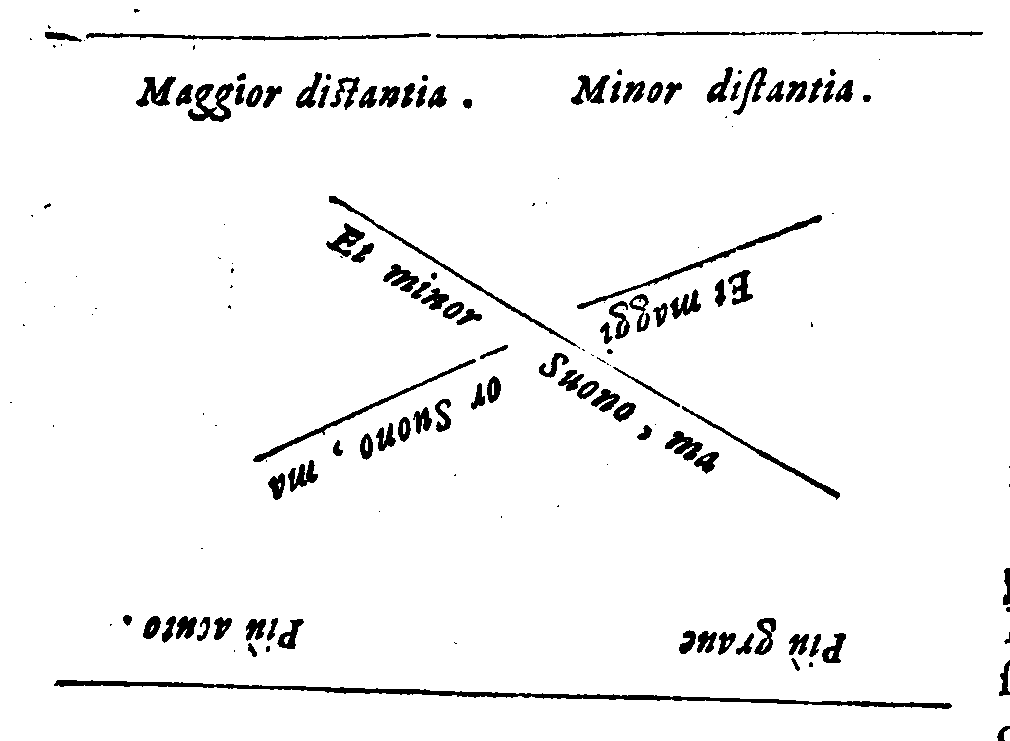
Opinione di Porfirio, ilqual tiene, che non sia fuori di ragione, il tenere; che i Suoni & le lor Differentie si ritrouano sotto due Predicamenti.Cap. XV.
De gli accidenti che accascano intorno al Suono; & di quelli prima che sono considerati intorno al Luogo & al Tempo.Cap. XVI.
 tia di quelli che leggeranno, con i soliti caratteri ò figure,
usate da Moderni. Il
perche dall'essempio
addotto potiamo comprendere, ch'appresso i Musici moderni i Luoghi de i Suoni & delle Voci per il più, si descriuono sopra cinque linee parallele; & sopra i
loro Spacii posti di dentro; come sono le sequenti; & più oltra ancora secondo 'l
tia di quelli che leggeranno, con i soliti caratteri ò figure,
usate da Moderni. Il
perche dall'essempio
addotto potiamo comprendere, ch'appresso i Musici moderni i Luoghi de i Suoni & delle Voci per il più, si descriuono sopra cinque linee parallele; & sopra i
loro Spacii posti di dentro; come sono le sequenti; & più oltra ancora secondo 'l
 bisogno; dellequali ciascuna è nominata col nome proprio; come uederemo altroue; essendone però segnate solamente alquante con una delle seguenti Cifere, che dinota il nome di una chorda ò Suono contenuto nel Sistema
massimo; come auanti si è mostrato, & anco si dimostrerà al suo luogo; lequali
bisogno; dellequali ciascuna è nominata col nome proprio; come uederemo altroue; essendone però segnate solamente alquante con una delle seguenti Cifere, che dinota il nome di una chorda ò Suono contenuto nel Sistema
massimo; come auanti si è mostrato, & anco si dimostrerà al suo luogo; lequali
 Cifere secondo il loro Translato, nominano Chiaui; che si scriueano prima
con queste lettere F. C. & G. ma dopoi
corrotte le prime forme ò figure; furono
ridutte da più Moderni nelle forme che si ueggono al presente. Quanto poi al
Secondo accidente ch'è il Tempo; secondo il Mouimento di tardo ò ueloce, diciamo un Suono esser più lungo ò più corto dell'altro quanto alla duratione del
Tempo che consumiamo cantando, come sarebbe dire; quando nella Modulatione dimoriamo secondo 'l Tempo più lungo & di maggior quantità in un Suono, ò secondo il tempo breue & di minore; percioche le Modulationi si debbono
accommodar secondo 'l Tempo considerato nella lunghezza & nella breuità de
i Suoni; & come quello che tiene il luogo del Rhythmo, come è di lungo ò
breue, rispetto l'un'all'altro; come si scorge in questo essempio. Laonde è da
auertire, che i Musici de nostri tempi & anco i più Antichi segnauano il Tempo
Cifere secondo il loro Translato, nominano Chiaui; che si scriueano prima
con queste lettere F. C. & G. ma dopoi
corrotte le prime forme ò figure; furono
ridutte da più Moderni nelle forme che si ueggono al presente. Quanto poi al
Secondo accidente ch'è il Tempo; secondo il Mouimento di tardo ò ueloce, diciamo un Suono esser più lungo ò più corto dell'altro quanto alla duratione del
Tempo che consumiamo cantando, come sarebbe dire; quando nella Modulatione dimoriamo secondo 'l Tempo più lungo & di maggior quantità in un Suono, ò secondo il tempo breue & di minore; percioche le Modulationi si debbono
accommodar secondo 'l Tempo considerato nella lunghezza & nella breuità de
i Suoni; & come quello che tiene il luogo del Rhythmo, come è di lungo ò
breue, rispetto l'un'all'altro; come si scorge in questo essempio. Laonde è da
auertire, che i Musici de nostri tempi & anco i più Antichi segnauano il Tempo
 lungo ò breue con una
delle segenti Figure ò
Cifere; secondo che pareua conueniente al Compositore della Cantilena; &
questo non secondo gli Accenti grammatici; de i quali ne ragionaremo nell'Ottauo libro; ma secondo gli Accenti Rethorici, ò Musici, con lequali scriuono
lungo ò breue con una
delle segenti Figure ò
Cifere; secondo che pareua conueniente al Compositore della Cantilena; &
questo non secondo gli Accenti grammatici; de i quali ne ragionaremo nell'Ottauo libro; ma secondo gli Accenti Rethorici, ò Musici, con lequali scriuono
 ancora ò depingono
(dirò cosi) i Colori ò
Arie di esse Cantilene; come si è mostrato
di sopra, contenuti nelle Modulationi delle loro parti. Onde à questo proposito
alcuni poco intendenti dicono ch'io hò errato, quando nel cap. 49. della Terza
parte delle Istitutioni segnai il Tempo lungo & lo breue separatamente con uarie
Figure; cioè, quello con la figura
ancora ò depingono
(dirò cosi) i Colori ò
Arie di esse Cantilene; come si è mostrato
di sopra, contenuti nelle Modulationi delle loro parti. Onde à questo proposito
alcuni poco intendenti dicono ch'io hò errato, quando nel cap. 49. della Terza
parte delle Istitutioni segnai il Tempo lungo & lo breue separatamente con uarie
Figure; cioè, quello con la figura 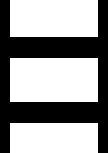 . che chiamano Breue; & questo con la figura
. che chiamano Breue; & questo con la figura 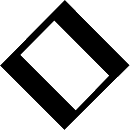 .
che dicono Semibreue; cosi ancora hauer segnato il lungo con la Semibreue
.
che dicono Semibreue; cosi ancora hauer segnato il lungo con la Semibreue 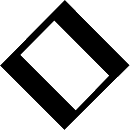 . &
il breue con la.
. &
il breue con la. 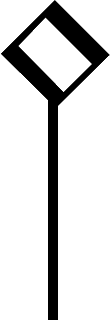 . Minima; percioche li pare che 'l Tempo lungo si debba segnare
con la Figura.
. Minima; percioche li pare che 'l Tempo lungo si debba segnare
con la Figura. 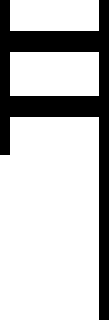 . che chiamano Lunga, & lo Breue con la figura.
. che chiamano Lunga, & lo Breue con la figura. 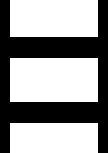 . Breue; accioche il nome delle Figure dinotino il Tempo significato per quelle; & insieme nel nome corrispondono: quasi che queste Figure.
. Breue; accioche il nome delle Figure dinotino il Tempo significato per quelle; & insieme nel nome corrispondono: quasi che queste Figure. 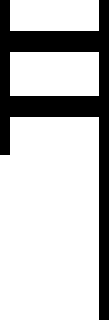 .
. 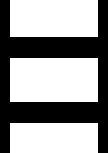 .
. 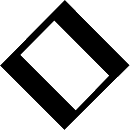 .
. 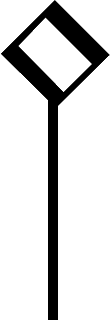 . per relatione
ò comparatione, non fussero doppie di tempo l'una all'altra; cioè la maggiore
page 76
alla minore seguente; come la Lunga alla Breue, & questa alla Semibreue, &
cosi la Semibreue alla Minima; & che qual si uoglia non si potesse applicare à
qual si uoglia Tempo lungo ò breue; seguendo le Figure per ordine; misurando
l'uno & l'altro de i loro Moti con un Moto commune. Et perche hò detto nel
cap. 6. di questo Libro; che 'l suono è considerato dal Musico, come il Punto è
considerato dal Geometra; però mi souiene hora, che Francesco Salines, di
natione Spagnuolo huomo di buona dottrina; alquale desidero ogni felicità;
raccontando alcuni luoghi; ne i quali gli pare ch'io mi sia ingannato nel trattar
le cose della Musica, pone questo per un'errore; che io definisco la Musica
pigliata uniuersalmente; la quale douea prima diuidere che definire; per esser nome Analago, com'ei dice, alla Mondana, Humana & Istrumentale; & inciampa biasimando la Diuisione ch'io fò della Musica Organica nella Naturale & nell'Arteficiale; dicendo, che tutti gli Antichi le reputarono
una cosa istessa; quasi che non ui fusse differentia alcuna tra quella, che nasce da gli Istrumenti naturali & quella c'ha l'esser da gli Arteficiali; ilche fà anco
dell'Arteficiale diuisa nella Piana & nella Misurata, & nella Rhythmica & nella
Metrica; & ciò fà nel cap. 33. del Terzo libro della Musica, ch'ei scrisse in lingua
Latina: onde quanto egli habbia ragione, il lettore, leggendo accuratamente il Cap. 5.
8. & 9. della Prima parte delle mie Istitutioni, potrà giudicar s'io
son degno di reprensione; imperò ch'ei scriue, che sopra ogn'altra cosa mi son
affaticato nell'affirmare, il Suono esser nel Canto indiuisibile, come è il Punto
nella Linea; & anco ch'io non hò auertito, che 'l Suono è considerato dal Musico, come principio dell'Harmonia, & cosi essere indiuisibile; & che il Tempo & la Tardanza ch'è in esso, non è considerato dal Musico, ma dal Rhythmico, ilquale considera la Seconda parte per il Genere della Musica, diuersa dalla prima; alquale il Tempo breue è nel Rhythmo indiuisibile, come l'Vnità ne
i Numeri & il Suono nell'Harmonia: & che li pare che non habbi inteso, che la
Duratione ne i Suoni non si possa far da un solo Suono; ancora ch'io potesse
hauer letto appresso di Boethio queste parole:
1. Musicae
cap. 3.
. per relatione
ò comparatione, non fussero doppie di tempo l'una all'altra; cioè la maggiore
page 76
alla minore seguente; come la Lunga alla Breue, & questa alla Semibreue, &
cosi la Semibreue alla Minima; & che qual si uoglia non si potesse applicare à
qual si uoglia Tempo lungo ò breue; seguendo le Figure per ordine; misurando
l'uno & l'altro de i loro Moti con un Moto commune. Et perche hò detto nel
cap. 6. di questo Libro; che 'l suono è considerato dal Musico, come il Punto è
considerato dal Geometra; però mi souiene hora, che Francesco Salines, di
natione Spagnuolo huomo di buona dottrina; alquale desidero ogni felicità;
raccontando alcuni luoghi; ne i quali gli pare ch'io mi sia ingannato nel trattar
le cose della Musica, pone questo per un'errore; che io definisco la Musica
pigliata uniuersalmente; la quale douea prima diuidere che definire; per esser nome Analago, com'ei dice, alla Mondana, Humana & Istrumentale; & inciampa biasimando la Diuisione ch'io fò della Musica Organica nella Naturale & nell'Arteficiale; dicendo, che tutti gli Antichi le reputarono
una cosa istessa; quasi che non ui fusse differentia alcuna tra quella, che nasce da gli Istrumenti naturali & quella c'ha l'esser da gli Arteficiali; ilche fà anco
dell'Arteficiale diuisa nella Piana & nella Misurata, & nella Rhythmica & nella
Metrica; & ciò fà nel cap. 33. del Terzo libro della Musica, ch'ei scrisse in lingua
Latina: onde quanto egli habbia ragione, il lettore, leggendo accuratamente il Cap. 5.
8. & 9. della Prima parte delle mie Istitutioni, potrà giudicar s'io
son degno di reprensione; imperò ch'ei scriue, che sopra ogn'altra cosa mi son
affaticato nell'affirmare, il Suono esser nel Canto indiuisibile, come è il Punto
nella Linea; & anco ch'io non hò auertito, che 'l Suono è considerato dal Musico, come principio dell'Harmonia, & cosi essere indiuisibile; & che il Tempo & la Tardanza ch'è in esso, non è considerato dal Musico, ma dal Rhythmico, ilquale considera la Seconda parte per il Genere della Musica, diuersa dalla prima; alquale il Tempo breue è nel Rhythmo indiuisibile, come l'Vnità ne
i Numeri & il Suono nell'Harmonia: & che li pare che non habbi inteso, che la
Duratione ne i Suoni non si possa far da un solo Suono; ancora ch'io potesse
hauer letto appresso di Boethio queste parole:
1. Musicae
cap. 3.
Neque enim quoties pellitur chorda, unus edi tantum putandus est Sonus, aut unam in his esse percussionem; sed toties Aër feritur, quotiescum chorda tremebunda percusserit.Laonde per rimuouer questa mala impressione dalle menti de i Lettori, à questo risponderò breuemente, che molto mi dispiace, che 'l Salines habbia poco inteso quello c'habbia uoluto dire il suo Amico; percioche è uero ch'io dico che i Suoni sono diuisibili; ma dico Diuisibili nella duratione, cioè, nel Tempo, quanto alla lunghezza & non quanto alla larghezza: essendoche ogni Suono nasce dal Moto, & ogni Moto si fà col Tempo; ilquale essendo ò lungo ò breue, è diuisibile, & cosi il Suono che non si fà nello Istante, nella sua duratione è diuisibile. Imperoche quanto alla larghezza; cioè, alla distantia di graue & di acuto; poiche i Suoni non hanno larghezza ueruna, sono indiuisibili. Et accioche ogn'uno intenda; poniamo, ch'alcuno cantando tenga fermo in un Tenore tanto la Voce, quanto importi un Tempo musico, ch'è il ualore d'una Breue; parlando come Prattico; inteso per questa Figura
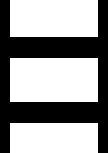 . il qual tempo chiamaremo Lungo, rispetto al Breue; che
noi intenderemo per quello che porta seco la seguente figura
. il qual tempo chiamaremo Lungo, rispetto al Breue; che
noi intenderemo per quello che porta seco la seguente figura 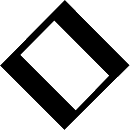 . dico, che questo
Tempo nella sua duratione, nell'istesso Tenore si può diuidere in due Tempi
breui, in questo modo.
. dico, che questo
Tempo nella sua duratione, nell'istesso Tenore si può diuidere in due Tempi
breui, in questo modo. 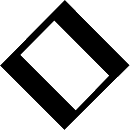
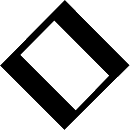 . Ilperche in cotal maniera il Suono sarà diuisibile
nella sua duratione; come la Linea nella sua lunghezza: ma non si potrà giamai
diuidere (sopposta anco la duratione in un Tenore) nella larghezza, che importa distantia di suono graue & di acuto; come anche la Linea; percioche sarà
page 77
uno & equal Suono & d'uno istesso Tenore. Laonde essendo il Suono fatto nel Tempo, & essendo il Tempo diuisibile; cosi anco è diuisibile il Suono: & perche il Suono è cagionato dal Moto, & il Moto hà il
suo principio dallo Istante; ilquale è simile
al Punto, dalquale la Linea hà il suo principio; però il Suono inquanto è indiuisibile come è il Punto nella Linea, si dee
intendere nella longhezza & non altramente: essendoche si come il Punto non è lungo ne largo ne alto; ma dal suo Riportamento da un luogo all'altro fà la Linea, che è conclusa tra due punti estremi, laquale è solamente lunga; cosi il Suono, che da se stesso non è graue, ne acuto; se
non è riportato in luogo diuerso; diremo cosi; & fuori del suo orizonte; non è lungo ò corto; se non per la duratione del
Moto, dalquale ello nasce. Però quando
dico, nel Suono cascare il Tempo nella duratione; cotal Tempo è necessario
che sia ò lungo ò breue, rispetto alla misura di esso Tempo, il che non si può negare; percioche il Suono secondo la duratione,
se 'l contenerà nel Metro ò Verso (per
essempio) due Sillabe lunghe, che faranno due Tempi lunghi; ilche contiene lo
Spondeo; come à dire, A¯gnus¯. questi due tempi si trouano diuisi in quattro
Tempi breui equiualenti à i due sudetti lunghi, in una istessa Quantità & duratione; cioè, in uno Proceleumatico; come, Do ˘. cu ˘. i ˘. mus ˘. ouer si come, Pa ˘. ri. ˘. e ˘. ti. ˘. busquepremunt arctis; che si troua appresso di Virgilio
Geor. 4.
Aenei. 2.
& 5.
tre fiate, & contiene Quattro Sillabe breui, che sono equiualenti allo Spondeo. Et
se bene ei dice, che 'l Tempo & la tardanza, non è considerato dal Musico, ma
dal Rhytmico, questo è detto fuor di ragione; essendoche solo al Musico s'appartenga il considerare i Suoni & le Consonanze, & anco il Moto numeroso, che
consiste nel Mouimento che si troua tra quelle parti, che contiene la Υ῾πόκρισις;
cioè, l'Attione; molto necessaria al buon Oratore; & tra quelle della Προσωδία;
ouer'Accento; nellequali sono numerate tra l'altre il Graue & l'Acuto, con il
Lungo & il Breue; cose che si usano nella buona Pronuncia; dallaquale si forma
la Musica Rhythmica, sottoposta alla Scientia della Musica: percioche cotali
Accenti uengono dalla detta Pronuncia della Oratione, che sono cose (come
hò detto sottoposte à questa Scientia, dellaquale essa Rhythmica è una Specie;
come hò dichiarato nelle Istitutioni;
par. 1.
cap. 9.
& consiste nel Mouimento della persona, come si scorge in quelli, che danzano ò ballano. Et quando dice, che 'l
Tempo breue è indiuisibile al Rhythmo, come l'Vnità ne i Numeri & il Suono nell'Harmonia, dice bene; percioche appresso il Rhythmico non è cosa alcuna che sia sotto 'l Tempo breue, perche è come Elemento; & sotto 'l Suono,
come principio & primo Elemento de gli Interualli & delle consonanze, non
ui è cosa alcuna; essendoche non si troua cosa che cada prima di lui sotto l'Vdito. Et perche la lunghezza & breuità cadono sotto 'l Tempo, è necessario,
che siano almeno diuisibili come hò detto, secondo la duratione; percioche il
Principio & il Fine del tempo sono rinchiusi tra due Istanti; i quali uniti insieme (se far si potesse) non farebbono Tempo alcuno; per essere gli Istanti
indiuisibili, che non si possono porre insieme. Laonde misurandosi il Tempo, è necessario che ui sia una misura minima, dalla quale ei sia misurato;
poiche in tutti i Generi ue n'è una prima (come insegna il Filosofo
2. Caeli. 28.
& Metap.
10. tex.
3. & 4.
) che
è misura di tutto quello, che si troua in quel Genere, quantunque cotal
cosa si potesse diuidere in molte altre parti minori di lei. Il perche si può
dir con ragione; che si come il Logista ò Computista (come fù dichiarato
nel cap. 8. del Libro precedente) prende per suo Principio quella Vnità per
indiuisibile ne i suoi computi, ch'è materiale & diuisibile, & non è quella che
intende il mathematico, ch'è separata dalla Materia; cosi quel Suono che prende
page 78
il Musico per indiuisibile & come suo principio ne gli Interualli & nelle Consonanze, non è quello che ei intende Diuisibile nella Duratione. Et se ben al Salines pare, ch'io non habbia inteso che la duratione sudetta non si possa far da un
solo Suono, ilche uuole prouare con l'autorità di Boethio; parmi ch'egli non
habbia ne letto, ne ueduto il cap. 11. della Seconda parte delle mie Istitutioni;
perche haurebbe conosciuto troppo bene, che questa dottrina hò imparato
da questo autore. Et forse anco che non si è ricordato, che si può intendere
questo termine Indiuisibile per l'Atto & per la Potentia: onde sapendo quello
ch'importa Principio, & essendo il Punto principio della Linea; non ha parte
alcuna, ne in lunghezza, ne in larghezza; onde non è diuisibile ne in atto, ne
in potentia per duratione, quantunque nel Sito sia permanente. Ma il Suono
se bene è principio della Modulatione, è diuisibile però nella sua duratione ò
nel Tempo ch'ei porta seco; come hò mostrato. Et quantunque il Tempo breue è principio ò misura del Lungo; per esser'Elemento della compositione de i
Piedi ne i Versi; secondo che è Principio & Elemento, è indiuisibile; ma in quanto importa semplicemente Tempo quantunque
breue, poi c'hà per termini estremi due Istanti; potrà sempre esser misurato da un Tempo minore. Vuole anco il mio Salines ch'io mi sia doppiamente ingannato; perche la Musica Piana
& la Figurata, com'ei dice, & la Rhythmica & la Metrica equalmente sono naturali & arteficiali; ne io dico però altramente nel cap. 5. & nell'8. & nel 9. del primo delle Istitutioni. Maggiormente ancora dice, perche io penso che la Piana
& la Figurata si trouino nelle Figure ò Note, & nelle Parole; ma la Rhythmica
& la Metrica solamente nelle Parole; come nella Oratione soluta & ne i Versi;
Ilche dice egli, dimostrando che 'l Padre Santo Agostino dica non esser cosi;
distinguendosi la Grammatica dalla Musica per questo; che la Grammatica considera la lunghezza & la breuità delle Sillabe nelle Parole poste ad arbitrio dell'Huomo; & la Musica considera il Rhythmo naturalmente essere in molte altre cose; quantunque egli habbia detto, che il Rhythmo non sia considerato
dal Musico; & essi Metri non minormente si ritrouano nelle Modulationi che si
fanno senza parole, che in quelle che le contengono. Ma questo mio dolcissimo
Amico, per quello ch'io m'accorgo, non hà mai ueduto quello, ch'io scriuo ne
i sudetti tre Capi; ne i quali dimostro chiaramente, che queste sorti di Musica
Piana & Misurata si fà secondo 'l Tempo dimostrato con alcuni Caratteri ò Figure poste sopra alcune Linee ò Spacii, che ci rappresentano il Suono ò la Voce,
con la Velocità ò Tardità del tempo; percioche in cotal cosa & molt'altre (il
che si dee tenere à memoria per sempre) si usano i Segni per le cose Significate. Ma ei non si ricorda, che nel fine del cap. 9. sopranotato adduco in mio fauore la ragione del sudetto Santo dottore; & concludo, queste due sorti di Musica potersi anco attribuire alla Musica arteficiale; percioche ogni giorno udimo al suono d'uno Istrumento accommodarsi uarie sorti de Versi ò Metri; secondo 'l numero ò tempo numeroso, che si comprende nel Suono. Et forse,
che da questo ei prese argomento, c'habbia uoluto dire, che la musica Rhythmica & la Metrica non si potesse udire, sonando il Musico & cantando insieme
in un tempo. Ma siami in fauore quello, che hò discorso nel cap. 9. del lib. 8
sopra quell'Istrumento, che si chiama Ciembalo; & di più quello, ch'à questo mio proposito è detto dal Poeta:
. Ilperche in cotal maniera il Suono sarà diuisibile
nella sua duratione; come la Linea nella sua lunghezza: ma non si potrà giamai
diuidere (sopposta anco la duratione in un Tenore) nella larghezza, che importa distantia di suono graue & di acuto; come anche la Linea; percioche sarà
page 77
uno & equal Suono & d'uno istesso Tenore. Laonde essendo il Suono fatto nel Tempo, & essendo il Tempo diuisibile; cosi anco è diuisibile il Suono: & perche il Suono è cagionato dal Moto, & il Moto hà il
suo principio dallo Istante; ilquale è simile
al Punto, dalquale la Linea hà il suo principio; però il Suono inquanto è indiuisibile come è il Punto nella Linea, si dee
intendere nella longhezza & non altramente: essendoche si come il Punto non è lungo ne largo ne alto; ma dal suo Riportamento da un luogo all'altro fà la Linea, che è conclusa tra due punti estremi, laquale è solamente lunga; cosi il Suono, che da se stesso non è graue, ne acuto; se
non è riportato in luogo diuerso; diremo cosi; & fuori del suo orizonte; non è lungo ò corto; se non per la duratione del
Moto, dalquale ello nasce. Però quando
dico, nel Suono cascare il Tempo nella duratione; cotal Tempo è necessario
che sia ò lungo ò breue, rispetto alla misura di esso Tempo, il che non si può negare; percioche il Suono secondo la duratione,
se 'l contenerà nel Metro ò Verso (per
essempio) due Sillabe lunghe, che faranno due Tempi lunghi; ilche contiene lo
Spondeo; come à dire, A¯gnus¯. questi due tempi si trouano diuisi in quattro
Tempi breui equiualenti à i due sudetti lunghi, in una istessa Quantità & duratione; cioè, in uno Proceleumatico; come, Do ˘. cu ˘. i ˘. mus ˘. ouer si come, Pa ˘. ri. ˘. e ˘. ti. ˘. busquepremunt arctis; che si troua appresso di Virgilio
Geor. 4.
Aenei. 2.
& 5.
tre fiate, & contiene Quattro Sillabe breui, che sono equiualenti allo Spondeo. Et
se bene ei dice, che 'l Tempo & la tardanza, non è considerato dal Musico, ma
dal Rhytmico, questo è detto fuor di ragione; essendoche solo al Musico s'appartenga il considerare i Suoni & le Consonanze, & anco il Moto numeroso, che
consiste nel Mouimento che si troua tra quelle parti, che contiene la Υ῾πόκρισις;
cioè, l'Attione; molto necessaria al buon Oratore; & tra quelle della Προσωδία;
ouer'Accento; nellequali sono numerate tra l'altre il Graue & l'Acuto, con il
Lungo & il Breue; cose che si usano nella buona Pronuncia; dallaquale si forma
la Musica Rhythmica, sottoposta alla Scientia della Musica: percioche cotali
Accenti uengono dalla detta Pronuncia della Oratione, che sono cose (come
hò detto sottoposte à questa Scientia, dellaquale essa Rhythmica è una Specie;
come hò dichiarato nelle Istitutioni;
par. 1.
cap. 9.
& consiste nel Mouimento della persona, come si scorge in quelli, che danzano ò ballano. Et quando dice, che 'l
Tempo breue è indiuisibile al Rhythmo, come l'Vnità ne i Numeri & il Suono nell'Harmonia, dice bene; percioche appresso il Rhythmico non è cosa alcuna che sia sotto 'l Tempo breue, perche è come Elemento; & sotto 'l Suono,
come principio & primo Elemento de gli Interualli & delle consonanze, non
ui è cosa alcuna; essendoche non si troua cosa che cada prima di lui sotto l'Vdito. Et perche la lunghezza & breuità cadono sotto 'l Tempo, è necessario,
che siano almeno diuisibili come hò detto, secondo la duratione; percioche il
Principio & il Fine del tempo sono rinchiusi tra due Istanti; i quali uniti insieme (se far si potesse) non farebbono Tempo alcuno; per essere gli Istanti
indiuisibili, che non si possono porre insieme. Laonde misurandosi il Tempo, è necessario che ui sia una misura minima, dalla quale ei sia misurato;
poiche in tutti i Generi ue n'è una prima (come insegna il Filosofo
2. Caeli. 28.
& Metap.
10. tex.
3. & 4.
) che
è misura di tutto quello, che si troua in quel Genere, quantunque cotal
cosa si potesse diuidere in molte altre parti minori di lei. Il perche si può
dir con ragione; che si come il Logista ò Computista (come fù dichiarato
nel cap. 8. del Libro precedente) prende per suo Principio quella Vnità per
indiuisibile ne i suoi computi, ch'è materiale & diuisibile, & non è quella che
intende il mathematico, ch'è separata dalla Materia; cosi quel Suono che prende
page 78
il Musico per indiuisibile & come suo principio ne gli Interualli & nelle Consonanze, non è quello che ei intende Diuisibile nella Duratione. Et se ben al Salines pare, ch'io non habbia inteso che la duratione sudetta non si possa far da un
solo Suono, ilche uuole prouare con l'autorità di Boethio; parmi ch'egli non
habbia ne letto, ne ueduto il cap. 11. della Seconda parte delle mie Istitutioni;
perche haurebbe conosciuto troppo bene, che questa dottrina hò imparato
da questo autore. Et forse anco che non si è ricordato, che si può intendere
questo termine Indiuisibile per l'Atto & per la Potentia: onde sapendo quello
ch'importa Principio, & essendo il Punto principio della Linea; non ha parte
alcuna, ne in lunghezza, ne in larghezza; onde non è diuisibile ne in atto, ne
in potentia per duratione, quantunque nel Sito sia permanente. Ma il Suono
se bene è principio della Modulatione, è diuisibile però nella sua duratione ò
nel Tempo ch'ei porta seco; come hò mostrato. Et quantunque il Tempo breue è principio ò misura del Lungo; per esser'Elemento della compositione de i
Piedi ne i Versi; secondo che è Principio & Elemento, è indiuisibile; ma in quanto importa semplicemente Tempo quantunque
breue, poi c'hà per termini estremi due Istanti; potrà sempre esser misurato da un Tempo minore. Vuole anco il mio Salines ch'io mi sia doppiamente ingannato; perche la Musica Piana
& la Figurata, com'ei dice, & la Rhythmica & la Metrica equalmente sono naturali & arteficiali; ne io dico però altramente nel cap. 5. & nell'8. & nel 9. del primo delle Istitutioni. Maggiormente ancora dice, perche io penso che la Piana
& la Figurata si trouino nelle Figure ò Note, & nelle Parole; ma la Rhythmica
& la Metrica solamente nelle Parole; come nella Oratione soluta & ne i Versi;
Ilche dice egli, dimostrando che 'l Padre Santo Agostino dica non esser cosi;
distinguendosi la Grammatica dalla Musica per questo; che la Grammatica considera la lunghezza & la breuità delle Sillabe nelle Parole poste ad arbitrio dell'Huomo; & la Musica considera il Rhythmo naturalmente essere in molte altre cose; quantunque egli habbia detto, che il Rhythmo non sia considerato
dal Musico; & essi Metri non minormente si ritrouano nelle Modulationi che si
fanno senza parole, che in quelle che le contengono. Ma questo mio dolcissimo
Amico, per quello ch'io m'accorgo, non hà mai ueduto quello, ch'io scriuo ne
i sudetti tre Capi; ne i quali dimostro chiaramente, che queste sorti di Musica
Piana & Misurata si fà secondo 'l Tempo dimostrato con alcuni Caratteri ò Figure poste sopra alcune Linee ò Spacii, che ci rappresentano il Suono ò la Voce,
con la Velocità ò Tardità del tempo; percioche in cotal cosa & molt'altre (il
che si dee tenere à memoria per sempre) si usano i Segni per le cose Significate. Ma ei non si ricorda, che nel fine del cap. 9. sopranotato adduco in mio fauore la ragione del sudetto Santo dottore; & concludo, queste due sorti di Musica potersi anco attribuire alla Musica arteficiale; percioche ogni giorno udimo al suono d'uno Istrumento accommodarsi uarie sorti de Versi ò Metri; secondo 'l numero ò tempo numeroso, che si comprende nel Suono. Et forse,
che da questo ei prese argomento, c'habbia uoluto dire, che la musica Rhythmica & la Metrica non si potesse udire, sonando il Musico & cantando insieme
in un tempo. Ma siami in fauore quello, che hò discorso nel cap. 9. del lib. 8
sopra quell'Istrumento, che si chiama Ciembalo; & di più quello, ch'à questo mio proposito è detto dal Poeta: Numeros memini, si uerba tenerem;& questo basti. page 79
Del Colore terzo accidente ò passione del Suono, & della Modulatione ò Canto, & delle sue Parti appresso i Musici antichi.Cap. XVII.
 gli antichi Musici si come anco sono
stati in molte altre cose più diligenti de
i nostri; cosi anco sono stati intorno
le cose della Musica, massimamente nell'essercitio del Modulare ò Cantare osseruarono, che in ogni Canto perfetto si ritrouauano Quattro specie di Modulatione; la prima dellequali era detta Α'γωγὴ, come conducimento, dirò cosi; & era,
quando in essa si trouaua un certo progresso ordinato ne i Suoni, che si seguitauano l'un l'altro per grado; & questa conteneua tre parti, dellequali la prima era
quella, che procedeua per una determinata consequentia procedendo di grado
in grado, uerso l'acuto; & chiamauano ευθεῖα, cioè, Rettitudine ò Dirizzamento; la Seconda era quella, che procedeua per il contrario uerso il graue pur per
grado, & la diceuano Α'νακάμπλουσα, come Reflesso ò Ritorno; ma la Terza era
mescolata de Suoni che procedeuano uerso l'acuto simigliantemente per gradi;
& uerso il graue per salti; ò per il contrario; & la chiamarono Περιφερὴς, cioè, Circoito ò Ritondezza, come sarebbe quella
che è posta nell'essempio seguente.
gli antichi Musici si come anco sono
stati in molte altre cose più diligenti de
i nostri; cosi anco sono stati intorno
le cose della Musica, massimamente nell'essercitio del Modulare ò Cantare osseruarono, che in ogni Canto perfetto si ritrouauano Quattro specie di Modulatione; la prima dellequali era detta Α'γωγὴ, come conducimento, dirò cosi; & era,
quando in essa si trouaua un certo progresso ordinato ne i Suoni, che si seguitauano l'un l'altro per grado; & questa conteneua tre parti, dellequali la prima era
quella, che procedeua per una determinata consequentia procedendo di grado
in grado, uerso l'acuto; & chiamauano ευθεῖα, cioè, Rettitudine ò Dirizzamento; la Seconda era quella, che procedeua per il contrario uerso il graue pur per
grado, & la diceuano Α'νακάμπλουσα, come Reflesso ò Ritorno; ma la Terza era
mescolata de Suoni che procedeuano uerso l'acuto simigliantemente per gradi;
& uerso il graue per salti; ò per il contrario; & la chiamarono Περιφερὴς, cioè, Circoito ò Ritondezza, come sarebbe quella
che è posta nell'essempio seguente.
 La seconda specie era, quando nel modo del cantare si trouaua una scambieuole positione d'Interualli, che chiamauano Πλοκὴ, quasi che uolessero dire Complicamento ò Abbracciamento; & la Terza consisteua in una reiterata percussione, fatta spesse fiate, che chiamauano Πεπλεία, quasi uolessero dire Giuoco;
page 80
della quale si potea comprendere quali Voci ò Suoni erano da porre da un canto, & quante fiate; & da quali si douesse incominciare, & in quali dar fine: Ma
la Quarta era una continua statione de Suoni ò Voci in un istesso luogo ò Tenore, nelqual si cantauano più sillabe ò parole; & era detta Τονὴ; quasi Fermezza; de i quali modi porremo gli essempi, accioche si possa intendere in parte
almeno, se non in tutto, quello, c'habbiamo uoluto dire.
La seconda specie era, quando nel modo del cantare si trouaua una scambieuole positione d'Interualli, che chiamauano Πλοκὴ, quasi che uolessero dire Complicamento ò Abbracciamento; & la Terza consisteua in una reiterata percussione, fatta spesse fiate, che chiamauano Πεπλεία, quasi uolessero dire Giuoco;
page 80
della quale si potea comprendere quali Voci ò Suoni erano da porre da un canto, & quante fiate; & da quali si douesse incominciare, & in quali dar fine: Ma
la Quarta era una continua statione de Suoni ò Voci in un istesso luogo ò Tenore, nelqual si cantauano più sillabe ò parole; & era detta Τονὴ; quasi Fermezza; de i quali modi porremo gli essempi, accioche si possa intendere in parte
almeno, se non in tutto, quello, c'habbiamo uoluto dire.
 I Latini non hebbero cotali cose in consideratione nel Modulare ò Cantare:
ma li bastaua sapere che cotale atto non poteano far se non in tre maniere; prima proferendo solamente il Suono ò la Voce senza uarietà alcuna, applicandoli una delle nostre cinque lettere uocali A. E. I. O. V. cantando ò Modulando
con lo Spirito solamente, senza muouer la bocca; come si farebbe nel seguente
I Latini non hebbero cotali cose in consideratione nel Modulare ò Cantare:
ma li bastaua sapere che cotale atto non poteano far se non in tre maniere; prima proferendo solamente il Suono ò la Voce senza uarietà alcuna, applicandoli una delle nostre cinque lettere uocali A. E. I. O. V. cantando ò Modulando
con lo Spirito solamente, senza muouer la bocca; come si farebbe nel seguente
 essempio; Forse al modo che faceuano i Sacerdoti d'Egitto; come narra Demetrio Falereo nel lib. della Elocutione; che usauano il Suono delle lor Sette lettere uocali, che sono le seguenti α. ε. η. ι. ο. υ. & ω. quando uoleuano celebrare col
Canto i loro Dei; & le faceuano etiandio udire, quando uoleano imitare il Suono della Tibia ò della Cetera, che usauan l'altre
Genti; per la soauità della uoce, che in se ritengono. Dopoi i nostri Modulauano ò Cantauano (come si fa al
presente) proferendo le Figure del Canto & la Modulatione, con una di queste
Sillabe, Vt. Re. Mi. Fa. Sol. La; secondo l'applicatione di Guido monacho Aretino; come qui si uede.
essempio; Forse al modo che faceuano i Sacerdoti d'Egitto; come narra Demetrio Falereo nel lib. della Elocutione; che usauano il Suono delle lor Sette lettere uocali, che sono le seguenti α. ε. η. ι. ο. υ. & ω. quando uoleuano celebrare col
Canto i loro Dei; & le faceuano etiandio udire, quando uoleano imitare il Suono della Tibia ò della Cetera, che usauan l'altre
Genti; per la soauità della uoce, che in se ritengono. Dopoi i nostri Modulauano ò Cantauano (come si fa al
presente) proferendo le Figure del Canto & la Modulatione, con una di queste
Sillabe, Vt. Re. Mi. Fa. Sol. La; secondo l'applicatione di Guido monacho Aretino; come qui si uede.
 Vltimamente applicauano ad esse Figure cosa, che hauesse qualche significato; come sono Parole contenute in una Prosa ò in Verso; come si uede nell'es
page 81
sempio sequente nella Modulatione di due Versi del Petrarca. Ma i Greci erano soliti, come faciamo noi scriuere sopra un foglio di carta le lor Cantilene,
Vltimamente applicauano ad esse Figure cosa, che hauesse qualche significato; come sono Parole contenute in una Prosa ò in Verso; come si uede nell'es
page 81
sempio sequente nella Modulatione di due Versi del Petrarca. Ma i Greci erano soliti, come faciamo noi scriuere sopra un foglio di carta le lor Cantilene,
 che conteneuano una gran parte di tutte quelle cose, c'habbiamo nominato di
sopra, & ne faceuano una Tauola di pittura ò Essempio; acciò che 'l Cantore
sapesse quello c'hauea da cantare, & lo chiamarono Διάγραμμα; cioè, Descrittione; come è quello della Cantilena. Innanzi al dì dell'ultima partita; ch'io mostrai
ultimamente; la qual si può considerare in due maniere; prima, inquanto che
è descritta & adornata con Caratteri & Figure conuenienti, di modo che si
può cantare; dopoi, inquanto al suo Canto ò Aria, che gioua & diletta gli
Vditori; perche in queste due cose consiste (come ho detto altroue
1. Istit.
cap. 41.
) il Fine
del Musico. Essendoche se bene il Canto da se stesso porge diletto; tuttauia
congiunto all'Armonia delle parole, non solamente diletta; ma gioua anco,
secondo la qualità del Soggetto, che si tratta in esse; come costumi, che si
rappresentano nel cantare: se bene può anco offendere, quanto al Soggetto;
cioè, quello ch'ascolta come dichiarai nelle Istitutioni, non è ben disposto.
Erano etiandio, oltra queste c'ho mostrato, alcun'altre Forme di modulare
ò cantare appresso gli Antichi musici, lequali communemente erano chiamate ἤχων, ouero Strepiti; ma perche non sono di molta importanza, & hauendole trattato assai lungamente nel Terzo libro de Re musica; doue ciascuno
con suo bell'aggio le potrà uedere; però le lascio da un canto, per non esser lungo; & lasciarò la cura ad alcun'altro, di
trattar minutamente simili cose, col
passare à ragionar de gli Interualli, che sono considerati nella Musica nel secondo luogo; contentandomi di hauer detto questo poco del Suono & de i
suoi Accidenti.
che conteneuano una gran parte di tutte quelle cose, c'habbiamo nominato di
sopra, & ne faceuano una Tauola di pittura ò Essempio; acciò che 'l Cantore
sapesse quello c'hauea da cantare, & lo chiamarono Διάγραμμα; cioè, Descrittione; come è quello della Cantilena. Innanzi al dì dell'ultima partita; ch'io mostrai
ultimamente; la qual si può considerare in due maniere; prima, inquanto che
è descritta & adornata con Caratteri & Figure conuenienti, di modo che si
può cantare; dopoi, inquanto al suo Canto ò Aria, che gioua & diletta gli
Vditori; perche in queste due cose consiste (come ho detto altroue
1. Istit.
cap. 41.
) il Fine
del Musico. Essendoche se bene il Canto da se stesso porge diletto; tuttauia
congiunto all'Armonia delle parole, non solamente diletta; ma gioua anco,
secondo la qualità del Soggetto, che si tratta in esse; come costumi, che si
rappresentano nel cantare: se bene può anco offendere, quanto al Soggetto;
cioè, quello ch'ascolta come dichiarai nelle Istitutioni, non è ben disposto.
Erano etiandio, oltra queste c'ho mostrato, alcun'altre Forme di modulare
ò cantare appresso gli Antichi musici, lequali communemente erano chiamate ἤχων, ouero Strepiti; ma perche non sono di molta importanza, & hauendole trattato assai lungamente nel Terzo libro de Re musica; doue ciascuno
con suo bell'aggio le potrà uedere; però le lascio da un canto, per non esser lungo; & lasciarò la cura ad alcun'altro, di
trattar minutamente simili cose, col
passare à ragionar de gli Interualli, che sono considerati nella Musica nel secondo luogo; contentandomi di hauer detto questo poco del Suono & de i
suoi Accidenti.

Terzo Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
Quello che sia Interuallo, & delle sue Specie.Cap. I.
che 'l Consonare & l'Accordare appresso Tolomeo è una cosa istessa; & consonante esser quello interuallo, che nel peruenire all'Vdito, lo ferisce senza offesa; come la Diatessaron; dette perciò significare Symphone;per usar le loro parole formali;
& quelle poiche nel peruenire all'Vdito, la feriscono, non solo senza offesa, ma con dolcezza,dicono ch'accordano;
& sono le Diapente, dette perciò significare Paraphone; l'altre possono quelle, che non solo nel farsi udire, feriscono il senso senza ueruna offesa ò dolcezza tale, che non si desidera più oltra, & tali sono le Diapason; lequali perciò significare le dissero Homophone, ò uolete Antiphone;laqual distintione, dicono, che fà Aristotele. Ma uorrei ben sapere, doue Aristotele & Tolomeo s'habbiano imaginato, non che scritto, questa sottile distintione, che sanno; essendoche Tolomeo nel cap. 7. del Primo de gli Harmonici; doue tratta queste cose, scriue; che sono tre Generi de Suoni inequali; il primo è detto Ο῾μοφώνων; cioè, De gli Vniuoci, dirò cosi, ouer Equisoni; come la Diapason & l'altre, che di quella si compongono; che sarebbe una di quelle la Disdiapason: il secondo è detto Συμφώνων, cioè, de i Consonanti; ne i quali connumera la Diapente & la Diatessaron: ma il Terzo è detto Ε'μμελῶν, cioè, De gli Atti al canto. Dalche si comprende, ch'ei non pose in altro luogo la Diapente, che tra le Symphone; ne meno la Diapason hà collocato tra altri Suoni, che tra gli Homophoni; Dipoi non sò uedere, che pur'una fiata ei facesse mentione delle Paraphone, ne delle Antiphone. Perche se bene Aristotele fa mentione ne i Problema Sec. 19. Prob. 12. 14. & 16. delle Antiphone & delle Homophone, & anco delle Symphone, non trouo però ch'ei faccia mentione alcuna delle Paraphone; ne che mai in alcun luogo facesse cotale distintione, che si possa conoscere & uedere, che 'l Consonare sia differente dall'Accordare; come dicono costoro. Et se Psello nel Compendio della Musica pone la Diatessaron & la Diapente in quel genere di Consonanze, detto da Greci Παράφωνον; & anco pone con Aristotele insieme la Diapason tra quelli del Genere; che chiamano Α'ντίφωνον; aggiungono anco à questa la Diapasondiatessaron, la Diapasondiapente, & la Disdiapason. Ma se hauessero considerato, che 'l Consonare & l'Accordare non è inteso diuersamente da Tolomeo; come hanno detto con poco consiglio & giudicio; ma per una cosa istessa; haurebbono potuto anche intendere, che l'Accordare & lo Discordare, & il Consonare & lo Dissonare sono due cose diuerse & contrarie, & non hauerebbono errato cosi pazzamente; percioche uolendo eglino dimostrar (come stimano) un mio, che credono errore, ne commettono due. Ma lasciamo questo da un canto, & diciamo, che da quello che si è detto potiamo comprendere, che gli Antichi greci insieme con essi noi haueano Quattro differentie de Suoni, tra 'l numero de i Quindeci collocati nel Systema massimo; de i quali alcuni tra loro insieme percossi sono al tutto Asperi & Non atti à far Consonanza alcuna, ne à portare all'Vdito alcuna soauità; laonde sono lasciati da un canto, come sono insopportabili; & meritamente si chiamano Ecmeli; come quelli che non possono esser admessi in alcun buon conserto. Alcuni altri fattisi udire insieme, sono per il contrario al tutto atti à cotale conserto; percioche si trouano per ogni modo soaui & diletteuoli; onde facilmente dall' Vdito sono accettati & admessi, essendoche tra loro tanto commodamente si possono congiungere, che meritamente si possono chiamare Homophoni ò Antiphoni; ancorache siano de Suoni inequali. Ma alcuni altri, quando sono in page 84 sieme percossi offendono minormente con asprezza l'Vdito; percioche l'un di essi essendo più graue ò più acuto dell'altro, commodamente s'acconsentiscono insieme; essendoche peruengono più soaui & più espediti all'orecchie. Laonde anco Diaphoni & Emmeli sono chiamati; come euidentemente sono quelli, che si fanno udire commodamente nell'ordine della Melodia; iquali insieme percossi; quando uengono all'Vdito ottimamente corrispondono, & maggiormente sono atti da esser collocati tra gli Emmeli nella Melodia istessa: Ilperche anco Paraphoni si chiamano; come quelli c'han luogo tra gli Antiphoni, essendoche gli Antichi chiamarono Antiphone le Voci, come quelle che sono più eccellenti de tutti i Suoni; come anco la Voce humana è molto più bella dell'altre; perche nascendo dalla Mente & dalla Intelligentia, è anco articolata: onde è nuntia & ambasciatrice; come uuole Aristotele, 1. Periher. di quelle Passioni che sono nell'anima. Ma quei Suoni prima che si dicono essere l'uno all'altro in Dupla ò in Quadrupla proportione, sono detti generalmente Symphoni, & specialmente Antiphoni; ouer, come si uoglia, Homophoni: dopoi quelli, che sono detti essere in Sesquialtera & Tripla generalmente si chiamano Symphoni, & specialmente Paraphoni. Quelli ancora, che in Sesquiterza & Dupla Sesquiterza si corrispondono, generalmente insieme & specialmente si dicono Symphoni; essendoche per il Genere hanno un nome equiuoco. Oltra di ciò quelli che ne i predetti quindeci Suoni sono numerati Superparticolari nelle loro Proportioni, generalmente Diaphoni, & particolarmente Emmeli sono detti: ma quelli che in tutti gli altri Interualli sono collocati, sono detti tutti Diaphoni generalmente, & specialmente sono chiamati Moti & di Male uoci, & anco Ecmeli.
La Cagione ch'indusse l'Autore à dire, & dimostrare, che 'l Diatono diatonico antichissimo non era quello, c'hoggi si usa nelle Cantilene; ma il Naturale ò Sintono di Tolomeo.Cap. II.
Da niun'altro de i Generi delle Proportioni, dal Molteplice & Superparticolare in fuori, rinchiuse nelle parti del Numero Quaternario, potesse nascere alcuna forma di Consonanza, che fusse atta a i concenti della Musica:Dopoi, che
Quel Genere ò Specie di Cantilena ch'usauano, era il Diatonico diatono:Ilperche haueano tanto per uero, come da gli infiniti loro Scritti si può comprendere; che s'affaticarono con le lor Dimostrationi di far capace chiunque uolesse dar opera alla Musica, che cosi fusse: Per laqual cosa conoscendo io dalle molte esperientie c'hauea fatto, cioè esser impossibile, & non esser uero; cominciai à dubitar molto sopra questa cosa; onde mosso dal desiderio grande ch'io hauea di sapere, se cosi potea essere; hauendomi dato alla contemplatione & inuestigatione di cotal cosa; dopo hauerne fatto infinite proue & dimostrationi; ritrouai per certo, che cotali Propositioni & Conclusioni erano repugnanti alla uerità; percioche se 'l si usaua, come si usa anco al presente, il Ditono & lo Semiditono; essendo il Ditono della Specie Diatonica diatona, che usauano; secondo i loro Principii & Opinioni; contenuto dalla proportione Super 17. partien page 85 te 64. & il Semiditono dalla Super 5. partiente 27. ne i Superpartienti; ouer ch'erano Interualli dissonanti, ò che se erano Consonanti, non erano contenuti da cotali proportioni; & haueano altra forma. Laonde hauendo conosciuto questo non poter esser'à patto alcuno; mi mossi à credere & tener per certo, che la detta Specie diatona à niun modo si potesse usare, ne si usasse. Per laqual cosa incominciai à dimostrarlo in due maniere: prima col mezo della Diuisione della Prima consonanza Diapason, ch'io pigliai per il Tutto diuisibile, & come Soggetto principale di questo mio pensiero, secondo la proportionalità harmonica, & delle sue parti, che patiuano cotale diuisione: dopoi, con la Esperientia fatta di cotali parti, co 'l mezo d'alcuni Istrumenti, ch'io feci fabricare à questo proposito, ridussi il tutto nel desiderato fine. Et se ben dal principio il primo Mezo m'induceua timore; quantunque conoscesse la uerità della cosa; essendoche non si trouaua alcuno, ne de gli Antichi ne de i Moderni; per quello che fin'allora hauea trouato appresso i Scrittori di questa Scientia; c'hauesse nel diuider le Proportioni della Musica, col mezo di cotale Proportionalità, passato oltra la Dupla, forma uera & naturale della Diapason; da Lodouico Fogliano da Modena in fuori; ilqual dimostrò molte Consonanze & Interualli hauer le forme loro nelle proportioni de gli altri Generi ò Specie, ancorache non gli bastasse l'animo d'affermare ò negare che cotai Consonanze & Interualli al suo tempo si usassero; ne dire, che la Specie di cantilena che si usaua allora, fosse la Naturale ò Syntona diatonica di Tolomeo; ne con dimostratione alcuna si fece intendere, che la Specie ch'usauano i Musici in quel rempo, non fusse la Diatona diatonica; tuttauia l'Esperientia madre delle cose, che fu il Secondo mezo, mi daua buon'animo; di modo che ogni giorno certificandomi del fatto; finalmente conobbi, che non solamente i due primi Generi di proportione sudetti; ma in ciascheduno de i Cinque, ch'erano rinchiusi ne i numeri contenuti nel Senario; come dimostrai in molti luoghi; si trouauano le uere Forme delle Consonanze musicali: tanto delle Semplici, quanto delle composte. Ilperche; per non lasciare il Mondo inuolto in questo errore; mi diedi à scriuere & dimostrare; prima, che in tutti i Generi di proportione si trouauano le uere & naturali Forme delle Consonanze della Musica; dopoi, tolsi à dimostrare, ch'era impossibile, che s'adoperasse il Diatono diatonico antico; ma che si cantaua & sonaua il Naturale & Syntono; cosi nominato da Tolomeo. Per laqual cosa hauendo fatto questo palese al Mondo, senza rispetto alcuno; mi apportò nel principio non poco trauaglio & disturbo; percioche mi fù dibisogno rispondere in uoce & in carte à molti, che sopra di questo nuouo Paradosso mi haueano scritto da molte parti; non si potendo eglino risoluere à credere, che cosi fusse; essendoche (com'è uero) niun fin'à quel tempo hauea predicato apertamente questa Verità; ne mai hauea detto, che questa fusse quella Specie, che si usaua, & non la Diatona; ne mai s'oppose alcuno ad alcuno ch'affirmasse, che si cantaua la sudetta Diatona, da me in fuori; ilche conferma anco il mio già nominato Discepolo amoreuole dicendo prima; che
Della Musica s'hauea quella istessa contezza, che delle Indie occidentali; & che in tal cecità perseuerarono gli Huomini, fin'à che il Gaffurio prima, & appresso il Glareano, & poscia il Zarlino;per usar l'istesse sue parole;
Prencipi ueramente in questa moderna prattica; incominciarono ad inuestigar quello, che ella fusso, & à cercar di trarla fuori delle tenebre, oue era stata sepolta.Dopoi dice
di uoler prima di ciaschedun'altra Specie essaminare, come più noua & principale quella, doue concorrono uniuersalmente tutti i Prattici de i nostri tempi; mossi dall'autorità del Reu. M. Gioseffo Zarlino; laquale secondo ch'à lui piace; è il Syntono inci page 86 tato da Tolomeo;dopo laquale essamina, dice,
di uedere, quando gli occorrerà con l'istessa diligentia quello, c'HANNO TENVTO TVTTI: DA LVI IN FVORI; come Guido Aretino, il Glareano, il Gaffurio, il Fabro, il Valgulio, & altri graui Scrittori:Et aggiunge, scriuendo dell'Vso delle Consonanze imperfette, cotali parole:
Et tale opinione, ch'elle fussero l'istesse dell'Antiche, durò nelle menti de gli Huomini, finche uenne il Reuer. M. Gioseffo Zarlino: ilquale con diuerse ragioni hà cercato di dimostrare al Senso & all'Intelletto, che TALI IMPERFETTE CONSONANZE NON SONO IN MODO ALCVNO QVELLE, che si trouano tra le chorde distribuite secondo il Diatono diatonico.Et più oltra seguitando dice:
A quest' Huomo essemplare di costumi, diuita, & di dottrina DEVE IL MONDO, per le molte belle fatiche, ch'egli hà fatto; particolarmente intorno la Musica, perpetuo obligo; dalle quali si trae cognitione d'infinite cose; & SENZA NE SAREBBONO FACILMENTE LA MAGGIOR PARTE DE GLI HVOMINI AL BVIO.Ma presto mutò proposito, O' che gran leggierezza, ò che gran malignità; onde se gli può ben dire senz'alcun rispetto, & con ogni uerità, Volubile, come porta il suo cognome; & quello che dice Ouidio: In Epistola Oeno. ad Paridem .
Tu leuior folijs, tunc cum sine pondere succiImperoche domenticatosi i beneficij, ch'egli dice prima, c'hò fatto al Mondo, ò grande ingratitudine; & la dottrina che di sua bocca confessa d'hauere imparato da me; ò gran trascuraggine; si dimostra dopoi à fatto maligno & ingrato, con queste parole.
Mobilibus ventis arida facta volant.
Quando il Diatonico che si canta hoggi, fusse ueramente quello, che tiene il Zarlino; non perciò gli se ne deue; come di cosa da lui ritrouata, render gratie: auenga che quella tale opinione (ancorache come impertinente, non è approuata) fù con diligentia scritta da Lodouico Fogliano, già sessanta ò settant'anni, nella Seconda settione della Musica theorica; ne altra differentia è fra loro che nella quantità & misura de Semituoni.Et uolendo, come persona urbana, render gratie & splendore anche al Fogliano delle sue fatiche, soggiunge:
Nelqual proposito l'uno & l'altro s'ingannano.Ma quando ben fusse uero; cosa che da i Studiosi di buona conscientia non sarà facilmente creduta; auanti ch'io in cominciassi à scriuer cosa alcuna, & gettare i fondamenti della mia Fabrica; che sono la maggiore importantia d'ogn'altra cosa, per seguitare il resto, cioè, se prima ch'io hauessi scoperto & publicato le uere Forme de gli Interualli di quella Specie di Musica, & detto che la specie d'harmonia, ch'usiamo sia naturale ò Syntona di Tolomeo, co 'l mettere in luce le Istitutioni; io hauessi ueduto la Fatica del Fogliano, che mi sarebbe stato di molto aiuto & di gran contento, come la uidi dopoi; che gran peccato sarebbe stato? quando ei, non solamente non nomina pure una sola fiata il sudetto Syntono; ma etiandio non nomina anche Tolomeo se non nel luogo sudetto una sola uolta. Ma sia come si uoglia, basta ch'ei trattò la cosa per il diritto & come si dee trattare; se bene in molti luoghi della sua opera ei scriue molte cose che non stanno (come si dice) al martello; dellequali hò uoluto se non dimostrare il modo, per ilquale ueramente s'habbiano da intendere dirittamente; senza palesare il suo nome, co 'l uolerlo tassare, passando il tutto con silentio; percioche non è cosa ciuile cosi sfacciatamente scoprire gli altrui errori; ma si ben poco urbana, se bene è usata da molti de nostri tempi, à fine d'esser tenuti dal Volgo huomini di giudicio & di ualore: ma conoscendolo Huomo degno di molte laudi, nel cap. 71. della Terza parte delle Istitutioni, ne hò fatto di lui honorata mentione. Ma forse che questo mio Discepolo disse (per farmi un poco di fauore) che nel Fogliano & me non u'era altra differentia, che ne i page 87 Semituoni, credendo, che questo facesse, che quello c'hò dimostrato della sudetta specie Naturale ò Syntona, stesse altramente di quello che dee stare: Essendoche forse ei non sapea, che se bene è possibile che nel dimostrare una cosa, alcuna fiata molti concorrono nell'istessa conclusione; è però impossibile, che ne i mezi delle dimostrationi; quando bisogna da nuouo trouarli, & sono più di uno; in una cosa istessa possino concorrere. Et tale difficultà nasce; accioche alcuno non si marauigli, perche tallora ui concorre l'intendere più ò meno l'un dell'altro di coloro, che nella cosa istessa s'affaticano: il che può nascere da due cose; l'una dall'atto determinato di colui ch'intende dalla parte dell'Oggetto; & in questo necessariamente tutti uengono ad intenderla ad un modo; come si uede in molte Proposte d'Euclide; che tutti quelli, che l'hanno dimostrate, tendono ad un fine, & spesse fiate usano gli istessi Mezi: Onde s'alcuno la intendesse diuersamente di quello, che l'intende un'altro, non l'intenderebbe per il diritto, & sarebbono differenti non solo nel modo di dimostrare, ma etiandio nella conclusione: L'altra può nascere dalla determinatione dell'atto dell'Intendere dal canto di colui c'hà da intendere; percioche essendo l'uno in questo più disposto ch'un'altro; può anche meglio di lui intendere & esser capace più d'una cosa; come uediamo per esperientia; che s'alcuno haurà la uista più perfetta d'un'altro, sarà anco meglio disposto di lui, nel uedere una cosa lontana. Ma la dispositione dell'Intendere può essere, ò dalla parte dell'Intelletto ch'è più perfetto, ouer dalla parte delle uirtù inferiori, dalle quali esso nostro Intelletto agente se ne serue nelle sue operationi: onde tutti quelli, c'hanno le carne molli & delicate & il corpo loro meglio organizato, sortiscono anco Anima migliore; secondo l'opinione d'alcuni Naturali. Ilperche niun si dee marauigliare, quando alle uolte (se ben di raro) si ritroua, che due Autori conuengono & s'affrontano insieme nella conclusione d'alcuna cosa; se ben discordano molte fiate nelle Dimostrationi, doue con corrono molti Mezi: percioche se non è impossibile, è almen difficile, ch'in ogni cosa s'affrontino. Ma quanto sia urbano & ueridico questo mio Discepolo, & quanta cortesia habbia usato uerso il suo Precettore, dal quale egli hà imparato (com'ei confessa) molte cose; ò troppo grande ingratitudine; ogn'un da questo lo potrà conoscere; che fuori d'ogni proposito, nella Tauola ch'ei fa del suo Trattato; senza far mentione alcuna in esso di lui, scriue queste parole;
Gioseffo Zarlino si attribuisce per sue molte cose, che non sono;oltra che molte fiate nel margine assegna molti errori, & manifesti mendacii; iquali non si trouano nelle mie Opere; tra i quali, accioche da uno se ne conosca molti; il Primo d'ogn'altro è posto nel margine del sudetto Trattato & dice:
Quale sia, secondo 'l Zarlino, la specie che si canta hoggi; nel Ragionamento quinto delle Dimostrationi, alla Definitione terza:nel qual luogo, tanto parlo io di questo, quanto del reame del Pretegianni ò del Giapan. Hora per ritornare al mio proposito, dico; che la Discordanza ch'io trouai tra le cose ridotte in atto & quelle che sono esplicate ne i Scritti di coloro, c'hanno scritto della Musica; mi diede occasione di creder prima, & dopoi di cercar di farmi certo con uere ragioni & dimostrationi, che 'l Diatono diatonico antichissimo, per modo alcuno non era quello, che si usaua à quei tempi, ne anco à nostri; ma si bene il Naturale ò Syntono già tante fiate nominato; ilquale contiene quelle Consonanze, c'hanno le lor uere & naturali forme tra quei numeri, che sono le parti del Senario, primo Numero perfetto; come infinite uolte hò detto. page 88
Come le uere & naturali Forme delle Consonanze si possino arteficiosamente ritrouare & udire in atto, col mezo del Quadrato geometrico; & che tra loro conuengono per ragioni ò proportioni di quei numeri, che per natural dispositione sono contenuti nel Senario.Cap. III.
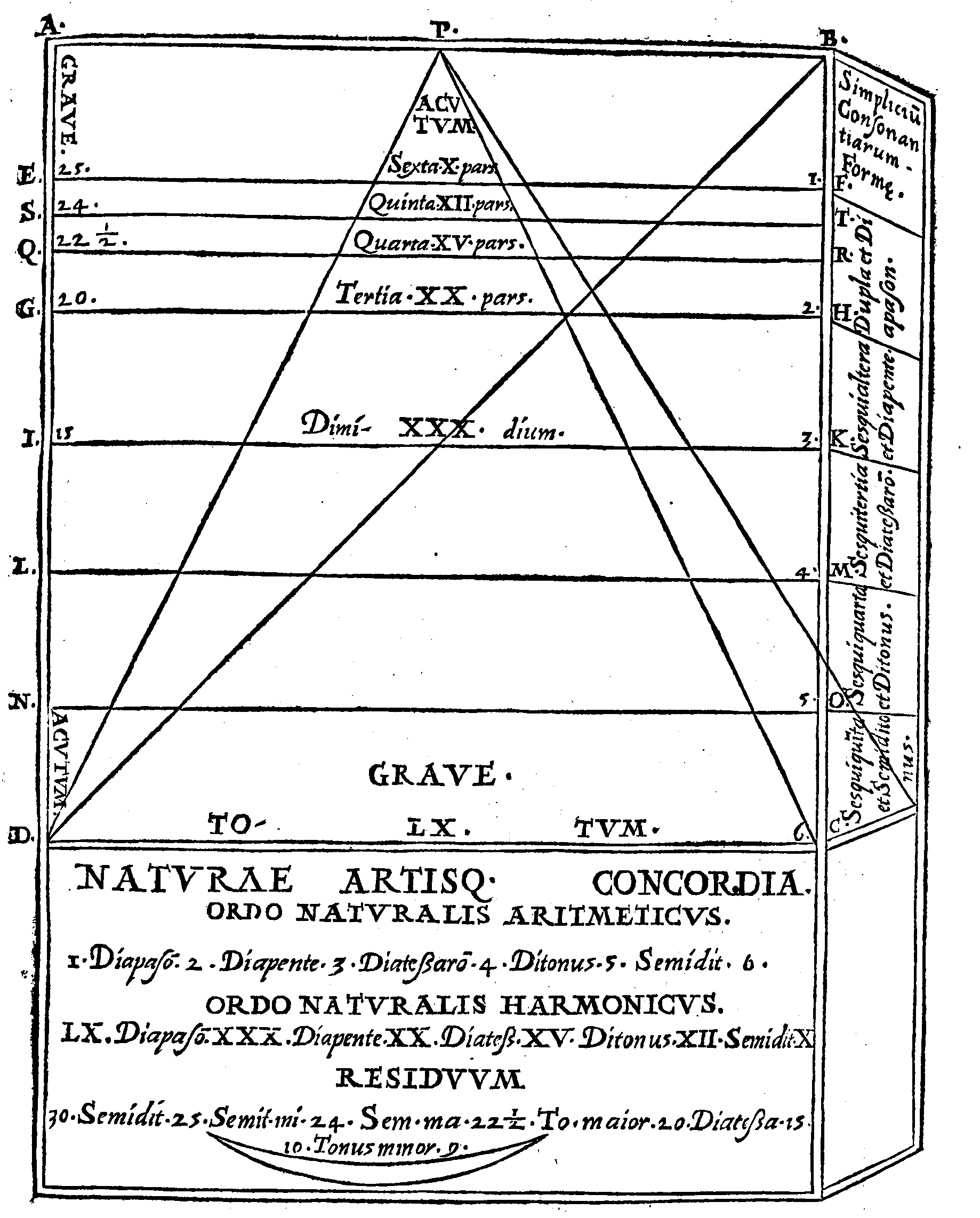
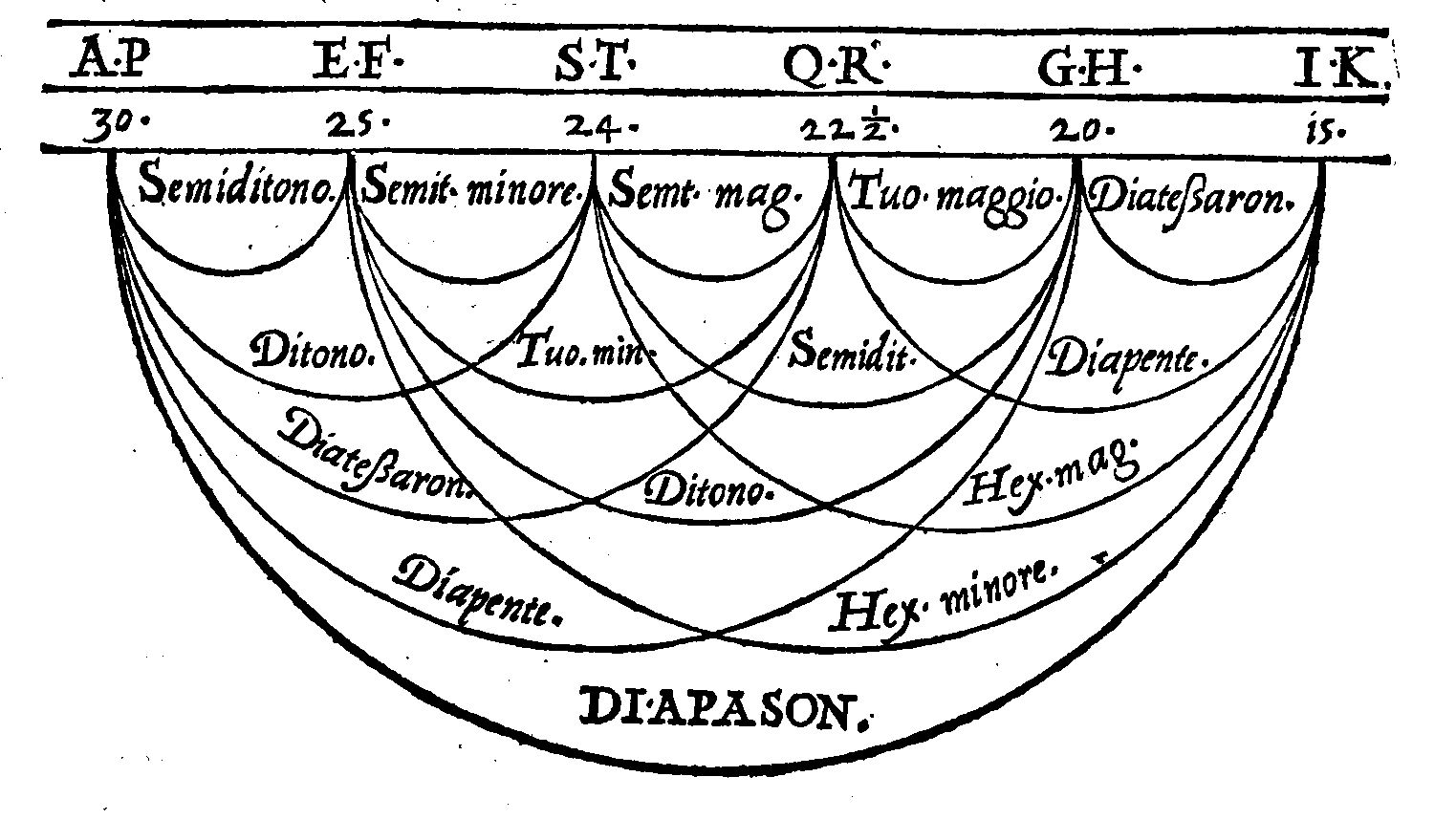
Vostra Sig. nel cap. 3. del primo delle Istitutioni dice; che l'Imperfette consonanze della proportione & forma che le contiene il Genere diatonico Diatono, sono in tutto dissonanti; & consequentemente non possono esser quelle, ch'al presente usano i moderni Contrapuntisti nelle lor Cantilene; poiche s'accordano; ma si bene quelle del Syntono di Tolomeo; per esser tale in questa Specie la natura loro; la qual cosa insieme con quello che segue, afferma l'istesso Gentil'huomo nel suo Discorso; come la può di nuouo uedere in esso. Vero è, che non dice, che gli Interualli consonanti habbiano ad esser contenuti tra le parti del Senario; come recita V. S. R. in quel luogo; anzi confessa, di cotal cosa NON NE HAVER MAI TROVATO MENTIONE APPRESSO ALCVNO DE GLI ANTICHI SCRITTORI. ouer ch'hauendola mai letta, gli è di memoria caduta; & de i Greci ne ha ben letto con accuratezza Quindeci ò Sedeci, oltra à molti Fragmenti; & de Latini, quanti mai ne hà potuto hauere. Ilche si può uedere, quanto questo era lontano dalle menti di quei Antichi musici.Ma quanto in questa cosa, c'hora hò dimostrato, si scopra maligno (per usar questa parola) lo uederemo da quello che segue.
In qual maniera sia stata calonniata la sudetta Inuentione, & mostrate che non sia dell'Autore.Cap. IIII.
Donde crediamo noi, c'habbiano tratto i Musici d'hoggi questa cosi sottile consideratione; che tra le Parti del numero Senario sia contenuto ciascun semplice & parte de i Composti musici interualli consonanti?Et seguita;
Il considerar l'ordine, per ilquale sono poste le Proportioni nel secondo Genere di maggiore inequalità, detto Superparticolare; tengo per fermo, c'habbia porto loro questa si fatta occasione; con hauere accoppiato i Diece primi Interualli à due à due, per ordine naturale; & ridottogli poscia ne i minori termini loro, nell'essempio che segue,con l'aggiungerui una Chiosa cauata dal cap. 15. & 16. della Prima parte delle Istitutioni; che dice cosi:
Numeri disposti secondo la natura del genere Superparticolare; tra i quali si troua in atto la Forma, non solo di qual si uoglia semplice musicale Interuallo; ma in potentia ciascuno de i misti & composti: Et chi più oltra andasse, trouarebbe ancora quelli, che contengono il Maggiore & Minor Semituono: iquali Numeri, quando fussero altramente considerati, si haurebbe la Forma di qual si uoglia altroMa qual cagione, di gratia, poteua addurre, che fusse più sciocca di questa? quasi che non fusse stato più facile il conoscer cotal cosa ne i Numeri semplici, contenuti dal Senario, & Contraseprimi, che sono termini Radicali delle forme ò Proportioni delle Consonanze, quando si seguono l'un l'altro per ordine naturale, come fanno questi. 6. 5. 4. 3. 2. 1; che tra i numeri Tra loro composti, che sono collocati in questo suo essempio. Quando egli hauesse detto, che si hauesse hauuto cotale consideratione dal Quaternario, numero tanto celebre appresso i Pithagorici; nel quale sono contenute tutte le Forme delle Consonanze, che chiamano Perfette; forse che si haurebbe accostato al douere; & se gli haurebbe potuto prestar fede: ma che hà da fare cotesta cosa con quell'ordine? Chi è colui, che non ueda, che dall'ordine c'hò tenuto nel far le Diuisioni delle Consonanze col mezo della Proportionalità harmonica, dallaquale mai non mi son discostato; non siano nati cotali numeri? ilche dimostra il cap. 13. della Prima & il 39. della Seconda parte delle Istitutioni; doue hauendo conosciuto che nel Quaternario erano collocate le Forme delle Consonanze dette Perfette; potea etiandio conoscere, nel Senario esser poste le forme non solamente di queste, ma delle Imperfette ancora: tanto più, che in esso Senario finiscono i termini di tutte le Consonanze, tanto Perfette, quanto Imperfette; contenute nella lor uera & naturale Forma, ne i loro proprii luoghi; come à ciascheduno può esser manifesto. Ma lasciamo questa cosa uana da un canto, che non è ne uera ne propria, & ueniamo all'altra, laquale è una uanissima Fauola; quando dice, cheInteruallo desiderabile.
Potrebbe anco essere, che si fatta consideratione fusse stata tratta dall'Ottauo cap. del 3. Lib. de gli Harmonici di Tolomeo; ouer dal 14. del Primo del suo Quadripartito; doue esso Tolomeo uà ingegnosamente comparando insieme gli Aspetti de Pianeti, alle forme de gli Interualli musici de suoi tempi, quando dice: Il Tetragono & Quadrato comparato al Trino, fa la Sesquiterza, comparato all'Hexagono ò Sestile, che dir lo uagliamo, fa Ses page 95 quialtera; comparato all'Oppositione, fà Dupla; & con tutto 'l cerchio del Zodiaco, fà Diapasondiapente; ilqual Tutto comparato di nuouo al Quadrato, fà Disdiapason; & comparato ultimamente tre quadrati à due trini, fanno tra di loro l'istessa relatione, che ha 9 à 8.Io confesso ch'io non credea che questo mio speculatiuo Discepolo fusse anco si buono Astrologo: ma s'ei hauesse ben considerato & inteso questa cosa, non n'haurebbe detto parola; percioche quanto ben s'accordino tutti gli aspetti de i Pianeti con le Consonanze; quelli che sono intendenti della Scientia astronomica & della Musica insieme, lo potranno dire. Io aspettaua ch'ei dicesse ancora, che questa sottile Inuentione fusse stato tratta dal numero de i Dodici Duchi figliuoli d'Ismaele, ò de i dodici Patriarchi figliuoli di Giacob; ò forse d'altro Duodenario, che sono molti nelle Sacre lettere; accioche hauesse dimostrato anco, che fusse stato Theologo. Ma che haurebbe importato, se bene io l'hauessi tolta da qual si uoglia cosa, che fusse compresa dal Senario numero? A queste sue ragioni ne soggiunge un'altra assai bella & piaceuole, degna ueramente di un tanto intelletto; che
Tra i sudetti Aspetti non si trouano le Forme delle Consonanze imperfette; perche l'Imperfettione non si permette ne si comporta in cielo:quasi che cotali Consonanze nella loro specie & nella loro forma non fussero perfette, ma discordanti & (dirò cosi) mostruose. Ei però non s'auede, che 'l nome d'Imperfetto non fù introdotto da i Prattici per altro, se non per distinguer quelle Consonanze, c'hanno le Forme loro tra 'l Quaternario; riputato da Pithagorici (com'hò detto altroue) Perfetto; da quelle che l'hanno oltra il detto numero, nel Senario; acconsentendo à questo tutti i Theorici: Et forse le chiamarono Imperfette; & credo che questa sia la uera cagione; perche le ritrouarono Dissonanti nelle lor forme tra i Numeri, & ne i Suoni le udiuano Consonanti; onde pensauano che si usasse la Specie diatona & non la Syntona; come ha creduto il Dottissimo Fabro Stapulense, ilquale di ciò nella Prima & nella Seconda del 3. de i Elementi musicali ne fà non poca marauiglia. Et quando questo mio speculatiuo Discepolo attribuisce al Cielo perfettione, per non ritrouarsi in lui quelli Aspetti, che sono conformi à queste consonanze, s'inganna; percioche questo sarebbe più tosto attribuirli Imperfettione; essendoche i Cieli (come dice la Diuina scritturaGen. 2. ) sono perfetti, & ogni ornamento loro. Oltra di questo, per distruggere questa bella consideratione del Senario, fà ogni cosa accioche insieme molt'altre c'hò scoperto & di nuouo ritrouato, non siano anco credute mie, ma d'altri; onde soggiunge:
Io credeuo, che questa facoltà del Senario fusse interamente un nouo trouato, & credo non essere altramente cosi, laqual cosa mi fà dubitare, che siano dell'altre cose (circa l'Inuentione) che sono antichissime, & ci sono predicate per noue da questo & da quello.Ma da quello ch'ei dice; che potrebbe essere, che tale consideratione si hauesse tratto da tale ò tale cosa; si può conoscer la sua uanità; percioche prima non è inuentione antichissima; dopoi, perche non si troua inuentione, sia qual uoglia, che con l'indrizzo d'alcun'altra cosa materiale non sia posta in atto. Et s'à questo proposito si potesse dire, che non è nuouo concetto, il dire, che le forme delle Consonanze si ritrouino tra quei Numeri, che sono nel Senario; ma che sia cosa antica & della natura; percioche si poteua credere, cotal cosa essere in quell'ordine di Numeri, che contiene l'essempio mostrato di sopra; si potrebbe dire anco, che chi trouò il fabricar le Naui con asse ò tauole & chiodi, non fusse stato l'Inuentore di cotal cosa, ma si bene la Natura; percioche l'Asse & i chiodi con che esse sono fabricate, erano prima in potentia nell'Arbore & nel Ferro, che nell'Arte; & dopoi sono stati ridotti da essa Arte nella forma che si uedo page 96 no. Et di più si potrebbe dire, che colui che ritrouò il fare l'Asse & li Chiodi, non fusse stato l'inuentore; percioche già il Legno & il Ferro erano in essere: & à questo modo si procederebbe in infinito, & non si trouarebbe ch'alcuno fusse stato Inuentore d'alcuna cosa, ma la Natura. Dice anco più oltra; parlando del Quadrato sudetto dimostrato nella 14. del 2. delle Dimostrationi, che
questa non è nuoua inuentione, ma che è cosa tolta di peso dal cap. 2. del. 2. Lib. de gli Harmonici di Tolomeo;& lo dice fuori d'ogni proposito, quasi burlandosi;
di questo gran Mathematico lo racconta per scherzo, quanto al proposito occorreua; per dinotare gli Interualli musicali di quei tempi;che è cosa non degna d'un tanto dotto Huomo & singolare. Però, chi uuol conoscere questo, & s'io m'attribuisco quello, che non mi peruiene, legga nel Proemio della Prima parte delle Istitutioni, & trouerà queste parole formali:
Io hò preso fatica di scriuere le presenti Istitutioni, raccogliendo diuerse cose da i buoni Antichi, & ritrouandone anch'io molte di nuouo.Et nella proposta sudetta, ritrouerà queste:
Auanti ch'io ui dimostri alcuna cosa, ue ne uoglio dimostrare una molto bella, & ingegnosa & forse (dirò cosi) anco nuoua.Onde si uede, che la mia intentione non è stata mai di uestirmi de gli altrui panni, come se miei fussero; ma di raccoglier quelle cose, che trouaua appresso i buoni Autori, & aggiungerui qualche cosa del mio; percioche è impossibile, ch'alcuno non possa ritrouar da nuouo ogni cosa; come hò più uolte detto. Il nominar poi in ogni luogo quelli, da i quali si uà raccogliendo le cose; come forse costui haurebbe uoluto; non solo leua il decoro al Scrittore; ma etiandio rende fastidio à quelli che leggono, come si proua nel leggere le scritture di molti Giureconsulti; nellequali non si uedono altro (se ben'è cosa à loro necessaria) che infinite allegationi di Leggi, di Testi, di Chiose, di Paragraphi, & di nomi infiniti di Dottori; ilche è stato cagione, che mi hà fatto lasciar cotal cosa da un canto: tanto più, perche mi hò anco seruito d'alcuni Scrittori in alcune cose, iquali hanno posto insieme i pareri di molti, che non si trouano in essere; onde io non hò uoluto porre ne i miei Scritti cosa alcuna d'importantia, che (per quanto habbia potuto fare) non habbia uoluto uederla nel fonte, & nel luogo dalquale ella è stata cauata. Ma per ritornare al Quadrato ò Helicon, dissi di dimostrar cosa molto bella & ingegnosa, & forse anco noua; percioche era sicuro, ch'alcuno haurebbe potuto dire, che fusse di Tolomeo, & che io me l'hauessi attribuito: però, se bene in questo mio Quadrato si trouasse il sudetto Helicon, non sarebbe inconueniente: Ma non è l'Helicon istesso, per essere in assai & assai cose alterato; essendoche questo contiene solamente le Forme delle prime & perfette Consonanze & del Tuono maggiore, & quello che contiene non solo le Forme delle prime & perfette; ma etiandio dell'Imperfette consonanze, con l'un & l'altro Hexachordo, col Tuono maggiore & lo minore, & li due Semituoni, com'hò dimostrato. Questo è diuiso in molte parti, secondo le ragioni dell'unità, per ordine naturale, & secondo l'ordine delle parti che si fà nella quantità continua, ilche in questo non appare cosa alcuna di queste. Laonde, si come non si troua Animale, che in molte parti; come nella figura, nella parte Vegetatiua & sensitiua, & forse anco (se uogliamo credere à Galeno) nella Discorsiua, più s'assimiglia all'Huomo, che la Simia, & per questo la Simia non è, ne si può dire Animale rationale ouer'Huomo; cosi il sudetto Helicon non sarà mai, ne si potrà mai chiamare ne dire essere il Quadrato nominato; se bene in alcune cose à questo quello s'assimigliasse; come nel contenere le Forme delle prime Consonanze perfette; ma nelle Imperfette poi, non ui si troua conformità alcuna. Conuiene anco diuersamente nella Diuisione fatta diametralmente page 97 per la linea, che passa dall'angolo superiore posto à banda sinistra, all'inferiore à banda destra; & da quella che cade dal primo angolo, che cade sopra la metà del lato opposto à banda destra; ma non conuien nell'esser diuiso ad un'istesso modo; percioche l'Helicon è diuiso nella sua figura in due parti equali dal diametro ad un modo, & il Quadrato da cotale diametro è diuiso ad un'altro. Quello è diuiso nella superficie in tre Parallelogrammi, che conuengono in lunghezza, ma in larghezza sono differenti; & questo è diuiso prima in tre maggiori Parallelogrammi, che sono tra loro equali; & dopoi quello che è di mezo è diuiso simigliantemente in due minori tra loro equali; di modo che sono Quattro in numero, de i quali i due estremi sono più larghi & simili, gli altri due mezani sono anco simili, ma più stretti de gli altri due; Quantunque tutti siano equali in lunghezza. Non è adunque una cosa istessa il Quadrato della 14. Prop. della 2. delle Dimostrationi & il mostrato di sopra, con la Figura Helicon di Tolomeo; se bene in molte cose conuengono tra loro: se però non fusse da dubitare, che la Differentia costituisca ò nò la Specie.
Che l'Ordine naturale ò natural Sito delle Consonanze non fù conosciuto da Pithagora, ne da alcun'altro de gli Antichi Filosofi.Cap. V.
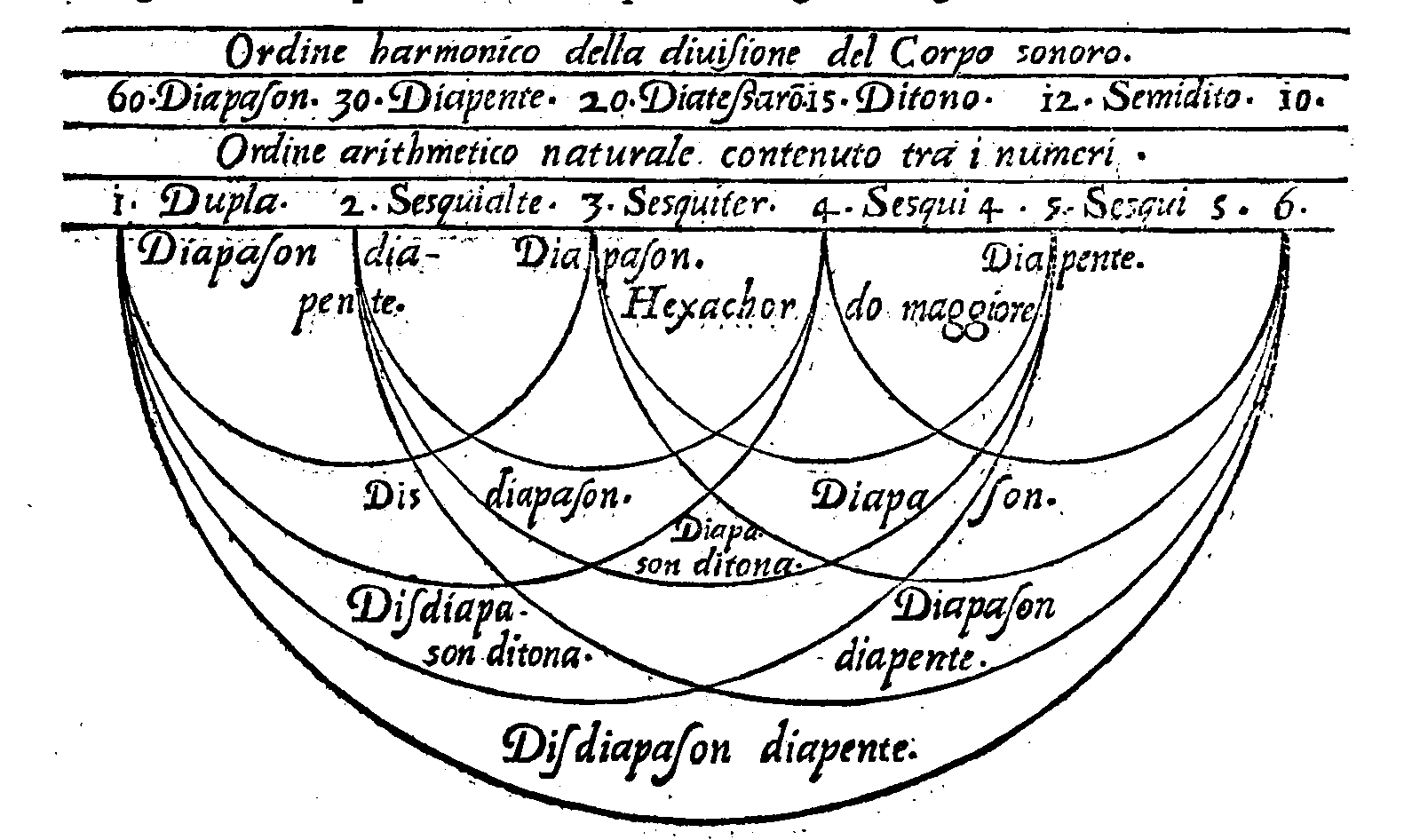
Solutioni d'alcuni dubij fatti sopra quello che si è detto nel Capitolo precedente.Cap. VI.
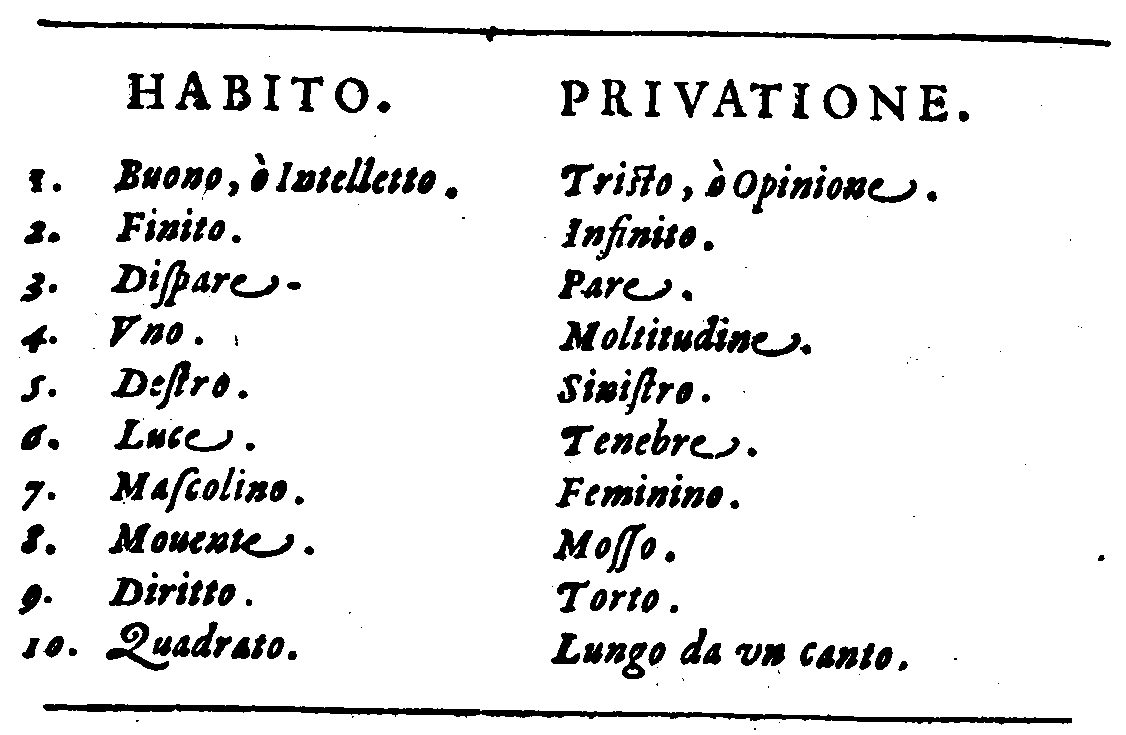
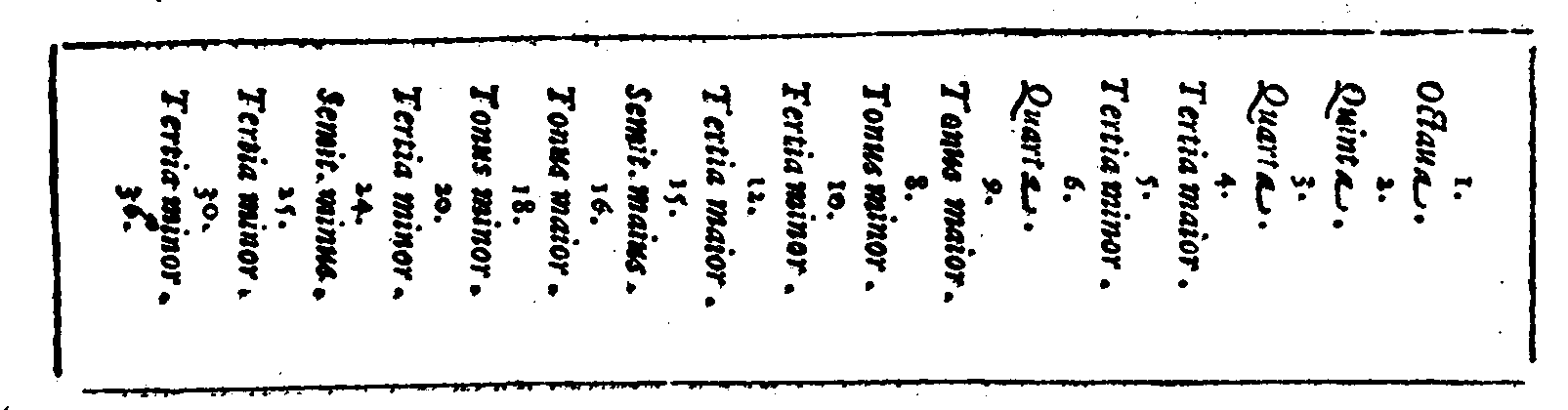
S'è lecito il nominar due Interualli di due diuerse forme ò specie con vn solo nome commune.Cap. VII.
Ispositione del Testo d'una delle Questioni Conuiuiali di Plutarcho, intorno la forma della Diatessaron.Cap. VIII.
Si come quelli, che osseruano la proportione canonica nella Lira, dicono la Diapente consonanza generarsi dalla Ragione ò Proportione Hemiolia, & dalla Dupla la Diapason; & dicono anco, che la Diatessaron, laquale è sopra l'altre fosca, consiste nella Epitrita; cosi gli Harmonici di Dionigio ò Baccho considerarono esser tre le Consonanze; ò per dirle meglio, le Conuenienze che si fanno nel mescolare il Vino con l'Acqua; che sono, la Diapente, la Diatrion, & la Diatessaron; onde dicono & cantano in questo modo.Onde è da sapere, che considerate queste parole nella loro superficie, si potrebbe dire, che 'l Testo fusse falso; & specialmente quello, che stampò già Aldo Manutio uecchio in Venetia, che si troua in alcuni luoghi imperfetto & incorretto; percioche se la Terza mescolanza dell'Acqua col Vino era cosa da quelle persone, che nomina Plutarcho; l'altre due erano quelle, c'haueano possanza di far diuentar l'Huomo ebrio per la crapola, & questo nella mescolanza di due parti d'acqua con una di Vino; & il primo temperamento di due parti di uino con tre d'acqua inducea sonno, & generaua obliuione, dellaquale ei dice, che non si troua la maggior Mescolanza; non può essere, che la Terza mescolanza di page 107 tre con una, potesse esser fatta nella Epitrita; se noi la intendiamo per quella, che chiamiamo Sesquiterza proportione; percioche non conuiene à cotale mescolamento; poiche non fà alteratione alcuna, come fanno le altre; anzi è la più debole delle due narrate. Ilperche è da sapere, che quando Plutarcho narra l'ordine delle proportioni secondo quella setta, ch'ei chiama de Canonici, de i quali n'habbiamo ragionato nel Primo libro, nomina primieramente la prima mescolanza, Diapente, cioè; Per cinque, dal numero delle Cinque chorde, che contiene questa Consonanza nella sua modulatione; & secondariamente la chiama Hemiolia, per la sua forma, ch'è cosi nominata. Per tal modo anco chiama Diapason la seconda; come quella c'hà ragione in tutti gli Interualli che contiene, & la sua forma nomina Dupla; nominando la terza Diatessaron, che procede modulando per Quattro chorde, & la sua forma chiama Epitrita. Dopoi pone, secondo gli harmonici Dionisiaci, i nomi delle lor tre Consonanze; anzi più tosto dirò Conuenienze; delle quali la prima chiama Διὰ πέντε; la seconda Διὰ τριῶν; & la terza Διὰ τεσσάρων; non da alcun termine ò numero di chorde, che contengono come Consonanze musicali, che si adoperano nelle Cantilene, quando si procede per cinque, per tre, & per quattro chorde; ma dal numero delle Parti, ch'entrano ne i sudetti temperamenti; perche nel primo ue n'entrano Cinque; onde si dice cotal Temperamento farsi Διὰ πέντε; cioè, Per cinque: nel secondo uen' entrano Tre; onde dice, che si fà Διὰ τριῶν; Per tre: & nel Terzo uen'entrano Quattro, & si dice farsi Διὰ τεσσάρων; Per quattro. Ilperche dal Testo sudetto si conosce chiaramente, ch'essendo la prima di 3. & 2. nella proportione di numero à numero detta Η'μιόλια, che noi diciamo Sesquialtera; & quella del secondo di 2. & 1. nella Διπλασία ò Dupla; quella del Terzo di 3. & 1. senza dubio par che sia detta fuori di ragione Ε'πίτριτα; se 'l si hà da intenderla per la Sesquiterza. Ma ueramente in quest'ordine cotal parola si dè intendere secondo la mente de i Dionisiaci; non à cotal modo, ma secondo che è detta da Ε'πὶ, che dice Sopra, & da τριτὸς, cioè, dal Terzo & numero Ternario; quasi che uoglia dire, che si pone una parte di Vino, sopra tre di Acqua. Quando adunque Plutarcho parla delle Conuenientie ò Temperamenti sudetti, fatti secondo l'ordine de i Canonici; intende i termini ò nomi delle sudette consonanze, come hò dichiarato, che corrispondeno à quello ch'ei uolea dire, dal numero delle chorde, che contengono; hauendo rispetto à i termini della proportione delle chorde estreme, come si uedono nell'essempio seguente. Et non può esser'altramente, che in queΠέντε πίνειν, ἤ τρία, ἤ μὴ τέσσερα.che uuol dire:Cinque sono da beersi, ò Tre, & non Quattro.Percioche Cinque consistono nella ragione Hemiolia; poste insieme tre parti d'Acqua con due di Vino: Tre, nella Dupla, in una di Vino temperato con due d'Acqua: Quattro, in una di Vino mescolato con tre d'Acqua; & questa proportione ò ragione è Epitrita, & appartiene à Prencipi ò Giudici d'eleuato ingegno, che conuersano nel Prianeo, ouer à Sobrij Dialettici, ouer'Oratori contemplatiui nelle dispute loro. Ma la mescolanza de gli altri di due parti con una, fà diuentar l'Huomo mezo ebrio per la crapola; & lo temperamento di due parti con tre, della quale niuna è maggiormente Musica, senza dubio induce il sonno, & genera in colui che bee, domenticanza di pensieri.
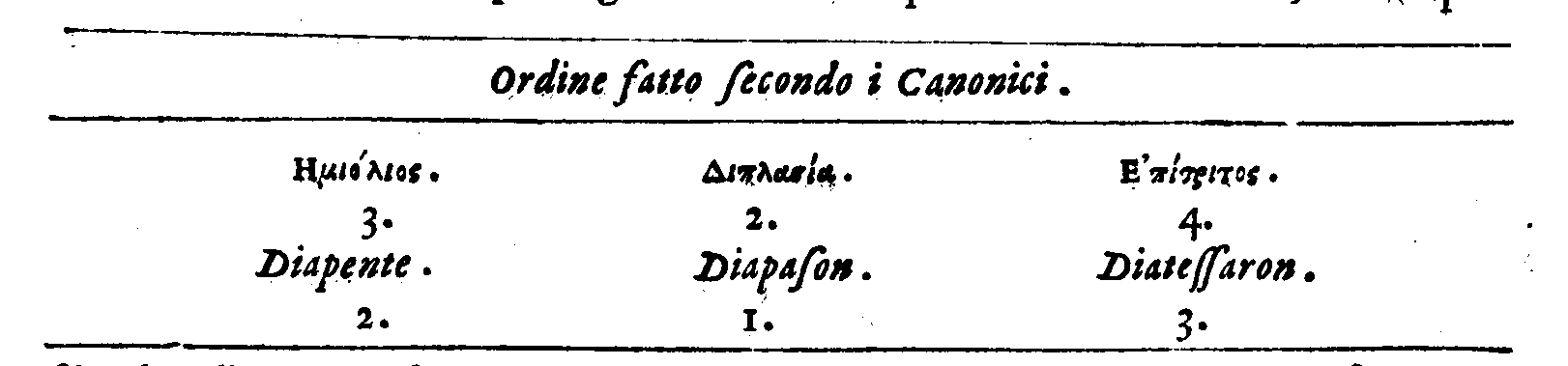
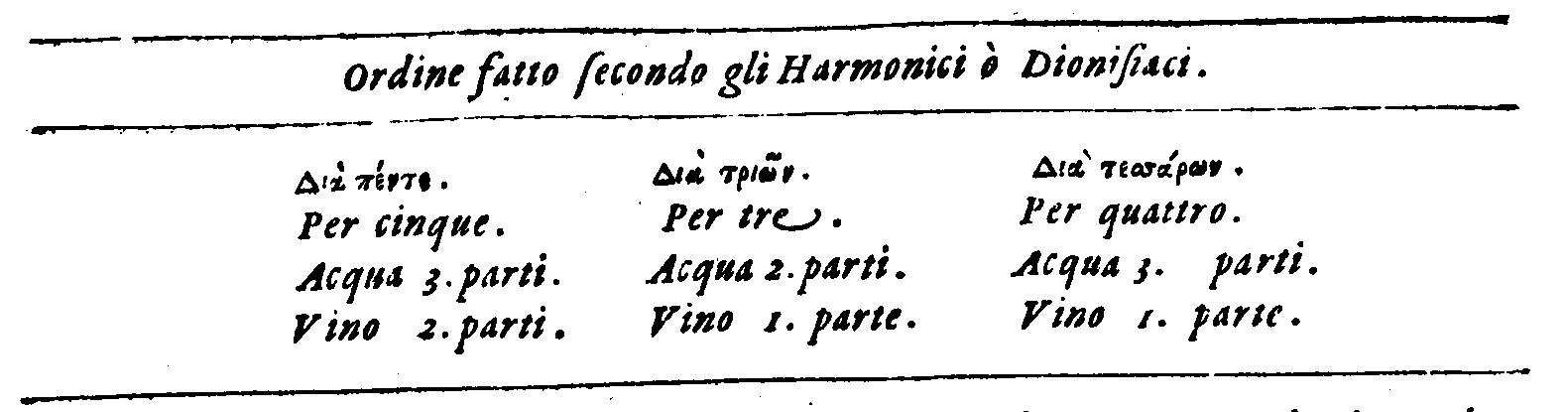
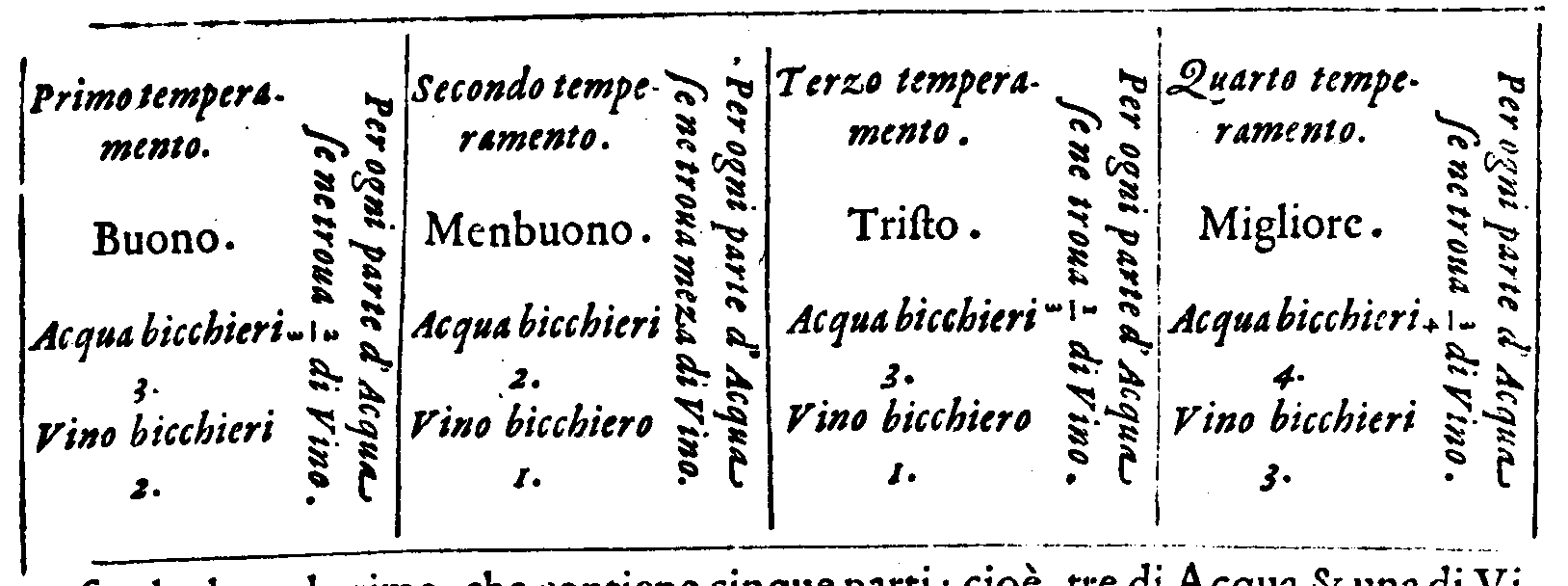
Da che fusse indotto Plutarcho à dire; che 'l Ternario & l'Vnità siano i Termini della Diatessaron;quantuque non dica cosi il Testo, come habbiamo ueduto. Onde dice prima, che
Plutarcho in quel luogo, uuole più tosto esser considerato da Beone & Buon compagno, che da seuero Mathematico; & come in virtù rispondente alle consonanze musicali, & non apunto secondo le proportioni delle Quantità del numero; & in somma come cosa detta piaceuolmente à tauola, & che mostri in certo modo il medesimo effetto, & non l'istesso fatto.Quasi che non fus page 109 se lecito, che in un conuito allegro, non ui potesse esser de gli huomini dotti & sobrij che potessero parlare sobriamente del Vino, come gli piace, come si costuma al presente farsi alle mense de gran Prencipi, & anco di maggiore importanza, & non come fanno i balordi & poco sinceri: Et che anco non fusse stato lecito à Plutarcho, come sobrio, di parlare sauiamente; ma d'introdurre un'altra persona; come è quella d'Aristone, ch'era uno de conuitati; fusse stato ebrio & pieno di uino; & che à lui fusse stato lecito il dir le pazzie. Ma quel suo dir senza proposito:
In virtù rispondente alle Consonanze musicali, & non à punto secondo le proportioni delle quantità del Numero;par che uoglia inferire, che non potesse apunto hauer corrispondentia alle proportioni del numero: il perche non intendendo quello, c'habbia risolto Plutarcho in cotal Questione, hauendo prima à suo modo fatto un Commento sopra le parole d'Aristone; per conclusione, come buon Mathematico, dice dopoi; che
L'intentione di Plutarcho è, di considerare solo il maggior termine di ciascuna proportione delle tre semplici Consonanze; dal quale detrattone, per la parte del Vino una sola Vnità; uuole l'altre che rimangono siano le parti dell'Acqua.Et lo proua con questa sua ragione, dicendo:
Hora perche il termine maggiore della Sesquiterza è 4. dal quale detrattone, per la parte del Vino, l'Vnità; quello che gli auanza per la parte dell'Acqua, è 3. & però uà l'Autore in proposito della Sesquiterza comparando 1. à 3.Ma questa sua chimera non s'imaginò mai Plutarcho; essendo che la comparatione è Tripla & non Sesquiterza; però se è uera questa sua Regola; che cauandone per la parte del Vino l'Vnità dal Quaternario, maggior termine della proportione Diatessaron; ne uenga 3. il che è contra la sua dottrina; una parte d'Acqua nella Diatessaron si uerrebbono à mescolare con 3. di
![3. Diapente. 2.
1
[line]
2
2. Diapason. 1.
1
[line]
1
4. Diatessaron. 3.
1
[line]
3](../../zarsop/ill/308_4.gif)
Puossi ancora dir cosi; delle 4. parti, 3. di acqua; & cosi si uiene à far mentione de i proprij termini della Sesquiterza: ilqual modo di comparatione usato nell'altre Consonanze, torna molto bene:Ma quanto questo sia al proposito, lo considerino i Lettori giudiciosi; percioche se dal 4. termine maggiore della forma della Diatessaron, se ne piglierà 3. per il termine minore; ne resterà 1. Questo stà bene; ma se dal 2. termine maggiore della Dupla si cauerà l'Vnità; ne uerrà Vno di acqua; & se dal 3. termine maggiore della Sesquialtera si leuarà il 2. per il termine maggiore; la cosa non tornerà bene, secondo la sua Regola; come qui si uede. Aggiunge anco nel suo Commento, che 'l
Prouerbio de gli Allegri nonNellequali parole dice due cose; l'una che la Diapason à lungo andare potrebbe portare ubbriachezza; quasi che 'l Vino temperato secondo la Diapente, come si è mostrato, non hauesse più forza di far dormire & leuare il ceruello à coloro, che troppo ne beuessero; che quello che è temperato secondo essa Diapason; percioche secondo questa, ogni bicchiere che si bee, contiene una parte di Vino & due d'acqua; & secondo quella, ogni due parti di Vino, contengono tre parti d'acqua; che tanto è dire; ch'ogni parte di uino ne contenga una & meza d'acqua. Onde non è da marauigliarsi, se 'l Disputante celebrò sommamente quello, ch'è temperamento secondo la Diapente. L'altra cosa, è ch'ei dice, che 'luolea, che 'l 4. s'impacciasse col fatto loro à modo alcuno: ilquale è uno de i fondamenti della Sesquiterza; & era l'ultima & più lontana consonanza del Vino; & cosi la Ses page 110 quiterza & Diatessaron, dal bere loro; ma non cosi diletteuole al gusto, come ricercaua la buona cera, c'hà per fine l'Allegria, & il quasi ricreamento de gli spiriti, senza pericolo dell'ubbriachezza; laquale à lungo andare di Tauola, potrebbe per auentura portarsi dalla Diapason. E però il Disputante celebrò sommamente la Diapente; considerando in essa, come ancora nella Diapason, i termini delle Forme loro sommati insieme, & della Diatessaron solo il maggiore.
Disputante celebrò questo temperamento, considerando nella Diapente, come ancora nella Diapason, i termini delle lor forme sommati insieme, & della Diatessaron solo il maggiore;onde si uede, che non hauendo egli inteso i termini del secondo Ordine, come intender si deono, & come hò dimostrato; hà confuso molte cose di modo che non tornano bene. Ma lasciamo hormai il parlare del mescolamento del Vino con l'Acqua; & ricordinsi i Musici, quelli dico, à i quali è attribuito il nome de Beuitori & amatori grandemente del Vino, quando saranno inuitati à qualche conuito, di quel bello & utile ricordo di Catone,
Vino te tempera;che dice, che dobbiamo dar opera al uiuer sobrio & temperato; temperando noi stessi al Vino, & non mescolando con esso l'Acqua; accioche beuendone troppo ingordamente; essendo tocchi da questo diuin liquore, non diuentiamo uerbosi, & d'alcuno non ci sia detto,
Pauca in conuiuio loquere:percioche il Vino si dee bere parcamente, per utilità & sanità del corpo; & non ad altro fine: essendoche; come dice la Scrittura diuina; è utile alla debolezza dello stomaco; come lo dimostra il santissimo Apostolo Paolo, scriuendo à Thimotheo ; essortandolo ad usarlo, ma poco, per cotale rispetto; & non per compiacere al Senso; come fanno hoggi di una gran parte de gli Huomini: percioche beuuto à cotesto modo, acuisse l'ingegno, allegra lo spirito, & iscaccia la malenconia: tanto più, che quando esso spirito è pieno (dirò cosi) di tristezza; uiene non solamente ad essiccare la carne, ma etiandio l'ossa. Beuasi adunque il Vino à questo fine, & usasi moderatamente, acciò si uenga nel modo che si dee usare à conseruare in noi quello, che sopr'ogn'altra cosa è desiderato in questo mondo da ogni uiuente, ch'è la Sanità; & fuggiamo infinite infirmità, ch'apporta seco il bere troppo auidamente, & senz'alcuna misura. Ilperche hauremo in memoria sempre i due sequenti Versi di Virgilio Poeta celebratissimo, che à questo proposito nel fine di un suo Epigramma dice in due uersi in questo modo.De Venere & Vino.
Vina sitim sedent, natis Venus alma creandisChe uogliono dire:
Seruiat. hos fines transiluisse nocet.
Scaccin 'la sete i Vini, & l'alma Venere
Serui nel generar feconda prole;
Che nuoce il trapassar cotesti termini.
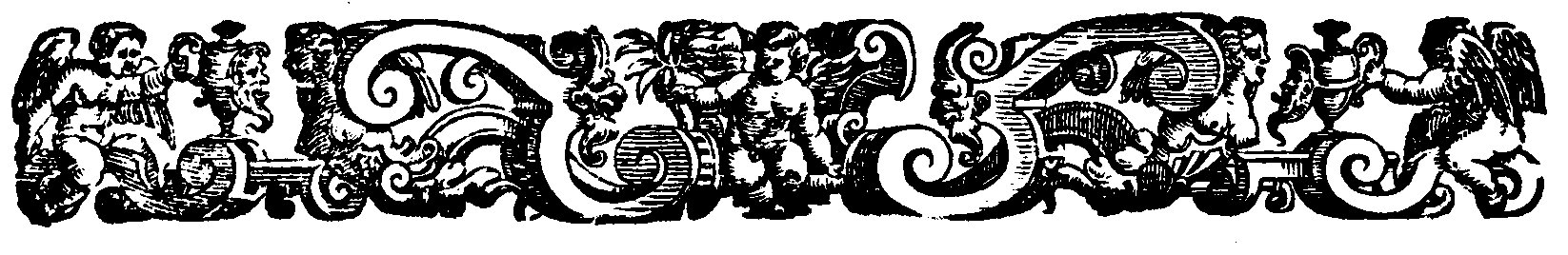
Quarto Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
De i Generi delle Harmonie ò Cantilene, & de i lor Colori ò Specie; & prima di quelle del Diatonico. Cap. I.
Γένος ἐστὶ ποια τεττάρων φθόγγων διαίρεσις.ouer, com'altri dicono, è una certa proprietà ò diuisione ò distributione di quattro Suoni in ciaschedun Tetrachordo. Si può anco dire, che sia quello, che dimostra (dirò cosi) in uniuersale il costume della Melodia ò canto, & contiene in se Tre specie distinte; percioche sono tre sorti di Modulatione, Diatonica, Chromatica, & Enharmonica; alle quali Euclide In Introductorio musicae. aggiunge la Mista ò Commune, che nasce dalla mobilità del Moto, rispetto al Rimanente, de i Suoni mezani, come altroue hò dichiarato; & nel Cap. 16. del 2. delle Istitutioni fù dimostrato, quello ch'era ciascuna di esse. Et perche da i Suoni mutati si fanno le differentie de i Generi & delle Specie; & tali differentie chiamano i Greci χρῶαι; cioè, Colori, che sono differentie particolari de i Generi sudetti: però uoglio prima parlar di quelle cose, che cado page 112 no intorno al Genere & alla Specie, che di quelle che occorrono intorno al Systema; acciò incominciamo con miglior'ordine, & siamo più facilmente intesi. Et se bene i Colori ò Differentie ò Specie, che li uogliamo dire, rationali & conosciuti, sono (secondo 'l parere di Tolomeo) Otto solamente; cioè, Cinque Diatonici, due Chromatici, & uno Enharmonico; tuttauia non uoglio restar di porre insieme, & commemorar tutti quelli, che d'altri ancora sono stati ritrouati & considerati, & posti insieme; & saranno gli Otto seguenti Diatonici, Otto Chromatici, & Sette Enharmonici; che sono in tutto al numero di Ventitre, contenuti tra gli Estremi suoni della Diatessaron: & prima de i Diatonici, de i quali il primo è l'Antichissimo, detto Diatono ò Diatonico; ilquale fù abbracciato dall'uniuersità de Musici, come quello che credeuano che s'adoperasse nelle nostre Cantilene, fin'à tanto ch'io dimostrai esser tutto il contrario; & questo, per maggiore intelligentia, segnarò co i numeri Radicali delle sue proportioni; accio più facilmente da altri si possa conoscere. Ilche farò etiandio
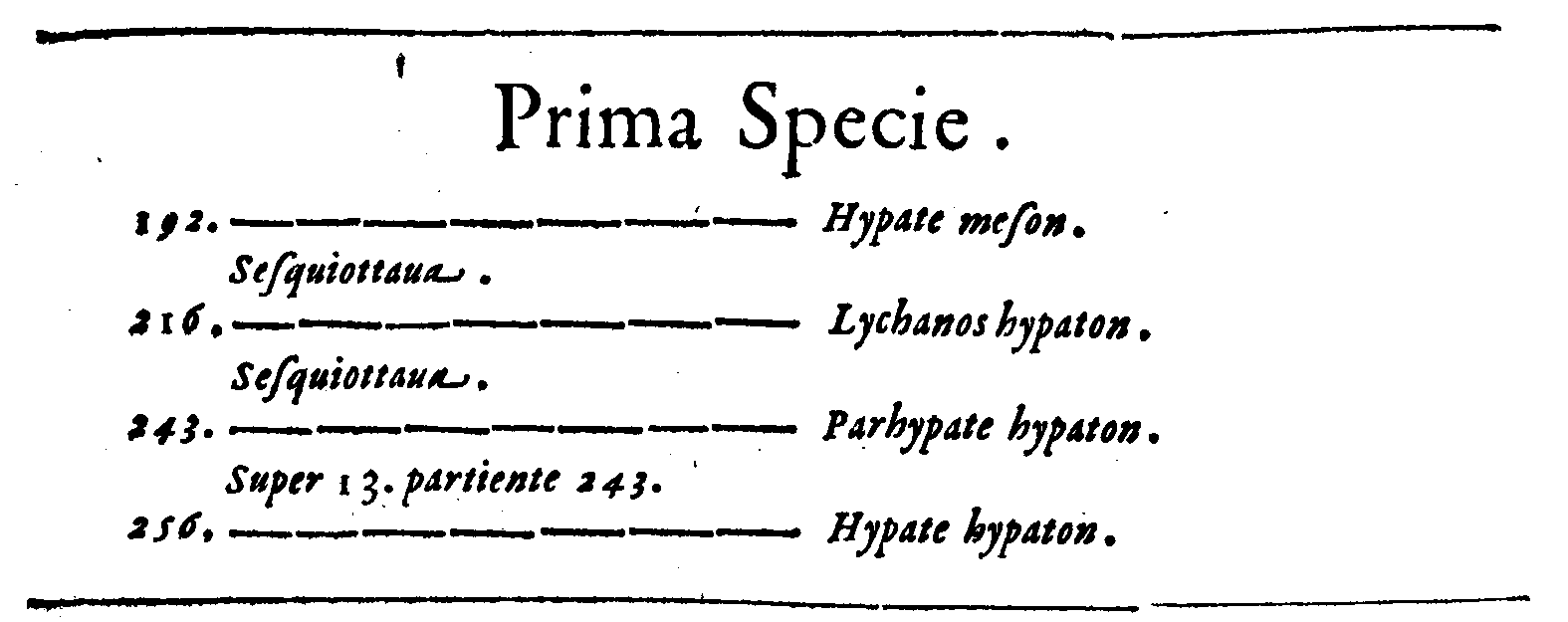
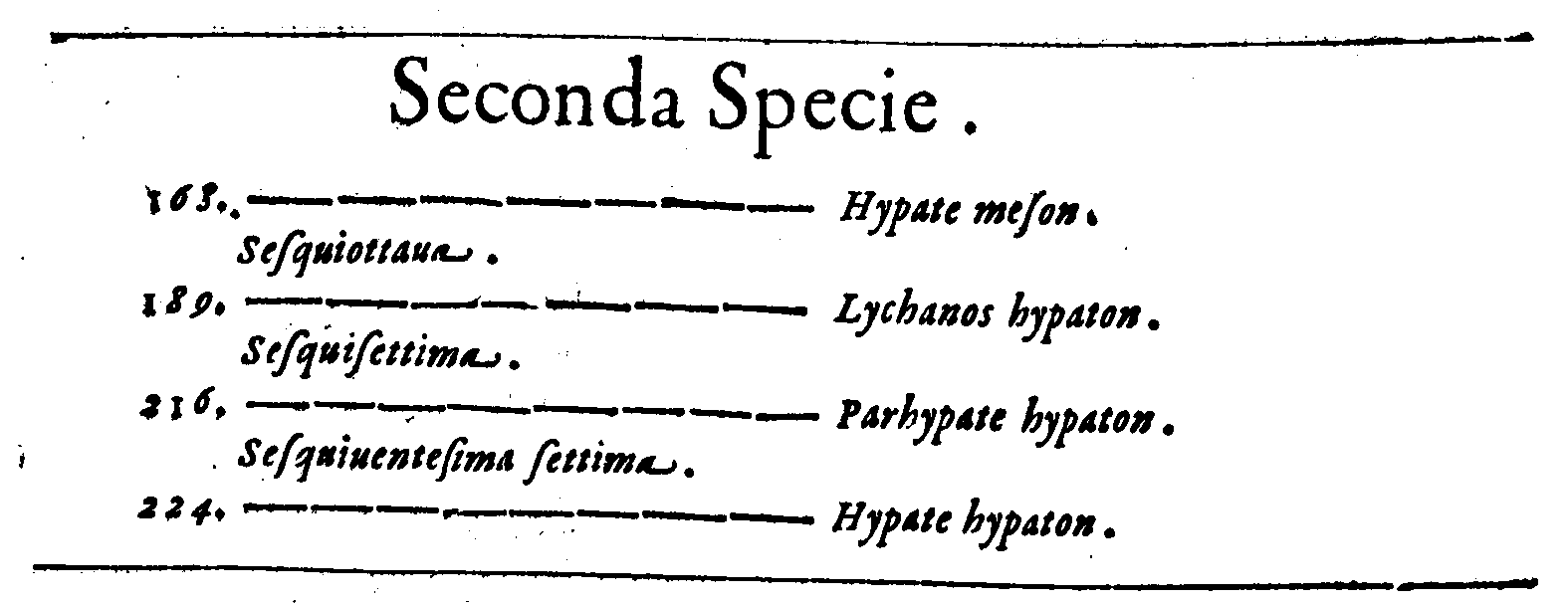
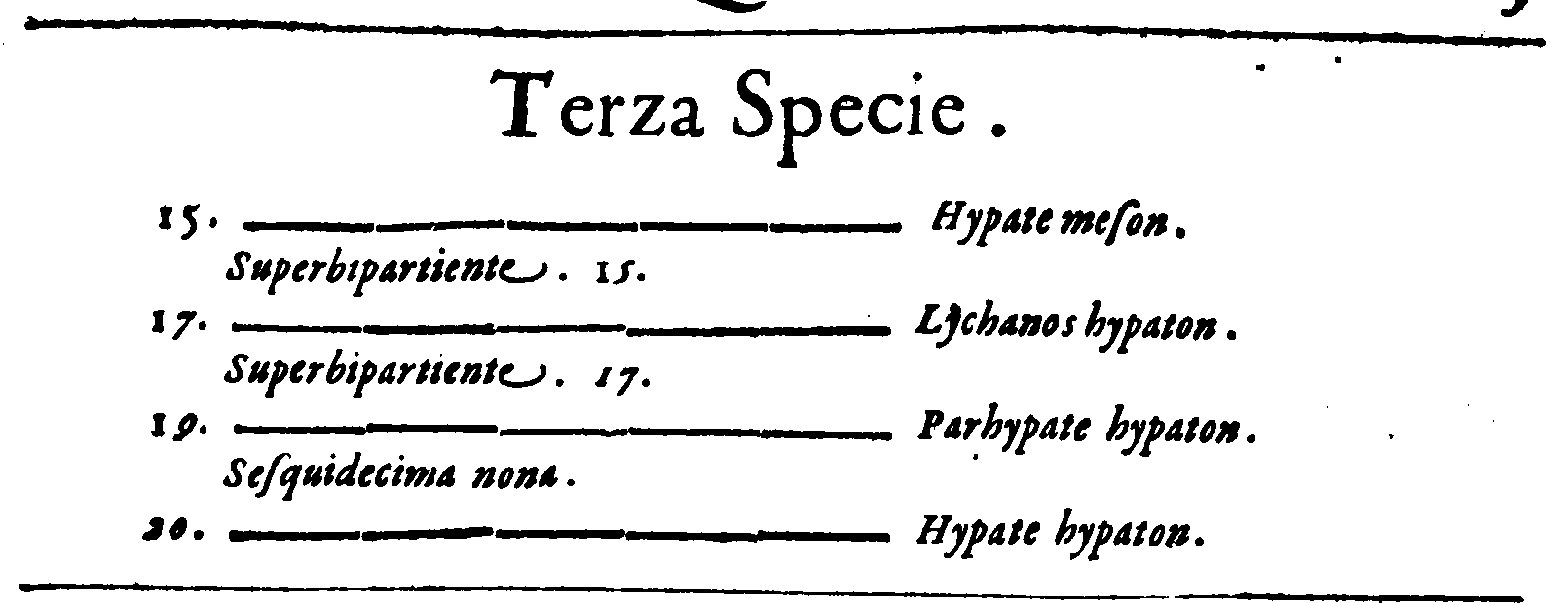
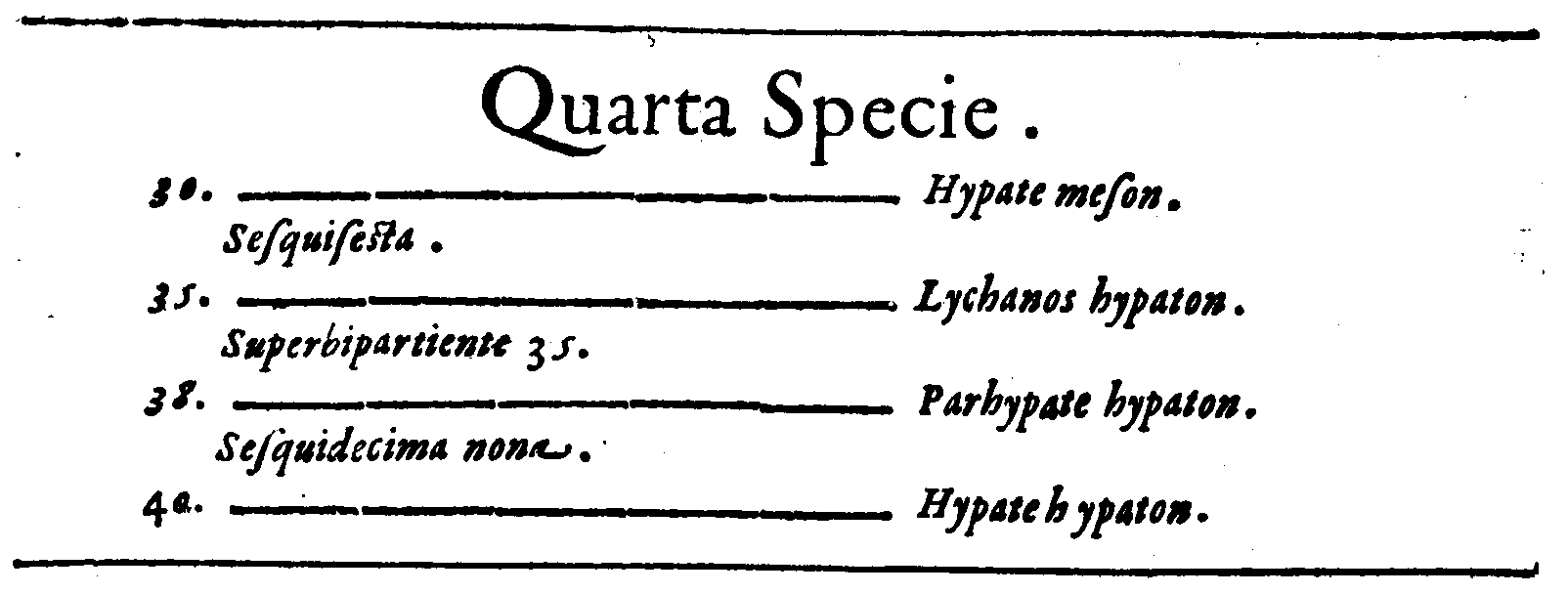
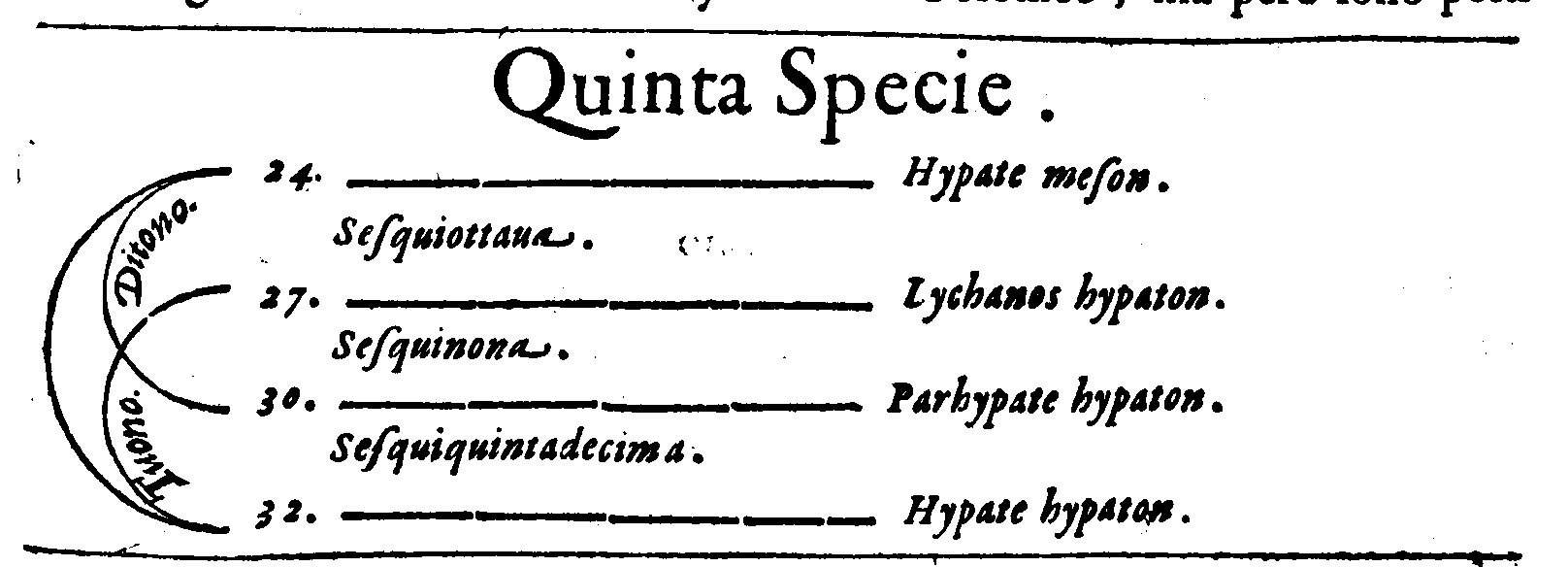
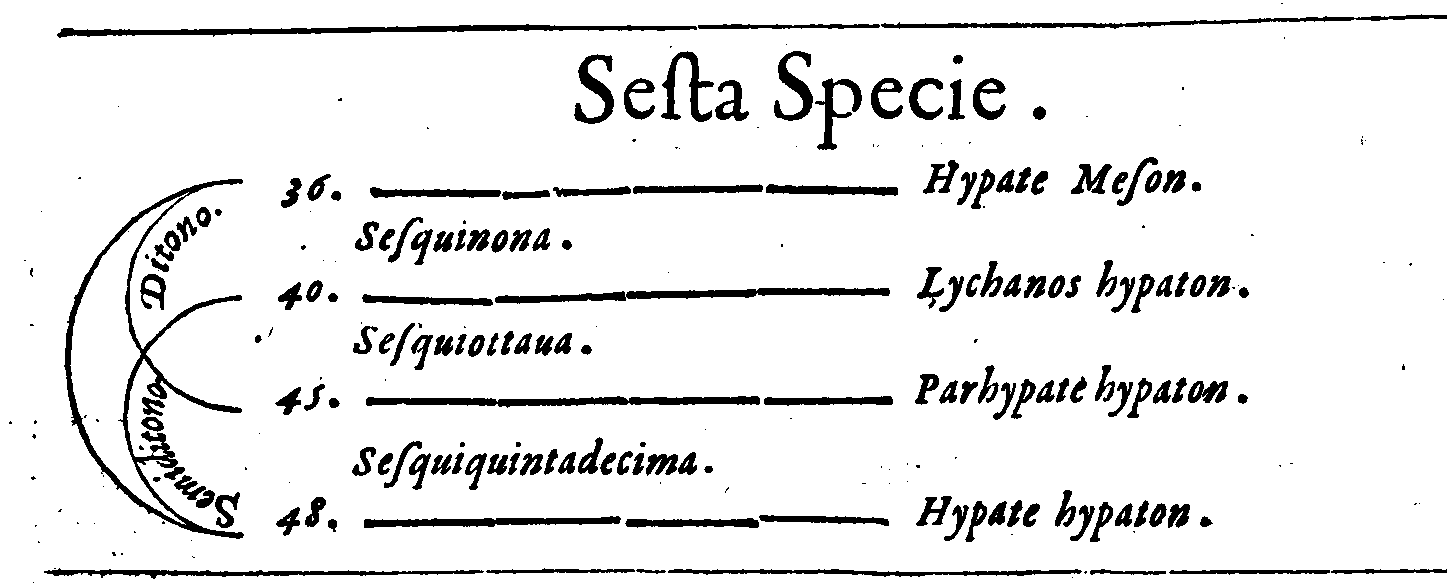
Didimo Pithagorico Musico nobilissimo, fù qualche anno auanti Tolomeo, & fece in ciascun de i tre Generi d'harmonia una nuoua Distributione di chorde; & tra l'altre quella, ch'egli fece nel Diatonico, procedeua in ciascun suo Tetrachordo nella maniera, ch'è quello posto di sopra; che è del Systema il più graue, detto Hypaton. Venne dopo Tolomeo, & mutò l'ordine de i due Interualli men graui di ciascun Tetrachordo; mettendo quello di mezo al luogo men graue, & il men graue nel luogo di mezo; con dire, che al maggiore non conueniua esser iui collocato, ma si bene à quello di lui minore, & maggiore del più graue.Et più oltra dicono:
Dalche potete comprendere, qual sta la parte, c'hà Tolomeo nel Syntono; & à chi si debba di ciò dar l'honore & la palma.Più oltra fuori d'ogni proposito fanno questa interrogatione:
Per qual cagione crediamo noi, che quelli, c'hanno cerco persuaderne, che quello c'hoggi si canta è tutto Syntono, nella Specie diatonica intendendo; habbiano più tosto detto esser di Tolomeo, che di Didimo ? non facendo (per quanto si vede) applicato à questo nostro modo di comporre & cantare commodo ne incommodo maggiore questa di quella distributione.Allaquale rispondono prima con poca intelligentia; & dicono:
Quello che non haurebbe dato noia à noi & à molti altri, pregiudicaua forse à disegni de gli Autori di queste cose.Ma questo è un modo di parlare tra i denti. & quando seguono ancora più oltra, scoprono quello che gli è molto contrario, & dicono.
L'Interuallo che nella Distributione di Didimo si troua tra G. sol re ut, &(cioè, quelli che sono d'altro parere)mi. è un Ditono, & non una Terza maggiore, di quelle che la più parte credono, che si cantino hoggi; & quello che si troua tra
mi & esso G. sol re ut, è un minore Hexachordo, & non una sesta minore: la onde hauendo essi
detto prima ne i loro Scritti; che si fatti Interualli erano dissonanti; che ueramente sono; ueniuano troppo alla sco page 115 perta & in un subito à porgere occasione d'impedire i di segni loro.Et incominciando à scoprir la loro ignorantia, soggiungono:
Che essi Interualli appartiscono tali; eccoui la prima specie del Diapason, distribuita secondo l'intentione di Didimo; laquale essaminata da uoi diligentemente; trouarete esser uero quello, che si è detto. Et quantunque in quelli di Tolomeo sia occorso l'istesso; non perciò è stato cosi manifesto al Senso & giudicio de Volgari; & si è possuta all'uniuersale sin ad hora tal cosa più facilmente defraudare. Et tale è stata la cagione, che più di Tolomeo, che di Didimo habbia detto essere la prima specie Diatonica, che si canta hoggi: se già non uolessimo dire, laqual cosa non credo in modo alcuno, c'hauessero ignorato(cosa che ueramente ignorano eglino)
la differentia che si troua tra esse.Quanto però sia differente la Costitutione di Didimo da quella di Tolomeo, ciascuno che essaminarà le Costitutioni sequenti, lo potrà più manifestamente conoscere.
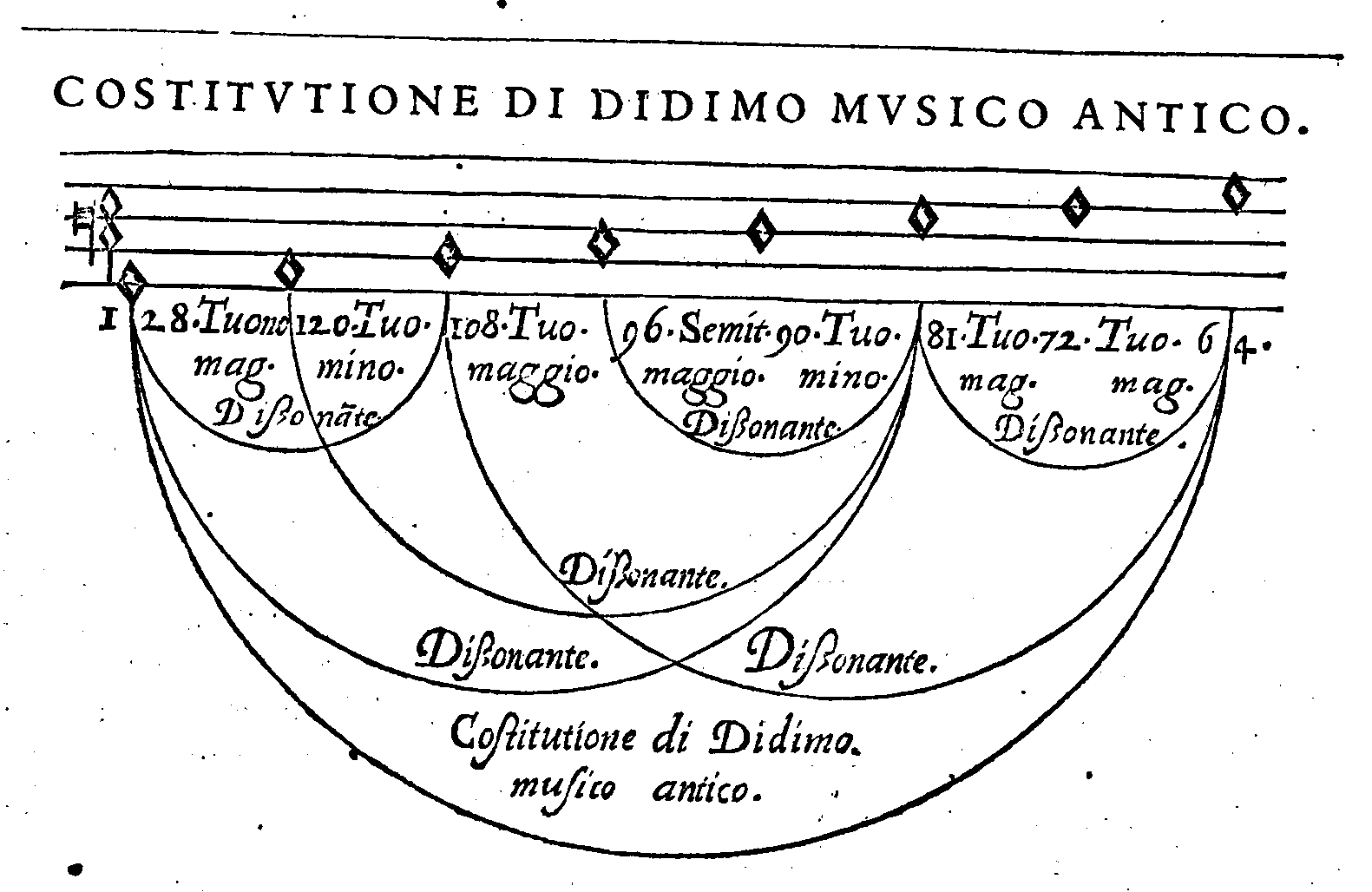
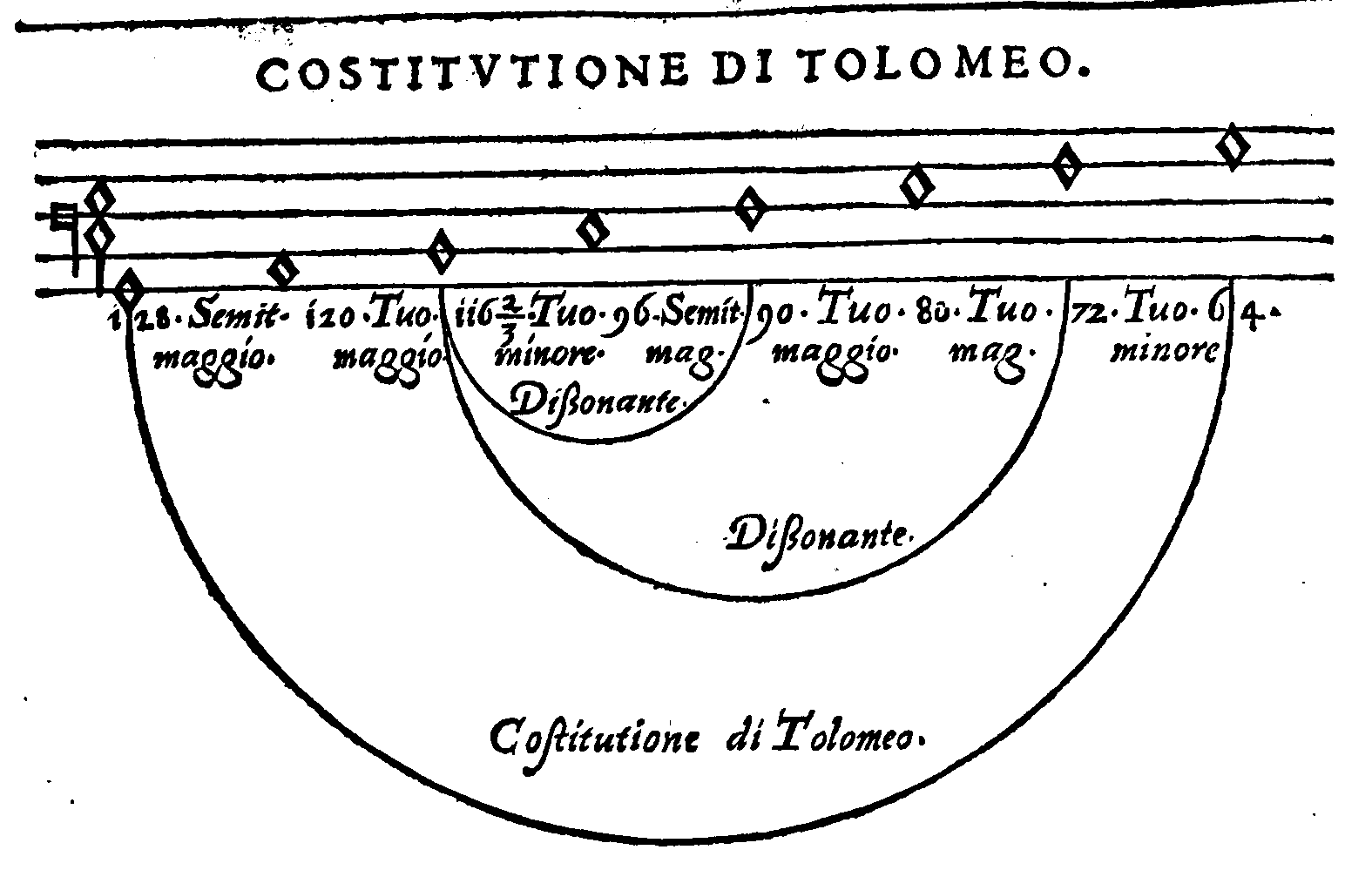
 . è un Ditono antico, & non una Terza maggiore delle moderne, che si cantano: Chi è colui c'habbia una scintilla solamente
delle cose della Scientia, che non sappia? percioche è cosa, che l'haurebbe ueduta il loro Cimabue; & haurebbe anco conosciuto, che nella Costitutione di
Tolomeo è una Terza maggiore ò Ditono consonante; dalche doueano almen
conoscer la Differentia, ch'è tra queste due Specie; percioche haurebbono anche conosciuto, che tra la chorda G. & la
. è un Ditono antico, & non una Terza maggiore delle moderne, che si cantano: Chi è colui c'habbia una scintilla solamente
delle cose della Scientia, che non sappia? percioche è cosa, che l'haurebbe ueduta il loro Cimabue; & haurebbe anco conosciuto, che nella Costitutione di
Tolomeo è una Terza maggiore ò Ditono consonante; dalche doueano almen
conoscer la Differentia, ch'è tra queste due Specie; percioche haurebbono anche conosciuto, che tra la chorda G. & la  . ui è l'Hexachordo minore moderno consonante: Ma in quella di Didimo si troua pur l'Hexachordo minore,
ma dissonante. Laonde poteuano almen ueder la differentia, ch'è tra l'una &
l'altra di queste due Costitutioni; la qual consiste in questo; che quelli Interualli, che si trouano in quella di Tolomeo, sono consonanti; & in quella di
Didimo sono Dissonanti. Come adunque poteua questo far pregiudicio à i
disegni di coloro, che affermano (come dicono) che si compone & si canta la
Specie naturale ò Syntona di Tolomeo, & non quella di Didimo? poiche nella Costitutione di Tolomeo si troua solamente un Semiditono imperfetto tra la
Terza & la Quinta chorda, & una Diapente anco imperfetta tra la Terza & la
Settima; & in quella di Didimo tra la Prima & la Terza, & tra la Quarta & la
Sesta il Semiditono imperfetto, tra la Sesta & l'Ottaua il Ditono dissonante, tra
la Prima & la Sesta l'Hexachordo minore; & tra la Terza & l'Ottaua il maggiore dissonanti. Cosi ancora tra la Seconda & la Sesta si troua la Diapente, ma
imperfetta & dissonante; lasciando da dir nell'una & nell'altra Costitutione della Semidiapente & del Tritono di queste specie; di modo che contiene Sei interualli dissonanti. Ilperche manifestamente danno segno, che ueramente eglino & non quelli, che persuadono che si canta hoggi il Syntono, hanno ignorato la differentia, c'hanno tra loro queste due Costitutioni. Vltimamente da
questo anco poteuano conoscer tale differentia, che quella di Didimo contiene
page 117
il Tuono maggiore nel terzo, sesto & settimo luogo ò interuallo; & nel
secondo & quinto il minore; & quella di Tolomeo contiene il maggior
Tuono nel secondo, quinto & settimo, & lo minore nel terzo & sesto.
Questa adunque è la cagione, perche più tosto s'habbia detto & persuaso
con ogni uerità; per parlare al modo loro; che quella Specie che si canta, è quella di Tolomeo, & non quella di Didimo; essendo ueramente più copiosa d'Interualli consonanti, di qualunque altra Costitutione; onde torna più commodo al nostro modo di comporre; se ben non intendono quello, che dicono; uogliono che questo sia stato la cagione. O sottil ragione; quando dicono;
. ui è l'Hexachordo minore moderno consonante: Ma in quella di Didimo si troua pur l'Hexachordo minore,
ma dissonante. Laonde poteuano almen ueder la differentia, ch'è tra l'una &
l'altra di queste due Costitutioni; la qual consiste in questo; che quelli Interualli, che si trouano in quella di Tolomeo, sono consonanti; & in quella di
Didimo sono Dissonanti. Come adunque poteua questo far pregiudicio à i
disegni di coloro, che affermano (come dicono) che si compone & si canta la
Specie naturale ò Syntona di Tolomeo, & non quella di Didimo? poiche nella Costitutione di Tolomeo si troua solamente un Semiditono imperfetto tra la
Terza & la Quinta chorda, & una Diapente anco imperfetta tra la Terza & la
Settima; & in quella di Didimo tra la Prima & la Terza, & tra la Quarta & la
Sesta il Semiditono imperfetto, tra la Sesta & l'Ottaua il Ditono dissonante, tra
la Prima & la Sesta l'Hexachordo minore; & tra la Terza & l'Ottaua il maggiore dissonanti. Cosi ancora tra la Seconda & la Sesta si troua la Diapente, ma
imperfetta & dissonante; lasciando da dir nell'una & nell'altra Costitutione della Semidiapente & del Tritono di queste specie; di modo che contiene Sei interualli dissonanti. Ilperche manifestamente danno segno, che ueramente eglino & non quelli, che persuadono che si canta hoggi il Syntono, hanno ignorato la differentia, c'hanno tra loro queste due Costitutioni. Vltimamente da
questo anco poteuano conoscer tale differentia, che quella di Didimo contiene
page 117
il Tuono maggiore nel terzo, sesto & settimo luogo ò interuallo; & nel
secondo & quinto il minore; & quella di Tolomeo contiene il maggior
Tuono nel secondo, quinto & settimo, & lo minore nel terzo & sesto.
Questa adunque è la cagione, perche più tosto s'habbia detto & persuaso
con ogni uerità; per parlare al modo loro; che quella Specie che si canta, è quella di Tolomeo, & non quella di Didimo; essendo ueramente più copiosa d'Interualli consonanti, di qualunque altra Costitutione; onde torna più commodo al nostro modo di comporre; se ben non intendono quello, che dicono; uogliono che questo sia stato la cagione. O sottil ragione; quando dicono; Che non haurebbe dato noia à molti:si alli poco intendenti della Musica: Onde non sanno dire, per qual cagione
Pregiudicaua à i disegni de gli Autori & Inuentori di questa verità.Et quando dicono, esser occorso l'istesso ne gli Interualli di Tolomeo; &
Questa cosa non essere stata cosi manifesta al senso & giudicio de Volgari; & che più facilmente à questo modo fin'hora s'habbia possuto defraudare:Da quello che si è detto & mostrato, ogn'un può conoscere, quanto sia uero; quando anche sopra il Tetrachordo di Tolomeo hanno posto questo titolo:
Diatonico Syntono di Tolomeo; ilquale secondo che piace al Zarlino, è quello che si canta hoggi; la cui opinione è confutata dall' Autore,cioè del Trattato nominato. Ma quando hauran fatto, come si dice, il conto con l'Hoste, facilmente lo potranno conoscere. Et per seguitar quello, c'habbiamo incominciato, il Settimo Tetrachordo di quest'ordine è di Tolomeo, & lo chiama Equale diatonico, & è il seguente; forse cosi chiamato, dalla
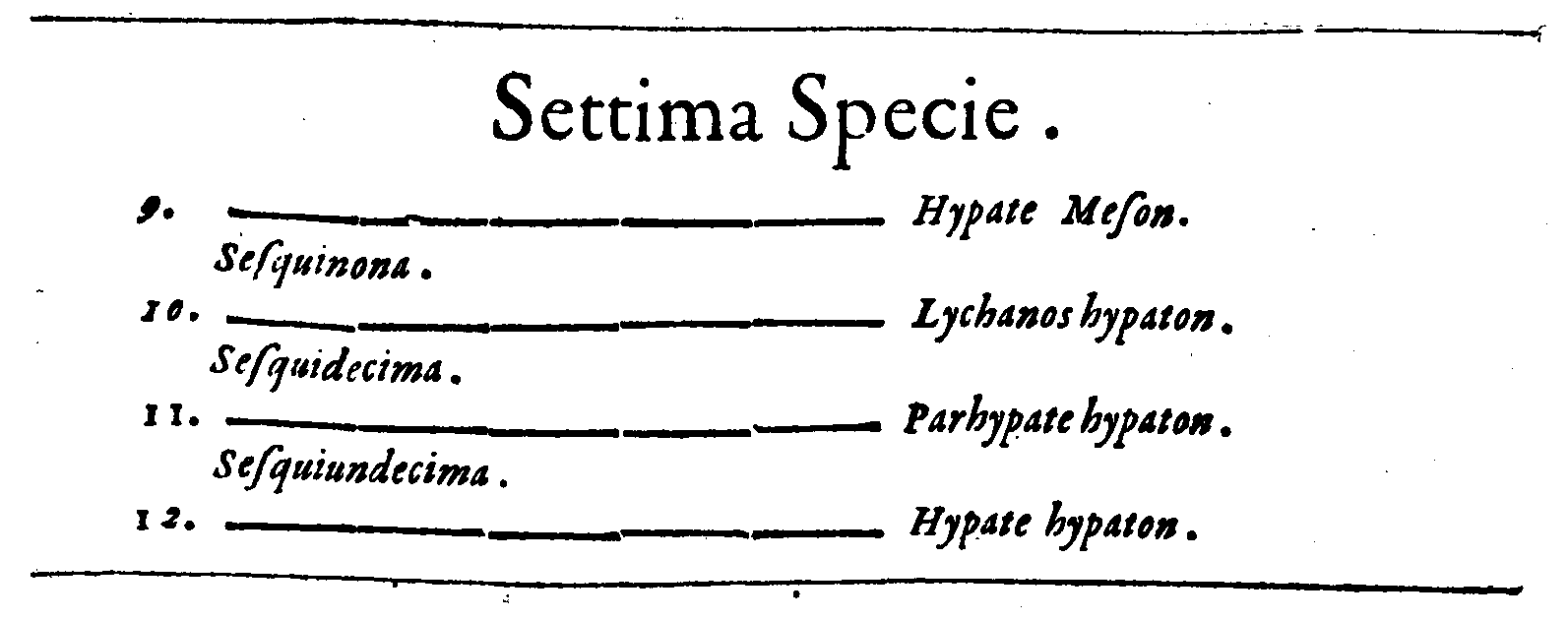
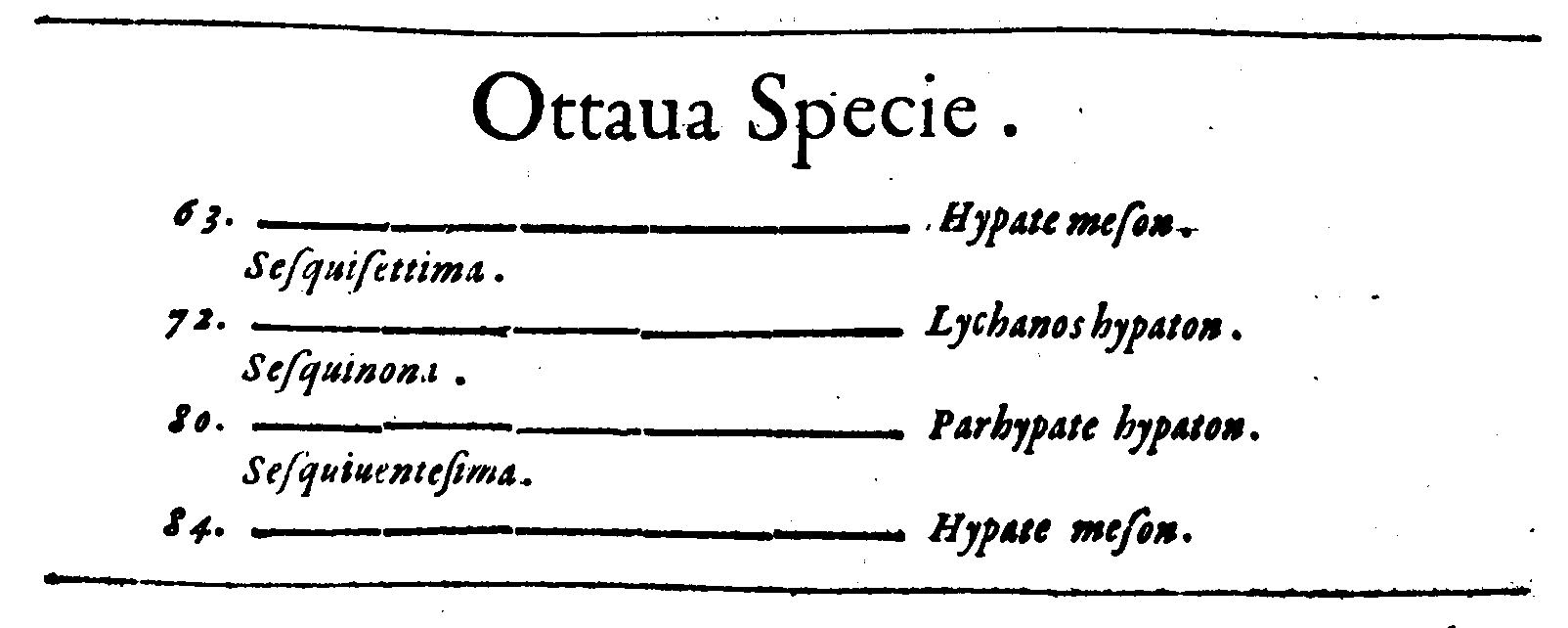
De i Colori ò Specie d'Harmonia contenute nel Genere Chromatico. Cap. II.
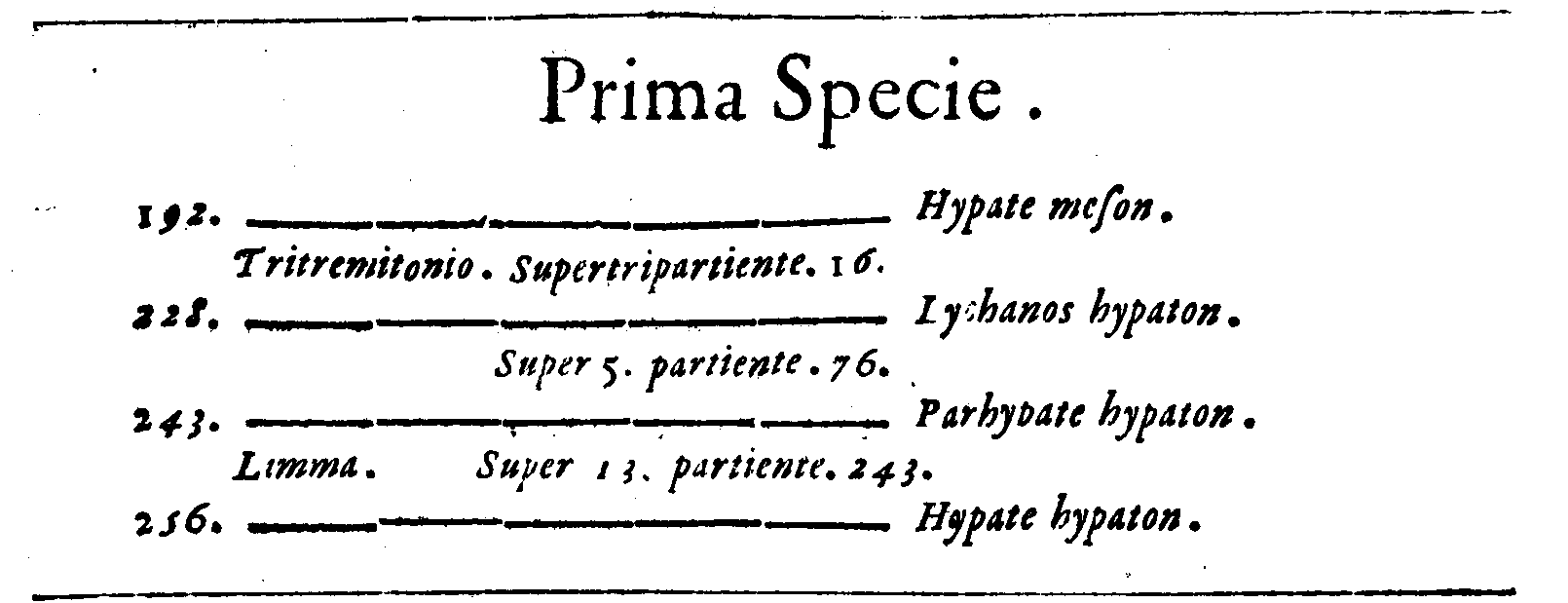
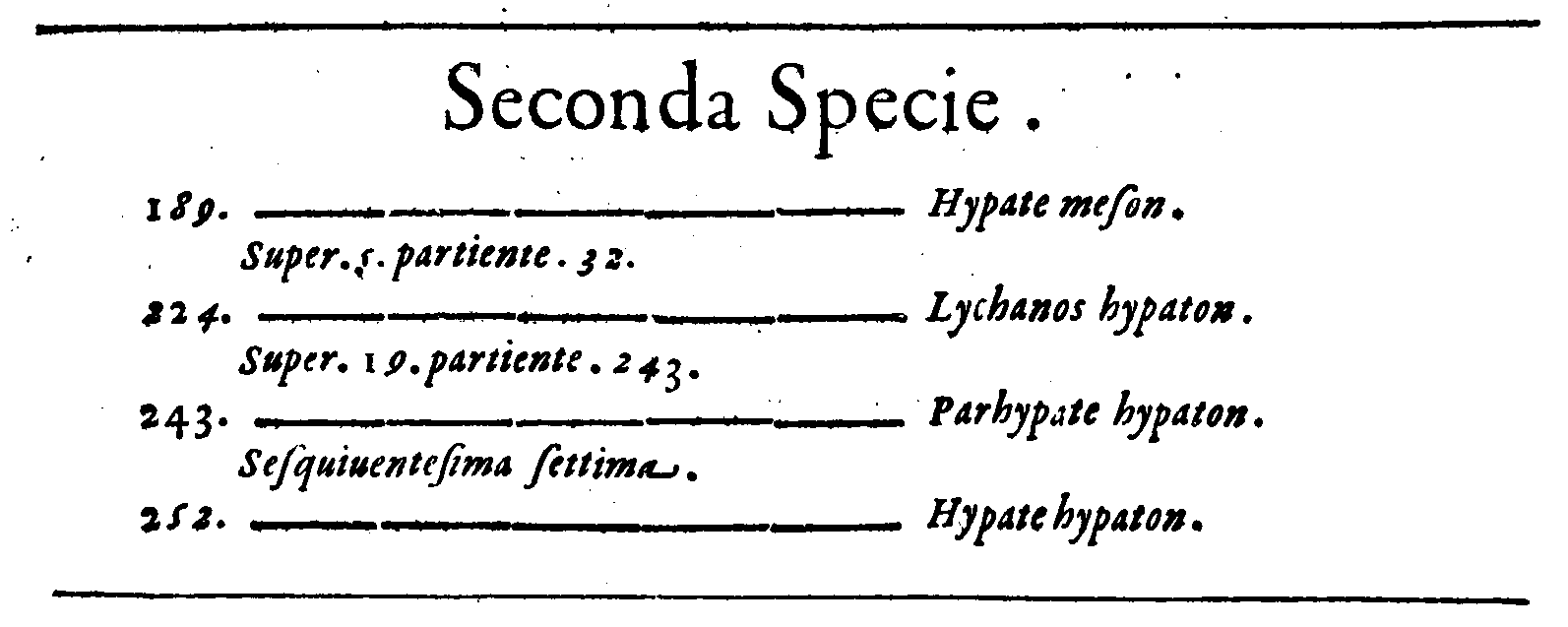
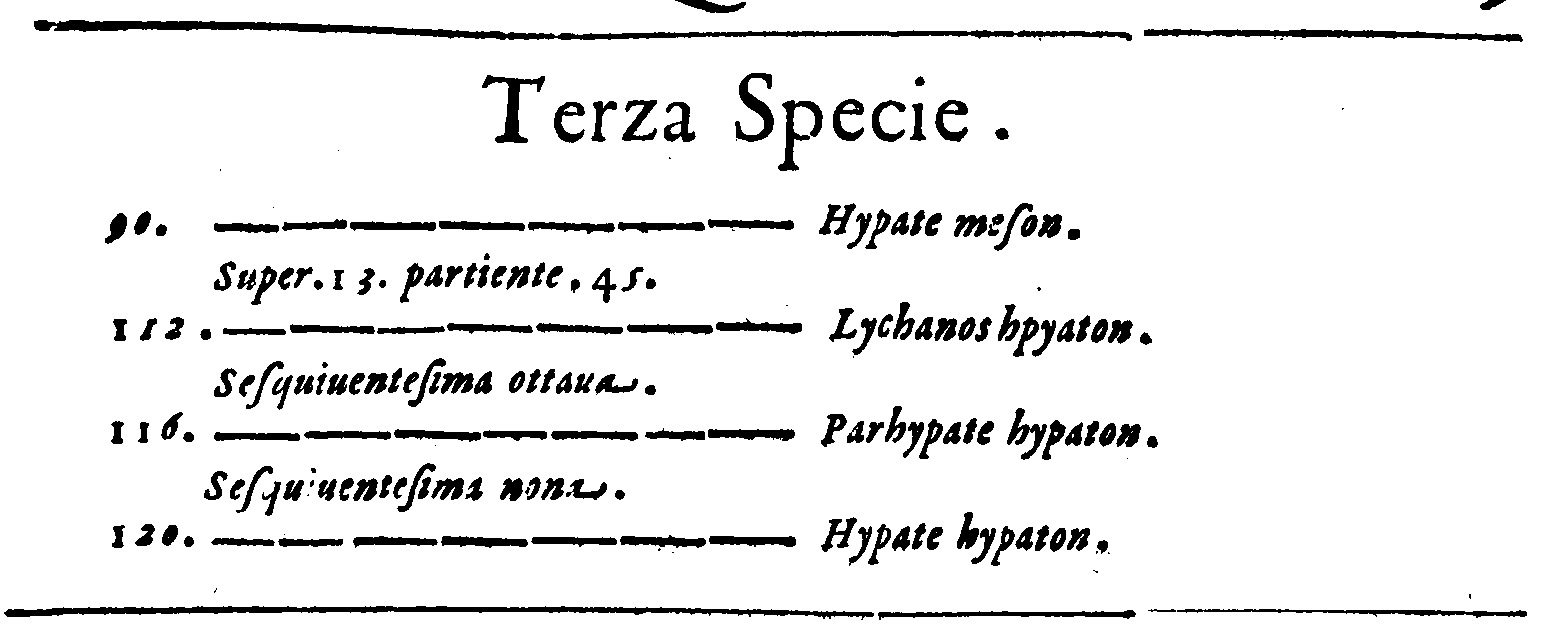
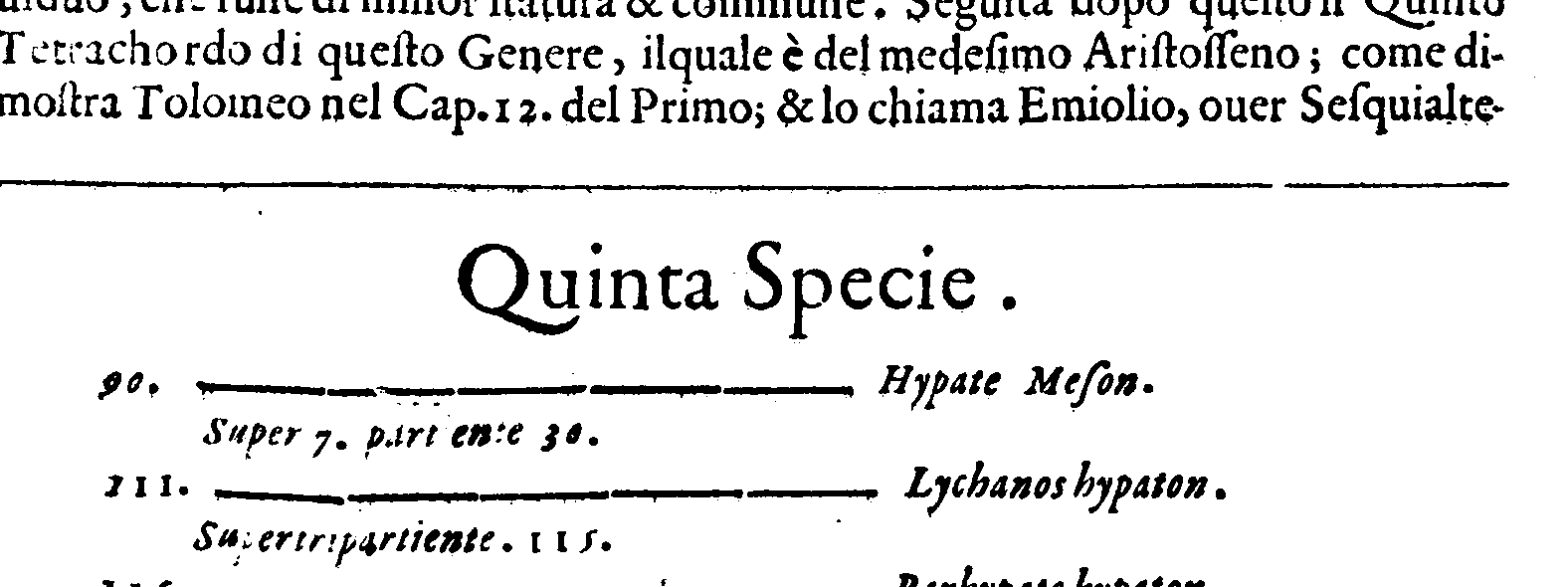
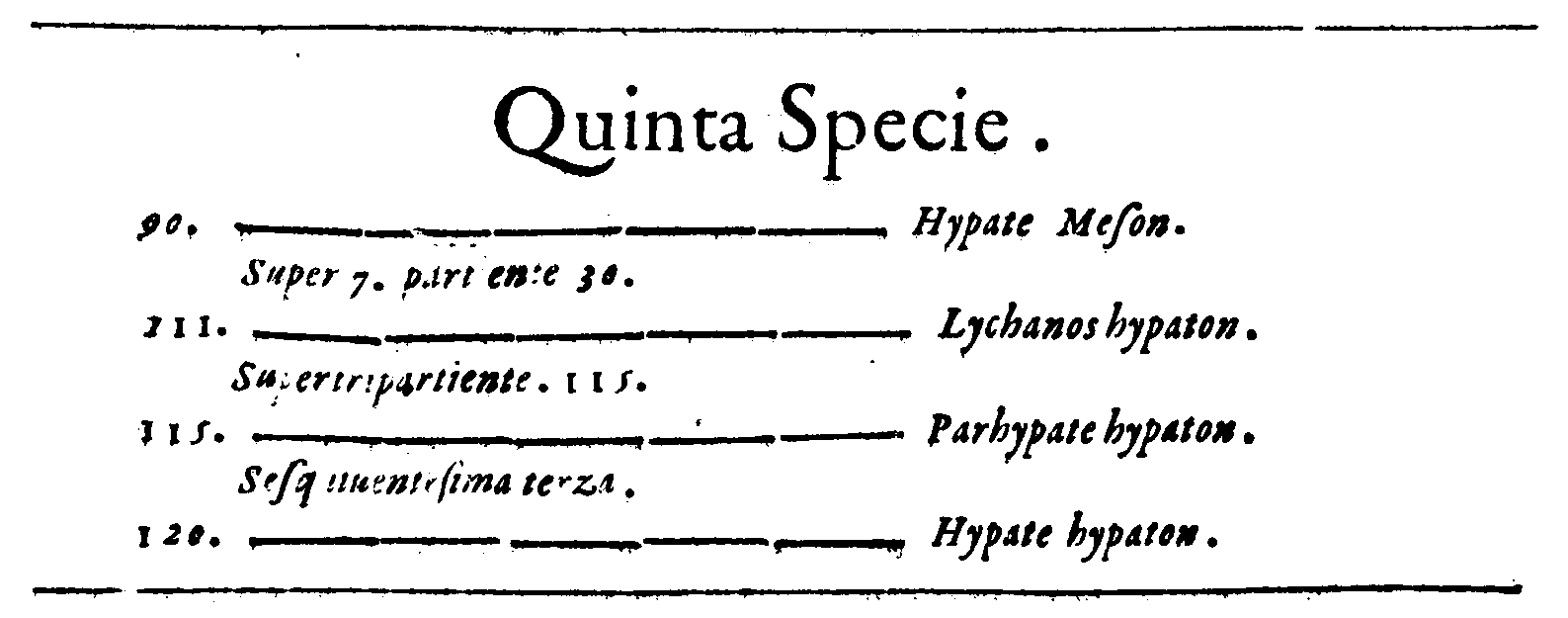
ch'io habbia preso per quello che si costuma hoggi, posto nel cap. 46. della 2. parte delle Istitutioni; ch'io l'habbia page 120 malamente distribuito; uolendo io in quel luogo, com'in molti altri, che 'l Sesquiottauo non sia capace d'altro Semituono che del Maggiore & del Minore del Syntono; oltra hauerlo io prima insieme con Tolomeo confutato;& è il seguente, sopra ilquale,
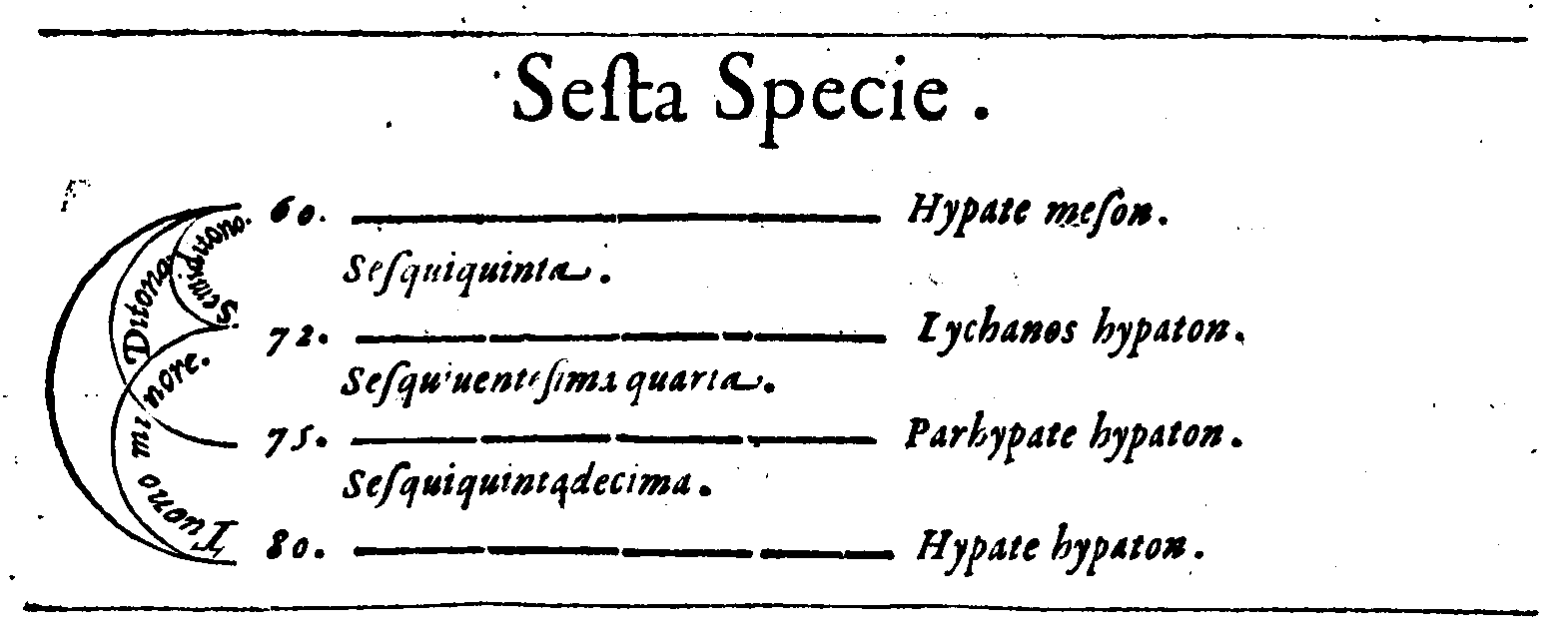
 . collocata tra la seconda & la quarta
d'ogni Tetrachordo diatonico; che con l'estrema di tal Tetrachordo fa il Trihemituono ò gli estremi del Semiditono con la detta acuta, & il Tuono minore con
l'estrema graue; come si uede tra le chorde di questo Tetrachordo, segnate
secondo le distanze ò Interualli delle loro uere proportioni rationali, che sono
contenuti in esso. Et se bene uiene ad essere un'istesso con quello di Didimo;
credo ch'egli mai non si imaginasse di cauarlo fuori & darli forma per cotal uia;
com'è auenuto à me del sudetto: ilche ogni Studioso lettore potrà comprendere, quando haurà conosciuto il modo c'hò tenuto
nella Costruttione ò fabrica dell'Istrumento moderno, posto nel Cap. 47. della Seconda parte delle Istitutioni, contenente le chorde di tutti tre i Generi. Il terzo errore è, quando dicono, che malamente hò distribuito il sudetto Tetrachordo; massimamente uo
page 121
lendo io in quel luogo; come ne gli altri ancora; che 'l Sesquiottauo non d'altro
sia capace che del maggiore & minor semituono del Syntono, delche non mi
marauiglio; perche se molti altri luoghi ne i miei Scritti eglino hanno inteso
malamente; anche questo si può porre appresso quelli: Ma è ben peggio quando errano nella Radice, perche ogni cosa resta confusa. Non mi ricordo, d'hauer mai detto cotal pazzia, & s'io l'hauessi detta, l'haurebbe ueduto il contrario
nel Tetrachordo Synemennon del Monochordo posto nel Cap. 40. della sudetta parte, che nasce per accidente: percioche in quello tra la chorda Mese &
. collocata tra la seconda & la quarta
d'ogni Tetrachordo diatonico; che con l'estrema di tal Tetrachordo fa il Trihemituono ò gli estremi del Semiditono con la detta acuta, & il Tuono minore con
l'estrema graue; come si uede tra le chorde di questo Tetrachordo, segnate
secondo le distanze ò Interualli delle loro uere proportioni rationali, che sono
contenuti in esso. Et se bene uiene ad essere un'istesso con quello di Didimo;
credo ch'egli mai non si imaginasse di cauarlo fuori & darli forma per cotal uia;
com'è auenuto à me del sudetto: ilche ogni Studioso lettore potrà comprendere, quando haurà conosciuto il modo c'hò tenuto
nella Costruttione ò fabrica dell'Istrumento moderno, posto nel Cap. 47. della Seconda parte delle Istitutioni, contenente le chorde di tutti tre i Generi. Il terzo errore è, quando dicono, che malamente hò distribuito il sudetto Tetrachordo; massimamente uo
page 121
lendo io in quel luogo; come ne gli altri ancora; che 'l Sesquiottauo non d'altro
sia capace che del maggiore & minor semituono del Syntono, delche non mi
marauiglio; perche se molti altri luoghi ne i miei Scritti eglino hanno inteso
malamente; anche questo si può porre appresso quelli: Ma è ben peggio quando errano nella Radice, perche ogni cosa resta confusa. Non mi ricordo, d'hauer mai detto cotal pazzia, & s'io l'hauessi detta, l'haurebbe ueduto il contrario
nel Tetrachordo Synemennon del Monochordo posto nel Cap. 40. della sudetta parte, che nasce per accidente: percioche in quello tra la chorda Mese &
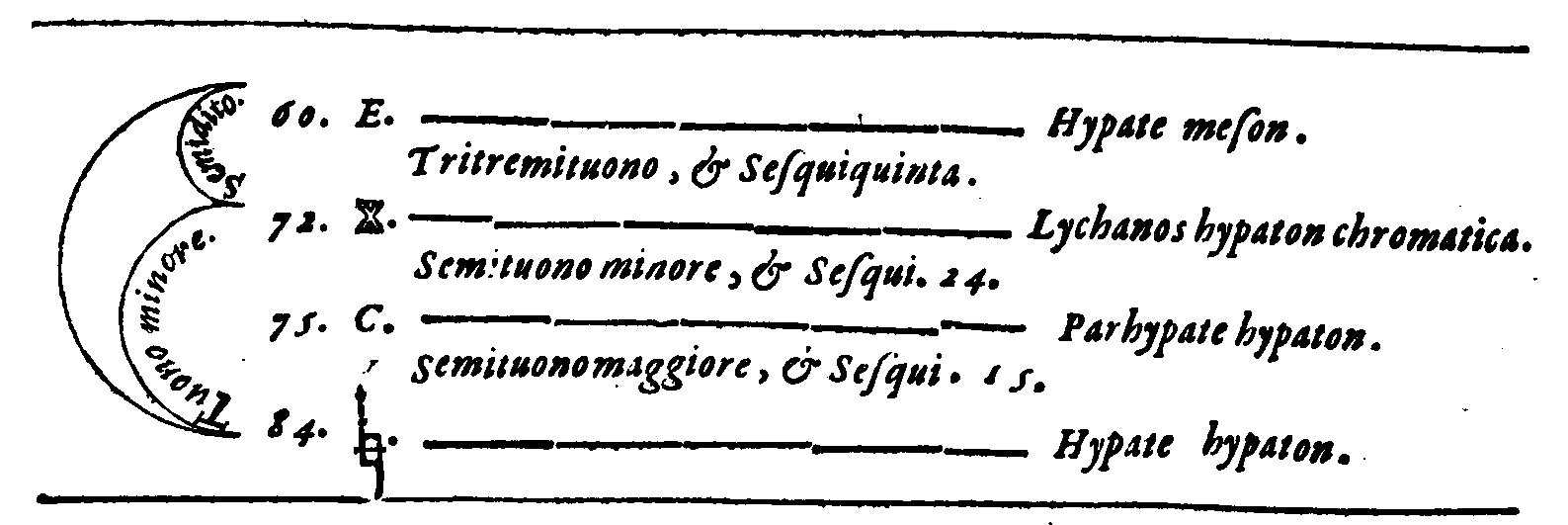
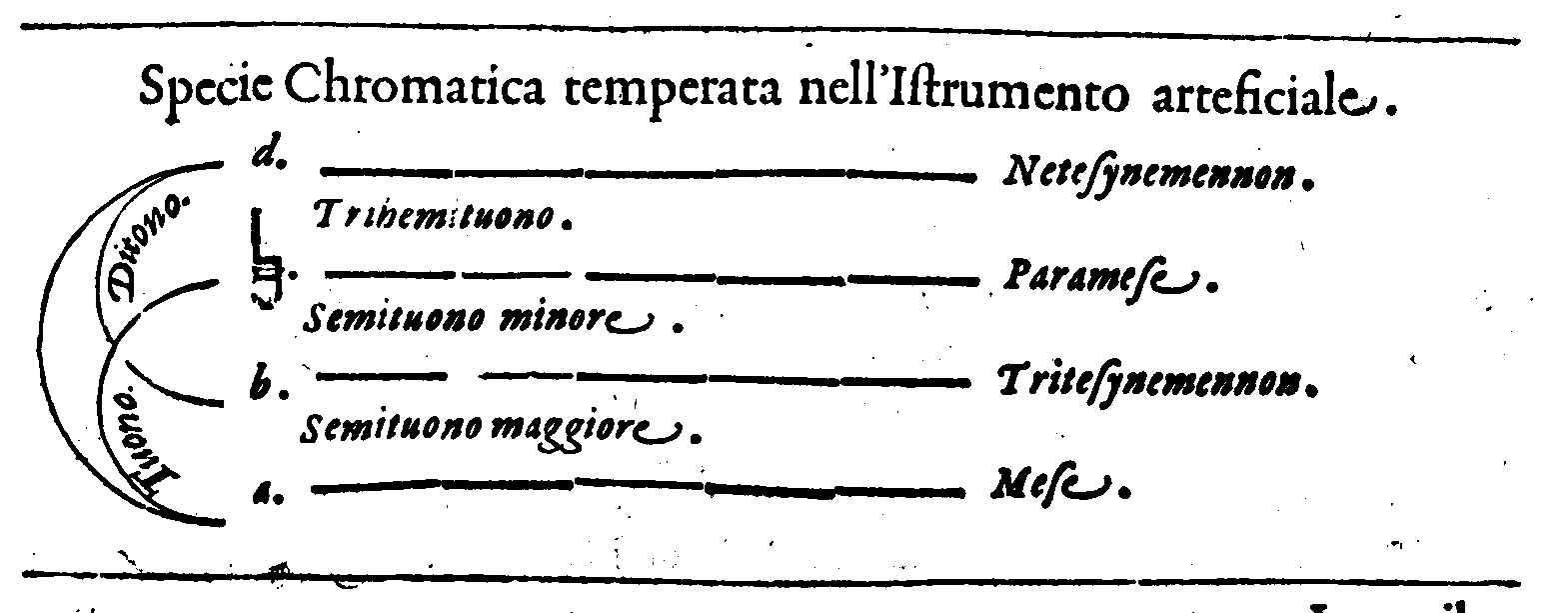
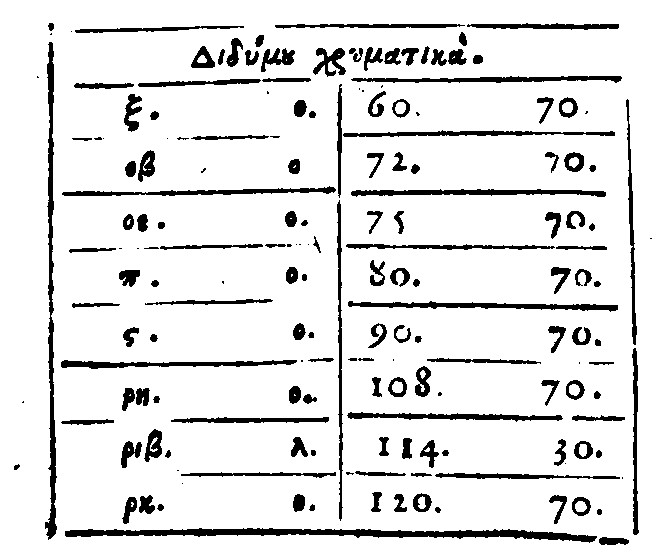
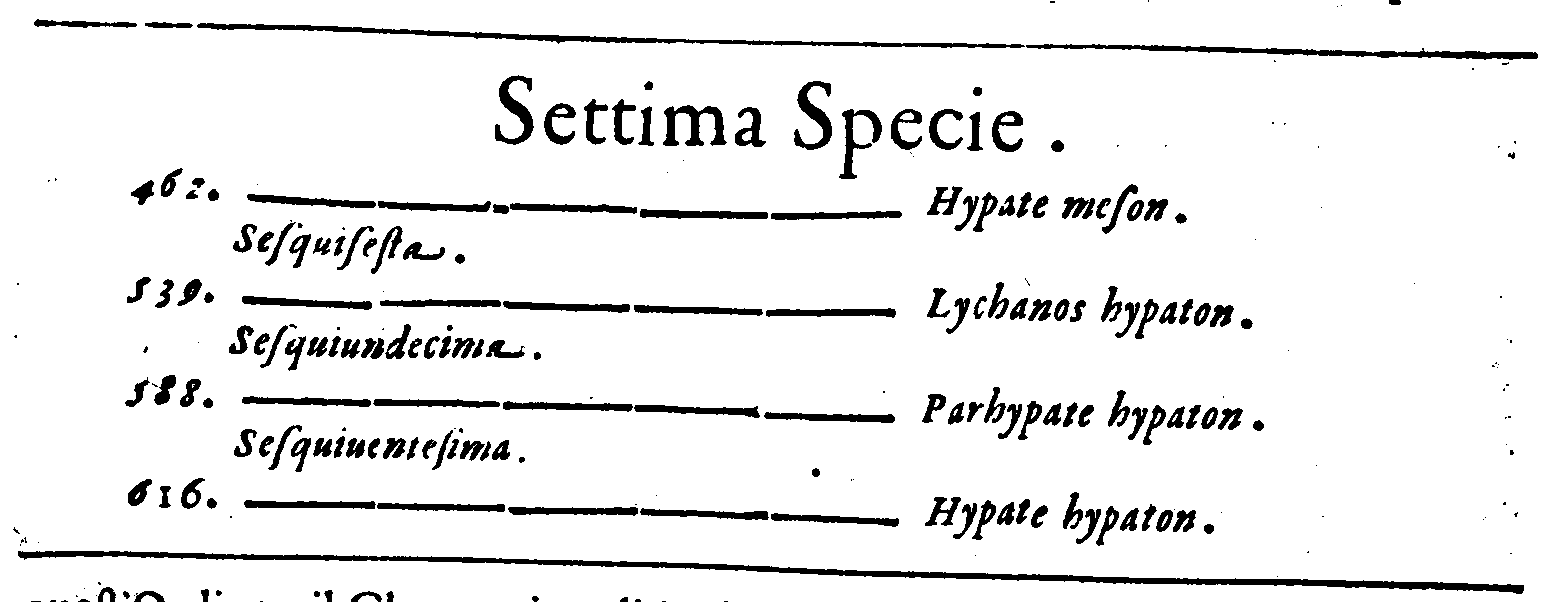
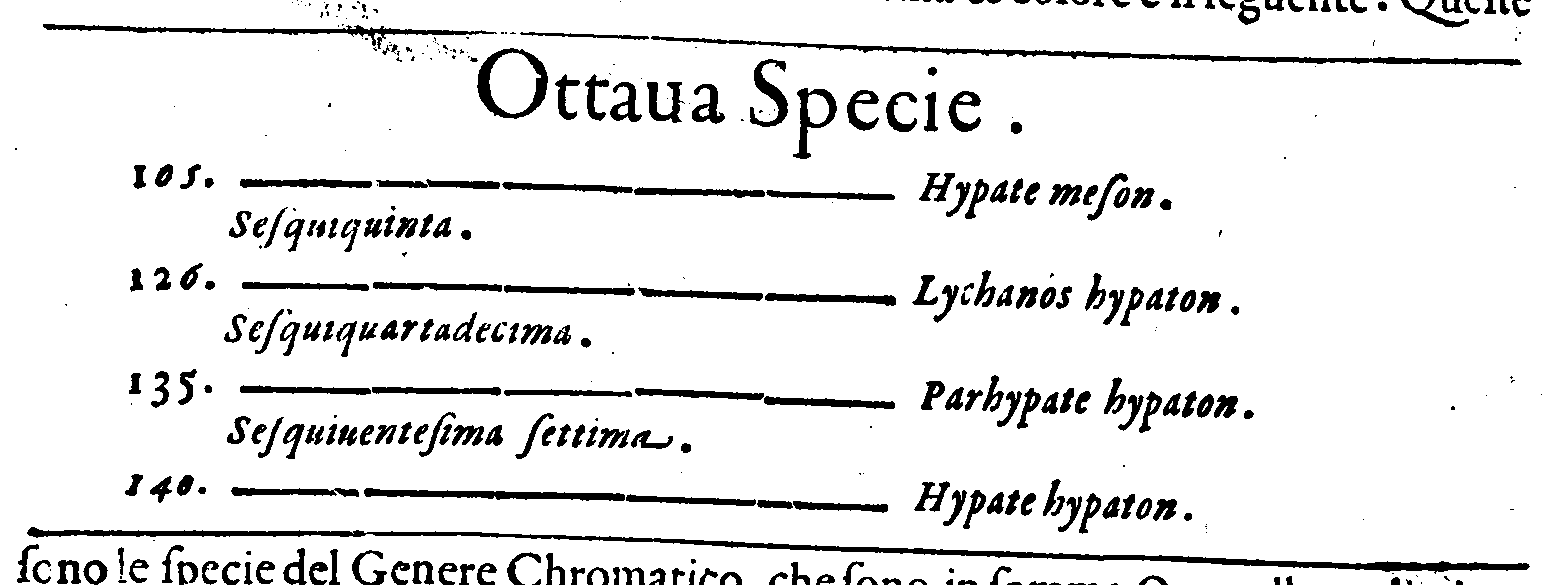
De i Colori ò Specie contenute sotto 'l Genere d'Harmonia detto Enharmonico. Cap. III.
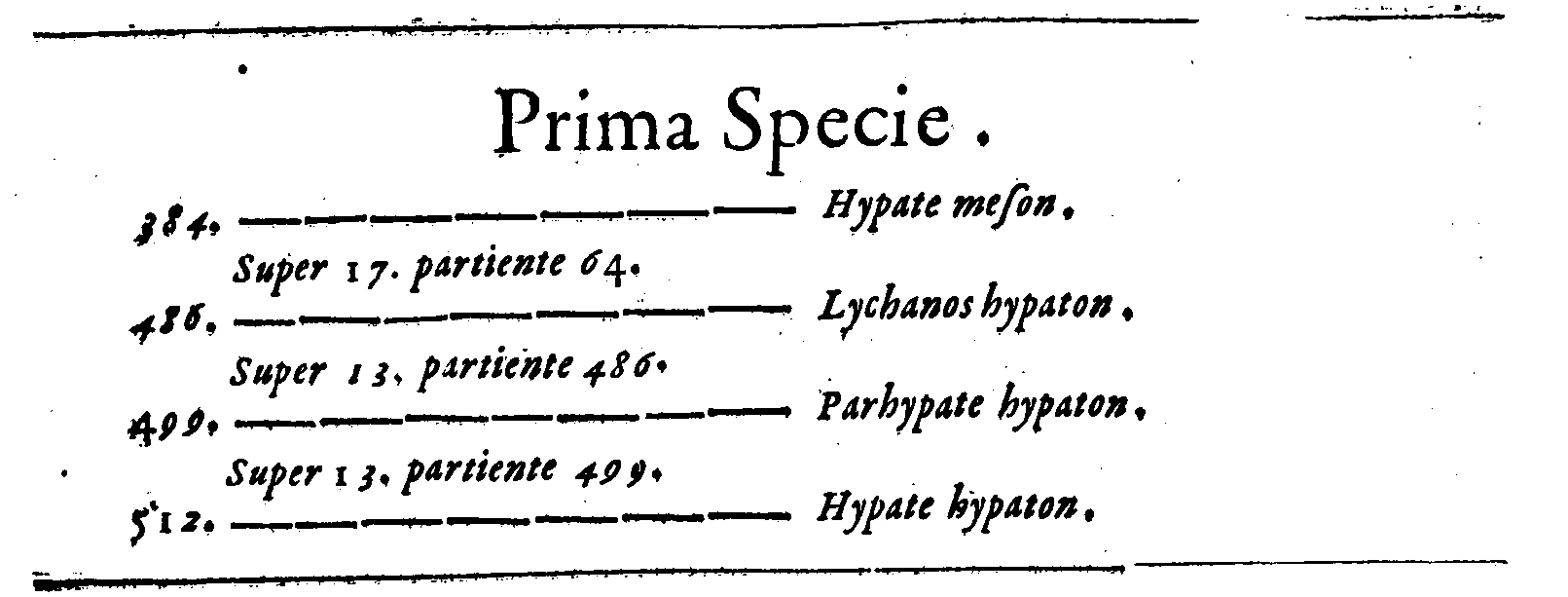
Nel Chromatico haueano più efficacia gli affetti molli & effeminati, che in altro; l'uso delquale essendo assai frequentato dal Lirico Timotheo tra gli Spartani; fù cagione ch'essi, come amatori della seuera Musica, lo cacciarono da i lor confini.Et per non far torto alla lor buona natura nel dir mal d'ogn'uno, soggiungono;
Ne di ciò è punto da marauigliarsi di Timotheo; auenga che la sua patria fù un'Isola della Grecia, detta Millo; gli habitatori, dellaquale erano (per quanto ce ne dicono gli Historici) huomini lasciuissimi & effeminati: & tali (per quello s'intende) sono ancora hoggi.Onde dicono che Timotheo non fù autore del sudetto genere Chromatico. Ma che l'Isola di Millo sia ò non sia nella Grecia; percioche è nell'Arcipelago, lascio la cura à i Geographi; Et il dire anco, che i Milesij fussero & anco siano huomini effeminati; questo dicono contra i buoni costumi & anco secondo la natura loro, & non fà al caso cosa alcuna; & è più tosto in nostro che in loro fauore. Ilperche è da notar due cose; la prima, quando dicono, che
Timotheo fù Lirico, & frequentaua il Genere Chromatico;la seconda,
ch'ei non fù quello, che ritrouò cotal Genere; se 'l s'intende per quello che fù al tempo del grande Alessandro.Ma eglino allegano tre autorità, che gli sono contrarie; quantunque pari à loro, che l'habbiano in lor fauore: La prima è quella d'Aristotele nel Secondo della Metaphisica, che dice:
Se non fusse stato Timotheo, non haueremmo tante sorti di Melodie:se bene il Testo non dice Melodie, ma μελοποΐας; laqual parola altroue hò pienamente dichiarato, essendoche egli ritrouò la Melopeia del Chromatico. La seconda è, che dicono, che Suida parlando dell'istesso, dice cosi:
Timotheo figliuolo di Tersandro tramutò la Musica antica in più Molle & delicata forma; ch'è proprio la natura del Chromatico, comparato all'Antichissimo Ditonico: E' ben uero, che da gli Huomini di giudicio gli fù imputato biasimo.Suida però non dice cosi; ma si bene in questo modo.
Timotheo figliuolo di Tersandro ò di Neomiso ò di Filopolite, Milesio Lirico; ilquale aggiunse alla Lira la Decima & la Vndecima chorda, & mutò l'antica Musica in un Modo più molle; fù ne i tempi d'Euripide Tragico, ne i quali regnò etiandio Filippo di Macedonia.Et dopò alquante parole segue nell'istesso Capo d'un altro Timotheo, dicendo:
Referiscono Timotheo tibicine una fiata con l'arduo modo di Minerua intanto hauer com page 125 mosso l'animo d'Alessandro; che nell'ascoltarlo fù concitato all'arme; & che questo Timotheo con gran prestezza chiamato, andò à lui in Persia.Onde si uede, che Suida è confuso; & forse per la incorrettione del Testo; come si trouano gran parte de i Libri greci; percioche in un'istesso capo (lasciando le parole ch'intrauengono di mezo) confonde il Lirico, co 'l Tibicina; ilperche in questo se gli può dar poca fede. La terza autorità è quella di Boethio posta nel Proemio del 1. Lib. della Musica, laquale eglino allegano con queste parole:
Essendo Timotheo in Sparta, riuolgeua la Musica graue, & seuera, c'hauea da essi Spartani riceuuto, nella Chromatica, che è Molle & effeminata; l'uso dellaquale grandemente nuoceua à gli anni teneri de fanciulli, facendoli diuentar tali: per lo che fù mandato in essilio.Nondimeno le parole di Boethio sono queste tratte dal Greco ch'egli cita:
Idcirco Timotheo Milesio Spartiatas succensuisse, quod multiplicem Musicam reddens, puerorum animis, quos acceperat erudiendos, officeret; & à virtutibus modestia praepediret. Et quòd harmoniam, quam modestam susceperat, in Genus chromaticum, quod mollius est, inuertisset;che uogliono dire:
Per laqual cosa i Spartani si sdegnarono contra Timotheo Milesio; che facendo la Musica molteplice, offendeua gli animi de i Fanciulli, iquali egli hauea presi ad insegnare, & gli impediua & retraeua dalla modestia della Virtù; perche l'harmonia ch'egli hauea riceuuto modesta, hauea riuolta nel Genere chromatico, ch'è più molle.Queste sono le parole di Boethio; onde non uedo, che questa autorità, ch'allegano, dica, che Timotheo non fusse l'Inuentore del sudetto Genere; percioche se bene non dice questo apertamente; non dice anco ch'egli non fusse quello; ma più tosto si può intendere ch'ei fusse l'Inuentore, hauendo questi miei contradittori detto prima, che l'uso di questo Genere era assai frequentato dal lirico Timotheo tra Spartani: & allegano la prima autorità d'Aristotele; che se Timotheo non fusse stato, non haueremmo tante sorti di Melodie; & dicono, ch'ei riuolgeua nella Chromatica, che è molle & effeminata, la Musica graue & seuera, c'hauea (come espongono) riceuuto da Spartani. Et io dico, ch'ei hauea riceuuta & imparata dal suo Precettore & non da Spartani; onde maggiormente queste autorità fanno per la parte affirmatiua di coloro, che tengono, Timotheo essere stato quello che la ritrouò, che per la negatiua: tanto più, che non ui è cosa alcuna, che dica il contrario; anzi eglino mordendo le genti dell'isola di Millo, prendono occasione da questo, di chiamarli lasciui & effeminati; & usando una loro certa amplificatione contra Timotheo, uengono à dire contra loro stessi. Ilperche assegnando questa loro opinione esser uera, dicono:
Il Zarlino ultimamente nel cap. 32. della 2. Parte dell'Istitutioni ne fà un discorso assai lungo; nel quale dice chiaramente, che non solo Timotheo, ritrouò il Genere chromatico, ma racconta in qual maniera lo potesse trouare. Et che questo tale Timotheo non potesse à patto alcuno esser quello che ritrouò il Genere chromatico, come dice il Zarlino; segno ue ne sia manifesto che Olimpo Frigio, scolare di Marsia, fù auanti la Guerra Troiana; alquale è attribuito l'Inuentione dell'Enharmonico: ma però dopo l'uso del chromatico.Aggiungono anco,
che l'Enharmonico, secondo Aristosseno & Plutarcho fù trouato insieme con la legge detta Currule del sopranominato Olimpo:sotto laquale si comprendeua il Ratto d'Hercole intorno le mura nella guerra Troiana; come distintamente dichiara il Valgulio, sopra la Musica di Plutarcho. Ma come può essere, ch'Olimpo fusse Inuentore di cotal legge; essendo stato per tanti anni auanti la sudetta guerra? Dicono etiandio, come può essere, che quel Timotheo, che fu tante decine d'anni dopo Olimpo, hauesse prima ritrouato il Genere Chromatico? In oltre dicono;
nel Decreto che fecero i Spartani contra Timotheo si leggono in quella lingua; che gli fù fatto, queste parole. Timotheo abbandonò l'Enharmonico, riti page 126 randosi al Chromatico, come più molle & facile. Volendo adunque che 'l conto torni secondo il nostro calcolo, è di mestiero trouare un nuouo Olimpo, ò un nuouo Timotheo; à quali siano attribuite l'inuentioni di questo & di quel Genere d'harmonia; & non melodia, come dice Aristotele.Ma à questo lor parlare si può prestar poca fede; percioche in esso non si troua uerità; essendoche dicono prima, che Olimpo Frigio fù trouator dell'Enharmonio, & scolare di Marsia, & fù auanti la Guerra Troiana. Ma furono due Olimpi, come referiscono Plutarcho & Suida più chiaramente; cioè, il Vecchio & il Giouane: Questo fu di Frigia & fù Tibicine, & si trouò ne i tempi di Mida figliuolo di Gadia Re di quella Prouincia; & quello fù della Misia, & fù simigliantemente Tibicina, & discepolo & innamorato di Marsia, & Poeta celeberrimo; & l'uno & l'altro uisse auanti la Guerra di Troia. Et se ben Plutarcho, di mente d'Aristosseno dice, che Olimpo ritrouò il Genere Enharmonico; non dice però, che fusse quello di Misia, ne quello di Frigia; ma scriue semplicemente che fù Olimpo. Laonde non sarebbe gran marauiglia, che si come hauendosi dopo un primo ritrouato un secondo Olimpo, ch'essercitò la Musica; cosi à questi due lungo tempo dopoi ne sia seguito un Terzo, & anco sia stato quello, che nomina Plutarcho, secondo 'l parere d'Aristosseno, per tale Inuentore, & sia etiandio stato (com'è il douere) dopo Timotheo inuentore del Chromatico; percioche (come affirma Suida) fù quello, che Mutò l'antica Musica in un modo più molle; & morì di età di Nouantasette anni massimamente essendosi anco dopo il primo ritrouato un'altro Aristosseno discepolo d' Aristotele; ne i tempi d'Alessandro Re di Macedonia, intorno gli anni del Mondo (secondo alcuni) 4850. & il primo fù ne gli Anni 4530. nel tempo d'Archiloco Poeta; & disse che l'Anima era Numero, che mouea se stesso: Et di questo non ne parla Plutarcho, ma si bene del Giouane; ilquale dopo la morte del suo precettore Aristotele, dimostrò di esser'à lui & à Platone poco amico: come dimostra Plutarcho, quando cita il 2. Lib. delle cose Musicali di esso Aristosseno; nelquale egli accusa Platone di errore, per hauer'eletto nella sua Republica l'harmonia Doria, & rifiutato l'altre. Et quantunque ne Plutarcho, ne Suida pongano un terzo Olimpo; non è da farsi marauiglia, quando non fanno anco mentione se non d'uno Aristosseno, che fù figliuolo di Mnesia (come dice esso Suida) & si chiamaua Spintharo, nato in Italia nella Città di Taranto; & fù à i tempi d'Alessandro (come hò detto) Re de Macedoni, & uide gli ultimi della Setta pithagorica, ch'erano uditori di Philolao & di Eurito, ambedue da Taranto; come uuole Diogene Laertio nel Lib. 8. nella Vita di Pithagora. Ilperche, da quello che si è detto, poiche non u'è altro autore, che dica ò afferma, che Timotheo, qual si fusse de i due nominati, non fù quello che ritrouasse il Genere chromatico; ne anco ritrouandosi alcuno Scrittore, che dica manifestamente, chi lo trouasse da quelle autorità, che più tosto dicono, che Timotheo Milesio lo ritrouasse, che non; & non affirmando anche Plutarcho, che l'un de i due nominati Olimpi, fusse stato quello, che ritrouò l'Enharmonio; seguita la conclusione fatta da questi miei amici; che fà dimistieri di trouar un' nuouo Olimpo; poiche già Timotheo è ritrouato. Et se ben pare che 'l Decreto fatto da i Spartani contra Timotheo, addotto da loro in suo fauore; sia contra quello che si è concluso, tuttauia si può dire, che Boethio istesso, interprete di cotale Decreto, è in fauore di Timotheo Milesio. Et se non fusse, ch'alcun potrebbe dire, ch'io lo faccio per empire (come si dice) il foglio; come fanno molti, che fuori d'ogni propoposito attaccano le cose l'una con l'altra, per mostrar d'hauer ueduto molti autori, ancora che ne intendino pochi; uorrei scriuere un nuouo pensiero che page 127 mi souiene hora di cotesta cosa; habbiasi poi per uero, ò mettasi nel numero de i Paradossi, come si uoglia; & dire, questo esser uero, che Timotheo (come scriue Suida) mutò la Musica antica in un Modo più molle; come scriue Boethio; che l'Harmonia, ch'egli hauea riceuuto modesta, hauea riuolta nel Genere Chromatico: ò pur come dicono questi miei amoreuoli: ch'egli abbandonò, col testimonio d'Aristosseno, Enharmonico, ritirandosi al Chromatico, come più facile. Percioche (come mi pare) essendosi tralasciato i due più antichi, Diatonico & Chromatico, per qualche accidente, restando solamente l'uso dell'Enharmonico, ilquale era (come tutti confessano) difficile; Timotheo di nuouo, per la sua difficultà ritornò nel suo primo essere il Chromatico; con l'aggiungerui qualche cosa di nuouo: ilperche Aristotele nel sudetto luogo, non senza ragione, dice; che se non fusse stato Timotheo, non haueressimo molte Melopeie. Et ciò parmi ch'accenni Aristosseno, quando ei nel principio del Primo libro de gli Elementi harmonici, scriue in questo modo.
Τοὺς μὲν οὖν ἔμπροσθεν ἁρμονικοὺς εἶναι βού- λεσθαι μόνον, αὐτῆς γὰρ τὴς ἁρμονίας ἣπτοντο μόνον, τῶν δ'ἄλλων γενῶν οὐδεμίαν πώποτε ἕννοιαν εἶχον· σημεῖον δὲ τὰ γὰρ Διαγράμματα αὐτο͂ις τῶν ἁρμονικῶν ἔκκειται μόνον συστημάτων, Διατόνων δὲ ἤ χρωματικῶν οὐδεὶς πώποτε ἑώρακα. Καίτι τὰ διαγράμματά γε αὐτῶν ἑδηλουν τὴν πάσαν τῆς μελωδίας τάξιν, ἐν οἷς περὶ συστημάτω ὀκτοχόρδων ἁρμονικῶν μονον ἔλεγον, περὶ δὲ τῶν ἄλλων γενῶν τε καὶ σχημάτων ἐν αὐτῶ τε τῷ γένει τούτῳ, καὶ τοῖς λοιποῖς οὐδ'ἐπιχειρεῖ οὐδεὶς κατὰ μανθάνειν. ἀλλ'ἀποτεμνόμενη τῆς ὅλης μελωδίας τοῦ τρίτον μέπους ἔντι γένος, μέγεθος δὲ τὸ Διὰ πασῶν, περὶ τοῦτου πᾶσαν πεποίηνται πραγματείαν.Che dice; Quelli adunque che sono stati auanti noi, hanno fatto professione d'essere Harmonici solamente; imperoche solamente diedero opera alle Harmonie; ma non hebbero notitia de gli altri Generi; & di questo n'è segno le Descrittioni de i Systemati harmonici, che sole si trouano: perche de i Diatoni, ouer Chromatici alcuno non ne hà hauuto notitia: essendoche le Descrittioni loro manifestano l'ordine della Melodia; ne i quali Systemati ueramente di Ottochorde hanno solamente trattato delle Harmonie: ma de gli altri Generi & Figure; tanto in esso Genere, quanto ne gli altri, niuno tentò di saperne: ma hauendo solo gustato la terza, ch'è di un Genere di tutta la Melodia, con la grandezza della Diapason, misero quiui ogni lor cura. Questo dice prima Aristosseno; ne à questo contradice, quando dopo passato poco più del mezo del primo Libro; parlando de i Tre generi di Melodia, dice; che 'l Diatonico deue precedere gli altri, come primo & più antico, prescritto della Natura primo; il secondo il Chromatico; ma il Terzo & supremo dice esser l'Enharmonico: essendoche prima ei parla di quelli, che fin'à suoi giorni essercitauano il sudetto Enharmonico; & solamente di esso scrissero nella facoltà della Musica. Et per tal modo si potrebbe accommodar questa Historia, che non ui si trouarebbe alcuna contradicione. Et perche queste cose; come sono anche molt'altre; per la uarietà di quelli che scriuono, sono difficili da sapersi; però potiamo conoscere, quanto sia difficile il uoler trattare una cosa, che sia stata scritta da molti diuersamente; & di questo habbiamo l'essempio del Magno Alessandro; quando fu sospinto dalla Legge Orthia à pigliar l'arme; come dicono; che ciò fu opera di Timotheo; tra i quali Suida è uno; come si è ueduto; ma ue ne sono anco di quelli, che dicono essere stato Senofante; com'io scrissi nel Cap. 7. della 2. parte delle Istitutioni. Simigliantemente tutti quelli che hò ueduto dicono, che Pithagora placò l'animo di quel Giouanetto furioso col mezo del modo Frigio; onde commandò al Sonatore, che mutasse il Modo, & cantasse lo Spondeo; tuttauia Galeno scriue nel Quinto libro de quelli che chiamò dell'Vso delle parti; che fù Damone musico. Per laqual cosa, dopo molte parole fatte di Olimpo & di Timotheo; si in questo luogo, come anco nel Cap. 9. della 2. Parte sudetta; potremo dire; che in questa materia non si può affirmar, page 128 ne negare, se non quello che si può dimostrar con qualche ragione, & con qualche autorità d'Autori approbati: onde la conclusione fù, & è in questo modo: Poniamo che Timotheo Inuentore del Genere chromatico non sia stato quello, che sospinse Alessandro à pigliar l'arme; come dicono molti; seguendo l'opinione di Suida; ma si bene un'altro più antico di lui; imperoche questo, com'ei dice, fù ueramente Sonator di piffaro; & lo chiamò à se Alessandro; & fù più antico di quello che fù Sonator di Lira, ò di Cetera; ciò non farà mai, che non s'appiglino al falso; essendoche tanto l'uno quanto l'altro si trouò in un'istesso tempo. Ma di questo si ueda anco il Cap. 7. della seconda parte dell'Istitutioni, & ueniamo hormai à dire del Secondo Colore, ò Tetrachordo del Genere Enharmonico; ilquale è quello d'Archita; come manifesta Tolomeo nel Cap. 13. del Primo libro de gli Harmonici; la cui forma è quella, che si uede qui appresso.
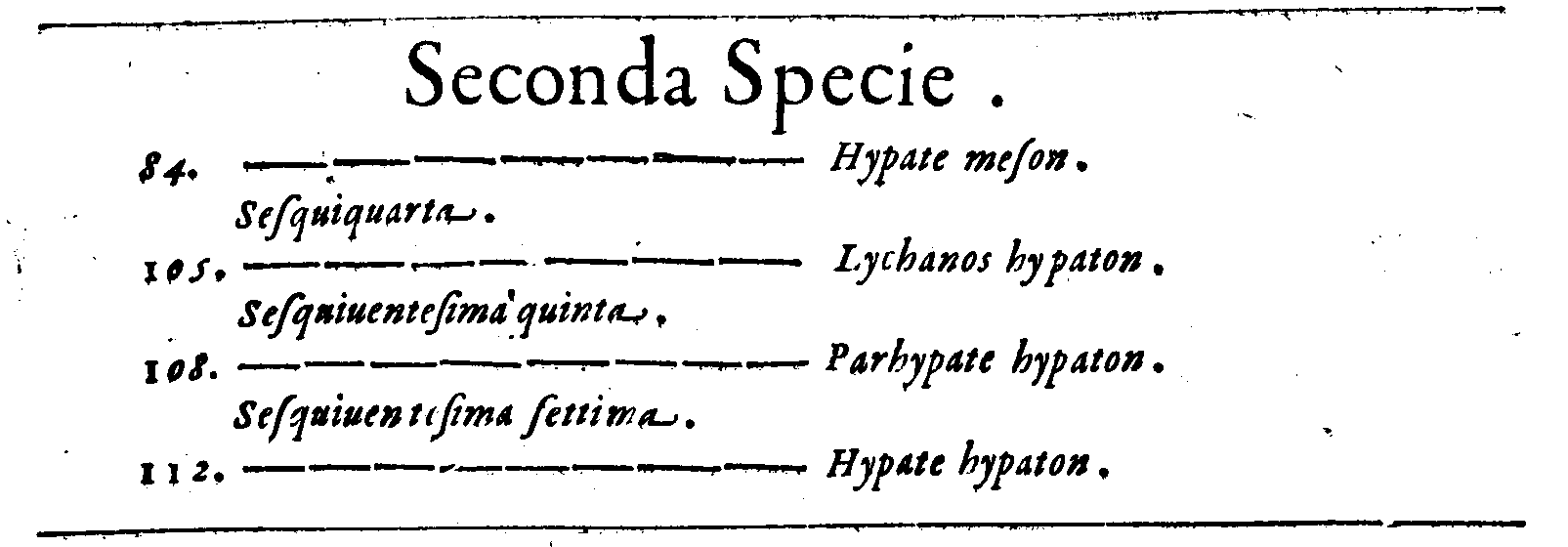
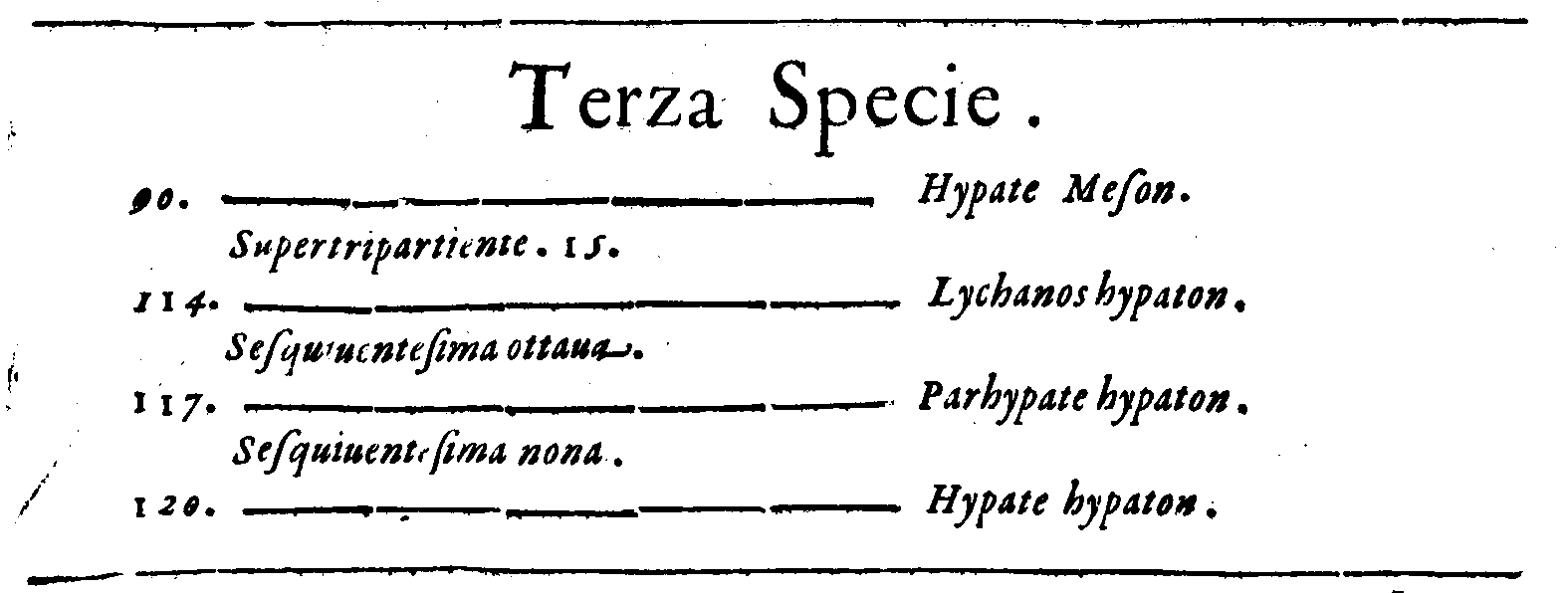
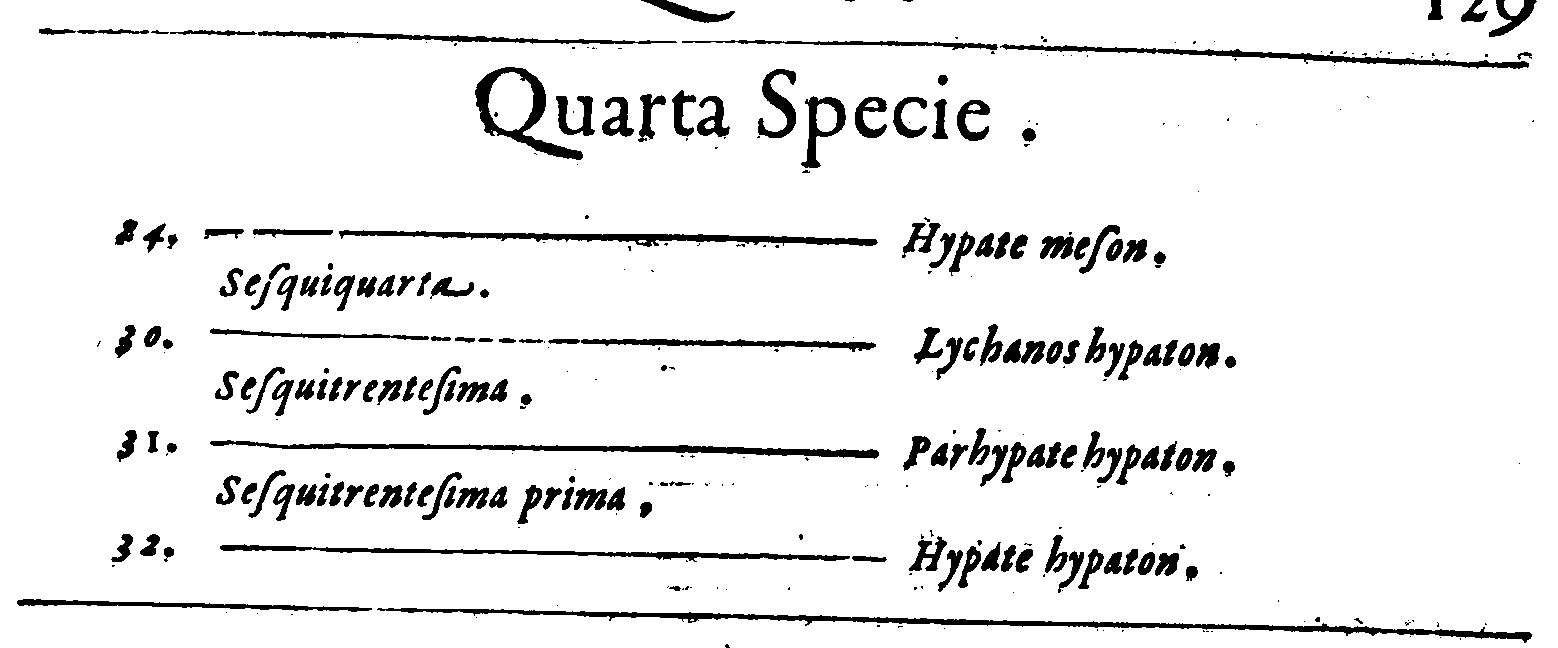
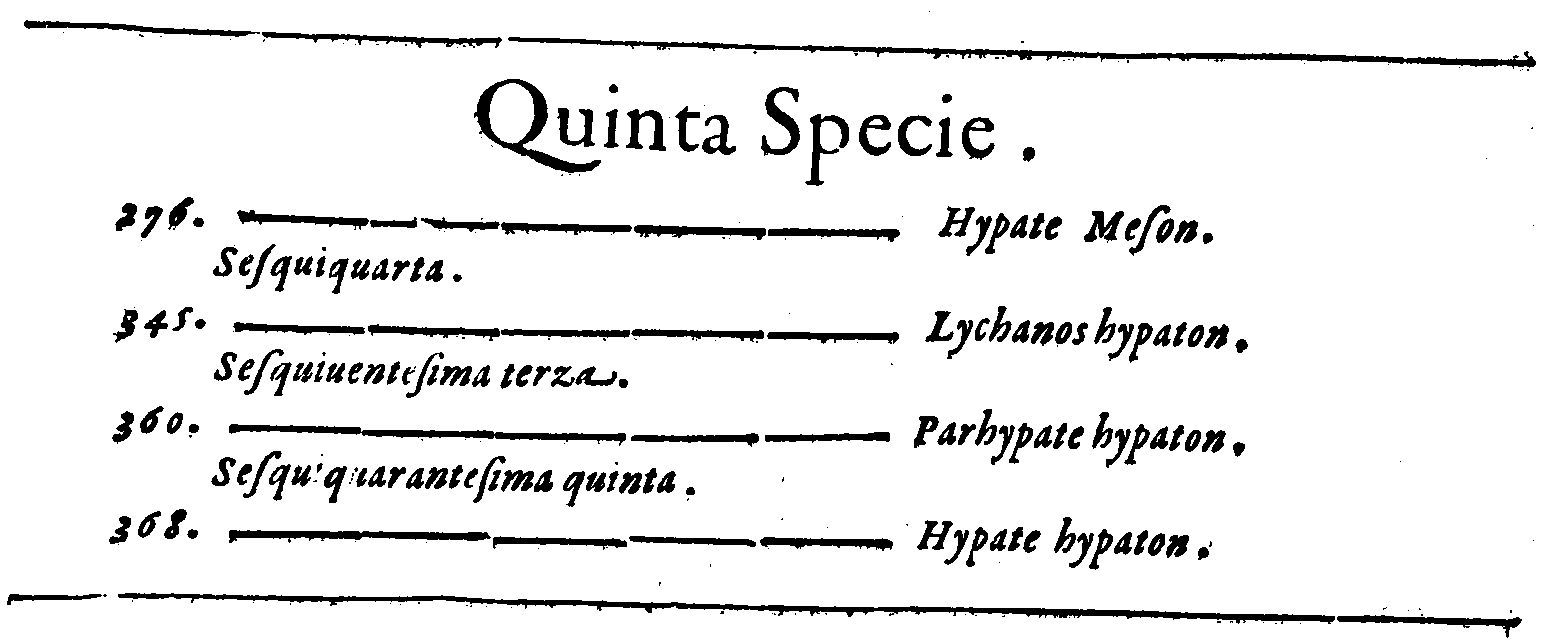
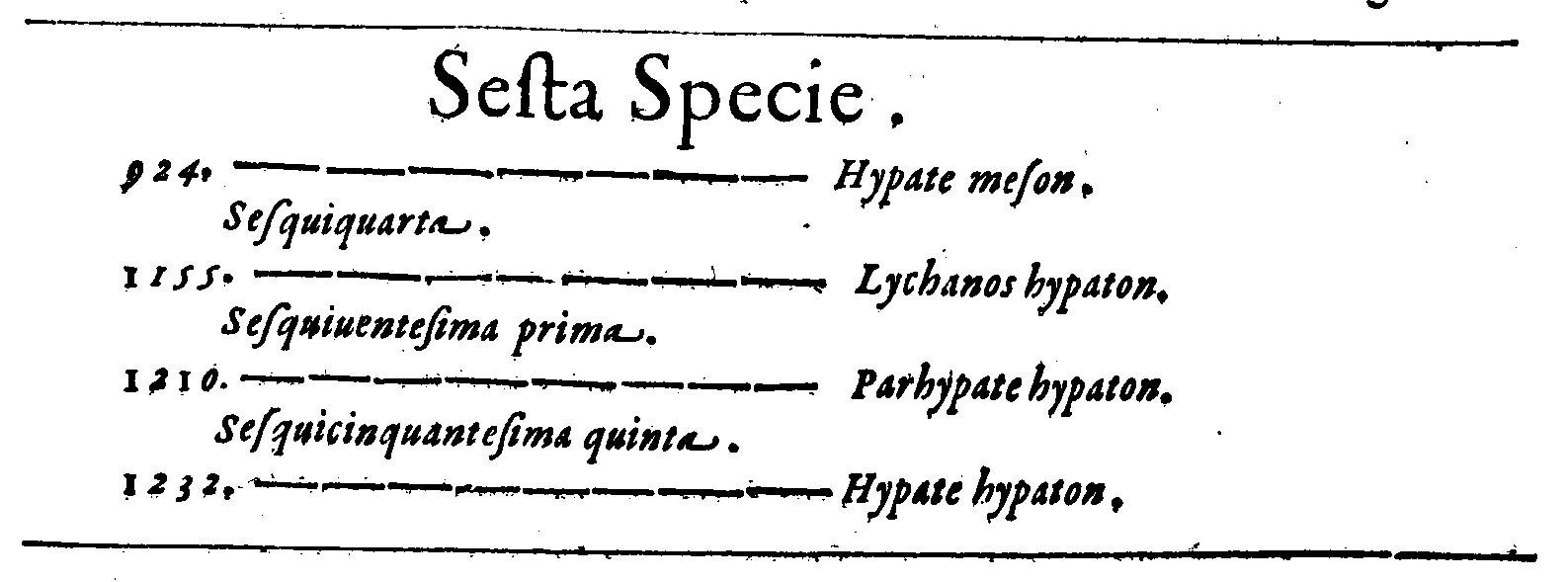
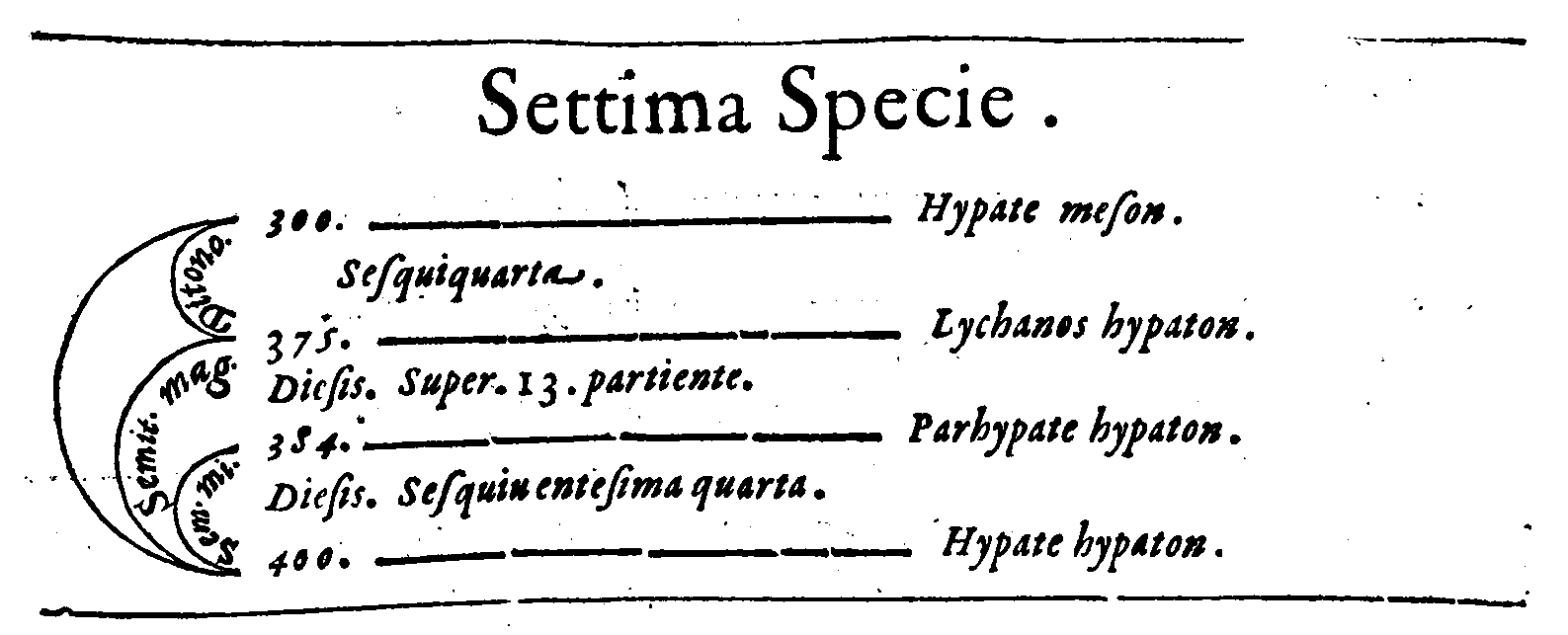
Quello c'habbia indotto alcuni credere, che la Specie che si canta hoggi, non sia la Naturale ò Syntona diatonica; ma più tosto quella, che si adopera ne gli Istrumenti arteficiali, & specialmente in quella da Tasti. Cap. IIII.
che La Specie d'harmonia, che noi usiamo cantare al presente, non sia la Naturale ò Syntona diatonica di Tolomeo; ma quella che si usa ne gli Istrumenti arteficiali temperati, massimamente ne gli Organi, Grauecembali & altri simili,Prencipi ueramente de gli altri Istrumenti. Et credo che ciò sia auenuto à loro, perche hauendo conosciuto col mezo della Esperienza, & da quello c'hò detto nel Cap. 45. della Seconda parte delle Istitutioni; tutte le fiate ch'al suono di cotali Istrumenti s'aggiungono le Voci, da tale congiungimento nascer buono & dolce effetto, & udirsi diletteuole & soaue concento; hanno uoluto anco credere & tener per fermo, che scompagnate le Voci de i Suoni di cotali Istrumenti; non cantiamo, ne usiamo nelle Cantilene uocali altri interualli, che ne i detti Istrumenti si trouano temperati: essendoche uniuersalmente si teneua; prima che con molte ragioni & dimostrationi hauessi scoperto & fatto palese, che ciò non era per alcun modo possibile, ne potea à patto alcuno stare, che la Specie che si canta hoggi & anco si suona in alcuna sorte d'Istrumenti fusse la Diatona diatonica antichissima, come teneuano i Musici; ma si bene la Naturale ò Syntona di Tolomeo, di modo che molti prima non sapendo che partito pigliar douessero; all'ultimo in tal modo è ita la cosa, che non ui è hora alcun di sano intelletto, che non creda & tenga per fermo, che non si canti più, ne soni la sudetta Diatona. Ilperche alcuni hauendo inteso questo nuouo Paradosso, si diedero à studiare per il diritto le cose della Musica; & incominciarono ad entrare à poco à poco nella diritta strada; & affirmare, con quelle ragioni, che pareuano à loro esser sufficienti; cotal cosa esser uera; & tanto più si persuasero questo esser cosi in fatto, quanto furono confirmati da quello che scriue quel Gentil'huomo di gentile spirito & letterato nel suo Discor so, ch'altroue hò nominato; 3. Lib. cap. 3. ilqual Discorso accommodarono & tirarono al loro proposito; come si legge nel Trattato messo fuori sotto 'l nome del nominato mio Discepolo; le cui parole stanno in questo modo.
Trouo per la lunga osseruatione, che le Voci naturali, & gli Istrumenti fatti dall'Arte, non suonano, ne cantano realmente in questa moderna Musica prattica alcuna specie delle Diatoniche antiche nella semplicità loro; ma si bene tre insieme diuersamente mescolate usano hoggi inauertentemente i Prattici, & sono queste: L'Incitato d'Aristosseno, il Diatono diatonico antichissimo, & il Syntono di Tolomeo. Fra gli Istrumenti di chorde tengo che la Viola d'arco, il Liuto, & la Lira con i tasti, suonino il Diatonico incitato di Aristosseno; & muouemi à creder questo, il uedere & udire in essi l'ugualità de Tuoni, ugualmente in pari Semituoni diuisi; & in tal maniera fù distribuito il detto Incitato d'Aristosseno. L'Organo poi, il Grauecembalo & la moderna Harpa, quanto al nouo accrescimento delle chorde, & non circal'istrumento nel primo suo essere, ch'antichissimo tengo; si discostano in questa cosa da quelli; come per essempio; nella diuisione de i Tuoni; per hauergli questi in Semituoni disuguali separati. Gli strumenti da fiato, come Flauti diritti & trauersi, Cornetti & altri simili, hanno; mediante la distributione de fori loro; aiutati appresso dalla buona maniera del discreto & perito Sonatore di essi, facoltà d'accostarsi à questi & à quelli, secondo 'l bisogno & uoler loro; & cosi parimente alle Voci; quando però elle non uolessero contra la lor natura piegarsi, & à loro cedere. Circa poi il Comporre & cantar d'hoggi, mi persuado; per quello ui hò detto; & al presente sono per dirui; che si mescoli il Diatonico diatono col Syntono di Tolomeo. Et le cagioni che mi muouono à creder ciò, sono queste. Certa cosa è, che se 'l si cantasse il Syntono semplice, che i Tuoni & i minori Semituoni; si come in tale Specie ui hò prouato essere la Natura loro; sarebbono inequali & di diuerse grandezze; mediante la qual disaguaglianza, si cantarebbono (per finirla) molte sorti di Quinte, Quarte, Terze & Seste.Et poco dopo questo, soggiunge page 132 le seguenti parole:
Dellequali cose non si troua per ancora (ch'io sappia) esserne state auertite alcune da Maestri di quest'Arte; ma ne anco è alcuno, che nel cantar queste più Arie insieme; che hormai sono Centocinquant'anni, ch'elle s'introdussero; habbia mai udito & oda tal confusa diuersità d'Interualli: perche in uero non u'interuennero mai; ne hoggi u'interuengono.Ilperche si conosce, che costoro da questo argomento restarono persuasi nel primo incontro & nella loro opinione; ilquale argomento s'hauessero ben considerato, haurebbono trouato, che doue dicono;
che si ode una confusa diuersità d'Interualli,tal cosa esser proceduta & procedere, dal non hauere inteso la cosa, come si deue: percioche se cotali cose, d'alcun Maestro di quest'Arte, ne d'alcun'altro, non sono mai state auertite; questo è accaduto, perche mai non caderono sotto 'l Senso; onde niuno mai l'hà udite, ne hora meno si odono; ne mai s'udiranno per l'auenire, tra quelli c'hanno buona intelligentia della Musica: essendoche (com'è uero quello che dicono) mai non interuenne, ne meno hoggi interuengono, ne interueniranno per alcun tempo cose tanto horribili da udire & tanto lontane dal uero. Et se ui fusse alcuna confusione come affermano, si potrebbe dire, ch'eglino sarebbono stati quelli, che ue l'hauessero posta: Et che maggior confusione si può udire in questa Scientia, che quando il Musico & il Cantore non sanno, ne conoscono quel che si facciano? essendoche quando si cantassero tre Specie diuerse insieme mescolate; sarebbe, non dirò difficile, ma impossibile, che 'l Musico ò Compositore, & il Cantore sapesse quello, che facesse; quantunque l'uno & l'altro fusse sapiente & molto bene essercitato nella sua Arte. Inquanto poi dicono, ch'io tengo & credo la tal cosa & la tale, & altri modi simili di parlare; questo ual poco; anzi nulla in una Scientia, com'è la Musica senza dimostrarlo; percioche il uedere & l'udire una cosa senza farne la proua essatta per hauer la certezza di cotal cosa; come hò detto altre uolte; nulla ò poco rileua; tanto più, che l'equalità de Semituoni, che dicono essere nella Viola d'arco, nel Liuto & nella Lira co i tasti; & anco nel Diatonico incitato d'Aristosseno; come dimostrerò al suo luogo; non può esser uera; senza hauerne fatto cotal proua; ne anco il discostarsi ò l'auicinarsi (termini che usano spesso) l'una cosa ad un'altra; dimostra che questa & quella siano una istessa; se ben s'assimigliano; ma sempre saranno due cose differenti. Et di più, gli Istrumenti da fiato nominati; per hauer, mediante la loro distributione de i fori, facoltà d'accostarsi à qual si uoglia delle due sorti d'Istrumenti nominati & cosi alle Voci; quando saranno aiutati dalla buona mano & dalla discretione & peritia del buon Sonatore di qual si uoglia Istrumento da fiato, secondo il bisogno & il suo uolere; non farà mai, che sia leuata la confusione, ma più tosto di nuouo riposta. Ne è buono argomento, ne buona proua, il dire di persuadersi, che nel cantare & comporre moderno si mescoli il Diatono col Syntono; & credere una cosa, senza il dimostrarla; & il dire, che se questo si cantasse solo, si udirebbe molte sorti di Quinte, Quarte, Terze, Seste & Ottaue, è ragione non solamente molto debole & di poco ualore; ma non è anco uera, come uederemo. Questa adunque è stata la prima cosa, c'hà mosso i sudetti à credere, che non si canti & suoni la Specie Naturale ò Syntona di Tolomeo. La seconda è; perche quello che si canta hoggi per modo alcuno (come hanno potuto conoscere principalmente da i miei Scritti) non può esser realmente l'Antichissimo diatono; per esser dissonante nel Ditono & nel Semiditono, & molto differente da esso ne gli altri interualli; ilche è tanto manifesto, che non accade farne alcuna replica. Dicono però che 'l Diatono d'hoggi; cioè, quello ch'intendono che si canti al presente; conuiene co 'l Syn page 133 tono in alcune cose; onde ripigliando una parte del sudetto Discorso fatto da quel Gentil'huomo; seguono, dicendo:
Primieramente l'Imperfette consonanze di questo (lasciando per hora di considerar le Dissonanze) crederò non errare à dire; che elle caschino quasi che sotto le proportioni di quello; ma non già son di parere, che elle si congiunghino insieme de parti à esso simili; come per essempio: Tengo che la Terza maggiore sia contenuta da una proportione irrationale, assai uicina alla Sesquiquarta; ma non già che i suoi lati (per cosi dirgli) siano il Tuono Sesquiottauo & lo Sesquinono; ma si bene due parti uguali di detta Terza, talequale ella è diuisa al modo de Tetrachordi d'Aristosseno, ma non cosi essattamente. La Terza minore poi crederò, ch'ella sia composta d'un Tuono dell'istessa misura di quelli della maggiore, & d'un'altro Interuallo alquanto più grande della Sesquindecima, & in tal maniera & di si fatte parti composti insieme uerranno tutti gli altri Interualli; &, dall'Ottaua in poi, tengo che qual si uoglia altro non sia in modo alcuno contenuto dalle proportioni assegnate loro; intendendo nella maniera che ueramente si cantano hoggi communemente.Cosi dicono; & non starò hora à dimostrare quanto s'ingannano in questa sua proposta in molte cose; ma dirò solamente, che questa è la prima conuenientia, c'hà questo loro Diatonico, c'hoggi s'adopera ne i canti col Syntono di Tolomeo, lasciando l'altre da un canto, che per esser fondati sopra fondamenti falsi, sono di poco ualore; non s'accorgendo però, che la cosa stà altramente, & al mio & non al loro modo; & che la diuisione de i Tetrachordi fatta al modo d'Aristosseno, uà ad un'altra maniera di quello ch'intendono, & che anco la Distributione che fanno, & togliono per il Mezo di dimostrare questo loro pensiero esser uero, non è la sua, ma la mia; come al suo luogo sarà manifesto. Et per confermare questa loro inconuenientia, soggiungono queste parole:
Di maniera che per le perfette consonantie nel modo che si cantano hoggi, uengono accostarsi al Diatono diatonico; & le imperfette al Syntono di Tolomeo; ma sempre d'una istessa misura & ugualità de Tuoni:Quasi che 'l Syntono non contenesse quelle istesse Consonanze perfette nelle lor uere forme, di quello che fà il Diatono; lasciando anco di dir della equalità de i Tuoni tante fiate replicata, detta fuori d'ogni uerità. Alla fine dicono, che
Qual si uoglia Interuallo dall'Ottaua in fuori, non cade, cantato nella maniera che si costuma hoggi, sotto la proportione & misura di quella, ne di questa specie:onde uengono à concludere, che non si canta altra Specie, che quella c'hanno mostrato nella Distributione de gli Interualli, contenuti nella Diapason F. & f. della Quarta Specie; come uederemo: Laqual conclusione si sforzano prouar con la sudetta Distributione; & di nuouo stabilire cotale opinione loro strana; quando dicono, che
Credono che si cantino hoggi gli Interualli consonanti da i più eccellenti Cantori di purgato Vdito, che si trouino dentro le uere proporitoni loro.Et ciò dicono ueramente bene; percioche in fatto è cosi: ma non intendendo quello che dicono; come instabili soggiungono quello, che discorda da quello c'hanno detto in molti luoghi; cioè, che
Gli arteficiali istrumenti si suonano, chi più & chi meno da esse lontane:& si sforzano anco molto di uoler far credere & toccar con mano, che si canta hoggi circa la perfettione de gli Interualli, non meno imperfettamente (come dicono) di quello che si suoni: Perche uogliono che
Di necessità, qual si uoglia Quarta uenga sempre, nell'esser cantata secondo l'uso di questa nostra Prattica moderna, superflua; & diminuta la Quinta.Finalmente concludono questa loro opinione, come dimostrata, esser uera contra quello c'hanno detto di sopra con queste parole:
Ne segue adunque necessariamente, contra il commun parere; che le Quinte si cantino hoggi diminute, & superflue le Quarte, dal lor uero essere: Per lo che, si uiene, dall'Ottaua in poi, à cantar qual si uoglia Interuallo fuori della uera page 134 sua proportione; & consequentemente dissimile da quelli, che sono contenuti nel Senario & dal Syntono; quantunque l'Vniuersale gli approui per perfetti, & se ne satisfaccia intieramente; per non hauere udito i ueri; & toltoti da qual sia speranza di poterli migliorare.Ma non può stare insieme il Perfetto & lo Diminuito: ilperche quanto costoro s'ingannino, & quanto s'ingannarebbe ogn'uno che tenesse cotale opinione per uera, lo uedremo; se ben li potrebbe parere, che costoro hauessero ogni ragione, quando dicono con molta arroganza contra loro stessi:
Hora da questo solo abuso considerate l'Imperfettione della Musica de nostri tempi, & di quanto l'Vniuersale s'inganni, & quanto malageuolmente possa la uerità delle cose conoscere; & quanta poca cognitione habbia della uera Musica, non hauendosi fin'hoggi conosciuto, ne anco la grandezza, non che la qualità & natura de gli Interualli cantabili & udibili; che sono i semplici suoi Elementi & Principij:Ilche dicono, ò come ignoranti delle cose, ò come ingrati delle fatiche di quelli, che s'hanno affaticato per illustrar questa Scientia, cercando eglino di porla un'altra fiata al buio: ma dubito, che ui concorra l'una & l'altra di queste due cose; percioche le molte contrarietà, che si trouano ne i loro Scritti, hora affermando, hora negando una cosa, ilche dimostra instabilità; col trattare cosi bene, come fanno, le cose Mathematiche; ilche nasce dalla Ignorantia; Il uoler diminuire & fuor l'altrui honore, nasce da Malignità inescusabile. Si potrebbe ueramente dire, ch'alcuno in tutto & per tutto fusse fuori di sè, quando credesse, che sin'hora si hauesse hauuto tanto poca cognitione delle cose della Musica; come dicono; & che da altri che da loro non si hauesse potuto hauer la perfettione di questa Scientia; della quale ne fanno gran professione: percioche da quello c'habbiamo in parte dimostrato, & da quello che si dimostrerà; si potrà conoscer essere il contrario; & quanto possino esser buon mezo nell'acquistar cotal cosa. Ma il Tempo padre della Verità, scopre il tutto; ilperche credo anco, che molti di loro fin'hora se ne siano chiariti; & conoscano questa loro opinione esser uana & sciocca; & che 'l mio credere, che si canti la sudetta Specie naturale ò Syntona & non altra, non sia errore; come non credendo eglino, che l'Imperfette consonanze (come hò già scoperto) usate da i Moderni ne i lor Contrapunti; siano quelle, c'habbiano le Forme loro naturali delle Proportioni contenute nella sudetta Specie; che sono rinchiuse tra le parti del Senario; & non quelle del Diatono diatonico; se bene non hanno mai negato alcuno de i miei Principij; anzi più tosto confirmato. Ma da quello c'hò scritto nel Primo capo di questo Libro; dicono due cose: prima, che dalla nouità della cosa mi lasciai indurre; & dopoi, à credere & dire, che cosi fusse il uero, che si cantasse la sudetta Specie. Dicono,
C'hò cercato di dimostrare al Senso & all'Intelletto con diuerse ragioni, che le sudette Consonanze non siano in modo alcuno quelle del Diatonico;& dicono bene: percioche hò dimostrato ueramente, & non persuaso cosi esser à questi due Giudici principali della Scientia, che nominano, in tutte le cose, ch'intorno à i Suoni possono occorrere; i quali, essendo concordi, mi dauano segno euidentissimo, che non ui potea esser'errore; onde come potea far di non mi lasciar persuadere una tanta Verità? & conoscendo ciò esser uero col mezo di molte dimostrationi, come non lo potea credere, & dirlo apertamente; poiche lo sapea? Hò creduto ueramente à questo modo, & à questo modo credo, & crederò per l'auenire; essendoche non è semplicemente credere; ma sapere col mezo della Dimostratione: ilqual modo nelle Scientie, senza la Dimostratione; come auiene spesso, non è sapere: onde resta l'errore essere il suo, se credono, come dicono, & di tutti quelli che credono con esso loro; & non il mio: quando si lasciano persuadere ad una loro sciocca & falsa page 135 ragione, dicendo; che
Dal Syntono di Tolomeo si hanno le Terze & le Seste consonanti, & che queste, che cantiamo, sono altresi consonanti.; adunque sono l'istesse di Tolomeo: Ma quelle che cantiamo sono contenute sotto quelle forme, che si trouano temperate ne gli Istrumenti da tasti, adunque non sono quelle di Tolomeo.Laonde hauendosi lasciato persuadere à cotal ragione; si hanno lasciato indurre à credere quello, che non è uero: percioche non hanno conosciuto da quello ch'io scriuo nel Cap. 6. del 1. Lib. la fallacia della consequenza; che proceder nell'argomentare da un Genere ò Specie ad un'altra; & dal Naturale all'Arteficiale, non ual cosa alcuna; essendoche se l'hauessero conosciuto, haurebbono inteso, che la Conclusione del loro Sillogismo era falsa: & forse che si haurebbono abiurati di cotale opinione dal uero molto lontana: ilche si uedrà esser cosi à i suoi luoghi. Ma prima che passiamo più oltra, mostraremo i mezi, co i quali hanno uoluto dimostrar, questa loro opinione cosi strana esser uera.
In quante maniere si siano sforzati di prouare, che la Specie che si canta & sona hoggi, non sia la Naturale diatonica ò Syntona di Tolomeo; & prima del Primo modo. Cap. V.
Voler far uedere, che in essa congiuntione ò Specie, si troua maggior numero d'Interualli, di quello che si troua nella Specie che cantiamo.Il secondo fanno col mezo delle Proportioni, co i Numeri, sottrahendo la forma ò proportione, che ritrouano in un minore, da quella d'un' altro che sia maggiore. Ma nel Terzo si sforzano di mostrar con la Temperatura dell'Istrumento da Tasti, la quale hò nominato di sopra: mandata in luce dal mio Discepolo, come da suo Inuentore. Quanto al Primo mezo, si sforzano di dimostrar questa loro chimera; & di prouar esser uero quello, che tengono, con alcune loro sciocche dimostrationi; percioche fanno professione di far sensatamente uedere in fronte; che à quelle dell'altre Specie diatoniche si riduca quella, nella quale i moderni Contrapuntisti compongono, & i Cantori cantano le lor Cantilene; & pigliano per lor fondamento i Sedeci Interualli sequenti per ordine, che si trouano collocati tra le chorde del sudetto Systema ò Costitutione arteficiale; contenuti ne i lor minimi & radicali termini; che in se contengono le due nominate Diapason poste insieme; & non sono maggiori di essa Diapason; tra i quali pongono prima d'ogn'altro il Comma seguendo gli altri di mano in mano; & sono quelli del seguente essempio: page 136
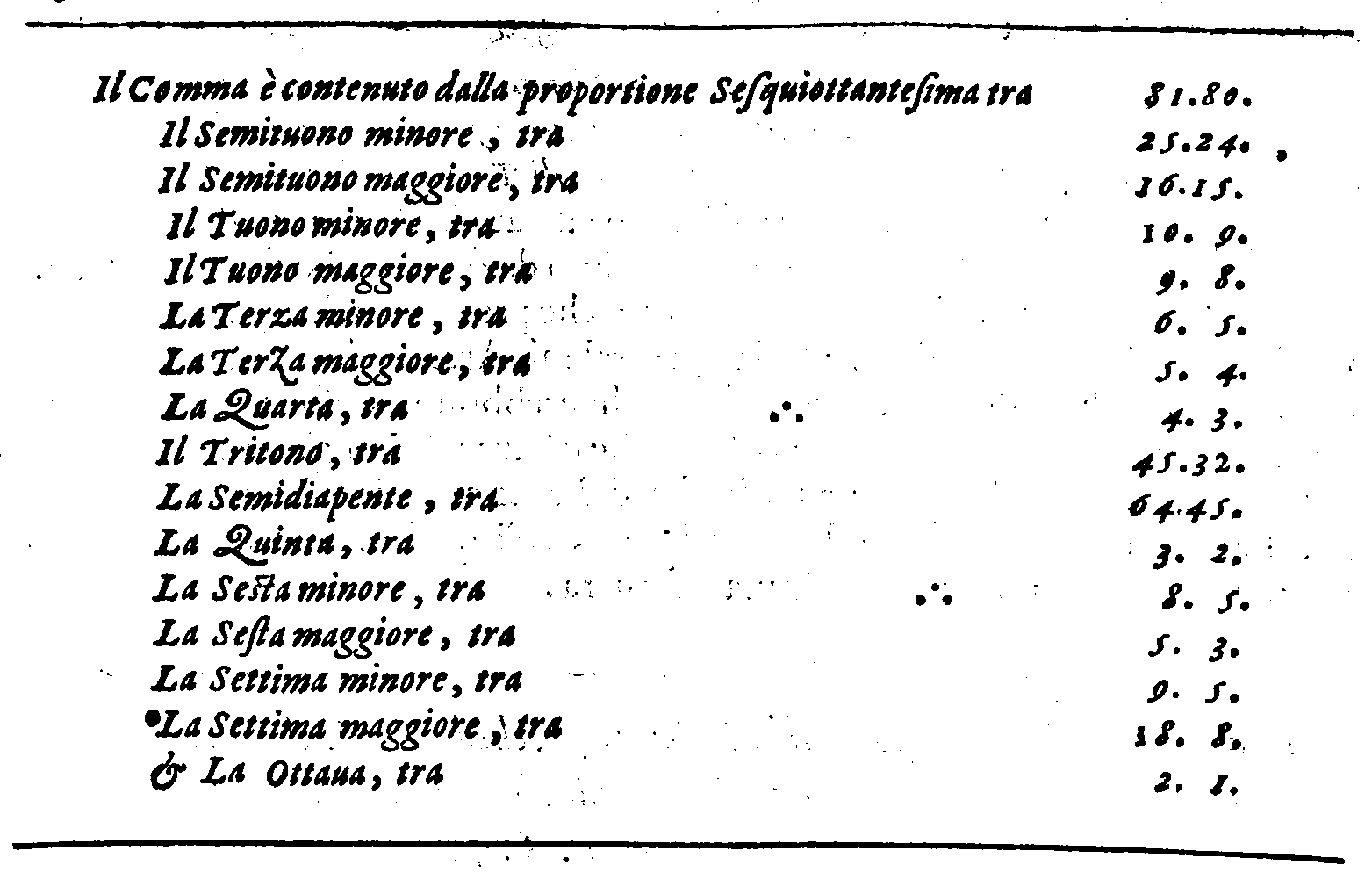
Vogliono prouare con questi Principij. che questa Specie non è quella di Tolomeo, detta Naturale ò Syntona; & che questa consta di maggior numero d'Interualli diuersi, de i proposti:percioche fondano ogni loro ragione sopra quelli Interualli, che nascono nel sudetto Systema, tra le chorde del Tetrachordo Synemennon, & quelle del Diezeugmenon; ouer delle due sudette specie della Diapason insieme congiunte: imperoche considerano tra esse chorde molti altri Interualli differenti di forma, da i Sedeci mostrati, come uederemo al suo luogo; i quali non fanno al proposito; per non essere di cotal Specie; quantunque nascono per accidente nel suo Systema arteficiale, per la sudetta unione. Per prouare adunque cotesta loro Chimera usano alcune loro Dimostrationi, fondate sopra le due sudette Diapason, diuise secondo la natura del Syntono ne i suoi Interualli; la prima delle quali, è la seguente; che contiene le chorde del
 Tetrachordo Meson & quelle del Diezeugmenon; l'altra quelle del Meson &
quelle del Synemennon. Alle quali anco aggiungono le due sequenti, quanto si può dire monstruose; formate secondo il loro capriccio, & fatte de Se
page 137
Tetrachordo Meson & quelle del Diezeugmenon; l'altra quelle del Meson &
quelle del Synemennon. Alle quali anco aggiungono le due sequenti, quanto si può dire monstruose; formate secondo il loro capriccio, & fatte de Se
page 137
 mituoni solamente; & immediatamente, senza porre alcuna cosa di mezo, seccamente uengono à dire; che ne gli essempii seguenti le due Note (per dir come
mituoni solamente; & immediatamente, senza porre alcuna cosa di mezo, seccamente uengono à dire; che ne gli essempii seguenti le due Note (per dir come
 dicono) del primo senza dirne alcuna ragione; & farne alcuna dimostratione;
non sono Vnisone; & che quelle del Secondo non sono lontane per la medesima distantia da quelle del Terzo; ne quelle del Quarto per il medesimo interuallo, che sono quelle del Quinto. Dicono anco quelle del Sesto esser men lontane di quelle del Settimo; & quelle del Ottauo esser due Interualli simili à quelli, che si trouano tra D. sol re & F. fa ut; & ciascun di loro esser l'Istesso dell'antico Semiditono, & necessariamente dissonante. In simil maniera uogliono prouare ancora, che è maggior Interuallo quello del nono essempio, che
dicono) del primo senza dirne alcuna ragione; & farne alcuna dimostratione;
non sono Vnisone; & che quelle del Secondo non sono lontane per la medesima distantia da quelle del Terzo; ne quelle del Quarto per il medesimo interuallo, che sono quelle del Quinto. Dicono anco quelle del Sesto esser men lontane di quelle del Settimo; & quelle del Ottauo esser due Interualli simili à quelli, che si trouano tra D. sol re & F. fa ut; & ciascun di loro esser l'Istesso dell'antico Semiditono, & necessariamente dissonante. In simil maniera uogliono prouare ancora, che è maggior Interuallo quello del nono essempio, che
 page 138
quello del Decimo; & quello dell'Vndecimo esser dissonante simigliantemente,
& maggiore del Duodecimo. Soggiungono etiandio, che le figure del Terzodecimo & quelle del Ventesimoquarto, non sono lontane per una Quinta; & le
due note seconde del Quartodecimo non esser distanti per un Tritono; considerate però nella maniera, che la intendono; cioè, in una Quarta, nella parte più
graue; & in un minor Semituono nell'acuto. Quelle anco del Quintodecimo
(secondo la loro opinione) non sono lontane per una Semidiapente; considerate in due Terze minori; & le due seconde figure del Sestodecimo, dicono non
esser lontane una dall'altra per una Diapente; considerandole però in una Semidiapente nella parte acuta, & in un minor Semituono nel graue. Non uogliono
anco, che sia la medesima distanza tra le note del Decimosettimo essempio, che
si troua tra quelle del Decim'ottauo; ne che le figure del Decimo nono siano distanti l'una dall'altra per Sesta maggiore, Niegano oltra di questo, che le note
del Ventesimo siano distanti per una Settima minore; & quelle del Ventesimo
primo siano lontane l'una dell'altra per una Ottaua: ma uogliono che quelle del
Ventesimo secondo siano equalmente distanti; & anco ultimamente di quelle
dell'ultimo essempio uogliono che cosi sia. Però, in qual maniera con questa
lunga & sciocca loro diceria possino prouar quello, che tengono, lascio considerare à quelli, c'hanno giudicio sano delle cose della Musica; poiche cotali Interualli non sono (come hò detto) della specie Syntona; ne entrano in alcuna compositione. Ma ritornando di nuouo alle Figure
del Terzodecimo & del Ventesimoquarto essempio; non contenti di quello, c'hanno detto, dicono ancora;
che
page 138
quello del Decimo; & quello dell'Vndecimo esser dissonante simigliantemente,
& maggiore del Duodecimo. Soggiungono etiandio, che le figure del Terzodecimo & quelle del Ventesimoquarto, non sono lontane per una Quinta; & le
due note seconde del Quartodecimo non esser distanti per un Tritono; considerate però nella maniera, che la intendono; cioè, in una Quarta, nella parte più
graue; & in un minor Semituono nell'acuto. Quelle anco del Quintodecimo
(secondo la loro opinione) non sono lontane per una Semidiapente; considerate in due Terze minori; & le due seconde figure del Sestodecimo, dicono non
esser lontane una dall'altra per una Diapente; considerandole però in una Semidiapente nella parte acuta, & in un minor Semituono nel graue. Non uogliono
anco, che sia la medesima distanza tra le note del Decimosettimo essempio, che
si troua tra quelle del Decim'ottauo; ne che le figure del Decimo nono siano distanti l'una dall'altra per Sesta maggiore, Niegano oltra di questo, che le note
del Ventesimo siano distanti per una Settima minore; & quelle del Ventesimo
primo siano lontane l'una dell'altra per una Ottaua: ma uogliono che quelle del
Ventesimo secondo siano equalmente distanti; & anco ultimamente di quelle
dell'ultimo essempio uogliono che cosi sia. Però, in qual maniera con questa
lunga & sciocca loro diceria possino prouar quello, che tengono, lascio considerare à quelli, c'hanno giudicio sano delle cose della Musica; poiche cotali Interualli non sono (come hò detto) della specie Syntona; ne entrano in alcuna compositione. Ma ritornando di nuouo alle Figure
del Terzodecimo & del Ventesimoquarto essempio; non contenti di quello, c'hanno detto, dicono ancora;
che Nascendo la Quinta dalla Terza maggiore & dalla minore, si può insieme col Zarlino argomentare, che elle non siano altramente tali; ma di proportione & genere diuerso;aggiungendo nel margine de i loro Scritti; come questo fusse errore; queste parole:
Zarlino alla Prop. 30. del Secondo Ragionamento delle sue Dimostrationi.Io uorrei uolontieri saper da loro, doue nasca questo errore; ò dall'essempio che adducono, ò da quello che si troua scritto nella sudetta mia Proposta. Se uogliono che cotale errore nasca dalla Proposta, questo non può stare; percioche è uera & dimostrata per tale; & è in questo caso propriamente come la Legge, che manifesta solamente il Delitto, & condanna il Reo: onde, si come essa Legge, & il Legislatore non pecca, ne commette alcuno errore, manifestando il Delitto, & condannando il Reo; cosi tal Proposta non può etiandio ne lei, ne io, ch'io l'hò proposta, commettere alcuno errore; essendo ella uera, ne hauendo in se diffetto alcuno; quando manifesta cotal difetto. La Proposta 30. dimostra, che la Diapente contiene due Tuoni maggiori, un minor & un maggior Semituono; com'è uero; & essi dicono, che le Quinte sudette contengono una Quarta & un Tuono minore; adunque non sono (dicono) Quinte. Stà bene; ma uorranno forse dire; adunque è errore del Zarlino, che tiene che cosi sia? Et se cosi uolessero dire, questa loro conclusione non concluderebbe bene, percioche sò troppo bene, intendendola, come essi la pigliano, che non sono Quinte; & non si può negare, che siano tanto minori, quanto importa un de nostri Comma. Ne il Prattico ueramente erra, perche le pone in atto per Quinte consonanti, nell'Istrumento naturale; nelquale ogni giorno le ode tali; ò perche le riceua per tali nell'Istrumento arteficiale temperato: ne meno erra il Theorico; come pazzamente tengono costoro; percioche le piglia per quel uerso, che si deono pigliare, cioè nella lor forma uera, & non fuori di essa; percioche sà troppo bene, che la Specie naturale & Syntona non contiene in se cotali monstri. Errarebbe però ogn'uno, che le ponesse in atto, come essi le pongono, & considerano; & page 139 uolesse dedur le sue conclusioni da un Genere ò Specie ad un'altro; ò da un particolare ad uno uniuersale; come questi fanno; i quali sempre ò almeno per la maggior parte, ò malignamente ò ignorantemente che lo facciano, concludono in questo & in ogn'altro loro essempio dall'Arteficiale al Naturale; il ch'è fuori di proposito: percioche l'essempio che adducono delle Quinte & d'altri Interualli mostrati di sopra, cauano dal Systema arteficiale & non dal Naturale ò dall'Arteficiale temperato; & concludono, che essendo cotali Quinte nell'Arteficiale dissonanti; ne possendosi porre in uso consonanti; che non possono anco nel Naturale ouer nell'Arteficiale temperato esser consonanti, & s'ingannano. Dicono però bene, quando saranno contenute dalle forme, con le quali sono proposte da loro: ma quando saranno collocate nelle uere forme & naturali; come si debbono intendere; & come le intende la Natura; allora la cosa andrà in un' altro modo. Il Naturale però non è sottoposto ad alcun'ordine Arteficiale; ma si bene per il contrario: percioche l'Artefice, per quello che si è discorso nel Cap. 4. del Primo Libro, uà imitando la Natura, quanto puote; ma la Natura mai non imita l'Arte in cosa ueruna. Questa, nel temperare gli Istrumenti si sforza di leuar ogni difficoltà; acciò si possa in cotali Istrumenti co i Suoni imitar quella, nelle Voci; & fà più che puote, acciò ch'ogni positione, ò graue ò acuta ch'ella sia; facilmente habbia la sua corrispondente nella parte opposita, in qual si uoglia proportione; & quella può formare ogni Interuallo, grande ò picciolo; per esser ella al tutto libera; ilche non auiene all'Artefice, se ben fà ogni proua, per imitare essa Natura con la sua Arte. Questo non hanno conosciuto questi Aristarchi; onde sempre c'hanno uoluto parlar di simili fatti; poche conclusioni hanno fatto, che siano uere. Anzi uoglio dire; che non sapendo eglino distinguere queste due cose l'una dall'altta; uogliono che la Natura sia soggetta all'Arte; come si conosce dalle loro conclusioni & dimostrationi; se dimostrationi si possono chiamare. Et se uolessero dire, ch'è impossibile, uolendo far che cotali Quinte siano Consonanti; che non segua questo inconueniente; che l'uno de Tuoni maggiori, ch'entra nella compositione delle sudette Quinte, non seguiti l'altro; & che cosi sarebbe questa Specie non pura Syntona; ma d'un'altra Specie; si potrebbe dire, che se bene l'un de i Tuoni maggiori succedesse all'altro, per cagione d'empire (dirò cosi) la Quinta di modo ch'ella consti di tutte le sue parti, & ne gli estremi habbia la sua uera forma; non per questo si potrebbe dire, che la Specie non fusse semplice Syntona: percioche cotale Quinta sarà composta de i proprij Elementi; essendoche in essa si trouaranno due Tuoni, il maggiore & lo minore, col maggior Semituono; proprii & naturali Elementi, de i quali si compone la Specie: perche se bene in qual si uoglia Consonanza composta de i detti Elementi nel Systema massimo; come sarebbe dire del Syntono, composto de i suoi Tetrachordi naturali, dirò cosi, non si ritrouasse, che 'l Tuono maggiore hauesse luogo dopo un'altro maggiore, nella sua compositione; acciò non fusse ne i suoi estremi dissonante; non si potrebbe però dire, che bisognando in cotal'ordine un tale Interuallo; che tale Consonanza non fusse naturale di tal specie: Et tanto più, quanto ciò procedesse da gli Istrumenti naturali; poiche alla Natura è concesso di modulare quelli Interualli, che tornano al proposito, nel formar le consonanze ne i loro estremi. Replicheranno forse; & diranno; se due Tuoni maggiori si porranno in atto l'un dopo l'altro ne nascerà una Terza, che contenerà due Tuoni maggiori equali; cioè, un Ditono dissonante ne i suoi estremi; ilquale non è della Specie Syntona, ma della Diatona; adunque il Syntono non si adopera semplice. Rispondo, che allegare un'incon page 140 ueniente, per dir cosi, non è sciogliere un dubio. E' uero che nascerrebbe cotal Ditono; considerando la sua Compositione; ma questo Ditono non si porrebbe, ne si udirebbe mai, nel formar le Consonanze, che contiene il Syntono; per esser dissonante: percioche non si può dire, che dal congiungimento di due Tuoni, che formano un Ditono, à questo modo la Specie sia uariata, & non sia semplice; per hauer formato co i suoi interualli un'Indiuiduo, che non è contenuto nella sua Specie: come anco non si può dir nella generation d'un Mullo, che nasce d'una Caualla & d'un'Asino, che le Specie di questi due animali, l'una separata dall'altra, non sia l'una semplicemente Cauallina & l'altra Asinina; per hauer nella loro commistione generato una Terza specie, ch'è quella del Mullo; essendoche se ciò fusse uero, ne seguitarebbe questo istesso inconueniente in molti altri Interualli simili; che sono quelli de i Semituoni mostrati più oltra nel Cap. 11. che quantunque nascono della specie Syntona, per congiungimento de i suoi Interualli; tuttauia non sono tutti della Specie, se non un solo; come si è in più luoghi dimostrato. Ma questo interuallo del Ditono composto di due Tuoni maggiori non si trouarà già mai ne gli Affronti del graue & dell'acuto ne i Contrapunti; ma si bene nel cantare: & si trouerà anco il Ditono considerato composto d'un Tuono maggiore, & d'un minore; contenuto ne gli estremi dalla proportione Sesquiquarta.
Seconda ragione ch'usano questi Speculatiui Moderni, in uoler prouare il loro capriccio. Cap. VI.
 . della detta specie; ilquale si troua tra le chorde del
Sudetto Systema. Onde non si può ragioneuolmente dire (percioche s'argomentarebbe dall'arteficiale al naturale) che nel Systema massimo del Naturale
ò Syntono si trouano più Interualli di quelli, che usiamo nel cantare & sonare;
& che quello che cantiamo & soniamo non sia il Naturale ò Syntono di Tolomeo. Et se ad alcuno paresse; che la Specie che usiamo non fusse la sudetta Naturale ò Syntona: per non ritrouarsi in molti luoghi del detto Systema da una
chorda all'altra, molte Consonanze nella loro perfettione; come si scorge nel
Sequente Systema, ouero essempio; ma si bene molte loro specie, che sono dissonanti; ilche non si uede auenire nelle Voci & ne gli Istrumenti arteficiali temperati; s'ingannarebbe di gran lunga; percioche non si può dire, ne concludere
senz'errore, nella Compositione del Systema della Specie Naturale, ò Syntona
diatonica non si trouano quelli Interualli, che si trouano tra le Voci, & tra le chorde de gli Istrumenti arteficiali temperati;
adunque non s'usa cotale Specie:
Essendoche altro è il Semplice systema, che si ordina tra le chorde ò suoni secondo il modello ò forma della Specie Naturale ò Syntona semplice diatonica;
& altro è quello, che naturalmente uien fatto & ordinato tra le Voci dalla
Natura; dalle quali due sorti è molto differente il terzo, ch'è quello, ch'è
temperato ne gli Istrumenti Arteficiali: essendo il primo de i due terminato
nel suo ordine tra Dicisette chorde, & il terzo tra Sedeci temperati nella maniera, c'hò dimostrato altroue,2. Instit.
& prima
Quinti Demonst. che non si possono à patto alcun'alterare;
essendoche il primo è composto de i suoi Elementi, che sono il Tuono maggiore, lo minore, & il maggior Semituono, contenuti dalle lor forme naturali Sesquiottaua, Sesquinona, & Sesquiquintadecima; come si conosce nell'essempio; tra le quali chorde si uedono in atto esserui nati per accidente quelli
& molt'altri, che sono stati addotti per essempio da i nostri Moderni censori,
i quali però non s'usano nelle moderne Cantilene. Ma il Systema massimo;
che si fà naturalmente con le Voci, non è terminato d'alcun numero di
chorde; ò d'altri interualli ò altri termini, di modo che non sia libero, &
non ristretto tra alcuni termini ò spacii; percioche le Voci possono nel salire
& nel discendere; come molte fiate habbiamo detto; farsi acute ò graui, quanto
porta la ragione de gli Interualli, che s'adoperano nella Specie, senz'alcuna contradittione; essendoche dopo che la Cantilena è finita, non si uede alcun'Interuallo, che resti in atto tra coloro che cantano; ma si bene in po
page 142
. della detta specie; ilquale si troua tra le chorde del
Sudetto Systema. Onde non si può ragioneuolmente dire (percioche s'argomentarebbe dall'arteficiale al naturale) che nel Systema massimo del Naturale
ò Syntono si trouano più Interualli di quelli, che usiamo nel cantare & sonare;
& che quello che cantiamo & soniamo non sia il Naturale ò Syntono di Tolomeo. Et se ad alcuno paresse; che la Specie che usiamo non fusse la sudetta Naturale ò Syntona: per non ritrouarsi in molti luoghi del detto Systema da una
chorda all'altra, molte Consonanze nella loro perfettione; come si scorge nel
Sequente Systema, ouero essempio; ma si bene molte loro specie, che sono dissonanti; ilche non si uede auenire nelle Voci & ne gli Istrumenti arteficiali temperati; s'ingannarebbe di gran lunga; percioche non si può dire, ne concludere
senz'errore, nella Compositione del Systema della Specie Naturale, ò Syntona
diatonica non si trouano quelli Interualli, che si trouano tra le Voci, & tra le chorde de gli Istrumenti arteficiali temperati;
adunque non s'usa cotale Specie:
Essendoche altro è il Semplice systema, che si ordina tra le chorde ò suoni secondo il modello ò forma della Specie Naturale ò Syntona semplice diatonica;
& altro è quello, che naturalmente uien fatto & ordinato tra le Voci dalla
Natura; dalle quali due sorti è molto differente il terzo, ch'è quello, ch'è
temperato ne gli Istrumenti Arteficiali: essendo il primo de i due terminato
nel suo ordine tra Dicisette chorde, & il terzo tra Sedeci temperati nella maniera, c'hò dimostrato altroue,2. Instit.
& prima
Quinti Demonst. che non si possono à patto alcun'alterare;
essendoche il primo è composto de i suoi Elementi, che sono il Tuono maggiore, lo minore, & il maggior Semituono, contenuti dalle lor forme naturali Sesquiottaua, Sesquinona, & Sesquiquintadecima; come si conosce nell'essempio; tra le quali chorde si uedono in atto esserui nati per accidente quelli
& molt'altri, che sono stati addotti per essempio da i nostri Moderni censori,
i quali però non s'usano nelle moderne Cantilene. Ma il Systema massimo;
che si fà naturalmente con le Voci, non è terminato d'alcun numero di
chorde; ò d'altri interualli ò altri termini, di modo che non sia libero, &
non ristretto tra alcuni termini ò spacii; percioche le Voci possono nel salire
& nel discendere; come molte fiate habbiamo detto; farsi acute ò graui, quanto
porta la ragione de gli Interualli, che s'adoperano nella Specie, senz'alcuna contradittione; essendoche dopo che la Cantilena è finita, non si uede alcun'Interuallo, che resti in atto tra coloro che cantano; ma si bene in po
page 142
![Systema massimo arteficiale composto secondo l'ordine della Specie Naturale ò
Systema diatonica; contenuto tra Dicisette chorde, segnate con le
loro proportioni di Numero à Numero.
Numero & or
dine delle
chorde.
Nomi loro anti
chi.
Nomi loro moder
ni.
Forme semplici de
gli Interualli.
Nomi de gli
Interualli.
Proportioni
di quest'or
dine.
ACVTO
17. ——— Netehyperboleon. aa. la. ——— 216.
10. 9. Tuo. minore.
16. ——— Paranetehyperbol. g. sol. ——— 240.
9. 8. Tuo. maggiore.
15. ——— Tritehyperboleon. f. fa. ——— 270.
16. 15. Semit. maggiore.
14. ——— Netediezeugmenon. e. la. mi. ——— 288.
10. 9. Tuono minore.
13. ——— d. sol. re. ——— 320.
81. 80. Comma.
12. ——— Netesynemennon. [[mus.denh]]. la. ——— 324.
10. 9. Tono minore.
11. ——— Netedie. et Paranetesy. c. sol fa. ut. ——— 360.
16. 15. Semit. maggiore.
10. ——— Paramese. . mi. ——— 384.
135. 128. Semituono.
9. ——— Tritesynemennon. b. fa. ——— 405.
16. 15. Semituono magg.
8. ——— Mese. A. la. mi. re. ——— 432.
10. 9. Tuono minore.
7. ——— Lychanos meson. G. sol. . ——— 480.
9. 8. Tuono maggiore.
6. ——— Parhypate meson. F fa. ut. ——— 540.
16. 15. Semit. maggiore.
5. ——— Hypate meson. E. la. mi. ——— 576.
10. 9. Tuono minore.
4. ——— Lychanos hypaton. D. sol. re. ——— 640.
9. 8. Tuono maggiore.
3. ——— Parhypate hypaton. C fa. ut. ——— 720.
16. 15. Semit. maggiore.
2. ——— Hypate hypaton. . mi. ——— 768.
9. 8. Tuono maggiore.
1. ——— Proslambanomenos. A. re. ——— 864.
GRAVE.](../../zarsop/ill/406_1.gif)
![DIAPASON.
Diapason diminuta.
Hepta. minore diminuto.
Hexachordo minore diminuto.
Diapente diminuta.
Semitono diminuto.
Hexachordo maggiore superfluo.
Diapente diminuta.
Diatessar superflua.
Semiditono superfluo.
Semituono.
Ditono superfluo.
Comma.
D. 640. 4.
E. 576. 5.
F. 540. 6.
G. 480. 7.
a. 342. 8.
b. 605. 9.
. 384. 10.
c. 360. 11.
[[mus.denh]]. 324. 12.
d. 320 13.](../../zarsop/ill/406_2.gif)
Terza ragione di quelli, che non uogliono che si adoperi la Specie Naturale ò Syntona. Cap. VII.
Dite page 144 di gratia à coloro che uogliono, ch'ella sia quella Specie;parlando della Syntona; che si canta hoggi;
che ui diuidino in qual si uoglia maniera la Terzadecima maggiore, contenuta (secondo 'l Syntono) da questi numeri. 10. & 3. In tre Sesquialtere; come essi dicono, ch'ella contiene.Et questo è di prima uista falso; percioche niun di sano intelletto si troua, che dica, che la Terzadecima sudetta contenuta da questi numeri. 10. & 3. contenga tre Diapente, ò si possa diuidere in tre Sesquialtere.
 Seguono poi con l'Istesso parlare, dicendo:
Seguono poi con l'Istesso parlare, dicendo: Ditegli ancora, secondo l'essempio che segue appresso che ui diuidano in tre Sesquiterze la Dupla Superbipartiente quinta, forma della Decima minore; & dimandategli appresso di questo, quanto questo Interuallo sia da quello superato.Si sà, che gli estremi della Decima minore sono contenuti tra 12. & 5. però niuno, che sia mediocremente erudito nelle cose mathematiche, & nella Musica speculatiua, confesserà, ch'una Dupla Superbipartiente quinta, si possa diuidere in tre Diatessaron ò Sesquiterze di punto; ne una Tri
 pla Sesquiterza in tre Diapente ò Sesquialtere; poiche (per la 9. del Primo delle Dimostrationi) ne anco vn Superparticolare, ch'è più semplice, si può diuidere
in due parti. Nè si trouerà alcun che dica; com'essi dicono; che gli estremi dell'Interuallo Triplo Sesquiterzo che sono 10. & 3. contengano tre Sesquialtere; che sarebbono tra questi termini. 90. 60. 40. 27. ma si bene tra questi. 90. 60.
40. 26. 2/3 ouer tra questi. 27. 18. 12. 8. i cui estremi sono contenuti sotto la
proportione Tripla supertripartiente ottaua ne anco dirà che gli estremi dell'Interuallo Duplo superbipartiente quinto contenghino tre Sesquiterze tra
questi numeri; 12. & 5. che sarebbono tra questi 48. 36. 26 2/3. 20. quantunque
le contenghino tra. 48. 36. 27. 20 1/4. ouer tra. 64. 48. 36. 27. gli estremi de i
quali contengono la Dupla super. 10. partiente. 27. Percioche se fusse uero quel
che dicono; questi due Interualli maggiori proposti, non sarebbono propriamente diuisi in cotal parti proportionali; & ui
andarebbe altra fattura che questa; à
uolerli diuidere in cotal maniera. Ma quest'è ueramente un parlare improprio; essendoche queste Diapente & Diatessaron quando fussero à cotal
page 145
modo poste insieme, più tosto si potrebbe dire, che cotai Numeri contenessero
tra loro cotali parti più tosto adunate, che diuise. Voglio però inferire, che se
bene le tre Diapente, ò le tre Diatessaron non sono contenute tra i sudetti due
maggiori Interualli proposti, & nondimeno si cantano, & si ritrouano ne gli Istrumenti temperati, esser cosi diuisi; che non
gli Interualli del Syntono ò Naturale
diatonico, ma quelli de i sudetti Istrumenti temperati, & à cotal modo fatti imperfetti sono quelli, che si cantano. Et non s'aueggono, che in cotali Istrumenti ne la proportione della Terzadecima maggiore, ne quella della Decima minore, sono Tali ò tante, quante le suppongono; & le Proportioni ò forme delle Diapente sarebbono minori della Sesquialtera; & quelle della Diatessaron sarebbono maggiori della Sesquiterza; di maniera che l'Interuallo delle tre Diapente uerrebbe ad esser minore della Tripla supertripartiente ottaua, di Sei settime parti d'un Comma; & quello delle tre Diatessaron sarebbe maggiore per
la istessa quantità, della Dupla super. 10. partiente. 27. Ma quando in qual si uoglia Istrumento arteficiale si trouerà, che si possa continuare due, tre & anco più
Diapente, ouer qual si uoglia altro Interuallo; tanto uerso l'acuto, quanto uerso 'l graue, l'un dopo l'altro; ilche non sarà mai impossibile nell'Istrumento natural delle Voci; siano poi concluse in qual si uoglia maggiore Interuallo; allora si potrà dire propriamente che la proportione
de i loro estremi non sarà diuisa in tante proportioni ò interualli, quante le adunate insieme; ma si bene che ella sarà
(come hò detto) composta: & lo Progresso de gli Interualli contenuti tra i termini del maggiore che contiene, si chiamerà Geometrico; essendo quelli Interualli l'un'all'altro Proportionali; come sono le Dodici parti ò Semituoni fatti dalla diuisione della Diapason, come dimostraremo al suo luogo, tra loro equali. Ma dicami di gratia, prima d'ogn'altra
cosa, questi Speculatiui moderni,
che propongono queste cose; di che proportione uorrebbono che fusse tre Quinte ò tre Quarte continue proportionali molteplicate
l'una dopo l'altra, composte di tanti Semituoni equali & proportionali; come sono quelli, che uogliono
ch'empiscano di punto la Diapason nel manico del Liuto, ch'io dopoi li diuiderò la sudetta Terzadecima maggiore in tre Sesquialtere ò Diapente; & in tre
Sesquiterze ò Diatessaron, la Decima minore. Sò troppo bene, che questo
(da quello c'hò in loro conosciuto) non sapranno ne far, ne dire, non che dimostrare; essendoche quelle Proportioni ch'adoperano in cotali diuisioni, sono indeterminate & irrationali, facendole nascere simigliantemente da proportioni,
non dirò solamente irrationali; ma etiandio irrationali indeterminate. In quanto
poi uogliono, che se gli dica, di quanto la Dupla supertripartientequinta, credo
ch'eglino intendino di questa sia da quella di tre Sesquiterze superata; è buon conto da fare: percioche essendo la somma di tre Sesquiterze una Dupla super. 10. partiente. 27. leuata da questa la Dupla superbipartientequinta, resta la Sesquiottantesima, che è di punto la quantità & la forma d'uno de i nostri Comma. Et tal differentia si conosce anco da questo; che se
noi adunaremo (per la 16. del 1. delle Dimostrationi) tre Sesquiterze tra i Numeri composti; in questo modo. E. 12; a. 9;
d. 6 3/4.; & g. 5. 1/16. lasciando il 12. per il maggior termine dell'ordine, che hà da
nascere, simile à quello della Dupla superbipartiente quinta; il minore di tre Sesquiterze sarà 5 1/16. ilqual numero è maggiore del 5. termine minore della detta
Dupla supertripartientequinta; & per conseguente (per la 36. del sudetto Primo) sarà minore questa proportione, che non è la Dupla Super. 10. partiente. 27.
di tanta quantità, che importa 1/16. hauendo rispetto il 5 1/16 al 5. come sarà etiandio maggiore la Tripla super. 3. partiente. 8. che sono tre Sesquialtere adunate
page 146
insieme, della quantità d'un Comma; come si comprende da questo; che sommate insieme; per la sudetta 16. tre Sesquialtere tra i numeri composti, in questo modo C. 10; G.
6 2/3; d. 4 4/9; & a. 2. 26/27 ponendo pur'il maggior termine, che sia commune all'una & l'altra delle nominate proportioni; il minore uerrà 2 26/27. ch'è minore
del 3. termine minore della Tripla Sesquiterza: quanto importa 1/17. onde, per
la detta 36. sarà minor la proportione di 10. à 2 26/27. che quella di 10. à 3. Per
la qual cosa, l'hauer uoluto prima prouare, che due Note ò Figure del Canto (per
usar'i termini che usano) non siano Vnisone, ò che non facciano una Terza,
ouer'altro Interuallo; & dopoi, che tra due chorde impertinenti non si troui esser
il buono & uero Interuallo, che ricercano; & ultimamente l'addurre i due essempii delle tre Diapente, & delle tre Diatessaron adunate in sieme, che ne i loro estremi non facciano alcun'Interuallo consonante;
& che per questo non si canti ò
suoni, ne componi la Naturale ò Syntona diatonica; è cosa al tutto uana & inutile: percioche se ben nell'Ordine arteficiale della detta Specie Naturale & Syntona sarà uero; fallirà però cotale Consequentia
nell'ordine Naturale. E' adunque fuora di proposito, il uoler concludere che non si usi la sudetta Specie Naturale & Syntona di Tolomeo; perche nel Systema arteficiale non sono compresi molti Interualli, che nelle nostre Cantilene che si suonano & cantano,
non si trouano: ma si bene tornarebbe uera la conclusione, quando nell'Istrumento naturale s'usasse altri Interualli di quelli, che nelle loro proportioni &
forme proprie sono Elementali nel Systema arteficiale del Naturale ò Syntono nominato.
pla Sesquiterza in tre Diapente ò Sesquialtere; poiche (per la 9. del Primo delle Dimostrationi) ne anco vn Superparticolare, ch'è più semplice, si può diuidere
in due parti. Nè si trouerà alcun che dica; com'essi dicono; che gli estremi dell'Interuallo Triplo Sesquiterzo che sono 10. & 3. contengano tre Sesquialtere; che sarebbono tra questi termini. 90. 60. 40. 27. ma si bene tra questi. 90. 60.
40. 26. 2/3 ouer tra questi. 27. 18. 12. 8. i cui estremi sono contenuti sotto la
proportione Tripla supertripartiente ottaua ne anco dirà che gli estremi dell'Interuallo Duplo superbipartiente quinto contenghino tre Sesquiterze tra
questi numeri; 12. & 5. che sarebbono tra questi 48. 36. 26 2/3. 20. quantunque
le contenghino tra. 48. 36. 27. 20 1/4. ouer tra. 64. 48. 36. 27. gli estremi de i
quali contengono la Dupla super. 10. partiente. 27. Percioche se fusse uero quel
che dicono; questi due Interualli maggiori proposti, non sarebbono propriamente diuisi in cotal parti proportionali; & ui
andarebbe altra fattura che questa; à
uolerli diuidere in cotal maniera. Ma quest'è ueramente un parlare improprio; essendoche queste Diapente & Diatessaron quando fussero à cotal
page 145
modo poste insieme, più tosto si potrebbe dire, che cotai Numeri contenessero
tra loro cotali parti più tosto adunate, che diuise. Voglio però inferire, che se
bene le tre Diapente, ò le tre Diatessaron non sono contenute tra i sudetti due
maggiori Interualli proposti, & nondimeno si cantano, & si ritrouano ne gli Istrumenti temperati, esser cosi diuisi; che non
gli Interualli del Syntono ò Naturale
diatonico, ma quelli de i sudetti Istrumenti temperati, & à cotal modo fatti imperfetti sono quelli, che si cantano. Et non s'aueggono, che in cotali Istrumenti ne la proportione della Terzadecima maggiore, ne quella della Decima minore, sono Tali ò tante, quante le suppongono; & le Proportioni ò forme delle Diapente sarebbono minori della Sesquialtera; & quelle della Diatessaron sarebbono maggiori della Sesquiterza; di maniera che l'Interuallo delle tre Diapente uerrebbe ad esser minore della Tripla supertripartiente ottaua, di Sei settime parti d'un Comma; & quello delle tre Diatessaron sarebbe maggiore per
la istessa quantità, della Dupla super. 10. partiente. 27. Ma quando in qual si uoglia Istrumento arteficiale si trouerà, che si possa continuare due, tre & anco più
Diapente, ouer qual si uoglia altro Interuallo; tanto uerso l'acuto, quanto uerso 'l graue, l'un dopo l'altro; ilche non sarà mai impossibile nell'Istrumento natural delle Voci; siano poi concluse in qual si uoglia maggiore Interuallo; allora si potrà dire propriamente che la proportione
de i loro estremi non sarà diuisa in tante proportioni ò interualli, quante le adunate insieme; ma si bene che ella sarà
(come hò detto) composta: & lo Progresso de gli Interualli contenuti tra i termini del maggiore che contiene, si chiamerà Geometrico; essendo quelli Interualli l'un'all'altro Proportionali; come sono le Dodici parti ò Semituoni fatti dalla diuisione della Diapason, come dimostraremo al suo luogo, tra loro equali. Ma dicami di gratia, prima d'ogn'altra
cosa, questi Speculatiui moderni,
che propongono queste cose; di che proportione uorrebbono che fusse tre Quinte ò tre Quarte continue proportionali molteplicate
l'una dopo l'altra, composte di tanti Semituoni equali & proportionali; come sono quelli, che uogliono
ch'empiscano di punto la Diapason nel manico del Liuto, ch'io dopoi li diuiderò la sudetta Terzadecima maggiore in tre Sesquialtere ò Diapente; & in tre
Sesquiterze ò Diatessaron, la Decima minore. Sò troppo bene, che questo
(da quello c'hò in loro conosciuto) non sapranno ne far, ne dire, non che dimostrare; essendoche quelle Proportioni ch'adoperano in cotali diuisioni, sono indeterminate & irrationali, facendole nascere simigliantemente da proportioni,
non dirò solamente irrationali; ma etiandio irrationali indeterminate. In quanto
poi uogliono, che se gli dica, di quanto la Dupla supertripartientequinta, credo
ch'eglino intendino di questa sia da quella di tre Sesquiterze superata; è buon conto da fare: percioche essendo la somma di tre Sesquiterze una Dupla super. 10. partiente. 27. leuata da questa la Dupla superbipartientequinta, resta la Sesquiottantesima, che è di punto la quantità & la forma d'uno de i nostri Comma. Et tal differentia si conosce anco da questo; che se
noi adunaremo (per la 16. del 1. delle Dimostrationi) tre Sesquiterze tra i Numeri composti; in questo modo. E. 12; a. 9;
d. 6 3/4.; & g. 5. 1/16. lasciando il 12. per il maggior termine dell'ordine, che hà da
nascere, simile à quello della Dupla superbipartiente quinta; il minore di tre Sesquiterze sarà 5 1/16. ilqual numero è maggiore del 5. termine minore della detta
Dupla supertripartientequinta; & per conseguente (per la 36. del sudetto Primo) sarà minore questa proportione, che non è la Dupla Super. 10. partiente. 27.
di tanta quantità, che importa 1/16. hauendo rispetto il 5 1/16 al 5. come sarà etiandio maggiore la Tripla super. 3. partiente. 8. che sono tre Sesquialtere adunate
page 146
insieme, della quantità d'un Comma; come si comprende da questo; che sommate insieme; per la sudetta 16. tre Sesquialtere tra i numeri composti, in questo modo C. 10; G.
6 2/3; d. 4 4/9; & a. 2. 26/27 ponendo pur'il maggior termine, che sia commune all'una & l'altra delle nominate proportioni; il minore uerrà 2 26/27. ch'è minore
del 3. termine minore della Tripla Sesquiterza: quanto importa 1/17. onde, per
la detta 36. sarà minor la proportione di 10. à 2 26/27. che quella di 10. à 3. Per
la qual cosa, l'hauer uoluto prima prouare, che due Note ò Figure del Canto (per
usar'i termini che usano) non siano Vnisone, ò che non facciano una Terza,
ouer'altro Interuallo; & dopoi, che tra due chorde impertinenti non si troui esser
il buono & uero Interuallo, che ricercano; & ultimamente l'addurre i due essempii delle tre Diapente, & delle tre Diatessaron adunate in sieme, che ne i loro estremi non facciano alcun'Interuallo consonante;
& che per questo non si canti ò
suoni, ne componi la Naturale ò Syntona diatonica; è cosa al tutto uana & inutile: percioche se ben nell'Ordine arteficiale della detta Specie Naturale & Syntona sarà uero; fallirà però cotale Consequentia
nell'ordine Naturale. E' adunque fuora di proposito, il uoler concludere che non si usi la sudetta Specie Naturale & Syntona di Tolomeo; perche nel Systema arteficiale non sono compresi molti Interualli, che nelle nostre Cantilene che si suonano & cantano,
non si trouano: ma si bene tornarebbe uera la conclusione, quando nell'Istrumento naturale s'usasse altri Interualli di quelli, che nelle loro proportioni &
forme proprie sono Elementali nel Systema arteficiale del Naturale ò Syntono nominato.
Quarto modo, nelquale hora sottrahendo, & hora sommando insieme le proportioni de gli Interualli contenuti nel Systema massimo arteficiale del Naturale & Syntono diatonico; si sforzano prouare l'opinione loro esser uera. Cap. VIII.
 ui sia Consonanza alcuna, dicono: che Ciascuna di queste
Diatessaron, ò Quarte che le uogliamo chiamare, contiene due Tuoni maggiori & un maggior Semituono; come si
può anco chiaramente uedere tra l'Ottaua, Decima, & Terzadecima chorda, & tra la Duodecima, Quarta decima, &
Decima sesta del sudetto Systema massimo; ilqual Semituono separa essi Tuoni l'un dall'altro; onde sommati insieme i Numeri delle
proportioni loro, dal loro prodotto ne viene una proportione, che eccede
la Sesquiterza di vn Comma; il perche necessariamente gli estremi sono dissonanti. Et questo lo udirebbe un sordo, lo uederebbe vn cieco, & lo saprebbe dire un mutolo; & è cosa detta fuori d'ogni proposito; essendoche questo Interuallo non s'adopera nel cantare, ne anco nel sonar la sudetta Specie; ne meno si adoperano altri Interualli di questa sorte, che siano dissonanti; Se già non
uolessimo dire; per usar le loro formali parole; che
ui sia Consonanza alcuna, dicono: che Ciascuna di queste
Diatessaron, ò Quarte che le uogliamo chiamare, contiene due Tuoni maggiori & un maggior Semituono; come si
può anco chiaramente uedere tra l'Ottaua, Decima, & Terzadecima chorda, & tra la Duodecima, Quarta decima, &
Decima sesta del sudetto Systema massimo; ilqual Semituono separa essi Tuoni l'un dall'altro; onde sommati insieme i Numeri delle
proportioni loro, dal loro prodotto ne viene una proportione, che eccede
la Sesquiterza di vn Comma; il perche necessariamente gli estremi sono dissonanti. Et questo lo udirebbe un sordo, lo uederebbe vn cieco, & lo saprebbe dire un mutolo; & è cosa detta fuori d'ogni proposito; essendoche questo Interuallo non s'adopera nel cantare, ne anco nel sonar la sudetta Specie; ne meno si adoperano altri Interualli di questa sorte, che siano dissonanti; Se già non
uolessimo dire; per usar le loro formali parole; che La quantità del Comma, per esser cosi minima, tolta ò aggtunta à qual si voglia Interuallo, non habbia facoltà di rimouerlo dalla natura del proprio essere;ilche non credono (come dicono) in modo alcuno;
volendo particolarmente(come dicono)
M. Gioseffo Zarlino, che la metà habbia facoltà, aggiunta ò tolta da qual si voglia Interuallo consonante, di farlo dissonante.Et dicono il vero, ch'io lo dico, & è cosi in fatto; ma soggiungono;
Quantunque egli dopoi soggiunga;(& credono che ciò habbia detto per ischerzo)
che si habbia à lasciar da parte la consideratione della differentia de Tuoni maggiori & minori; laqual tolta via, ne porta seco quella delle varie specie de Semituoni; & cosi al Diatonico, che si canta hoggi, quando egli fusse il Syntono di Tolomeo, toltagli questa consideratione sola; per il che è forse tale; uiene à essere altro.Con la qual cosa dimostrano chiarissimamente di non hauer letto; & se pur'hanno letto, di non hauer'inteso quello, c'hà detto il Zarlino nel Cap. 13. della Terza parte delle Istitutioni. Ilperche il Lettore ueda, se ciò hò mai detto per ischerzo; poscia che nell'assignar le Specie della Diapason, non hò vsato mai vna simil maniera di parlare di cotali differentie de Tuoni; essendoche veramente non si conuiene, rispetto al priuilegio ch'ella hà; che tanto quella che si canta tra C. & c. quanto quella che si modula tra le chorde c. & cc. dirò cosi; è cantata sott'una forma determinata delle Sette sue specie; & determinato numero de Tuoni & Semituoni; ilche non hà l'altre Specie; onde non accadeua dirne cosa alcuna; ma si bene nel ragionamento di quelle della Diapente; percioche chi vorrà considerare la Prima specie di cotal Consonanza, che si troua tra C. & G. & questa che si troua tra G. & d. ritrouerà quella hauere il Tuono maggiore nel suo primo & più graue Interuallo, tra C. & D. & questa per il contrario, hauere il Tuono minore nel primo & più graue, tra G. & a. ilche non considerò gli Antichi, perche adoperauano il Diatono diatonico: onde non intendono la cosa per il diritto; essendosi abbarbagliati nel Systema arteficiale di questa Specie; come ad ogn'un'intendente può esser manifesto; & come potrà ciascuno etiandio da questa cosa tanto leggiera & di poca leuatura conoscere; in qual modo questi Speculatiui possino intendere quelle, che sono di qualche importanza; oue gli entra molta contemplatione. Hora à queste cose aggiungono, che i due Tuoni contenuti in ciascuna delle sudette due Diatessaron maggiori, & che anco il Prattico lo tocca con mano, per gli essempij dati; se bene spesse fiate dicono, che i Prattici, come ignoranti, non intendono cotal cosa: onde nell'essempio che segue, uogliono prouar questo, come Theorici, col mezo della facoltà Arithmetica, in questo modo; sommando la forma della Terza minore insieme con quella del Tuono maggiore; ilperche da page 148 tal somma ne nasce la Super. 7. patiente. 20. laqual consta di una Quarta superflua, d'un Comma. O che uanità: Chi è colui (di gratia) tanto goffo & tanto igno
![6 5. Forma della Terza minore.
9. 8. Forma del Tuono minore.
[line]
54. 40. Forma della Super. 7. patiente. 20. fuora de suoi numeri minori,
27. 20. & Ne i suoi numeri minori.](../../zarsop/ill/408_2.gif)
Non potersi hauer'il Tritono dal sommare insieme la forma della Quarta, & quella del Semituono minore; per esser'un Tuono maggiore quello, che bisogna diuidere per ciò fare, ilquale è capace, oltra il maggiore & minor Semituono, d'un Comma.Et questa è ragione, ch'ogn'un poco essercitato nella Mathematica, saprebbe fare: ma che hà da fare il Tritono, che si compone di due Tuoni maggiori & d'un minore, iquali sommati insieme, fanno la proportione Super. 13. patiente. 45. che si troua tra questi termini 45. & 32. con la Quarta & il Semituono minore? Dopoi uolendo mostrare, non però à buon proposito, come si possa conoscere una proportione costituita fuori della sua Radice; S'è maggiore ò minore d'un'altra; s'accommodano d'una Regola da tenere à memoria; come grandemente utile à questo negotio; sottraendo la forma del Tuono maggiore, dalla forma del Comma; come si uede nell'essempio; di doue nasce la Subsesquino
![81. 80. Forma del Comma.
9. 8. Forma del Tuono minore.
[line]
648. 720. Forma della Subsesquinona fuori de i suoi minori termini;
72.
9. 10. & Ne i uoi minor termini.](../../zarsop/ill/408_3.gif)
Pare di prima uista, d'hauer sottratto da un Comma un Tuono maggiore, & consequentemente, che quello superi questo di tal quantità; laqual cosa, quanto all'intelletto & al senso repugni, ciascuno il sà.Et seguono anco:
Quella è una Subsesquinona; laquale in tal luogo manifesta di quanto l'Interuallo, d'onde ella fù tratta, sia superato dal Sesquiottauo, & non di quanto il Comma lo superi; & però uengono tali proportioni meritamente dette Priuatiue, & Rationali; & quell'altre prime Positiue & Reali.La qual Regola quanto sia noua, bella & utile, & da chi se l'habbia imparata; senza renderne punto di gratia all'Inuentore; ogn'uno che leggerà il Cap. 30. della Prima parte delle Istitutioni, lo potrà sapere; & potrà per questa tra l'altre cose noue, dellequali costoro hauendosi prima seruito, l'hanno dopoi più tosto biasimate, che lodate. Et questo è il Quarto modo, co 'l quale cercando di stabilire gli altri, uanno à cadere in un laccio; dal quale mai non potranno ritrarre i piedi, dopo l'essersi auiluppati. Ma auertisca ogn'uno, ch'io non biasimo per questo le Dimostrationi arithmetiche, fatte con i numeri & con debiti modi; come forse alcun potrebbe credere; percioche questo sarebbe contra di me: & quando sono dirittamente fatte, à patto alcuno non possono indur falsità, & condurci in alcuno errore; ma si bene biasimo quelli, che co 'l mezo loro uengono à confondere i Generi delle cose; dimostrandone una per un'altra, Essendoche niuno di sana mente mai negherà, che sia uero, che 'l leuar'una quantità minore d'una maggiore; come sarebbe 7. da 12. non ne resti una minor di questa, che è 5. & che l'aggiunger questo al primo numero minore, che è 7. non uenga il primo maggiore; cioè, 12. Ilperche si come il primo lor modo di dimostrar, che quello che tengono è uero, non fà al proposito; essendoche (com'hò detto più volte) non vagliono le ragioni, che adducono; volendo concludere da un Genere ò Specie ad un'altro; cosi non uale il mezo di queste ragioni arithmetiche, quando s'introducono proportioni, che non fanno al proposito, ne sono d'alcuna vtilità; se ben concludono senz'alcuna falsità nelle ragioni & computi loro; percioche quantunque (per cagione di essempio) dicesse alcuno; da Venetia à Costantinopoli sono, poniamo, miglia 900. & da Venetia à Ragusi sono 400. adunque da Ragusi à Costantinopoli sono miglia 500. questo sarebbe vero inquanto alla ragione & al computo; ma inquanto che da Ragusi à Costantinopoli ui fussero tanti miglia & non fussero; questo, secondo la verità, sarebbe falsissimo; per l'Interuallo maggiore ò minore di quello ch'è il douere, che si soppone. onde il pigliare à questo modo una quantità per un'altra, farà sempre, che mai si concluderà il uero di quello, che si cerca.
Come vltimamente prouano col mezo de gli Istrumenti arteficiali temperati, il lor pensiero esser vero.Cap. IX.
Non si canta, ne si suona la Specie Naturale ò Syntona diatonica di Tolomeo:& dicono di più,
Di uoler far toccar con mano; che si canta hoggi, circa l'imperfettione de gli Interualli, non meno imperfettamente, che si suoni.Ilperche concludono all'usanza loro; che
Necessariamente & contra il commun parere, le Quinte si cantano hoggi diminuite, & superflue le Quarte dal lor uero essere; & che dalla Ottaua impoi, si uiene à cantar qual si uoglia altro Interuallo fuori della sua uera proportione; & consequentemente dissimili da quelli, che sono contenuti dal Senario & dal Syntono.Et dopo questo soggiungono un'altra maggior pazzia, dicendo; che
Quantunque l'Vniuersale gli approbi per perfetti; & se ne satisfaccia interamente; per non hauer mai udito i ueri; & toltosi da qual sia speranza di poterli migliorare;fanno uedere, quanto dalla loro opinione siano ingannati; essendoche uogliono, che per tal modo sia corretta la Natura dall'Arte; & che questa sia come essemplare à quella; & che sia imitata da quella, & non che l'Arte segua & imiti la Natura, come uero essemplare; contra quello che si è determinato nel Cap. 4 & ne i due seguenti del Primo libro; essendoche tengono anco per fermo, che 'l
Senso s'habbia corrotto nell'assuefarsi ad udir le Consonanze di continuo sotto le forme contenute da gli Istrumenti da chorde;& questo non s'accorda, ò poco almeno, con quello che dicono; percioche uogliono che si sia imparato di cantare quel modo che cantiamo, col mezo di tali Istrumenti; & particolarmente da quelli, che non hanno Tasti, come hà il Liuto & la Viola: Ma di questo legga il Lettore il Cap. 45. della Seconda parte delle Istitutioni, & i sudetti Capitoli; percioche dopo c'haurà molto ben considerato il tutto; se per caso conoscerà alcun che sia entrato nella opinione di costoro; non accaderà che faccia leggere altre Scritture in questa causa, ne ascoltare altri Auocati, che accusino ò difendino; essendoche s'ei sarà buon Giudice, potrà dar la Senten page 151 tia in fauore di coloro che tengono, che si canta la Specie Naturale ò Syntona; obligando tutti quelli, che tengono al contrario, di pagare ogni interesse, & ogni spesa, che fusse fatta in questa tanto euidente causa.
Che da gli Istrumenti arteficiali non si può concludere, che cantiamo altra Specie, che la Naturale ò Syntona. Cap. X.
In qual maniera si possa acquistar molte Consonanze nell'Istrumento arteficiale della Specie Naturale ò Syntona; acciò maggiormente s'accosti ad imitar quello della Voce. Cap. XI.
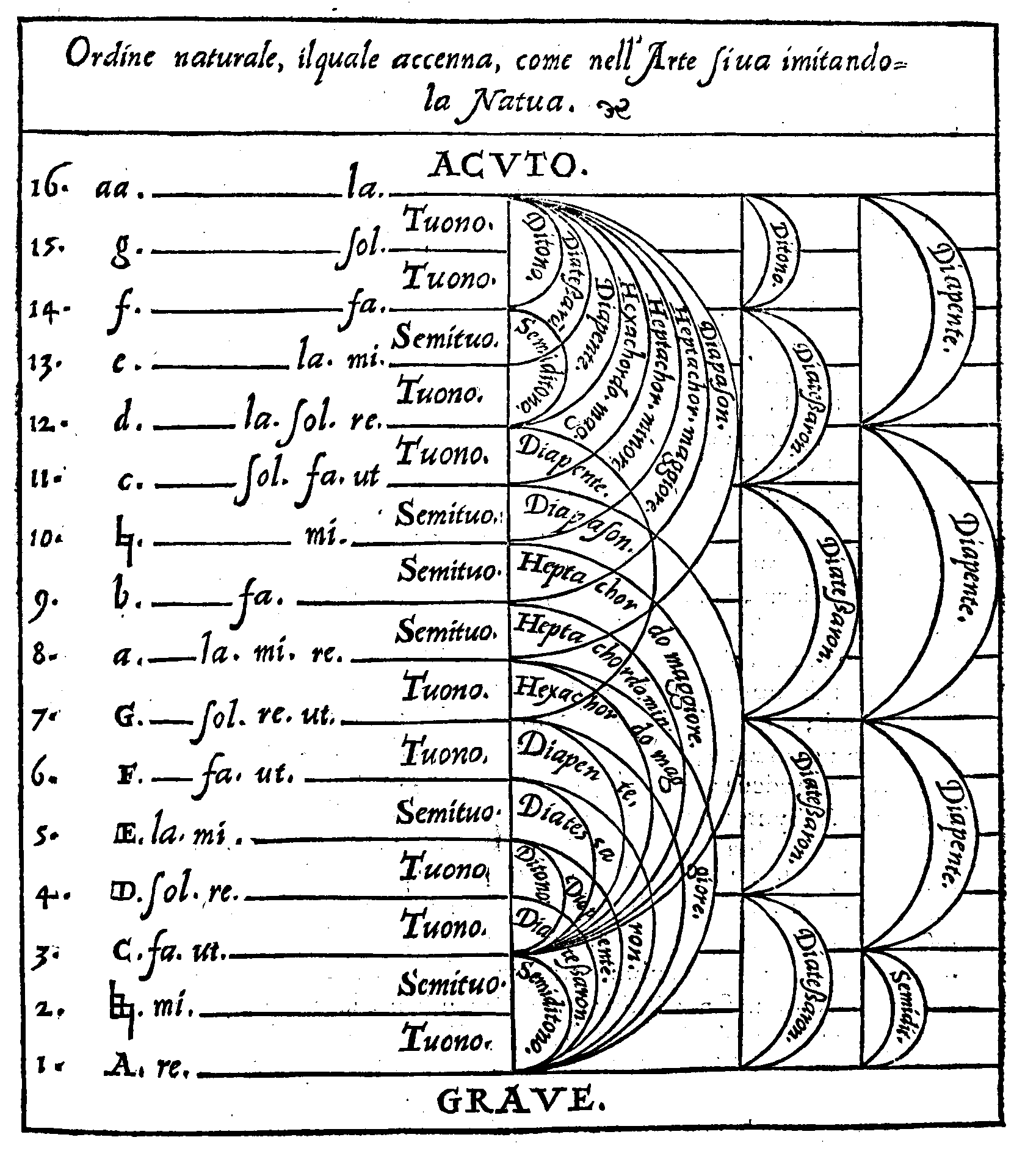
![Systema massimo arteficiale del Naturale ò Syntono diatonico; accresciuto
con molte chorde, per l'acquisto di molte Consonanze.
33. aa. 4320. Netehyperboleon. PARTE ACVTA.
23. 4608. Semituono. 16. 15.
31. g. 4800. Paranetehyperboleon. Semituono. 25. 24.
30. . 5120. Semituono. 16. 15.
29. . 5184. Comma. 81. 80.
28. f. 5400. Tritehyperboleon. Semituono. 25. 24.
27. e. 5760. Netediezeugmenon. Semituono. 16. 15.
26. b. 6000. Semituono. 24. 25.
25. b. 6075. Comma 81. 80.
24. d. 6400. Paranetediezeugmenon. Semituono. 256. 243.
23. [[mus.denh]] 6480. Netesynemennon. Comma 81. 80.
22. . 6912. Semituono. 16. 15.
21. c. 7200. Paranesy. Tritediezeug. Semituono. 25. 24.
20. . 7680. Paramese. Semituono. 16. 15.
19. b. 8000. Semituono. 25. 24.
18. b. 8100. Tritesynemennon. Comma. 81. 80.
17. a. 8640. Mese. Semituono. 16. 15.
16. . 9216. Semituono. 16. 15.
15. G. 9600. Lychanos meson. Semituono. 25. 24.
14. . 10240. Semituono. 16. 15.
13. . 10368. Comma. 81. 80.
12. F 10800. Parhypate meson. Semituono. 25. 24.
11. E. 11520. Hypate meson. Semituono. 16. 15.
10. b. 12000. Semituono. 25. 24.
9. b. 12150. Comma. 81. 80.
8. D. 12800. Lychanos hypaton. Semituono. 256. 243.
7. [[mus.Denh]]. 12960. Comma. 81. 80.
6. . 13834. Semituono. 16. 15.
5. C. 14400. Parhypate hypaton. Semituono. 25. 24.
4. . 15360. Lychanos hypaton. Semituono. 16. 15.
3. b. 16000. Semituono. 25. 24.
2. b. 16200. Comma. 81. 80.
1. A. 17280. Proslambanomenos. Semituono. 16. 15.
PARTE GRAVE.](../../zarsop/ill/411_2.gif)
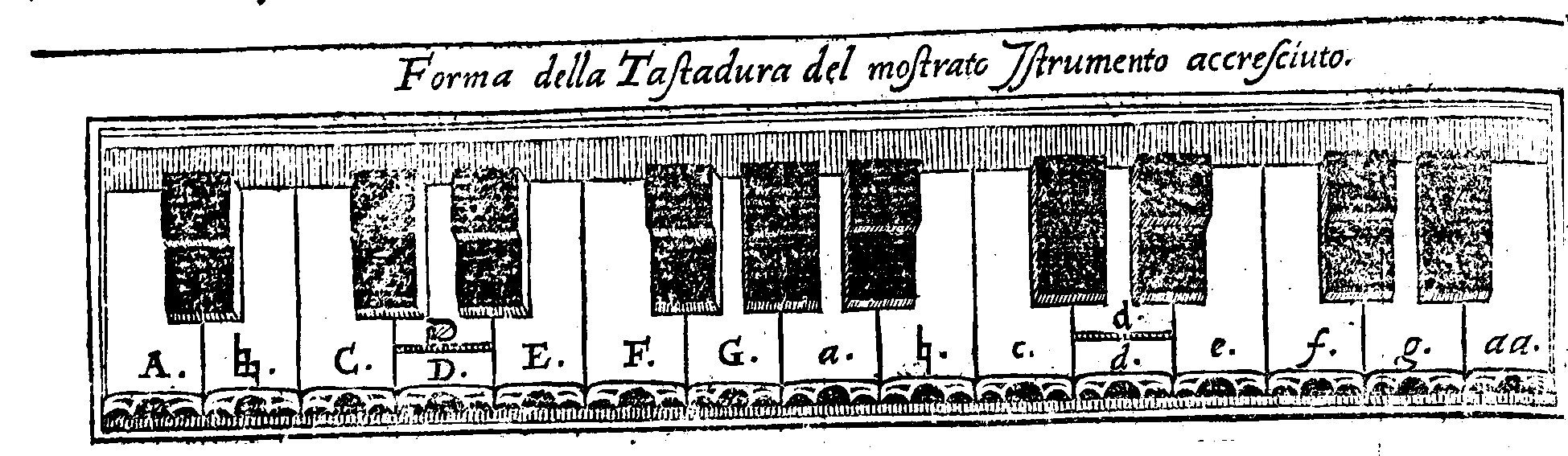
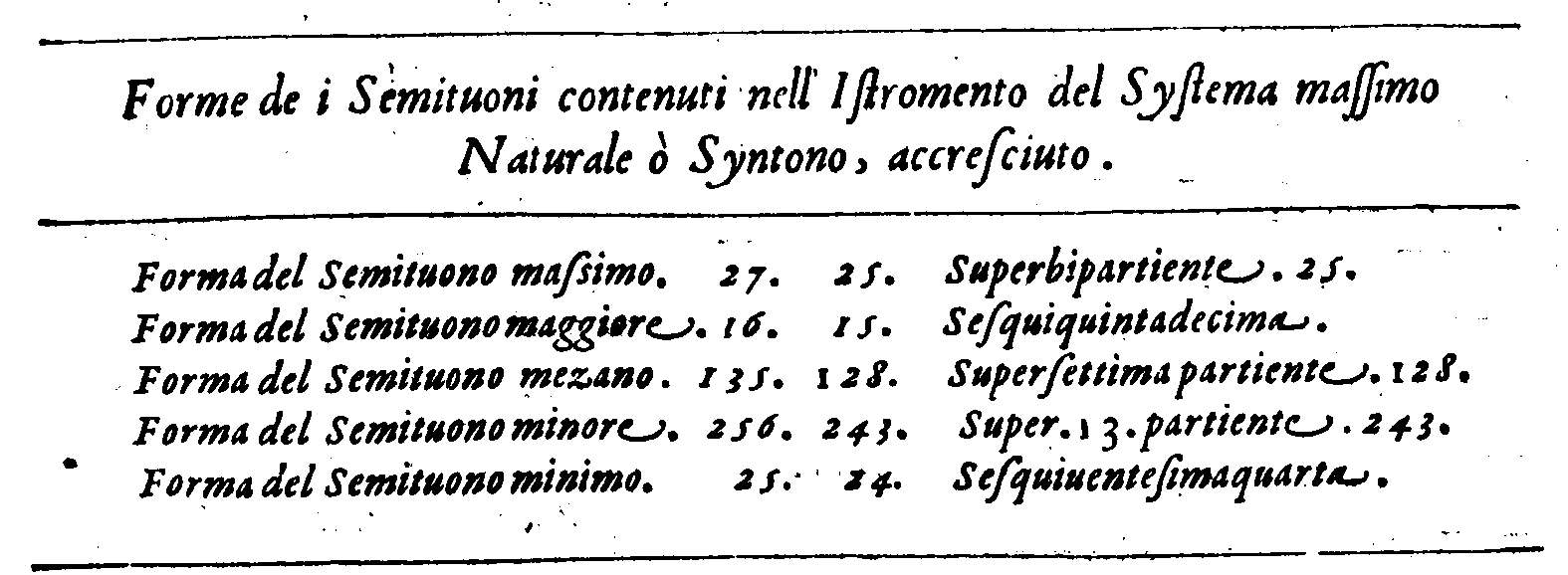
La cagione del Temperamento ò Partecipatione fatta ne gli Istrumenti da Tasti; & che l'Harmonia, che nasce da essi, non è Naturale & Syntona semplice; & che senza dubio veruno ella si canta, & anco si suona in alcune sorti d'Istrumenti.Cap. XII.
L'uno, & l'altro; se ben giocondamente & soauemente feriscono l'Vdito, non sono da esser connumerati tra le Consonanze; percioche tra i Numeri li trouaua esser collocati tra le proportioni, che sono fuori del Molteplice & Superparticolare, ma li vdiua in atto far dolce concento tra le Voci & i Suoni;cosa c'hanno etiandio creduto infiniti altri, ingannati dal non hauerle udite ne gli Istrumenti sotto quelle Forme, che credeuano che fussero contenute. Laonde essendo tenuta questa opinione tra i Musici antichi per certa, & ritrouandoui nel Systema diatono le chorde corrispondenti semplicemente l'una all'altra per Diapente, ouero per Diatessaron, & credendo che 'l Ditono & Semiditono fussero consonanti; se bene vedeano che le proportioni loro erano fuori delli due sudetti Generi; forse ponendole nel numero di quelli Interualli, che chiamano Emmeli; cercassero di ridurli à tal temperamento, che potessero satisfar'all'Vdito, ma non senza leuar la Diapente & la Diatessaron fuori delle lor uere forme; forse anco credendo, com'anco credono molti, che cotali consonanze temperate nel modo, che si odono ne gl'Istromenti da Tasti, fussero nelle lor uere & naturali forme; & cosi fusse introdotto questo modo di temperatura, che fin'hora si segue. Et credo che questa sia la uera cagione, quando che ancora non fusse stata introdotta d'alcuno, per cagione della Specie Syntona, per leuar la molteplicità delle chorde, aggiunte forse d'alcun'altro, nel modo c'hò mostrato; riducendole à quel numero, che hoggi si uedono ne sudetti Istrumenti; massimamente nell'Organo, Prencipe ueramente de gli altri Istrumenti; fabricato al mo page 158 dello di quello, dal quale nascono le Voci; uolendo nel temperarlo, come si fà, leuar le difficultà, che si trouarebbono nell'adoperarlo, quando ui fusse in esso quel numero di chorde, c'habbiamo mostrato nel Capitolo precedente, per imitar la Natura, laquale non admette cose superflue; come sarebbe il numero de tanti Semituoni, che si riducono in due solamente, l'uno alquanto dell'altro maggiore; se bene non si adopera se non il Maggiore; lasciando da un canto di dire qualche differentia, ancora che minima, che si potesse trouar tra i Minori, & di fare al tutto niuna memoria de gli altri, come di quelli, che non sono à patto alcuno necessarij per l'uso delle nostre Harmonie; siano poi temperati gli Istrumenti sotto la forma di qual si uoglia temperamento, che non fà caso. Et quantunque ui siano dell'altre opinioni, ch'io non uoglio riferire, per non le impugnare, & gettare il tempo; perche poco fanno al nostro proposito; tuttauia (come hò detto) tengo che la prima sia la uera & la migliore. Ma chi fusse ueramente il Primo, che desse notitia & dimostrasse le ragioni del Temperamento sudetto, non lo saprei dire; quantunque habbia veduto molte cose, parte in iscritto, & parte mandate fuori in stampa da diuersi. Sò ben questo, ch'è verissimo; che 'l non hauer ritrouato cose che faciano al proposito, & il non poter'hauer'hauuto cosa buona, mi diede occassione di cercare & inuestigare, come potesse trouare il uero modo & dimostratiuo, di dimostrar questa cosa; onde dopo lungo spacio di tempo hauendo trouato, incominciai à cercare quei mezi, con i quali cotal cosa si potesse ridurre sotto la dimostratione; & hauendo ueduto, ch'era fatica uana & inutile, il uolerlo fare col mezo de i Numeri & proportioni rationali; uolse Iddio, che dopo molti stenti & lungo spacio di tempo, ch'io spesi in cercare & inuestigar questa cosa, col mezo della Geometria la ritrouasssi. Ilperche posi in luce & dimostrai non solamente come in un modo, ma in tre, si potea far cotale temperamento; l'uno nelle Istitutioni, & gli altri due nelle Dimostrationi; ilche diede occasione à molti di prouar se potessero sopra di questo trouar cosa alcuna di nuouo. Laonde à questo proposito il Reu. Don Girolamo Roselli da Perugia, monaco di Monte Cassino, al presente Abbate di S. Martino in Sicilia, amico mio singolare, nella Seconda diuisione d'un Trattato ch'egli fà della Musica spherica, ch'io hebbi da lui scritto à penna, non ancora uenuto in luce, cosi scriue in questo proposito.
Il Fogliano nella sua Theorica s'attribuisce l'inuentione della Partecipatione; però come altri dicono; se ben s'hanno pensato alcuni seguirlo nel Canto; che ueramente i prattici buoni habbiano seguitato l'orecchio; se ben molti (come diceuo) si credeuano seguitar Tolomeo; è uenuto poi il Mag. Zarlino, c'hà escluso tutte l'altre diuisioni de gli Antichi, & accordatosi in parte co i Moderni, ne gli Istromenti hà fatto un'altra Partecipatione diuersa da quella del Fogliano & dall'altre, pigliando però i Numeri harmonici di Tolomeo per fondamento, hà con molte fatiche cercato di ritenere le Participationi de i Moderni, quanto hà potuto, uicine à questo segno; accostandosi all'uso Pithagorico in questo, che i Tuoni fussero tutti di ugual quantità tra loro.Ilche è uero; perche questo Reu. P. amico mio singolare & di buona dottrina, parla della Partecipatione fatta nel Libro secondo delle Istitutioni, & della prima dimostrata nel Quinto delle Dimostrationi, & non della seconda; onde seguita, dicendo:
Tenendo anche conto, come si uede, di tanti belli ingegni moderni, spuntando le Quinte & crescendo le Quarte, & cercando lasciar qualche Interuallo intatto à gli Antichi; & talmente portandosi, che quando quella di Tolomeo sia uera diuisione, hà lasciato più presto luogo à chi uorrà ammirarlo, che à chi uorrà superarlo. A me piacque assaissimo scorrendolo, come hò detto; che dopo non hò hauuto ne coppia del libro, ne del tempo; Et mi parue mirabile in questo, che non uolontieri, ma sforzato dichi essersi allontana page 159 to da gli Antichi, & hauer messa la Musica fuori del Numero, ridottola alle Quantità continue. Mi è parso poi più mirabile anche & d'acutissimo senso; che non ui trouaua poi (dolendosene) gusto compito. Quest'era un'inuitare se si potesse dir meglio; non gli bastando hauer giouato tanto. Sospiraua ancora di ueder la Musica in colmo, obligandosi per ogni uerso tutti li Studiosi del Canto. Ma che 'l Fogliano si habbia attribuita l'Inuentione della Partecipatione, lo potrà conoscere ogn'uno, quando conoscerà: ch'ei fù suegliato nel modo di diuidere il Tuono ò qual si uoglia Consonanza, dal Fabro Stapulense, nominato disopra, con l'aiuto della Geometria, nella 35. & ultima del Terzo de gli Elementi musicali .Tutto questo scriue questo mio dotto & P. Reu. alquale aggiungeremo il R. Francesco Salines borghese, Abbate di S. Pancratio della Rocca scalegna nel Regno di Napoli, professore di Musica nell'Academia di Salamanca, di molto ualore, come si conosce da i suoi Scritti; che nel Cap. 14. del 3. Lib. della Musica scriue queste parole.
Vnde quàm paucissimi ueram Organi temperandorum normam assequitur; quoniam adhuc ratio, qua fieri debeat, nondum cognita est.Se bene pur troppo nelle Istitutioni & nelle Dimostrationi questo si potea conoscere; ma in fatto disconcia ogni cosa quando soggiunge:
Eam nos, dum essemus Romae iuuenis, excogitasse uidebamur; & postea à Iosepho Zarlino traditam inuenimus nihil ab ea, quam nos excogitauerimus, discrepante.Ilperche par che uoglia inserire, che dopo che lui ritrouò cotal Temperamento, io l'habbia posto in luce; & accioche questo non gli sia attribuito à uanità, soggiunge iscusandosi:
Neque id mirum alicui uideri debet, quoniam una atque eadem est Veritas; & omnibus, eam ritè inuestigantibus, sese offert.Ma se ben la Verità è una, non è però dimostrata sempre con un mezo istesso, & ad un'istesso modo quando ui concorrono molte Operationi & molte Intentioni massimamente quando non ui sono Principii proprij & necessarii, & Mezi che siano proprii & ueri, & ui concorrino più Inuentioni di molte cose & diuerse; come uediamo esser auenuto della Quadratura del Circolo, non ancora da alcuno ritrouata, & nella Duplicatione del Cubo; nelle quali cose, quantunque molti si siano affaticati; non uediamo però, che fin' hora si trouino due, c'habbiano concorso nel Dimostrar la cosa, ne gli istessi Principij ò mezi, & nell'istesso modo; se ben si uede nella Dimostratione della Prima propoposta del Primo de gli Elementi d'Euclide, tutti quelli, che l'hanno dimostrata, esser concorsi in una istessa operatione, collocando il Triangolo equilatero sopra una data Linea retta terminata, col mezo della Figura circolare; conducendo dal suo centro alla circonferenza quelle linee, che faceuano dibisogno à dimostrar cotal cosa, per esser cosa semplice & ueramente facile; nella quale non ui concorre se non una Intentione. Imperoche sarebbe stato un gran miracolo in una cosa tanto difficile, che mi diede da pensare assai; nellaquale concorreuano diuerse Intentioni & diuerse Inuentioni; com'è il modo & la strada che si douea tenere à far cotale Partecipatione; come la Specie si douea temperare; come il Comma si douea diuidere diuersamente in tante, ò pure in tali parti equali; come bisognaua distribuirlo tra gli Interualli dell'Istrumento; cioè tra i Sette contenuti nella Diapason; il mezo del diuidere proportionalmente cotal Comma; & la Quantità di quanto si doueano accrescere ò sciemare i sudetti sette Interualli, che non ui fusse stato ueruna differentia; ilche se bene (dato che cosi fusse, com'ei dice) non è impossibile, è almeno tanto difficile, che si può ueramente porre tra quelle cose, che sono sommamente difficili, & apportano à gli huomini marauiglia. Più oltra, hauendo il Salines parlato nel Cap. 19. & 20. pur del sudetto Terzo libro, del Temperamento ch'io dimostro nel Secondo delle Istitutioni & di due altri appresso; scriue nelCap. 26. in questo modo:
Quae quodlibet horum trium page 160 temperamentorum instrumentis artificialibus esse uidetur aptissimum, neque plurà adhuc excogitata sunt; quorum primum à nemine, quod equidem sciam, positum est: Secundum inueni etiam (ut superius significaui) In Harmonicis Institutionibus Iosephi Zarlini Clodiensis: Tertium inchoauit quidem Ludouicus Follianus Mutinensis; sed non perfecit: quod idem Iosephus Zarlinus optime considerauit in suis Harmonicis Institutionibus. Nemo tamen haec tria simul agnouit, neque eorum inter se respectum & ordinem animaduertit.Ma lasciamo da un canto questo, & ritornando al nostro proposito, diciamo; che quanto alla cagione della Partecipatione di simili Istrumenti la potiamo conoscer da quello, che si è detto; ma chi fusse quello che la ponesse in uso, questo è impossibile di sapere; credo però, che colui che ri trouò prima la Tastatura di questi Istrumenti, che anco fusse il primo, che ritrouasse il suo Temperamento: Sia poi qual si uoglia fatto tra le Ottochorde d'una Diapason, ò tra quelle d'un Systema massimo di qual si uoglia specie, è impossibile (come si è detto più uolte) che gli Interualli in esso temperati ritenghino la lor naturale Specie ò Forma; & non siano alterati. Onde dico prima, in conclusione di questo ragionamento; che quella Specie d'harmonia, che si sono hoggi in cotali Istrumenti à questo modo temperati, non è à patto alcuno la Semplice naturale ò Syntona diatonica, quantunque in qualche parte ad essa si potesse assimigliare. Dico poi, che quella Specie, che si canta & si sona con alcune sorti d'Istrumenti, che non hanno i luoghi de i suoni determinati; Come sono il Trombone, la Lira, il Violino & altri simili; & di più, quella che si Compone, è la Specie Naturale & Syntona diatonica di Tolomeo; percioche è uero tutto quello c'hò detto & prouato nel Cap. 41. & 45. delle Istitutioni nella Seconda parte; & chi crede & tiene altramente, è in grande errore, & non intende quella differentia necessaria, ch'è tra l'Istrumento naturale della Voce, che potiamo dire uniuersale, & l'Arteficiale de i Suoni; che si può chiamar particolare. Et se fusse uero, come tengono alcuni, che non si cantassero mai, ne mai si sonassero gli Interualli terminati dalla Natura nelle loro uere & naturali forme; ne seguitarebbe un massimo inconueniente; Che Iddio & la Natura, come suo Istrumento, che non operano mai cosa alcuna in uano, hauesse dato à mortali una cosa, che non si potesse porre in atto, ma che fusse sempre in pura potentia; onde sarebbe in tutto uana & inutile; laqual cosa in tutto & per tutto è lontana dal uero. Ma perche questi nostri Moderni fondano la loro opinione sopra due sorti d'Istrumenti, com'hò detto, facendo in essi due Dimostrationi; però uoglio prima, che le uediamo, & dopoi, hauendole essaminate, si potrà conoscere, quanto sarebbe stato meglio, c'hauessero taciuto, che ragionato di quelle cose, che non intendono. Et perche, per fondamento di questa loro Distributione pigliano la Specie Syntona ò Incitata diatonica d'Aristosseno; mossi da quello, che uiene quel loro Gentil gentilhuomo nel suo Discorso, ilquale ho nominato nel Cap. 4. di questo Libro; che tra gli Interualli de i sudetti Istrumenti si trouano i Tuoni equalmente diuisi in due Semituoni, & che anco si suoni la sudetta Specie; hauendo per fermo, ch'Aristosseno diuidesse semplicemente l'Interuallo, che cade tra suono & suono, secondo la Qualità, senz'hauer rispetto alla Quantità, in parti equali; però, per non hauere à replicar più uolte l'istessa cosa, dimostraremo prima cotale Specie, & insieme essaminaremo, come si potrà meglio fare, l'intentione d'Aristosseno; & dimostraremo anco in qual maniera gli Aristossenici moderni habbiano potuto intendere questo Musico & Filosofo celeberrimo, & come l'habbiano potuto difendere dalle calonnie (come dicono) dategli da Tolomeo; Dopoi, dimostrati gli Errori, ch'eglino hanno page 161 commesso, nel uolere trattarle Mathematicamente uerremo à seguitare il nostro proposito.
In qual modo Aristosseno habbia costituito le sue Specie de i Generi semplici dell'Harmonia; & s'egli intenda diuidere l'Interuallo in parti equali & proportionali, ò nò. Cap. XIII.
Ε῎στι δὲ ὁ Τόνος ἡ τῶν πρῶτων συμφώνον κατὰ μέγεθος διαφορὰche vuol dire: E' adunque il Tuono la Differentia delle prime Consonanze, quanto alla Magnitudine ò Grandezza che la uogliamo dire: onde si uede, che tal differentia è secondo la Grandezza, la quale è posta nel Quanto, & non secondo la Qualità, perche soggiunse:
Ma diuidasi in tre diuisioni & moduliamo la sua metà, la Terza, & la Quarta parte, & siano i minori Interualli di questi fuori d'ogni ordine del Canto, & la Minima parte si chiami Diesis, che sia la minore dell'Enharmonico, & la più uicina à questo sia il minimo del Chromatico; ma la Massima sia detta Semituono.Onde è da sapere, che non si potendo far cotal diuisione se non nella Quantità ò Corpo sonoro, che è di Quantità continua; ouer ne i Numeri, che sono Quantità discreta; in confirmatione di quello c'hà detto poco dopo il principio del Secondo libro, dice; che
E' manifesto, che le Diuisioni, & le Figure si fanno intorno una certa stabile & permanente Magnitudine.Dice anco quasi nel fine di questo Libro;
Esser manifesto,da quello però c'hà detto di sopra;
ch'essa Diatessaron consta di due Tuoni & mezo.Ilche hauendo prouato, conclude con que page 162 ste parole.
Ω῾στε τῆς ὑπεροχής οὔσης τονιαίας τε, καὶ εἰς ἴσα διῃρημένης ὧν ἑκάτερον ἡμιτόνιον τε, καὶ ὑπεροχὴ μὲν τοῦ Διὰ τεσσάρων ἐστὶν ὑπὲρ τὸ Δίτονον, δῆλον ὃτι πέντε ἡμιτονιαίων συμβαίνει τὸ Διὰ τεσσάρων εἶναι:cioè, Di maniera che essendo l'Eccesso toniaco diuiso in due equali, de i quali l'uno & l'altro è Semituono; & è anco quello Eccesso, per il quale la Diatessaron sopr'auanza il Ditono; è manifesto, che essa Diatessaron è capace di Cinque Semituoni. Onde è da notare, ch'essendo in tutti gli essemplari Greci, c'ho ueduto, scritto Διὰ πέντε; si deono correggere & porui Διὰ τεσσάρων; acciò non si prenda errore; essendo che bisognerebbe à far bene il conto, che essa Diapente fusse capace di Sette, & non di Cinque Semituoni, al suo modo. Ma da quello che dice Aristosseno, che la Diatessaron è capace di Cinque Semituoni, si può comprendere, che egli non considera le Consonanze maggiori, come composte di Semituoni; come credono alcuni; se ben dice, che possono esser capaci; percioche chiama il Semituono Eccesso, per ilquale la Diatessaron supera il Ditono, nel modo che anco il Tuono è quello Eccesso, per ilquale la Diapente supera la Diatessaron; & è senza dubio contenuto nella Sesquiottaua proportione, secondo i Pithagorici; & cotale Eccesso ei pigliò per fondamento delle Diuisioni, nelle Costitutioni delle sue Specie de i Generi dell'Harmonia; se bene lo considera per un'altra maniera, nella Magnitudine ò Grandezza; quando egli dalla sua Diuisione fatta in molte parti, costituisce le Specie de i Generi dell'Harmonie à suo modo; poscia che lo diuide hora in due, hora in tre, hore in quattro, & tallora in Otto parti equali; & la Quarta parte nomina Diesis Enharmonico; la Terza, Diesis del Chromatico Molle; la Quarta con la Ottaua, Diesis del Chromatico Hemiolio, ouer Sesquialtero; ma la sua metà chiama Semituono, ilquale fà commune à tre Specie, come alle due Diatoniche, & à quella che nomina Chromatica Toniaca. Laonde uiene à costituire Sei Specie ò Differentie di Tetrachordi de i Generi semplici dell'Harmonia; due Diatoniche, tre Chromatiche, & vna Enharmonica; percioche (come si potrà uedere) la Diatessaron si considera come diuisa in 60. parti equali; nel modo che anco la considera in questo fatto Tolomeo: ilperche ponendo la Metà del sudetto Tuono, che sono 12. delle dette 60. parti, nel primo & grauissimo Interuallo di un Tetrachordo; & l'altre per ordine, in questo modo. 12. 24. 24. costituisce quella Specie, che chiama Diatonica Syntona ò Incitata. Hauendo anco collocato nel grauissimo Interuallo simigliantemente 12. parti, nel secondo 18. & nel terzo 30. in questo modo. 12. 18. 30. fece quello, che serue alla seconda Specie, che nominò Molle. Questo fece anco in quello, ch'è primo nella Specie chromatica, ponendo quest' ordine. 12. 12. 36. laquale chiama Tonica. Ma assegnando la Terza parte, che sono 8. al primo Interuallo & anco al secondo graue; al terzo ne assegnò 44. & costituì in questo Genere quella Specie, che si chiama Molle ò Delicata, in questo modo 8. 8. 44. Collocando etiandio la Quarta parte, in ciascheduno de i due più graui interualli, che sono 6. parti delle 60. & aggiungendone al terzo & più acuto 48. in questa maniera 6. 6. 48. formò il Tetrachordo del suo Enharmonico; percioche quando accommodò nel primo luogo & grauissimo & nel secondo ancora l'Ottaua con la sua Quarta parte, che furono 9. delle 60. dandone 42. all'acutissimo, in questo modo 9. 9. 42. formò il Tetrachordo di quella Specie, che nominò Chromatico Hemiolio ouer Sesquialtero; come nell'essempio si può comprendere. Ma se i due Tuoni l'uno all'altro seguenti, collocati da questo Musico eccellentissimo nel Syntono diatonico, & li due Semituoni graui posti nel Tonico chromatico, & quelli due Interualli, che seruono al Molle; cosi anco quelli, che collocò nel Sesquialtero siano equali & proportionali quanto à i page 163
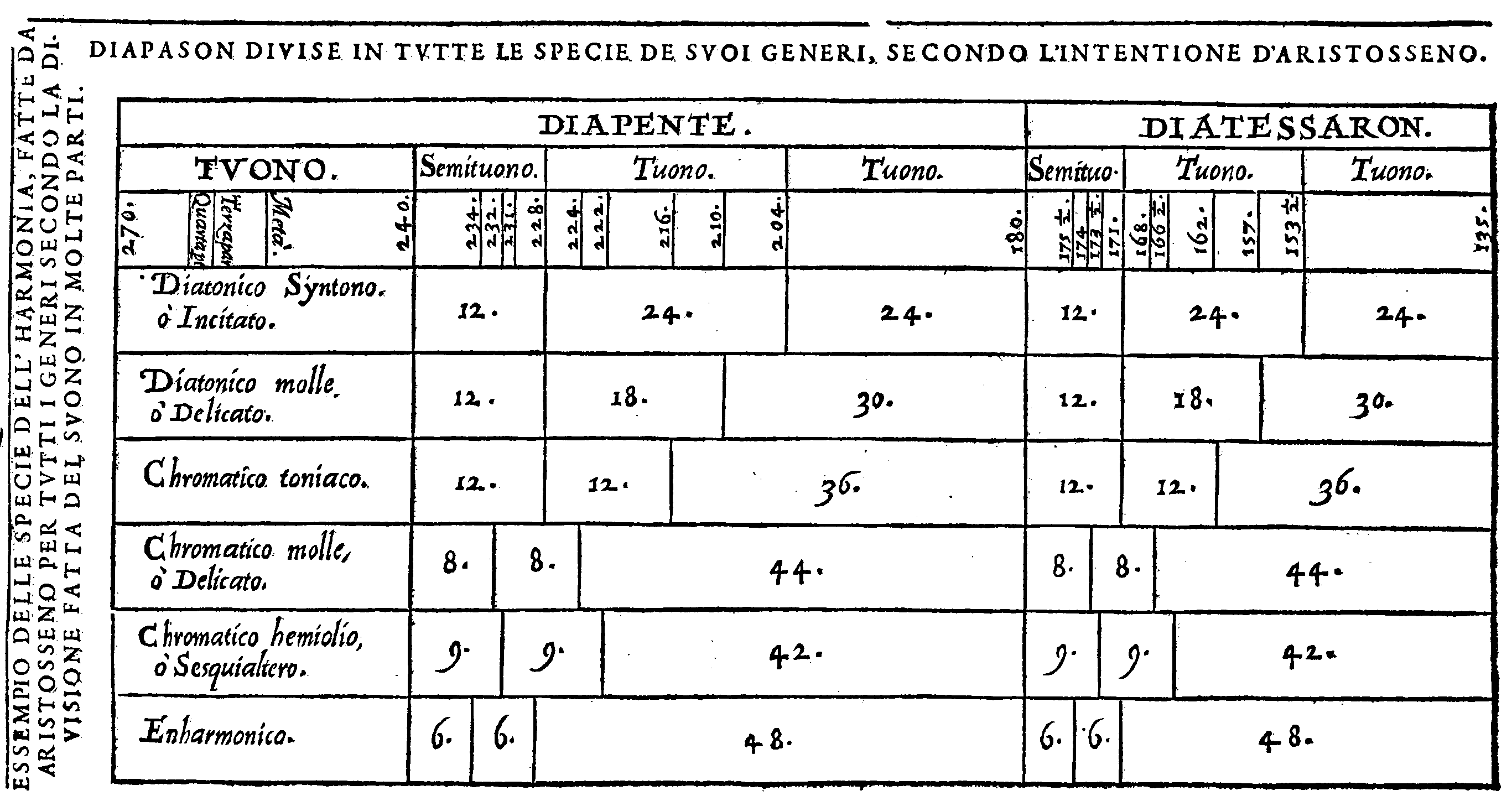
Il diuidere la Differentia, ch'è tra 'l Graue & l'Acuto di qual si uoglia Interuallo in due ò piu parti equali, nella magnitude ò Quantità continua, non è diuidere cotal Differentia in più equali & proportionali ne i Suoni. Cap. XIIII.
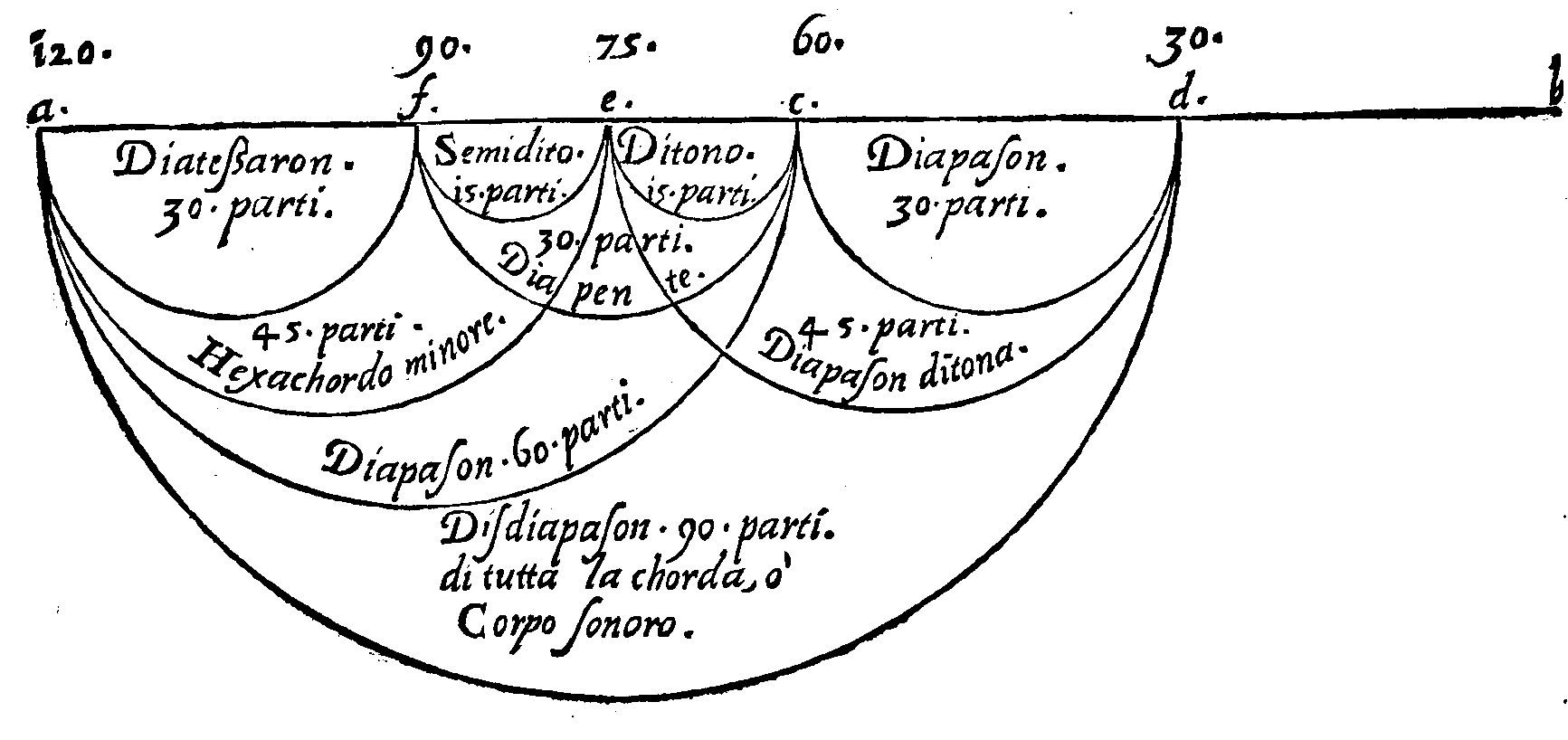
Che nella Diuisione del Quanto continuo, le Parti non mutano alcuna sua qualità, se non in quella del Suono.Cap. XV.
Quanto uenga ben difeso Aristosseno da i suoi seguaci Moderni. Cap. XVI.
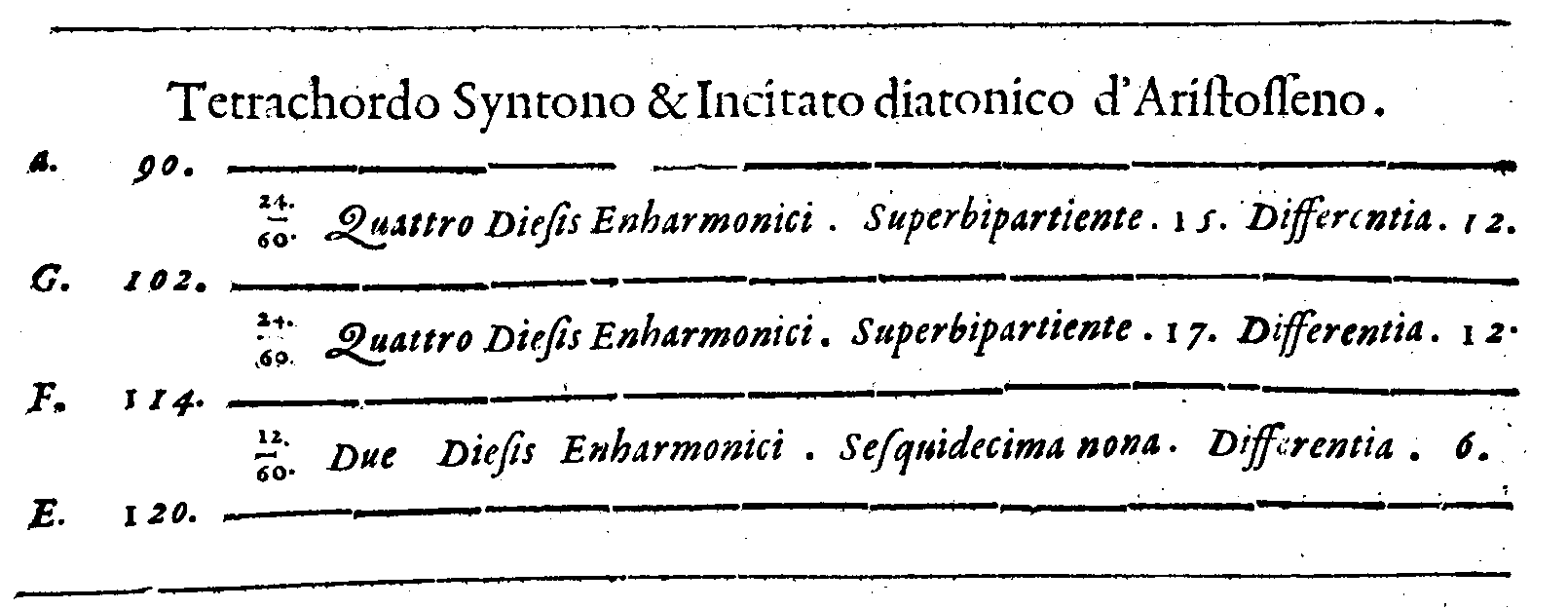
Aristosseno diuise primamente il Diatessaron, che constaua di due Tuoni & un'intiero Semituono, come conforme à suoi disegni; in Sessanta particelle, equali quanto al suono, & non quanto alla lunghezza della Linea ò chorda; se bene in essa era ancora tal quantità considerata.Et questa è una solenne pazzia; percioche altro è diuidere il Tuono, & costituire delle sue parti (com'habbiamo mostrato) le Specie de suoi Generi; & altro è dire ch'ei diuidesse la Diatessaron conforme à i suoi disegni; non intendendo quello c'habbia uoluto dire Aristosseno; il che dimostrano, quando dicono, che
Non per altra cagione si uedono nel Manico del Liuto & della Viola, andare i Tasti loro ristringendosi uerso il Corpo, & l'uno dell'altro maggiormente auicinarsi, quanto il suono dell'istessa chorda fatta più corta, si fa acuto.Ilche è detto con poca loro intelligentia dell'adotto Tetrachordo, ilquale dimostra essergli in tutto contrario. Laonde se cosi è, com'è ueramente; come se gli può credere, quando dicono & tengono, che tra gli Istrumenti da chorda la Viola d'arco, il Liuto, & la Lira co i Tasti, si suona il Diatonico incitato d'Aristosseno? poi che non hanno hauuto i Sensi tanto puri, come dimostrano, c'habbiano potuto uedere & udire, se in essi si troua l'Vgualità de Tuoni ugualmente diuisi in due pari Semituoni? Credono anche, contra la dottrina di questo Filosofo; che la Terza maggiore sia contenuta da una proportione irrationale assai uicina alla Sesquiquarta; ilche si è detto etiandio altroue; come scriue anco il più uolte citato Gentil'huomo.
Ma non già che i suoi lati siano il Tuono Sesqui page 168 ottauo & il Sesquinono, ma si bene due parti equali di detta Terza; tale quale ella è diuisa al modo de i Tetrachordi d'Aristosseno, ma non cosi essattamente.Et dicono; Non cosi essattamente; percioche il diuidere di questo celeberrimo Musico non s'accorda col modo loro; come si può conoscere dalla Temperatura de gli Istrumenti da Tasti; c'han dato fuori per noua & propria loro inuentione; nella quale (come dicono)
Si dee fuggire sempre l'inequalità de Tuoni, & tuore principalmente, secondo 'l modo d'Aristosseno; per non potersi in alcuna maniera diuidere in parti equali alcuno Interuallo Superparticolare;Onde errano in due cose; prima in questa equalità, percioche pongono i Tuoni inequali, come uederemo: non s'accorgendo; dopoi nel dire, che non si può diuidere in alcuna maniera alcuno Interuallo superparticolare in due parti equali; essendoche non conoscono che ciò si può fare in più modi ottimamente: ma questo dicono per ignorare il beneficio del Mesolabio & d'altri Istrumenti, che lo possono fare. Si dimostrano anco in tutto essere ignoranti delle cose d'Aristosseno, quando scriuono quest'altra pazzia:
Auenga che Aristosseno non istendesse, ne dicesse mai, che i Tasti si hauessero à distribuire; come per modo d'essempio si è detto, del Manico del Liuto; dopo l'hauer diuiso in Dodeci parti equali la Metà di tutta la lunghezza della chorda ò linea; imperoche molto ben sapea Aristosseno, d'hauere à distribuire in parti equali la Qualità del suono & non la Quantità della Linea ò chorde ò spacio; operando allora come Musico intorno al Corpo sonoro, & non come semplice Mathematico intorno la Quantità continua;& cosi uuole il mio diligente Discepolo, fatto (come si dice) Bolzone, insieme con costoro, che 'l primo Tasto solo occupasse la Nona parte dell'intera sua Metà, ò uogliamo dire la Diciottesima del tutto; & il secondo, la Nona parte di quello, ch'era auanzato all'istessa prima metà, dopo l'hauerne tratto il primo Semituono; & che il terzo tasto occupasse parimente la nona parte di quello spacio, che era rimasto alla Metà della chorda, dopo l'hauerne tolto il primo & secondo Semituono; ò pur uogliamo dire la Decimaottaua del Tutto, & cosi gli altri per ordine. Hora ueda lo Studioso lettore, come da questo loro Insonio intendino Aristosseno; quando uogliono (secondo 'l suo modo) che si continuino nel Liuto i Semituoni di proportione Sesquidecimaottaua; come sarebbe per essempio i due sequenti, contenuti tra i termini radicali, 361. 342. 324. le cui differentie sono 19. & 18. nel secondo Genere d'Inequalità, & quelli delle Diuisioni d'Aristosseno sono simili & nella proportione d'Equalità; come si può conoscere nel sopr'addotto Tetrachordo, che sono 12. & 12. Soggiungono ancora un'altra scioccheria in confermatione del loro errore, contra la Dimostratione, che fà Tolomeo, quando dimostra che 'l Tuono non si possa diuidere in due parti equali, & dicono; che
Non è huomo cosi d'ingegno tardo, che secondo però la facoltà Arithmetica, ne dubiti: ma che Aristosseno non disse cosi, ne intese; ma si bene nella maniera, che particolarmente hanno dimostrato nel mettere i Tasti al Liuto; nellaquale si può ueramente diuidere ciascun'interuallo musico in quante parti uguali si uoglia, non altramente che col mezo del Monochordo; perche in quell'atto il Suono è considerato dal Musico come qualitatiuo, & non come quantitatiuo:Et dicono di più che
Se bene Daniel Barbaro sopra Vitruuio la intende per l'opposito, & la dimostratione di Tolomeo è la medesima, di chi dicesse, che tra i termini minori del Diapason non si potesse, col mezo de numeri accommodare alcun'altro Interuallo; nulla dimeno tra la Hypate & la Nete ui è pure, oltra all'altre due chorde, la Lychanos & la Paramese, che danno alla parte graue la Terza & la Quinta, all'acuta la Quarta & la Sesta, & cosi parimente tra F. fa ut, et f. fa ut del Liuto, ui è pure, oltra al Tuono in due ugual parte diuiso, laEt questo che scri page 169 uono, tanto s'accorda col uero & con quello, c'habbiamo dimostrato d'Aristosseno, quanto (come si dice) la Luna co i Gambari: & non si trouerà alcuno che nieghi, che tra un'Interuallo non si possa aggiungere molte chorde mezane; come molte fiate hò dichiarato. Aggiungono anco più oltra, ch'. mi, che la separa in due pari proportioni.
Aristosseno non diuise in tal maniera un membro; com'è il Tuono della Disgiuntione, & poi un'altro; ma il corpo insieme della Diapason;onde dissero, come disopra dicemmo, conditionatamente.
Diatessaron conforme à i suoi disegni:lequali cose, quanto conuengano con quelle, che si è mostrato, ciascuno c'haura inteso il modo tenuto d'Aristosseno, lo potrà conoscere; essendoche non si troua, ch'ei diuidesse la Diapason ne alla guisa del Manico del Liuto; ne meno in parti equali; ne che mai parlasse de numeri ò proportioni. Et da questo è nato, che non intendono questo Filosofo; ne anco essendo da molti altri, che si pensano d'intenderlo, inteso; per la sua difficultà, hanno detto molte cose, che non stanno al martello. Dellaqual difficultà Vitruuio seguitatore della sua dottrina, n'è fedele testimonio, quando dice. Lib. 5. cap. 4.
Harmonia est Musica litteratura obscura & difficilis; maximè quidem quibus Graecae literae non sunt notae.Et dichiarando in questo proposito quello, ch' ei intese da i Scritti di questo Filosofo, aggiunge.
Igitur interualla Tonorum & Hemitoniorum & Tetrachordorum in uoce diuisit Natura, finiuitque terminationes eorum mensuris Interuallorum quantitate, modisque certis distantibus constituit qualitates, quibus etiam artifices, qui Organa fabricant, ex natura constitutis utendo, comparant ad concentus conuenientes eorum perfectiones.Non è adunque da marauigliarsi, se per la difficultà che si troua nella dottrina d'Aristosseno, costoro insieme col loro Bolzone dicono, ch'ei diuidea, non come semplice Mathematico nella Quantità continua; ma come Musico nel Corpo sonoro, la Qualità del Suono, & non la Quantità della Linea ò chorda ò Spacio, che lo uogliamo dire, in parti equali. Ma che bisogna dire à questo, poiche dal sudetto Filosofo conosciamo esser tutto il contrario, quando dice?
Δεῖ δὲ πρῶτον μὲν τοῦ τ'αὐτα μὴ εἰνοεῖν, ὃτι πολλοὶ ἣδη διήμαρτον. ὑπολαβόντας ἡμᾶς λέγειν. ὅτι ὁ τόνος εἰς τέσσαρα ἴσα διαιρούμενος μελωδεῖται. συνέβη δὲ τοῦτο αὐτοῖς, παρὰ τὸ μὴ κατανεῖν, ὅτι ἕτερόν ἐστι τότε λαβεῖν τρίτον μέρος τόνου, καὶ τό διελόντα εἰς τρία τόνον μελωδεῖν.cioè; Ma in uero fà dibisogno saper primieramente, che molti si sono ingannati; credendosi dire, che noi cantiamo il Tuono diuiso in Quattro parti; il che à loro è intrauenuto, perche ueramente non intendono, altro essere il pigliar la Terza parte del Tuono, & altro cantare il Tuono diuiso in tre parti. Di doue si comprende, ch'Aristosseno non era tanto fuori di se, che non sapesse, che 'l diuidere in cotal modo il Tuono, facea che nel canto ò nel suono le proportioni, che si trouano tra le uoci ò suoni, non poteano uenire equali & proportionali; essendoche quanto alla misura equale & alla Quantità, dice;
Altro è pigliar la Terza parte del Tuono;ma quanto alla proportione & qualità soggiunge:
Et Altro cantare il Tuono diuiso in tre parti.Ilperche è da auertire, che Aristosseno non dice, che tali parti siano equali; ma quando dice di sopra, ch'
Ogni interuallo consonante, dalqual si uoglia dissonante, discorda nella Magnitudine.è da intendere, che queste due qualità Consonante & Dissonante, sono anco poste sotto la Quantità, dallaquale, & non da altro luogo, si cauano le ragioni de tali Interualli, hauendosela pigliata per fondamento d'ogni sua ragione; ilche manifesta, quando dice:
Ma perche sono molte differentie delle Consonanze tra loro, pongasi una tra esse celeberrima: & questa è ueramente quella, che si tiene che uenga dalla Magnitudine, & siano Otto le Magnitudini delle Consonanze, delle quali la Minima sia la Diatessaron.Non sapea forse Aristosseno, che κατὰ μέγεθος uolea dire, Secondo la Magnitudine ò Grandezza? & che la Magnitudine ò Grandezza era quantità?. Troppo ben lo sapea; page 170 & se ben questi si sforzano di mantener le loro ragioni, con l'interpretare al loro modo quello che dice questo eccellentissimo Musico; non si ricordano però quello che dicono & dimostrano de gli estremi del Tetrachordo, ch'adducono come mezo delle loro ragioni; perche confessano, essere contenuti dall'istessa Proportione, che sono contenuti quelli del Diatono; ancora che per forza dimostrano per le proportioni de gli Interualli, che esso Tetrachordo contiene, che i Tuoni non sono equali; & dimostrano ch'Aristosseno non cauasse le ragioni de gli Interualli del suo Syntono d'alcuno de i Tuoni posti nel suo Tetrachordo, ne anco del Tuono posto nel Diatono; percioche altre sono le proportioni & parti, che nascono dalla diuisione del Tuono Sesquiottauo, fatto in due parti, & altre quelle che dimostrano nel loro proposto Tetrachordo; in niuna dellequali si troua l'Equalità de Tuoni, come dicono; ma si bene l'Inequalità; nella equalità delle parti, fatte di cotali Interualli. Laonde da quello, che fin qui habbiamo in questo fatto dimostrato, si può conoscere, quanto questi & altri seguaci di questo eccellentissimo Musico, l'habbiano potuto intendere; Ilche maggiormente conosceremo, quando s'haurà dimostrato le sudette loro Distributioni.
Delle Oggettioni fatte da Tolomeo à gli Aristossenici; & quanto bene questi habbiano difeso Aristosseno & loro stessi insieme, contra le addotte Oggettioni.Cap. XVII.
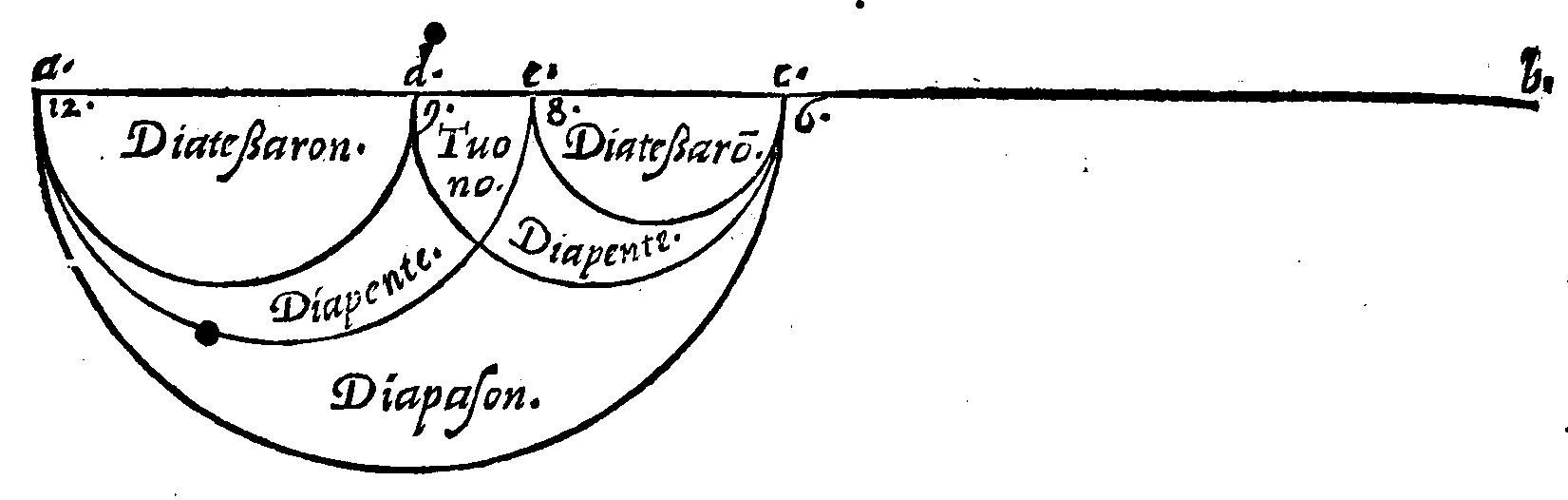
Carlo Valgulio Bresciano, molt'anni sono, prese la difesa d'Aristosseno contra Tolomeo, nella quale fà toccar con mano; quanto egli in tassar quell'huomo Eccellentissimo s'ingannasse, per non dir malignasse; & quanto hauesse il torto, nel cercar di dannarlo & torgli la reputatione;però uederemo quello che dice il Valgulio in questa sua difesa, nelle sudette Annotationi, nellequali scriue in questo modo.
Porphirio ne i Commentarij fatti sopra l'Harmonica di Tolomeo , istrutto primieramente dalle ricchezze de i Clarissimi filosofi Platone, Aristotele, Theophrasto & Panetio; hauendo trascritto di parola in parola, & esplicati con lunga oratione i lor pareri; disputa contra Tolomeo, essendo d'accordo co i Pithagorici che confirmauano l'Acuto & lo Graue nella Voce esser della Quantità; & gli Interualli musicali esser Quanti, & apertissimamente dimostra esser Qualità & Quali; lequali cose tutte lasciando hora da un canto, mi contentarò dell'autorità d'un solo; cioè, di Panetio, che scriue nel Lib. delle Proportioni, & Interualli della Geometria & della Musica in questo modo. Colui (dic'egli) che stima, che si possa diuider lo Spacio, ch'è tra l'Acuto & lo Graue, con una mezana uoce, è simile à colui, che dice, che tra 'l Calido & lo Frigido, & tra il Nero & il Bianco si possa fare una mezana diuisione; percioche la facoltà delle Consonanze non si considera nelle Magnitudini delle Voci, ma nella Qualità. Per laqual cosa, quando i Mathematici dicono, che la Diapason consiste nella Dupla proportione, non lo dicono, per la grandezza della voce della chorda, come sarebbe della Nete, sia più accresciuta della meza parte della Grandezza della Hypate; ilche dicono anco de gli altri, con questa ragione: Se le chorde ò più aspramente ò più languidamente l'una & l'altra; ò l'una più leggiermente, & l'altra con uehementia saran percosse; rimane nondimeno l'istesso Interuallo; abenche le chorde percosse rendino maggior suono; percioche non mutano Qualità: Di doue si fà manifesto, che gli Interualli delle Voci non sono Magnitudini, ma Qualità; Ma dicono, che tutta la Magnitudine della Chorda con la parte della sua grandezza diuisa in due parti, percosse insteme fanno il concento Diapason, & essere la Dupla; intendendo anco dell'altre Consonanze all'istesso modo. Hora gettati questi Fondamenti, & dichiarato breuemente, quanto si è potuto; facilmente liberaremo Aristosseno dalla calonnia; Il Tuono non potersi diuidere in due parti equali, che siano detti Semituoni equali; ilche stima Aristosseno potersi fare; & coloro che l'accusano, credono dimostrarlo con ragioni de Numeri in cotale modo. Il Tuono è in proportione Sesquiottaua, il Sesquiottauo interuallo nelquale è il Tuono, non si può diuidere in due parti, adunque ne anco si può diuidere il Tuono. Dicono anco, tra 16. & 18. Vnità contenersi l'Interuallo Sesquiottauo, & questo non lo poter diuidere se non vna Vnità indiuisibile, che sia la Decimasettima; & due Interualli fatti di uno, esser necessariamente inequali; imperoche quell'Interuallo è sempre maggiore, che giace tra numeri minori, che quello che si troua tra maggiori; adunque sarà maggiore il Semituono, che nasce tra 16. & 17. Vnità, di quello, che è posto tra 17. & 18. Queste cose sono dette esser uere, & à niun dotto esser dubiose; ma però non fanno quello che uogliono: ne per questo seguita, che 'l Tuono non si possa diuidere in due parti, ancora che l'Vnità posta nel mezo della Sesquiottaua proportione ne i numeri non si possa diuidere: Ma essa chorda, nella quale; come nella Regola; hauendo fatto dirittamente uarij partimenti; si formano uarij concenti di Voce; perche è Magnitudine perpetua & continua, in qual si uoglia parte, & in qual si voglia Spacio si può diuidere. Adunque si può anco diuidere in parti equali: percioche si è detto di sopra, secondo l'opinione di Panetio, Theophrasto, Porphirio & d'altri; & ueramente è manifestissima la cosa da se stessa; che le Consonanze Diapason, Diapente, Diatessaron, il Tuono & l'altre, non perciò statuirsi nelle proportioni & grandezze de Numeri; perche esse Voci & gli Interualli delle Voci siano numeri ò page 174 Magnitudini, & habbiano relatione del Quanto tra se, essendo manifestissimamente Qualità; ma perche la chorda & le parti di essa, che danno il Suono, hà quelle relationi fatte tra loro per il Quanto. Ch'impedisce adunque, che quello Spacio di chorda Sesquiottauo, nelquale statuiscono il Tuono, non si possa diuidere in due parti equali, che siano Semituoni pari? Quando i Mathematici dimostrano qual si uoglia parte della Quantità continua, potersi diuidere in parti infinite. A me sarebbe pronto nel Monochordo, che i Pithagorici chiamano Canon ò regola, dimostrar l'istesso mathematicamente, se non fusse manifesto quello ch'io proposi; Aristosseno essere accusato falsamente, che stimò il Tuono potere essser diuiso in due Semituoni equali: Ma era forse Aristosseno ignorante dell'Arithmetica, ilquale scrisse Volumi della facoltà istessa? ò forse non conosceua i Dogmi Pithagorici colui, che hebbe precettore Senofane nobile pithagorico?Questo è il Ragiouamento, che fà il Valgulio in difesa d'Aristosseno, contra Tolomeo; nel quale si trouano molte cose, che patiscono oppositione: dellequali la prima è; che ei lascia da un canto la prima clausula, ch'è scritta da Panetio; come si uede nel Cap. 12. del 2. lib. laqual dice: Quello che è detto nella Musica Semituono, è detto impropriamente; percioche in essa ei propone quello che uuol trattare; & da quello che segue si uede, che non esplica la uera opinione di Panetio & de gli altri: ma piglia quello da loro, che gli par che faccia al suo proposito: Onde fà dibisogno hauere à memoria tutto quello c'hò scritto nel sudetto Cap. 12. per maggiore intelligentia di questo fatto. Et si ri trouerà, che Panetio dimostra più tosto esser contra li Aristossenici, che in lor fauore: Se bene ei dice, che la facoltà delle Consonanze non si considera nelle Magnitudini delle Voci, ma nella Qualità; & questo è detto bene & fà al nostro proposito; ilche il Valgulio forse non conoscea, perche era troppo affettionato ad Aristosseno; ma l'haurebbe troppo ben conosciuto, se egli hauesse con diligentia considerato quello, che più oltra scriue Panetio in fauore de Pithagorici contra Aristotele, & contra molti Peripatetici; & specialmente contra Theophrasto. Percioche facea bisogno ch'ei considerasse la Qualità in due modi, come hò dimostrato poco auanti, nel Cap. 14. Prima, inquanto è collocata in atto nelle cose stabili & permanenti, com'è il Colore nel Corpo ò Superficie suo proprio soggetto; dopoi, in quanto si troua in potentia ne i Corpi sonori, & in atto nell'Aria, come nel proprio soggetto; & nel Genere delle cose successiue, com'è il Suono causato dal Moto. Oltra di questo, bisognaua c'hauesse auertito, quando dice, ch'Aristosseno tenea, che si potesse fare la diuision equale del Tuono; cosa ch'ei non dice: ch'altro è il uoler diuider lo spacio ò distantia, che si troua tra due qualità estreme & contrarie, & altro è il uoler porre una tra loro, che partecipi ò sia equalmente distante dall'una & dall'altra: de i quali due modi, il primo è impossibile; percioche le Qualità sono differenti l'una dall'altra di specie; come per essempio sono l'estreme Voci, & gli estremi Suoni, per l'acuto & per lo graue; essendoche altro è l'acuto & altro è il graue; come sono gli estremi de i Colori, che sono differenti tra loro; come il Nero dal Bianco: ma in un modo si considera il Colore, & in un'altro il Suono: questo, tra le cose che succedono l'una all'altra; & quello tra le cose stabili & permanenti: & tali differentie però uengono dalle cagioni, dallequali nascono, & à loro s'assimigliano: percioche si come il Suono graue ch'è grande, nasce da un Corpo grande sonoro, rispetto ad un picciolo; & per il contrario, l'acuto ch'è picciolo, nasce da un corpo sonoro picciolo, rispetto al grande & sono due estremi: Cosi gli Estremi de i Colori il Bianco, nasce prima da un massimo estremo Luminoso del Fuoco; dopoi da un'estremo minimo opaco della Terra, nelquale ei termina, riceuuto nella page 175 Trasparentia dell'Aria ouer dell'Acqua; & il Nero, nasce per l'opposito. Laonde il Colore non è altro che Estremità del Trasparente nel Corpo terminato: come uuole il Filosofo in quello ch'ei fà del Senso & delle Cose sensibili: & uuole che tra i Colori sia quella istessa conuenienza di proportione, che si troua tra Suono à Suono. Ilperche essendo i sudetti Estremi realmente separati l'un dall'altro, non si può dire, che si possano insieme diuidere; ma si bene questo si può dire, dell'uno ò dell'altro, separatamente: percioche il Colore disteso nella Superficie del Corpo, che è continuo, è qualità, che si può diuidere, diuidendo insieme la detta Superficie, nellaquale è contenuto, secondo la Quantità ò Misura & non altramente, in due parti equali; Per la qual cosa, si come con verità si può dire, che diuidendosi qual si uoglia Superficie d'ogni figura, che fusse equalmente larga, & contenesse in lunghezza Due piedi quadrati, in due parti equali, che ciascuna di esse verrebbe à contener la metà del Colore di tutta la Superficie, che sarebbe la quantità di Vn piede; non uariando però suo Colore la sua prima qualità; cosi anco si può dire, senza ueruno errore, che diuidendosi, ò per dirla più schiettamente, & usare un'altra Voce, ò Termine; forse più commodo à cotal controuersia; Tramezandosi due Suoni, che si trouano nel loro Soggetto in potenza, ch'è il Corpo sonoro, & in atto nell'Aria, con una mezana chorda; che quell'Interuallo, uerrà ad esser diuiso in due parti, di tanta proportione, quando sarà tra la mezana & le due estreme chorde. Onde il Suono, che si troua in un soggetto, dirò cosi; instabile, ch'è l'Aria; nella mutatione della misura & quantità del Corpo sonoro, dal quale egli uscisse, si muta anco nella Qualità; com'hò detto nel Cap. 15. ma non nel Colore; perche non è colorato: ilche si uede, che se da un Corpo sonoro vscisse un Suono graue, & di tal Corpo se ne faccia due parti equali separate l'una dall'altra; allora, dalla sua diuisione nascono due Suoni, l'uno dall'altro separati, equali & unisoni; & anco à quello che nasce da tutto 'l Corpo, equisoni. percioche le due parti fatte del detto Corpo non percuotono l'aria, secondo che facea il Tutto & intiero; ma più uelocemente. Dice adunque bene Panetio in questo fatto, che non si può porre un mezano Suono tra l'acuto & il graue; poi che tra loro non si troua un continuo, che si possa diuidere nel modo, c'habbiamo detto di sopra; ilche si può anco dire d'ogn'altra Qualità. La Seconda cosa, che patisce maggiore oppositione di cosa, che dica il Valgulio, è questa; lasciandone molte per breuità; ch'ei dimostra, non esser buon Mathematico; percioche prima adduce le ragioni & dimostrationi fatte da quelli, che non uogliono che si possa diuidere il Tuono in due parti, cioè, in due Semituoni equali; & dopoi dimostrate, dice;
Queste cose esser uere, & à niun dotto essere dubiose; ma non però fanno, ne per questo seguita, che 'l Tuono non si possa diuidere in due parti,massimamente perche la chorda, laquale è Magnitudine perpetua & continua; in qual si uoglia parte si può diuidere, in quanti Spacij si uogliano; ilperche conclude, che si può anco diuidere in parti equali. Ma per questa sua conclusione non si può intendere se non che cotali parti saranno equali solamente nello Spacio, come nella Materia ò Corpo, dalquale ne uenga il Suono, che è la Chorda; ma non nella proportione; cioè, non saranno proportionali; onde mi pare, che non habbia inteso quello c'habbia uoluto dire Aristosseno & Panetio, quando dice;
Che impedisce adunque, che quello Spacio di chorda Sesquiottauo; nelquale statuiscono il Tuono, non si possa diuidere in due parti equali, che siano Semituoni pari; essendoche i Mathematici dimostrano, qual si uoglia parte della Quantità continua, potersi diuidere in infinite parti?Ma la cosa non stà nel diuidere cotale Spa page 176 cio in cotal modo; essendoche non è difficile, & tutti quelli lo sanno, c'hanno un poco di cognitione delle Mathematiche; ma consiste nel diuidere in parti equali & proportionali; ilche non fece mai Aristosseno; ne facendo al modo suo, si può fare; come si è dimostrato nel Cap. 13. & nel 15. Quando anco soggiunge;
A me parrebbe pronto nel Monochordo, che i Pithagorici chiamano Canone, ò Regola, dimostrar l'istesso mathematicamente; se non fusse manifesto quello, ch'io proposi, Aristosseno esser'accusato, falsamente che stimò il Tuono poter'esser diuiso in due Semituoni equali.Non so ueder come uadi la cosa, secondo lui: percioche ueramente non è manifesto, com'ei dice; essendoche, prima Aristosseno non diuise in parti equali proportionali; ne fece mai mentione di equalità; come habbiamo dimostrato; & dopoi, molti sono concorsi nel dimostrare, che non si può fare, nel modo che gli Aristossenici attribuiscono ad Aristosseno, & uogliono che si faccia; & pochi sono stati quelli, anzi niun si troua; per quello c'hò fin'hora ueduto, c'habbia dimostrato, che si possa fare; & c'habbia difeso bene Aristosseno; ilquale non stimò, che 'l Tuono si potesse diuidere in due Semituoni equali; com'ei dice. Et se tutto quello c'hà scritto il Valgulio in sua difesa delle calonnie (come dice) dategli da Tolomeo, non proua contra Tolomeo, che 'l Tuono si possa diuidere, secondo 'l modo d'Aristosseno, in due parti equali & proportionali; ma semplicemente dice, che potendosi diuidere la Chorda in parti infinite, anco lo Spacio di chorda, nelquale statuiscono il Tuono, si può diuidere in due parti equali; per quanto mi posso ricordare non trouo, che mai Tolomeo negasse questo; ma dimostrò bene, che nel modo che lo diuidea Aristosseno ò gli Aristossenici, non si potea diuidere in due Semituoni, che fussero equali & proportionali, quantunque si potea fare ottimamente con i Numeri; percioche tal diuisione cascaua nella Progressione ò Proportionalità arithmetica; ch'appartiene à lei, il c'hò dimostrato, si nelle Istitutioni, come anco nelle Dimostrationi. Hora inteso tutto questo; Che potremo noi hora dire, se non ch'Aristosseno non sia stato altramente difeso dal Valgulio, come anche non è stato difeso dal Fabro Stapulense; come questi nostri moderni Aristossenici credono, anzi più tosto accusato, & che habbia confirmato la Dimostratione fatta da Tolomeo, percioche il Fabro nella 6. del Lib. 2 De gli Elementi musicali, hauendosi affaticato nel discorrere contra l'opinione d'Aristosseno & di Martiano ò (uogliamo dire) Felice Cappella, come lo nominano; finisce il suo ragionamento in queste parole.
Sic enim qui stolidum sensus iudicium sequentes, intellectum relinquunt; facilè ex disciplinarum aditis se explosos sentiunt.Dalle quali ogn'un può comprender quello, c'ha da tenere in questo fatto, secondo la mente d'Aristosseno & de gli Aristossenici. Et per finire dico, che mi par uedere Aristosseno essere stato anche cosi ben difeso dal Fabro, come dal Valgulio, nella Diuisione del Tuono contra Tolomeo; & quanto il medesimo Fabro contra di questo gran Mathematico, nel fine della 23. del Lib. 3. De i sudetti Elementi, habbia difeso l'opinione de Pithagorici, nella Questione della Diapasondiatessaron, se ella sia ò non sia Consonanza, quando dice queste parole.
Et reuera Ptolemaei cum Pythagoricis magis in nomine, quàm in re ipsa dissentio putanda est.ilche si potrebbono accommodare, credo, à quello che questi Moderni speculatiui dicono; che i Pithagorici sono stati molto ben difesi in questo caso dal Fabro contra Tolomeo. Ma di questo non ne uoglio dire altro; percioche credo, col mezo della Inuentione ritrouata & da me esplicata nel principio del Secondo delle Dimostrationi, del Mezano udibile; d'hauere in modo accommodato la cosa, ch'ogn'uno leggendo accuratamente il luogo & la Prima con la Seconda definitione seguenti, insieme con page 177 la Quarantesima proposta, potrà di cotal cosa restare à pieno satisfatto, & conoscere, come i Pithagorici con Tolomeo, in questa causa, si possono insieme accordare.
Le Sciochezze c'hanno detto alcuni contra Tolomeo, come calonniatore d'Aristosseno. Cap. XVIII.
Niun può prohibire, che qual si uoglia cosa diuersamente considerata, si possa trouare in molti Predicamenti.Ilperche se Tolomeo, per le ragioni addotte nel Cap. 14. del sudetto Libro, tenne; che i Suoni & le loro Differentie sono sottoposti alla Quantità; & dimostra gli errori, che commetteuano gli Aristossenici nella Diuisione del Tuono, iquali teneuano l'opposito; non era tanto da biasimarlo, com'ei hà fatto; tenendo con la setta de gli Aristossenici; che i Suoni siano solamente sottoposti alla Qualità. Ma lasciamo il Valgulio, & diciamo d'alcuni de Moderni insieme col mio dotto & prudente Discepolo; che uolendo accusare & anco tassare Tolomeo, come maligno & ignorante, in quello che scriue contra essi Aristossenici, uengono à dire il tutto in loro biasimo; essendoche dicono mille sciocchezze & mille cose ridicolose; Laonde il mio troppo ardito Discepolo; volendo difendere Aristosseno, come dice d'hauer fatto contra Tolomeo; più tosto l'offende, che difende; onde scriue, che questo rarissimo Mathematico prese occasione di riprenderlo in tre cose; la Prima, intorno la Distributione delle chorde; la Seconda, circa la Diuisione del Tuono in parti equali; & la Terza, intorno la Quantità de i Modi. Onde uedremo, in qual maniera ei lo difenda bene nelle due prime cose, lasciando la Terza da un canto. Incominciando adunque dalla Prima; introduce il caso con una dimostratione, ch'egli attribuisce à Tolomeo, in questo modo.
Dice adunque Tolomeo cosi: Se una chorda, per essempio, che sia tesa sopra una piana superficie, si diuiderà la sua metà co 'l compasso in dodici parti uguali; chiara cosa sarà, che dalla quantità del Suono, che 'l tutto con la metà contiene, ilquale vna Diapason uiene à essere, maggior parte ne conterrà l'ottauo, e 'l nono spacio, che non farà il primo & il secondo; con ilqual modo di misurare si uerrebbe à tale, chi andasse troppo in lungo; che una delle ultime parti conterrebbe quattro, cinque & più tanti della prima & seconda.Et in questa sua diceria si trouano molte cose fuori di proposito; essendo che introduce prima in Scena Tolomeo à far una dimostratione, col diuider la Metà d'una chorda col Compasso in Dodici parti equali, laqual non si troua ne i suoi Scritti; dopoi di scorre sopra questa diuisione, di modo che par che Tolomeo non sapesse quello, ch'importassero le parti della diuisione ch'ei cita; la qual uolendo dichiarare, induce in suo fauore la non intesa da lui accommodata diuisione de Tasti nel Liuto, secondo la distributione del Syntono d'Aristosseno; quando di sopra nel Cap. 16. dice la cagione, perche si uede nel manico del Liuto ò Viola d'arco, i Tasti loro d'andarsi ristringendo: Ilperche quasi ch'ei hauesse toccato il uiuo della cosa, soggiunge:
Mediante la qual dimostratione, che ne fà Tolomeo, pare ch'egli habbia, come per prouerbio si dice, ragioni da page 178 uendere, ma il fatto non stà cosi:Et non s'auede, ch'à queste parole soggiunge quello, ch'è tutto contrario à quello che si è dimostrato d'Aristosseno: perche dice; ch'
Aristosseno non intese, ne disse mai, che i Tasti si hauessero à distribuire nel modo, ch'egli hà detto nel sudetto Cap. 14. nel manico del Liuto; Imperoche molto ben sapea, d'hauere à distribuire in parti uguali la Qualità del Suono, & non la Quantità della linea, ò chorda, ò spacio.Questo però contradice (come hò detto) alla dottrina aristossenica; percioche Aristosseno non s'imaginò un tal modo di diuidere; come si uede in quello, c'habbiamo dimostrato di sopra; & si può conoscere nel Tetrachordo Syntono, che questo mio troppo ardito Discepolo hà prodotto in poco fauor delle sue ragioni; ilquale contiene due Tuoni di Proportione inequali. Ma doue mai hà egli ritrouato, di gratia, ch'Aristosseno si sognasse pure, non che dimostrasse ò accennasse una cosi fatta Distributione de Tasti nel Liuto? laqual quanto possa esser drittamente fatta, lo uederemo al suo luogo. Venendo hora alla Seconda cosa, dellaquale scriue, ch'Aristosseno è ripreso da Tolomeo; quando dice.
Lo riprende in oltre; che 'l Tuono non si possa diuidere in due parti equali; & ciò gli uuol prouare dimostratiuamente, in questa si fatta maniera, dicendo: Il Tuono è contenuto tra le 18. & 16. unitade, tra le quali non entra in mezo altro numero; che 'l 17. ilquale considerato come Diuisore del Sesquiottauo, uiene à diuiderlo in parti disugali; imperoche maggior parte è quella, ch'è contenuta della Sesquidecimasesta, che non è quella, che contiene la Sesquidecimasettima, un si fatto Interuallo 289. & 288. Laonde ne segue necessariamente, che non si possa diuidere il Tuono in due parti uguali.Questo è ben detto, quantunque le parole di Tolomeo stiano altramente; ma egli arrogantemente, come quello che sappia & intenda con facilità ogni cosa (ò che sfacciatezza) soggiunge:
Dellaqual cosa non è huomo cosi d'ingegno tardo, che; secondo però la facoltà arithmetica, ne dubiti.A questo aggiunge anco una gran pazzia, quando dice: ch'
Aristosseno non cosi disse, ne intese; ma nella maniera, ch'egli hà mostrato particolarmente nel mettere i Tasti al Liuto;& ciò dice, perche non intende ne Aristosseno, ne Tolomeo, ilquale nel Cap. 10. del lib. 2. de gli Harmonici, parlando drittamente, non contra esso Aristosseno, ma contra gli Aristossenici; dimostrandoli, che non diceuano bene, che la Diatessaron Consonantia si facesse di due Tuoni & mezo, dice cosi.
Non si diuide la Sesqiuiottaua, ne qual si uoglia altra delle proportioni Superparticolari indue equali proportioni; ma gli Aristossenici fanno equali proportioni la Sesquidecimasesta & la Sesquidecimasettima, che seguono dapresso la Sesquiottaua; tra lequali il Semituono sarà ueramente minore della Proportione Sesquidecimasettima & maggior della Sesquisestadecima.Ilperche questo mio Discepolo non è reale; essendoche non referisce bene quello, che dice Tolomeo; ancora che sia quasi l'istesso; ma più tosto il suo ragionare è fondato sopra quello, che si è detto, del Valgulio. Et quello che dice disopra della Differentia, che si troua tra queste due proportioni; ch'è l'Interuallo 289. & 288. uiene à confermar quello, c'hà concluso Tolomeo; quando dice:
La onde segue necessariamente, che non si possa diuidere il Tuono in due parti equali.Et se bene (com'egli dice) non è huomo cosi tardo d'ingegno, che secondo la facoltà Arithmetica dubiti di questo fatto; non negherà però, che per acchetare il Senso, bisogna adoperar la Ragione; essendoche col mezo de i Numeri Tolomeo spiega questo impossibile, non à questi tanto rari & sottili Mathematici Moderni; ma à quelli, che sono fatti d'un poco più grosso legname. Et quantunque Tolomeo sia facile da intendere da ogn'uno; non però il mio Discepolo l'hà inteso, come si pensa. Et che ciò sia uero, si può facilmente conoscer da questo, ilquale hò replicato più uolte, che dice; ch'Aristosseno non disse, ne page 179 cosi intese quello, che dice Tolomeo; ma si bene nella maniera ch'ei hà dimostrato particolarmente, nel mettere i Tasti del suo Liuto: tuttauia i Tasti del Liuto sono l'uno dall'altro disegualmente distanti; & quelli Interualli che fa Aristosseno della diuisione del Tuono in due parti, sono equali; come ogn'uno può conoscere. Et se fusse uero, ch'Aristosseno hauesse inteso la cosa per tal uerso; com'ei dice; haurebbe dimostrato essere un Mathematico & un Filosofo insieme (come si dice) da dozina. Perche chi uorrà considerare il modo, che tiene questo mio Discepolo, troppo facile al credere all'altrui opinioni; nel porre i sudetti Tasti, ilqual dimostrerò fedelmente al suo luogo; & quello che dice, che si potrà in quella maniera diuidere ogni Interuallo; potrà molto ben conoscere, ch'io non parlo al uento; essendoche altro è il diuidere un'Interuallo in più parti, secondo 'l modo ch'intendea Aristosseno, & com'anco l'intendea Tolomeo, ilquale è propriamente Diuidere; & altro è il modo ch'ei insegna: percioche ueramente è un'Adunare insieme, ò uogliamo dire Ordinare ò Moltiplicare molti Interualli d'una istessa denominatione ò proportione, l'un dopo l'altro, più tosto il Diuidere gli estremi della Diapason in molte parti proportionali; laqual Diuisione non si può far ueramente, se non col Mesolabio, ò con l'aiuto d'altri Istrumenti geometrici; come dimostrerò al suo luogo. Ma lasciamo andar da un canto molte cose; & diciamo quest'altra sua pazzia, che uuole,
Che 'l Musico nell'atto del diuidere consideri il Suono come qualitatiuo, & non come quantitattuo;quasi che si potesse diuider la Qualità senza la Quantità. Ilperche troppo bene intese il Dottissimo Daniel Barbaro, nel Cap. 4. del lib. 5. di Vitruuio ; alquale uanamente ei contradice. Ma perche questo suo intendimento & uerità non torna al proposito, non potendo dare ad intendere le cose, nel modo che li tornano commode; però biasima la sua dimostratione. Et per sigillare queste sue uanità, & mostrare apertamente, che non intende quello che dice; uuol che la Dimostratione di Tolomeo sia la medesima con quella, quando alcun dicesse che Tra i termini minori della Diapason non si possa col mezo de Numeri, accommodare alcun'Interuallo mezano, con quello che segue di sopra. Ilche quanto con uenga & faccia al proposito, lo lascio al giudicio di qual si uoglia, che sia nella Musica & nell'altre Scientie mathematiche mediocremente erudito.
Dell'Vso & Necessità dell'Istrumento Mesolabio, & d'altre cose che seruono all'uso della Scientia. Cap. XIX.
Sono stati alcuni, che allontanandosi nel distribuire l'istesse Chorde, nella medesima specie; cioè Syntona; da questo si fatto parere, hanno uoluto in uece delle Due settime parti del Comma, che si è tolto alla Diapente, & augumentato la Diatessaron; toglierne vna Quarta parte, per fare (à detto loro) meno imperfetta questa; & quella d'un Ventesimoottauo di esso Comma; ma poscia è restata la Sesta minore & la maggiore Terza dell'istessa misura, che 'l Syntono contiene; per hauer tolto al Tuono maggiore la Metà del Comma, & hauerla data al minore, & fargli vguali: laqual cosa reputarei degna di consideratione, quando che cosi stesse.Ecco la pazzia grande che dice; essendoche ei dimostra ueramente di non intender la Dimostratione: onde per far maggiormente conoscer la sua sciocchezza & la sua ignorantia, soggiunge:
Ma per essere infatto la medesima (Participatione) della prima, la metteremo appresso l'altre impertinentie.Se adunque ei non hà hauuto tanto giudicio, c'habbia conosciuto la differentia, ch'è tra la mia Prima & la Seconda partecipatione; laquale dic'essere una cosa medesima; ilche non è; & è ueramente cosa molto chiara; pensi ogn'uno da questo, com'ei habbia potuto conoscere la sua essere differente dalla mia Prima; com'ei dice; & esser buon Giudice nelle cose difficili & oscure d'altrui, che non intende; percioche la mia & la sua è una cosa istessa, se bene hà pigliato da partecipare un' altra Diapason. Ma questa è ben cosa ueramente da ridere; c'hauendo egli mostrato il Temperamento, ch'io son per dimostrare; si hà sforzato di dare ad intendere al Volgo, che non considera più oltra; che sia cosa noua, sua & non più ueduta d'alcuno; & molto differente da quello, ch'io mostrai nelle Istitutioni; delquale astutamente non ne hà uoluto far mentione alcuna; per non scoprirsi, che in fatto l'habbia tolto di peso & mascherato, col dimostrarlo nella sudetta Specie della Diapason; usando quella dottrina c'hò insegnato nel Cap. 42. & 43. della Seconda parte delle sudette Istitutioni; nel qual suo Temperamento dice, che l'Interuallo superparticolare non si può diuidere in altra maniera in parti equali, se non nel modo d'Aristosseno, se bene hò dimostrato che ciò si può fare ottimamente, col Mesolabio al meno. Ne anco hà uoluto nominare il Terzo modo di Temperamento, ch'io commemoro nella Prima proposta del Quarto delle sudette Dimostrationi insieme con gli altri due; percioche credo ueramente che non l'habbia inteso; massimamente, perche non l'hò dimostrato con essempio, come feci gli altri; ma l'hò lasciato all'arbitrio di chiunque lo uorrà porre in atto. Di tutte queste sciocchezze, c'hà detto, & delle ignoranze c'hà dimostrato il mio Discepolo, n'è stato gran parte cagione, il non conoscere l'uso & la necessità del sudetto Istrumento; delquale hò trattato nel Cap. 25. della Seconda parte dell'Istitutioni, & nella Vndecima proposta del Terzo delle Dimostrationi, dimostrando il modo di farlo, & di usarlo, per ritrouar quel numero di Linee mezane proportionali, tra due date, che faranno dibisogno; à che ello fù ritrouato, che saranno secondo 'l proposito: onde è detto Μεσολάβιος, dal verbo Μεσολαβέω; che uuol dire Pigliare, ò Riceuere, ò Tuordimezo: Ilperche si chiama quasi Riceuitore nel mezo. L'Vso di questo Istrumento è molto necessario nelle Dimostrationi di molte cose nella Musica; percioche co 'l suo mezo potiamo diuidere (dirò cosi) in quante parti equali & proportionali si uoglia ò pur tramezare proportionalmente da quante Chorde farà dibisogno, ogni Musico Interuallo; ponendole tra 'l Graue & l'Acuto di esso Interuallo; ritrouate nelle lunghezze delle Linee mezane proportionali; contenute nella diuisione; pur che prima si conosca i termini della Pro page 181 portione ò Interuallo, che contiene la Consonanza, che si haurà da diuidere. Laonde s'alcuno, per essempio, uorrà diuider la Diapason, contenuta nella proportione Dupla, da 2. & 1. in due, ouero in tre, & anco in più parti proportionali; piglierà due Retti linee; delle quali l'una sia il Doppio maggiore ò minore dell'altra, come sono le seguenti; & tra esse ne ritrouerà, con l'aiuto del su
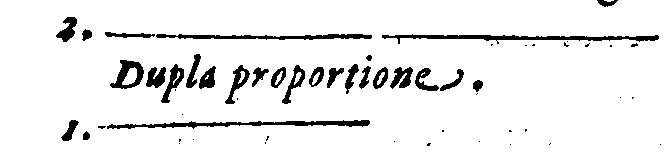
Come si possa trouar due rette Linee mezane proportionali tra due date, senza l'aiuto del Mesolabio. Cap. XX.
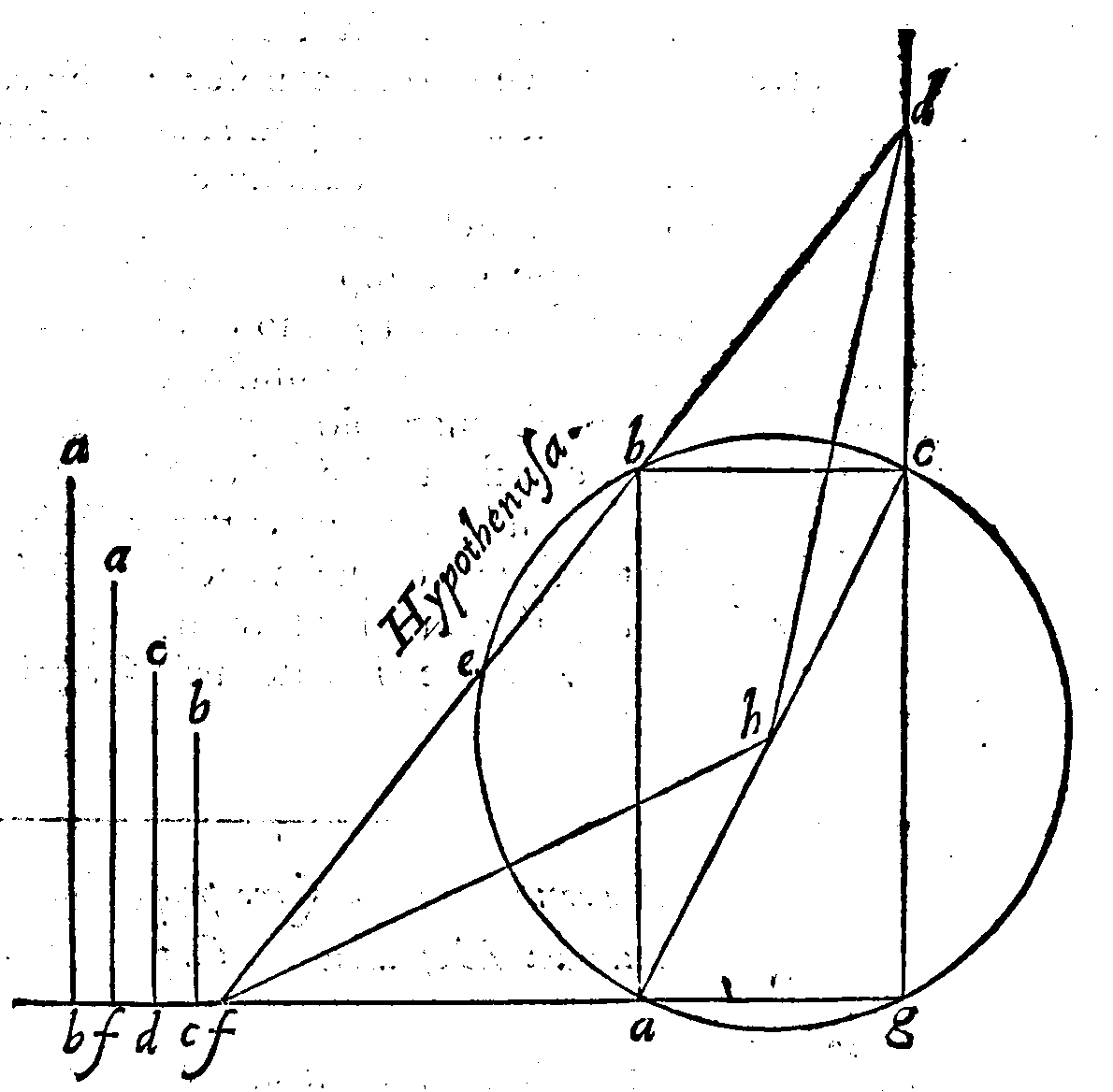
In qual maniera si possa Molteplicar, soggiungendo, qualunque proposto Interuallo; & d'alcuni auertimenti intorno al misurare, ò diuidere le Quantità. Cap. XXI.
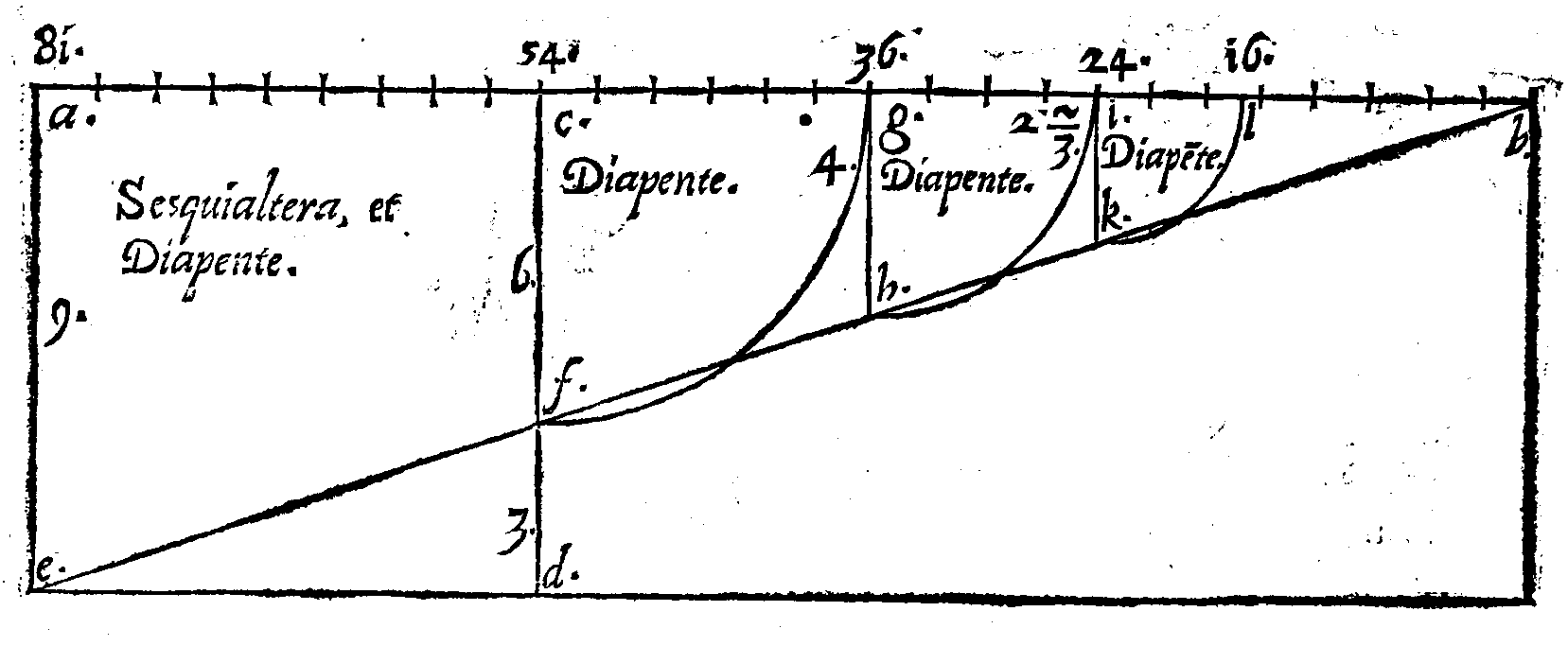
Altro modo di Molteplicare, detto Preporre, qualunque Interuallo si voglia proposto.Cap. XXII.
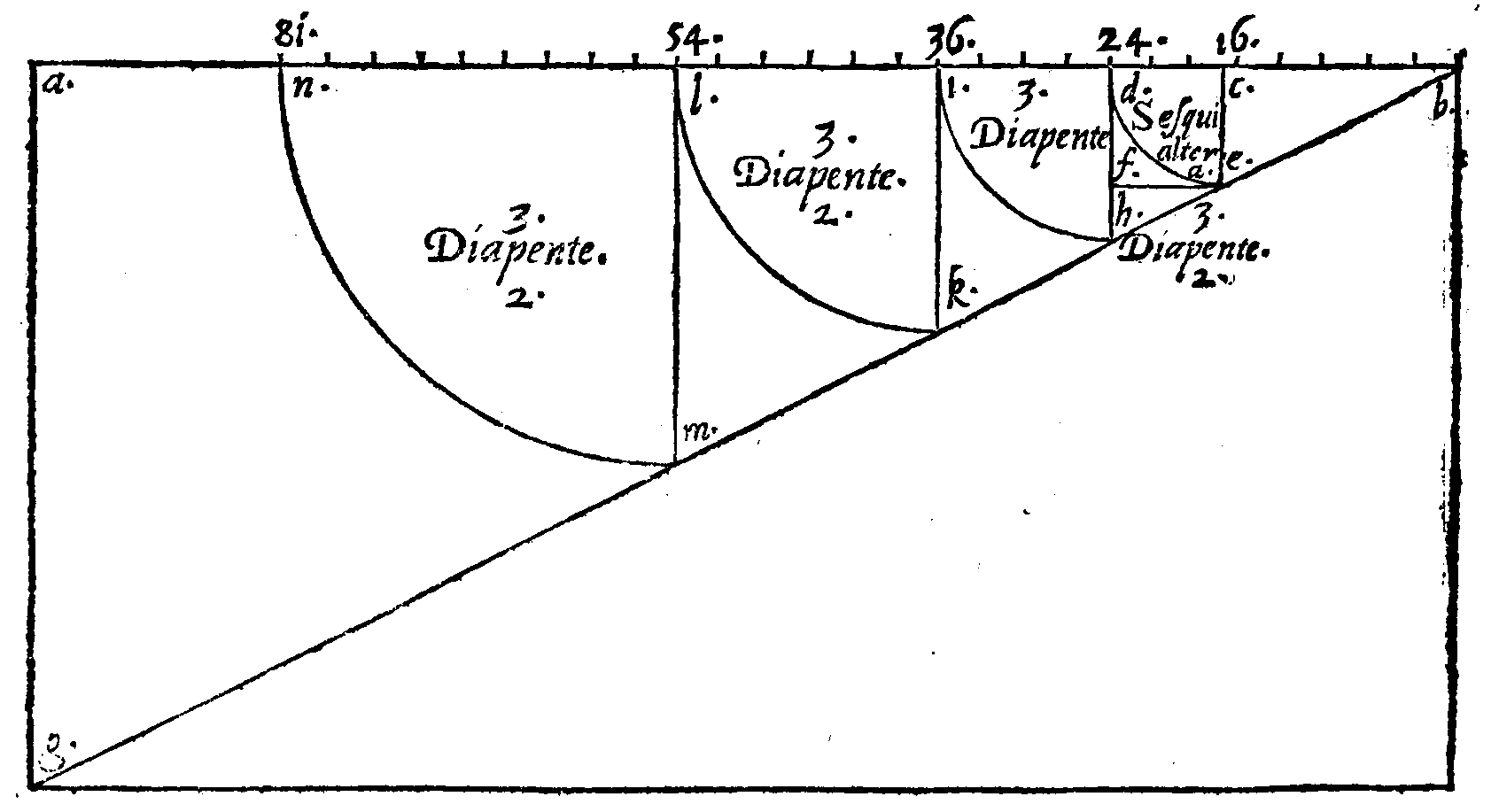
In qual maniera si possa Molteplicare ò Riportar uerso l'acuto un'Ordine d'Interualli accommodati alla loro proportione, tra i termini di qual si voglia Consonanza ò altro Interuallo. Cap. XXIII.
 . & c.
Volendola hora molteplicar, & riportarla breuemente, in tal maniera diuisa,
uerso l'acuto per l'Interuallo di essa Diapason; sopra la C. c. si descriuerà prima
il Quadrato C. c. H. I. tirando, secondo la Regola data nella Proposta 10. del
Terzo delle Dimostrationi, per maggior facilità, la linea CI. che cada perpendicolarmente dal punto C. & anco la cH. che cada dal punto c. che faccino
due angoli Retti, C. I. H. & c. C. I. dopoi nell'angolo C. si stabilirà un piede del
Compasso, colquale si descriuerà sette Quadranti; incominciando da i punti D.
in A; E. in K; F. in L; G. in M; a. in N;
. & c.
Volendola hora molteplicar, & riportarla breuemente, in tal maniera diuisa,
uerso l'acuto per l'Interuallo di essa Diapason; sopra la C. c. si descriuerà prima
il Quadrato C. c. H. I. tirando, secondo la Regola data nella Proposta 10. del
Terzo delle Dimostrationi, per maggior facilità, la linea CI. che cada perpendicolarmente dal punto C. & anco la cH. che cada dal punto c. che faccino
due angoli Retti, C. I. H. & c. C. I. dopoi nell'angolo C. si stabilirà un piede del
Compasso, colquale si descriuerà sette Quadranti; incominciando da i punti D.
in A; E. in K; F. in L; G. in M; a. in N;  . in O; & c. in I. che saranno CDA.
page 187
. in O; & c. in I. che saranno CDA.
page 187
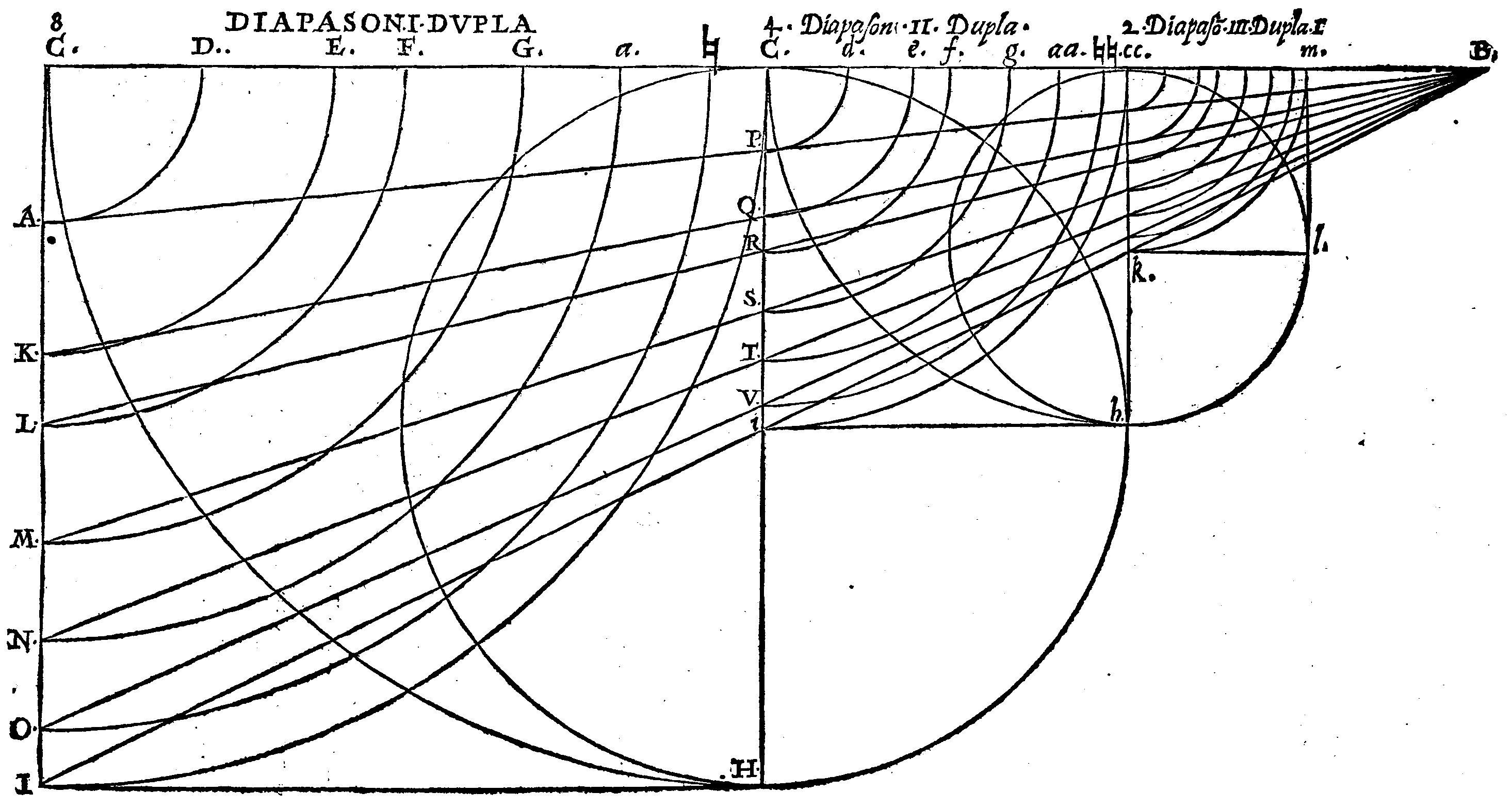
 O & CcI. Ilche fatto; dico; per la Seconda parte della 15. Def. del Primo de gli Elementi d'Euclide; che tanta sarà la Linea CA. quanta la CD. tanta la CK. quanta la CE & cosi l'altre seguenti, per
ordine; percioche cosi accompagnate partendosi dal Centro C, uanno à ritrouar
la circonferentia del suo Qudrante, ilquale è la Quarta parte del Circolo perfetto. Onde cotali linee tra loro sono equali, & le proportioni, che si trouano
tra le C. D. E. F. G a.
O & CcI. Ilche fatto; dico; per la Seconda parte della 15. Def. del Primo de gli Elementi d'Euclide; che tanta sarà la Linea CA. quanta la CD. tanta la CK. quanta la CE & cosi l'altre seguenti, per
ordine; percioche cosi accompagnate partendosi dal Centro C, uanno à ritrouar
la circonferentia del suo Qudrante, ilquale è la Quarta parte del Circolo perfetto. Onde cotali linee tra loro sono equali, & le proportioni, che si trouano
tra le C. D. E. F. G a.  . & c. si trouano consequentemente tra le C. A. K. L.
M. N. O & I. Hora da i punti A. K. L. M. N. O. & I. tirerò Sette linee rette
AB. KB. LB. MB. NB. OB. & IB. di modo che tutte insieme si congiunghino nel punto B. & haueremo sette Triangoli d'un'istessa specie c'hauranno
l'angolo C. Retto, & commune à ciascheduno di loro; & il lato CH. del Quadrato, per la seconda del Sesto de gli Elementi di Euclide; diuiderà proportionalmente i Triangoli in due parti, di modo che ne haueremo Sette altri
proportionali à i sette primi, che saranno contenuti nel Triangolo maggiore c. B. i. & esso lato sarà segato dalle sudette linee, ne i punti P. Q. R S. T.
V. & fatto in sette parti, che saranno cP. PQ QR. RS. ST. TV. & Vi. le
quali saranno corrispondenti per ordine l'una all'altra, & proportionali simi gliantemente alle CA. AK. KL. LM. MN. NO. & OI. in Dupla proportione. Et per prouar questo, descriuo prima sopra il centrro c. il Quadrante C. c. H. dopoi sopra 'l centro i. descriuo il Circolo c. h. H. secondo la
quantità del diametro c H. ch'è il lato del sudetto Quadrato. Non è dubio,
che essendo ci. Semidiametro di questo circolo, ch'è la metà di cH che cH.
sia il doppio di Ci. & che 'l diametro sia in Dupla proportione al Semidiametro ci. Ilperche diremo; si come la proportione del Semidiametro CI. del
Qudrante C. c. I. & quella del diametro ci. del circolo cih. sono in Dupla
proportione, cosi le proportioni delle parti fatte nel lato CI. del Quadrato C
c. H. I. corrispondenti à quelle del Semidiametro ci. del circolo c. h. i. sono in
Dupla proportione, come douea prouare. Ma per molteplicare & ridurre il
sudetto ordine ò Diapason C D. E. F. G. a.
. & c. si trouano consequentemente tra le C. A. K. L.
M. N. O & I. Hora da i punti A. K. L. M. N. O. & I. tirerò Sette linee rette
AB. KB. LB. MB. NB. OB. & IB. di modo che tutte insieme si congiunghino nel punto B. & haueremo sette Triangoli d'un'istessa specie c'hauranno
l'angolo C. Retto, & commune à ciascheduno di loro; & il lato CH. del Quadrato, per la seconda del Sesto de gli Elementi di Euclide; diuiderà proportionalmente i Triangoli in due parti, di modo che ne haueremo Sette altri
proportionali à i sette primi, che saranno contenuti nel Triangolo maggiore c. B. i. & esso lato sarà segato dalle sudette linee, ne i punti P. Q. R S. T.
V. & fatto in sette parti, che saranno cP. PQ QR. RS. ST. TV. & Vi. le
quali saranno corrispondenti per ordine l'una all'altra, & proportionali simi gliantemente alle CA. AK. KL. LM. MN. NO. & OI. in Dupla proportione. Et per prouar questo, descriuo prima sopra il centrro c. il Quadrante C. c. H. dopoi sopra 'l centro i. descriuo il Circolo c. h. H. secondo la
quantità del diametro c H. ch'è il lato del sudetto Quadrato. Non è dubio,
che essendo ci. Semidiametro di questo circolo, ch'è la metà di cH che cH.
sia il doppio di Ci. & che 'l diametro sia in Dupla proportione al Semidiametro ci. Ilperche diremo; si come la proportione del Semidiametro CI. del
Qudrante C. c. I. & quella del diametro ci. del circolo cih. sono in Dupla
proportione, cosi le proportioni delle parti fatte nel lato CI. del Quadrato C
c. H. I. corrispondenti à quelle del Semidiametro ci. del circolo c. h. i. sono in
Dupla proportione, come douea prouare. Ma per molteplicare & ridurre il
sudetto ordine ò Diapason C D. E. F. G. a.  . & c. uerso l'acuto; porrò il piede del
Compasso fermo nel punto c. & circonscriuerò sette altri Quadranti cdP. ceQ.
cfR. cgS. c aa T. c
. & c. uerso l'acuto; porrò il piede del
Compasso fermo nel punto c. & circonscriuerò sette altri Quadranti cdP. ceQ.
cfR. cgS. c aa T. c 
 . V. & c cc i. & cosi haueremo una Seconda Diapason
c. d e. f. g aa.
. V. & c cc i. & cosi haueremo una Seconda Diapason
c. d e. f. g aa. 
 . & cc. percioche, per le ragioni mostrate nella prima, tutto
quello che ella contenerà, corrisponderà à tutto quello, che contiene la Prima
in Dupla Proportione. Di modo che le chorde di questa Seconda Diapason risoneranno & faranno udire la Prima specie, diuisa ne i suoi Interualli, come la
prima posta nel graue, più acuta però, quanto importa lo spacio del suo interuallo; secondo 'l proposito. Et quando si uorrà anco passar più oltra, s'accommoderà sopra la linea c. cc. come facemmo il primo, il Quadrato c. cc. h. i.
delquale uerrà diuiso il lato cc. h. dalle sudette Sette linee, nella parte che serue per semidiametro, ch'è cc K. del circolo cc. l. K. in Sette parti; allequali facendone corrispondere nel cc m. col mezo de i Quadranti; Sette altre
parti in Quadrupla proportione alle Sette prime dal lato CI. & à quelle del
lato c.i. in Dupla, col porre il piede fermo del Compasso nel punto cc. haueremo, secondo 'l proposito, una Terza Diapason, piu acuta della precedente
per un simile Interuallo & per una Dupla proportione, & anco piu acuta della prima proposta per due Diapason; ò per una Disdiapason, come uogliamo dire, nella proportione Quadrupla; come si potrebbe dimostrare; ilche per esser
dalle cose dimostrate disopra, cosa chiara, lascio di dir molte cose; per non fastidire il Lettore; percioche oprando in questo modo, si potrà quasi andare in infi
page 189
nito. Et tenendo anco il modo, che si è tenuto nel Cap. precedente nel preporre
un'Interuallo ad un'altro, potremo etiandio preporre una Diapason diuisa nelle sue parti, posta nell'acuto, ad un'altra; senz'alcuno errore, & con poca fatica;
come ho detto; ilche si potrà fare in qual si uoglia Interuallo diuiso in molte
parti; siano poi Rationali ò Irrationali, come si uogliano.
. & cc. percioche, per le ragioni mostrate nella prima, tutto
quello che ella contenerà, corrisponderà à tutto quello, che contiene la Prima
in Dupla Proportione. Di modo che le chorde di questa Seconda Diapason risoneranno & faranno udire la Prima specie, diuisa ne i suoi Interualli, come la
prima posta nel graue, più acuta però, quanto importa lo spacio del suo interuallo; secondo 'l proposito. Et quando si uorrà anco passar più oltra, s'accommoderà sopra la linea c. cc. come facemmo il primo, il Quadrato c. cc. h. i.
delquale uerrà diuiso il lato cc. h. dalle sudette Sette linee, nella parte che serue per semidiametro, ch'è cc K. del circolo cc. l. K. in Sette parti; allequali facendone corrispondere nel cc m. col mezo de i Quadranti; Sette altre
parti in Quadrupla proportione alle Sette prime dal lato CI. & à quelle del
lato c.i. in Dupla, col porre il piede fermo del Compasso nel punto cc. haueremo, secondo 'l proposito, una Terza Diapason, piu acuta della precedente
per un simile Interuallo & per una Dupla proportione, & anco piu acuta della prima proposta per due Diapason; ò per una Disdiapason, come uogliamo dire, nella proportione Quadrupla; come si potrebbe dimostrare; ilche per esser
dalle cose dimostrate disopra, cosa chiara, lascio di dir molte cose; per non fastidire il Lettore; percioche oprando in questo modo, si potrà quasi andare in infi
page 189
nito. Et tenendo anco il modo, che si è tenuto nel Cap. precedente nel preporre
un'Interuallo ad un'altro, potremo etiandio preporre una Diapason diuisa nelle sue parti, posta nell'acuto, ad un'altra; senz'alcuno errore, & con poca fatica;
come ho detto; ilche si potrà fare in qual si uoglia Interuallo diuiso in molte
parti; siano poi Rationali ò Irrationali, come si uogliano.
Distributione ò Temperatura de gli Istrumenti da Tasti; posta dal mio Discepolo per noua Inuentione, & da lui ritrouata.Cap. XXIIII.
Per ben(ò che sfacciatezza di parole)chiarire i uostri noui dubij, è stato molto al proposito, hauer temperato lo Strumento secondo il Diatono; nella quale distributione uengano (come hauete udito) dissonanti quelli Interualli, ch'appresso de i Moderni prattici hanno nome di consonanze imperfette; non per la perfettione delle Quinte, come infiniti ardiscono dire
ma per la grandezza de i Tuoni, & picciolezza de i Semituoni. Volendo hora in tale Istrumento temperar di maniera le chorde del presente Diapason, che ciascun suo Ditono, Semiditono, insieme col maggiore & minore Hexachordo venghino consonanti, è di necessità ridurle, come elle erano prima. La qual Distributione s'accosta all'ordine & proportione del Syntono; non che ella sia l'istessa (come credono & scriuono alcuni) ne che gli autori di essa pensassero mai à tal cosa; ma uenne fatta loro à caso nel cercar d'accordare gli Interualli più uicini alla perfettione, che la natura dell'Istrumento; anzi la Quantità & Qualtità delle chorde, de rincontri, & del sapere di quelli Artefici comportaua: fuggendo sempre l'inequalità de Tuoni, insieme con ciascheduno inconueniente, ch'in questa moderna prattica da essi proceder potesse: per ilche fare noi al presente torremo principalmente; secondo 'l modo d'Aristosseno, per non potersi in altra maniera diuidere in parti equali alcuno interuallo Superparticolare; Quattro settime parti d'un Comma de nostri tempi; all'interuallo, ch'è tra la chorda F. fa ut, & G. sol re ut; con auicinar questa à quella per tal Quantità. Et accioche tra G. sol re ut, & A. la mi re rimanga, dopo l'hauer quella abbassata, quanto siè detto, la medesima distantia, che si troua tra F. fa ut, & G. sol re ut. allentaremo il detto A. la mi re per un intiero Comma, & di più una sua settima parte. Faremo dopoi la chordaQuesto dice il mio Discepolo, fuori d'ogni proposito; percioche non è buona ragione quella, che egli allega del maggior Semituono di questa Distributione, che ecceda di qualche cosa la Sesquiquintadecima; per esser tratto da un tutto maggiore del Sesquinono; onde si uede, che non intende quello che dice; percioche questo uiene fatto, dalla natura di cotale distributione: Et accioche ogn'un conosca apertamente quello, c'hà uoluto dire; porrò in atto & in prattica nel seguente essempio, quello ch'ei non hà uoluto fare per non scoprirsi maligno & ignorante; con questa sua mascherata Distributione; che sarà la sequente; Hora dopo quello c'hà detto auanti, seguita il suo dire, dopo fat. mi più page 190 graue dell'esser, nelquale si troua, un Comma con cinque settime parti; & cosi uerrà à contenere tra esso & A. la mi re, il medesimo spacio, ch'è tra i congiunti due Tuoni più graui. Il lasciare hora tra la chorda
. mi, & quella di c. sol fa ut, tutto l'auanzo, che si è tratto per rata da tre Tuoni, che concorrano alla compositione del Tritono, non conuiene in modo alcuno: perche non solo la Terza minore, che si troua tra a. la mi re, & c. sol fa ut; rispetto all'acquisto fatto; è, come uoi potete udire, dissonante. Ma ancora il Lemma, che prima era tra
. mi, & c. sol fa ut; nel uolerlo accrescere fin'al termine d'una Sesquiquindecima ò poco più; come hò detto; è fatto superfluo d'un mezo Comma. Ma perche la Quinta, che si troua tra F. fa ut, & c. sol fa ut, non resti diminuita di tanta Quantità; & che la sopradetta Terza minore uenga (con un poco più auicinarsi alla meno di lei, imperfetta) manco languida, & più grata all'udito; abbassaremo c. sol fa ut, due settime parti d'un Comma; & di tanto uerrà necessariamente diminuita ciascuna Quinta. Ilche fatto, sarà di mestiero, uolendo che tra esso c. sol fa ut, & d. la sol re, rimanga la medesima distanza, che si trouatra F. fa ut, & G. sol re ut, & gli altri Tuoni diminuiti; abbassarlo sei settime parti d'un Comma. Et accioche e. la mi, non ecceda quelli, lo abbassaremo un Comma intiero & tre settime sue parti di più: ilquale auanzo lasciaremo tutto all'interuallo, che rimane tra esso e. la mi, & f. fa ut; & cosi uerrà à essersi augumentato l'uno & l'altro minor Semituono & Lemma d'un Comma & di tre settime sue parti. Et quantunque il maggior Semituono di questa nuoua distributione, ecceda di qualche cosa la Sesquiquindecima; non è inconueniente, per esser tratto da un tutto maggiore del Sesquinono, per il qual'ordine poi si anderanno distribuendo tutte l'altre chorde, che essa Diapason hà sotto & sopra, & dentro i suoi termini.
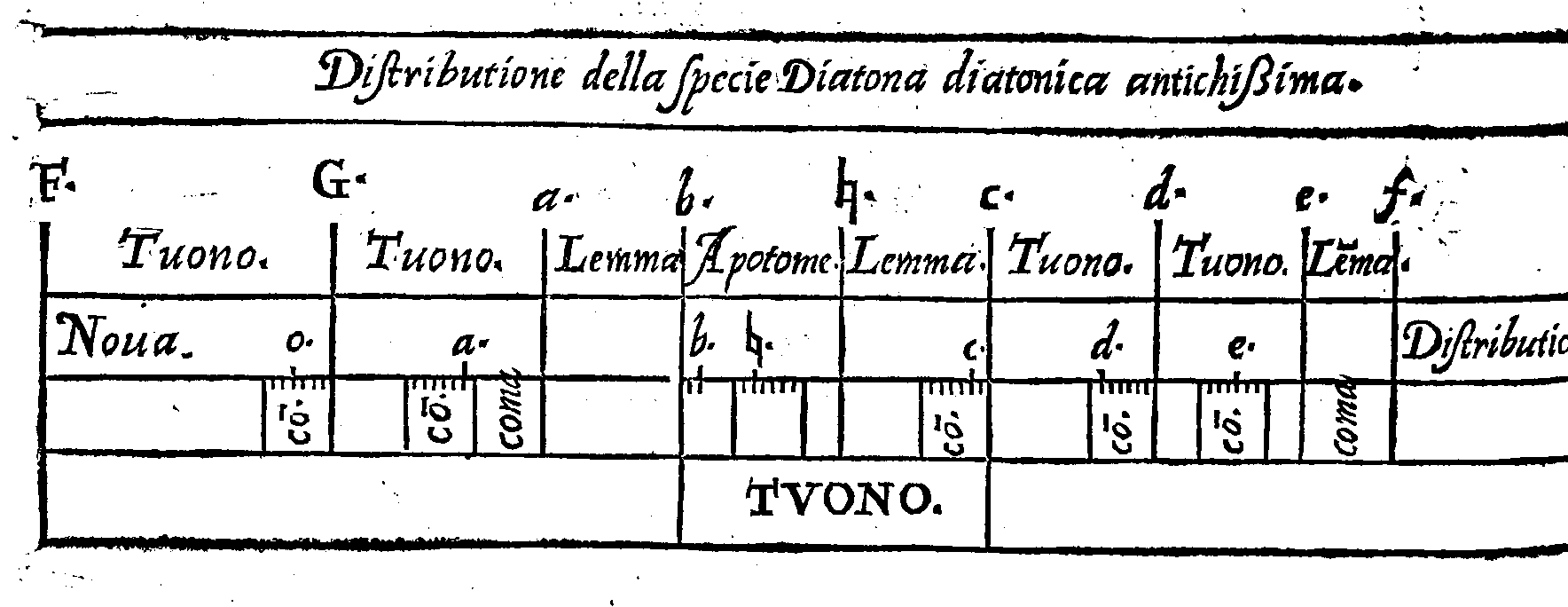
Potete hora da quello, che si è detto comprendere chiaramente, non solo che la Quinta uiene principalmente dal proportionato esser suo, rimessa, e tesa la Quarta;ma di che proportione?
Et inoltre, che page 191 quanto à chi uolesse per il contrario far la Diatessaron diminuita, & superflua la Diapente, è impossibile; ne può stare la cosa altramente, che in questa maniera: perche la principal cagione di ciò consiste nella quantità de Tuoni, che esse consonanze contengono; & in quella portione, di che essi Tuoni si diminuiscano, & se ne augumentano i Semituoni, che contengono tali Interualli, laquale hauete ancora possuto uedere quanto ella sia, tra quali chorde; perche, & come distribuita. Ma è da auertire in questo Temperamento, che le chorde, lequali prima conteneuano il Ditono, contengono hora la Terza maggiore, & la minore quelle, che conteneuano il Semiditono, & tra quelle chorde, che nel Diatono si troua il maggiore Hexachordo, ui si troua al presente la maggior Sesta, & la minore uiene à esser contenuta tra quelle, che rechiudeuano il Minore Hexachordo.Ma fin'hora questa sua non nuoua; com'egli dice; Inuentione, ma nuoua Mascherata non si è potuto conoscer dalle sue parole; ma si potrà ben conoscer da quello che segue, quello ch'ella sia, & insieme chi sia stato il suo Inuentore, il che è sommamente da notare; quando soggiunge.
Si troua adunque nel mostrato temperamento, essersi diminuito ciascun Tuono, di quattro Settime parti d'un Comma, intendendo però del Tuono maggiore & Sesquiottauo, il Ditono d'uno intiero, & di più d'una Settima sua parte; la Quinta, di due Settime parti, & Hexachordo maggiore di sei Settime parti: doue per il contrario uiene à essersi augumentato il minore Hexachordo d'un Comma intiero, & in oltre d'una Settima sua parte; la quarta, di due Settime parti; & il Semiditono di sei.Ma in tutto & per tutto gli la leua, quando dopoi poco, dice:
Ma lasciamogli da parte e torniamocene alla nostra Distributione delle chorde; laqual uolendo applicare al Diatonico Syntono, si sarà uenuto à torre à ciascun Tuono maggiore quattro Settime parti d'un Comma & di tre di esse si sarà augumentato l'Interuallo Sesquinono detto ancora Tuono minore. Per laqual cosa uerranno à essere fatti uguali: Si uiene ancora hauere diminuito ciascuna Sesquiquarta, forma della Terza maggiore, d'una Settima parte del Comma; & d'altratanto la Sesquiquinta, forma della Terza minore: poiche la Diapente resta scema di due Settime parti del detto Comma; talmente che la Sesquiquindecima, detta hoggi Semituono maggiore, uiene accresciuta di tre Settime parti del medesimo interuallo; & consequentemente la Sesquiuentiquattresima, detta Semituono minore, uiene à rimanere nella prima sua forma; l'opposito apunto di quello, che occorre alle Voci. Di maniera ch'essendo uero quanto hò detto; uerrà la Superbipartienteterza forma della Sesta maggiore, hauer preso augumento di quanto sia diminuita la minor Terza; & la Supertripartientequinta, forma della Sesta minore, uien parimente accresciuta di quanto si è diminuita la Terza maggiore: & la Quarta uiene à essersi augumentata delle due Settime parti del Comma, delle quali si diminuì la Quinta; & l'Ottaua lontana sempre da qual si uoglia estremo uitioso, rimane dentro la Dupla nella solita sua perfettione.In cotal modo adunque il mio Discepolo leua la maschera à questa sua Distributione, & la fà conoscere non sua, come chiaramente può conoscer lo Studioso lettore; dal Cap. 42. 43. & 44. del Secondo delle Istitutioni: Perche l'hauer preso la Diapason della Specie Diatona diatonica, per dimostrar ch'è cosa nuoua, non basta; essendoche questa è quella maschera ch'io dico; perche potea anche pigliar qual Specie ei hauesse uoluto; & ridurla nell'istesso temperamento; incominciando etiandio da qual si uoglia Chorda intesa come Rimanente, seguendo il temperar l'altre, come il Mosso; che sarebbe tornato bene: osseruando in questo fatto le Regole ch'io diedi ne i Capitoli sudetti; & miei Principij; Imperoche la cosa consiste principalmente nell'accordare & temperare tutte le Diapente & tutte le Diatessaron, nel modo c'ho fatto io & il Salines, & come egli lo confessa & ha posto in opera dopo me: se ben si lasciasse d'hauer'in consideratione gli altri page 192 Interualli; che ciò non fà caso. Et questa solamente è la uera cagione, che cotali Istrumenti uengano à cotal modo temperati; per far l'acquisto delle consonanze Imperfette; che sono il Ditono, & lo Semiditono: & è impossibile di poter fare altramente, acciò il tutto torni bene. Imperoche dopo l'hauer temperati questi, gli altri Interualli, tanto consonanti, quanto dissonanti, & li Tuoni & Semituoni, uengono per ogni modo & per forza nelle loro proportioni temperati, & ridotti fuori delle lor uere forme; come s'è ueduto nell'essempio. Et è cosa troppo manifesta à quelli che sanno; che si come da una sola cagione & propria non può nascere se non un solo & proprio effetto; cosi da tal maniera di diminuire & di accrescere gli oltre nominati Interualli; non può uenire se non un solo temperamento, ch'è l'istesso, che di sopra s'è dimostrato, con quello c'hò dimostrato nelle Istitutioni; se bene il mio caro Discepolo dice; che
Oltre il potersi molto bene ritronar ne gli Istrumenti di Tasti le Quinte & le Quarte nella uera proportione loro, senza impedir l'accordo delle Imperfette;ò che ignorantia;
ciascuno sensatamente lo può uedere & udire nel Temperamento di quello nuouamente da me ritrouato.Ma di questo non dirò altro per hora; percioche da quello c'hò detto di sopra, & da quello ch'io dimostrerò nel seguente Capitolo, si potrà conoscere, com'egli intenda la cosa; & si potrà comprendere quanti errori in dimostrar questa sua Dimostratione egli commetta, non s'accordando i fatti con le sue parole.
De gli Errori commessi nella sudetta Distributione. Cap. XXV.
Nell'Istrumento temperato secondo il Ditono, uengono dissonanti quelli Interualli, che chiamano i Prattici Consonanze imperfette; non per la perfettione delle Quinte, ma per la grandezza de i Tuoni, & picciolezza de i Semituoni:Et questo non è detto bene, ma perche la natura di cotal specie è tale, che non comporta, che cotali Interualli siano consonanti; se bene lo comporta, come sua cosa propria, la specie Naturale ò Syntona di Tolomeo; quantunque in molti luoghi nel Systema arteficiale di questa specie, come hò dimostrato altroue, non si troua tra la Prima & la Terza ò la Sesta chorda la consonanza. Il Quarto errore è, ch'ei promette di fuggir l'inequalità de i Tuoni, nondimeno (non s'accorgendo) ue la pone; nel modo c'habbiamo dimostrato più oltra. Il Quinto errore è, quando dice, che
Tal Distributione s'accosta all'ordine & proportione del Syntono, soggiungendo, che ella non è l'istessa, come credono & scriuono alcuni;percioche ueramente niuno crede, se in fatto non fusse fuori di se, che la Temperatura arteficiale d'un Istrumento da Tasti, sia quell'istessa del Syntono & Naturale; come si può uedere in quel ch'io dico sopra la Prima proposta del 4. Lib. delle Dimostrationi . Et ogni Huomo di sano giudicio sà molto bene, che l'accostarsi ò l'assimigliarsi questa cosa à quella, non fà, che siano una cosa istessa. Onde, si come non si può dire, che 'l Lupo sia Cane, ne la Simia sia Huomo; se ben s'accosta & quasi tiene l'uno l'effigie del Cane, & l'altra l'effigie dell'Huomo; percioche quello Indiuiduo è ueramente quello istesso, che ritiene in se quelle cose, che si ritrouano in altro, come; Forma, Figura, Parens, Locus, Tempus, Patria, Nomen; ilche dicono i Logici. Cosi non si può dire, che la Distributione fatta nell'Istrumento sudetto sia ò contenga il Syntono; come nel Cap. 45. della Seconda parte dell'Istitutioni hò dimostrato; ancora che in molte cose, come nell'Ordine & ne gli Interualli se gli assimigliano. Il Sesto errore fà, quando dice, ch'
Aristosseno diuidea la Qualità & non la Quantità del suono; & ciò faceua secondo 'l suo disegno.Questo è un parlare uano; percioche non sà dire, quello che fusse questo suo disegno; ma ueramente ciò non dice per altro, che per coprir la sua sciochezza, & mettere i Lettori in dubio; poiche uorrebbe pur dir quello, che non intende che dica Aristosseno. Ma legga il Lettore quello, c'hò scritto nel Cap. 13. di questo Libro, & conoscerà il tutto. Da questi errori c'hò raccontato, ne uiene il Settimo; quando specialmente in questa sua Distributione ei piglia le parti del Comma, come equali & proportionali, che ueramente non sono; per l'Impossibilita, che tiene di diuiderlo essattamente; percioche diuidendosi col compasso nella quantità continua ò Corpo sonoro; ouero nella Discreta con i Numeri, lo spacio del Comma in sette parti equali; come differentia che si troua tra 'l Tuono maggiore & lo minore, secondo 'l modo mostrato nel sudetto Cap. 13 nel Tetrachordo Syntono di Aristosseno; ouere secondo 'l modo tenuto da lui, nel porre i Tasti nel manico al suo Liuto, ò nella maniera che à mano à mano son per dimostrare; non hà da far cosa alcuna, col modo c'hà tenuto questo Filosofo nel comporre i suoi Tetrachordi; onde non è possibile, che possino essere proportionali; come si potrà anco uedere & conoscer nell'essempio del Capitolo seguente; ilquale scopre l'errore, & dimostra quanto ei sia buon m a- thematico. page 194
Come si possa errar nella distributione delle Parti fatte del Comma con i Numeri: & che i Tuoni nella Distributione mostrata non siano, ne possano esser'equali & proportionali. Cap. XXVI.
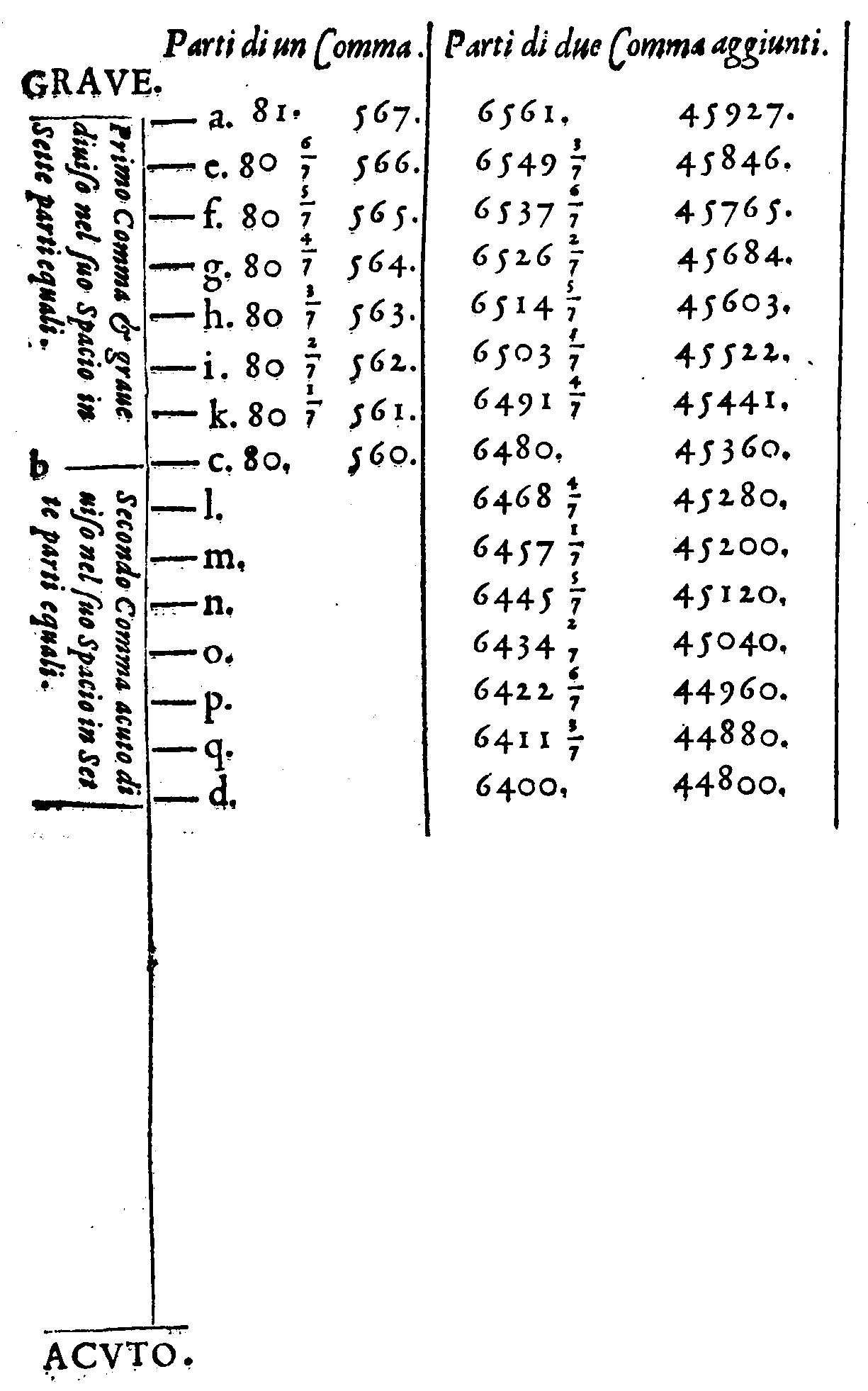
che 'l Lemma, ch'era prima traLasciamo stare il mal' uso di questo suo Poco più & Poco meno nelle cose dimostratiue, & diciamo, c'hauendo egli accresciuto questa sua Lima, oltra la Sesquiquintadecima di tre parti d'un Comma, ch'ei diuide in Sette parti equali, uuole che sia fatto superfluo anco della sua metà; onde se è uero, che tre sia la metà di sette ò il suo mezo dell'intiero, come dice; senza contradicione alcuna egli hà gran ragione, & ogni cosa torna bene à suo modo. Vltimamente, lasciando molt'altre cose da page 196 un canto, appresso gli altri errori si può metter questo; ch'io reputo il maggior de gli altri; quando ei attribuendomi, ch'io m'habbia seruito dell'altrui Inuentioni, se ne appropria una delle mie, clhe è la più bella, nella sudetta Distributione ò Temperamento, che si faccia; distribuendo il Comma tra Sette Interualli, contenuti nella Diapason. Et lo confessa manifestamente, sforzato dalla Verità, che è figliuola del Tempo, che non stà sempre ascosa, con quello che ei scriue nel suo Trattato, & è registrato nel Cap. 24. lasciando tutto 'l resto di quello ch'ei in questo proposito dice più di sopra, in questo modo;. mi. & c. sol fa ut; nel volere accrescere fin'al termine d'una Sesquiquintadecima ò poco più; è fatto superfluo d'un mezo Comma.
Ma lasciamogli da parte, & torniamocene alla nostra Distributione;col resto che seguita, fino alle parole:
In cotal modo adunque il mio Discepolo.Lequali, quanto siano conformi à quello ch'io insegno del modo del far cotal Partecipatione nel Cap. 42. & 44. della Seconda parte delle Istitutioni, ogni cieco & di poco giudicio, non che ogni Studioso, ch'attende alle buone lettere, lo potrà conoscere; percioche da questo nasce, ch'ei dice, i Tuoni di questa Partecipatione uenire equali di proportione; come anco si uedono nella mia; & che la proportione Sesquiuentesima quarta del Semituono minore resta nella sua uera forma; & che non può stare, che la Quinta & la Quarta in queste due Partecipationi uengano in due maniere; cosa che hò dimostrato anch'io. Che 'l Tuono maggiore si faccia corto di quattro settime parti d'un Comma, & non d'altra quantità, & altre simili, uengono necessariamente dal porre in opera le mie Regole. Dice anco, che l'opposito occorre alle Voci, circa la Distributione; ma di questo legga il Lettore il Cap. 45. del Secondo dell'Istitutioni, & si potrà chiarire. Aggiunge à questo, che
Le Quinte & le Quarte si trouano nelle loro uere forme ò proportioni, in questa sua Partecipatione, senza impedir l'accordo delle Imperfette:però quanto questo sia uero, da quello che si è detto, si può conoscere; eccettuando però, s'ei non uolesse intendere del Secondo modo di partecipare, ch'io dimostro nelle Dimostrationi, quantunque non uoglia, che ciò si possa fare. Quanto poi alla necessità, ch'ei dice di ridur le chorde del Diatono al primo temperamento ch'ei dimostra, com'erano prima, non era necessario pigliar più questa specie, che la Syntona; ne più questa Diapason, che quella: percioche questo è un uoler dar colore alla cosa; accioche pari esser fatta, secondo 'l douere. Ma se bene non si pigliasse alcuna Diapason, sia à qual si uoglia modo diuisa, bastarà solamente (osseruando le mie Regole) d'incominciare da una chorda ò positione stabile; ò da uno Rimanente, com'hò detto ancora; procedendo poi oltra col Mosso; percioche ogni cosa tornerà bene, Tutte queste cose dice il mio amoreuol Discepolo; ne però è da marauigliarsi, s'ei non l'habbia conosciute, hauendo in se qualche difficultà, poiche non seppe anche conoscere la differentia, ch'era tra questa mia prima Partecipatione fatta nelle Istitutioni, & la Seconda che io dimostrai nel Quinto delle Dimostrationi, nellaquale i Tuoni uengono medesimamente equali, & il Ditono con l'Hexachordo minore restano nelle lor uere Proportioni & forme, cosa che haurebbe ueduto un cieco; nondimeno dice, che
Cotal cosa reputarebbe degna di consideratione, quando cosi fusse, & che in fatto questa è la medesima che la mia prima.Non è adunque (per concludere) questa sua Distributione da lui non conosciuta differente dalla mia, ma è una cosa istessa. Laonde tutta la lode & tutto 'l biasimo, che ei dà à quella che non è sua, tutto ritorna in lode ò in biasimo della mia. Et per far fine hormai à questa cosa, uerremo alla Dimostratione dell'altro Temperamento, c'habbiamo proposto, dimostrando prima il modo che egli hà tenuto nel Distribuire nel manico del Liuto tra i Tasti la Diapason, diuisa (come dice) in Semituoni equali, & proportionali; la page 197 qual ueduta & essaminata, uerrò à dimostrare il modo, che haurà da tenere in cotal cosa, acciò ogni cosa torni bene & senza ueruno errore.
D'Vna nuoua Distributione fatta in dodeci Semituoni ò parti equali, accommodata ne i Tasti posti sopra il manico del Liuto. Cap. XXVII.
Che l'Ottaua nel Liuto & nella Viola,per usar le sue parole proprie,
che per gli istessi gradi procedono; lontana sempre da qual si uoglia imperfettione, consti di sei Tuoni, ò Dodici Semituoni; ouero(perche dice uolersi, più che puote, conformare all'uso de Prattici)
di cinque Tuoni, & di due Semituoni; & che ciascun Tuono loro sia minore del Sesquiottauo; & maggiore del Sesquinono. Dopoi, che 'l Semituono uien minore della Sesquiquindecima, & maggiore della Sesquiuentesimaquarta. Che la Terza minore è superata dalla Sesquiquinta; & la maggiore eccede la Sesquiquarta. Che la Diatessaron supera la Sesquiterza; & la Diapente è minore della Sesquialtera. Che la Sesta minore è superata dalla Supertripartientequinta, & la maggiore supera la Superbipartienteterza. Che 'l Tritono & la Semidiapente sono equali; & che questa è minore, & quello maggiore de i contenuti nel Syntono.Et queste sue Suppositioni uà prouando da Mathematico buon compagno, senza pensarui, in questo modo.
Il Tuono, secondo 'l Tutto diuiso in Diciotto parti equali, delle quali ne contiene due: cade tra esse & le Sedeci; ch'è l'istesso à dire, ch'è tra 9. & 8. La minor Terza contiene tre Semituoni; i quali sono dell'istessa valore, che di Tredecimeottaue parti del Tutto; & le Quindeci che restano, comparate alle Diciotto, hanno l'istessa relatione insieme, che hà il 6. al 5. forma uera secondo 'l Syntono della Terza minore.Et più oltra dice:
Due decime ottaue parti non sono altramente, in questa maniera di misuare, equiualenti alla Nona parte del tutto; imperoche esse parti sono considerate come portioni del Suono; & non come quantità della chorda.Et tutto questo dice, per non intender quello c'hò detto & dichiarato ne i due Cap. 11. & 13. di questo. Proua nondimeno quello c'hà detto in questo modo:
Misurando col Compasso si troua, che i due primi Semituoni del Liuto non occupano la Nona parte della lunghezza della chorda, come tre non sono l'intiera sua sesta parte; ma si bene qualche cosa meno.Quanto alla prima parte di questo che dice, senza dubio alcun'è tutto uero; anzi uiene à confirmar quello, c'hò detto altroue in questo Libro, & dimostrato nella 5. & nel suo Corollario del Terzo delle Dimostrationi; ma quanto alla seconda; dico, che considerato il Tutto come Corpo sonoro diuiso in molte parti, nel modo ch'io dichiarai nel 41. Cap. della Prima parte dell'Istitutioni, & nel Cap. 15. di sopra; tali parti uengono à sottoporsi primieramente & per se stesse alla Quantità, & secondariamente & per accidente, hauendo rispetto à i Suoni, che da esse usciscono, alla Qualità. Dopo questo uiene anco à dimostrar le ragioni di queste sue Suppositioni, in questo modo:
Ciascun Tuono del Liuto è minore del Sesquiottauo vna sesta parte del Comma antico; & ciò prouo in questa maniera: Chiara cosa è, che Sei Tuoni Sesquiottaui superano la Diapason d'vno di essi Comma: Se adunque Sei di quelli del Liuto la riempino intieramente, senza auanzarli, o mancarli cosa alcuna; vengono consequentemente ad esser ciascun di essi minore d'vna Sesta parte di esso Comma, di uno di quelli. Dico in oltre che 'l Sesquiottauo uiene superato da ciascun Tuono del Liuto di tre quarti della Sesquiottantesima, ch'è secondo i Moderni prattici, il Comma de nostri tempi: Imperoche ciascuna Ottaua è capace di cinque Sesquinoni tre Comma, & due maggiori Semituoni del Syntono; iquali due maggiori Semituoni ci danno un Sesquinono & un Comma & mezo di più, in circa.Et questo In circa, che dice, è da notare con diligentia da quelli, che fanno professione di buoni Mathematici; perche è termine incognito, che non è usato d'alcuno nelle page 199 Dimostrationi, se non da questo mathematico Moderno: però segue anco, dicendo:
Di maniera che noi possiamo ancora considerare in ciascuna Ottaua (come di essi capace) Sei tuoni Sesquinoni & quattro Comma & mezo(col suo)
incirca; iquali quattro Comma distribuiti per rata à detti Sei tuoni, ne uerrà à ciascuno due terzi: & di quel mezo(ch'è anco peggio di quello c'hà detto prima, per il suo raddoppiato incirca)
la Sesta parte. Hora, perche i due Terzi con la Sesta parte d'un mezo vengono à far congiunti insieme tre quarti dell'intiero di tal quantità; uiene necessariamente ciascun Tuono del Liuto à superare il Sesquinono.Et questo non è uero, rispetto di quel
Mezo di più incirca.Più oltra dice; che
Ciascuna delle Terze minori di questo, comparate alle Sesquiquinte, uengono diminuite di tre ottaui di Comma,& lo proua cosi bene:
L'Ottaua del Liuto consta appunto di quattro Terze minori, doue sottraendo da una Duplaquattro Sesquiquinte, gli auanza la Super. 23. partiente. 625.laqual proportione, dice che consta d'un Comma e mezo (col suo aggiunto)
Incirca; ilquale Interuallo distribuito alle quattro Terze minori,dice,
che ne toccarà à ciascuna di esse per rata, tre ottaui d'un Comma;intendendosi però quel mezo In circa;
& di tal quantitàdice,
che uiene diminuita ciascuna Terza minore del Liuto comparata alla Sesquiquinta.Et soggiunge, che
la maggior Sesta uiene accresciuta di tal quantità.O mathematico eccellente; come si potrà mai conoscer tali quantità di quanto siano, con questo tuo Incirca, ilquale alle fiate raddoppiato tallora rende intiera una di queste sue quantità, & tallora la supera, & tallora non ui aggiunge? Passa dopo questo à prouarla quantità delle Terze maggiori, & fà il suo conto questo buon Abachista in questo modo:
Egli è cosa certa che tre Terze maggiori del Liuto riempiano intieramente lo spacio d'una Ottaua; onde sottraendo tre Sesquiquarte da una Dupla, auanza la supertripartiente. 125.Et segue anco facendo conto:
Consta la sudetta proportione d'un Comma e mezo incirca, ilqual Comma e mezo(intendendo uisi però il suo Incirca)
distribuito per rata alle dette Terze maggiori, ne toccherà à ciascheduna un mezo; & di tal quantità,dice,
che uerrà successiuamente superflua qual sia di esse, & qual si uoglia Sesta minore di tal quantità diminuita.Ma chi sarà quel tanto buon Computista, che possa mai far ben conto con queste sue quantità incerte & indeterminate? Dimostra con seguentemente questo mio Discepolo le Quinte del Liuto esser diminute, cauando dodeci Sesquialtere da sette Duple, & restando la proportione Super. 2847. partiente. 521441. laquale è minore d'uno de i nostri Comma; onde conclude da questa sua dimostratiotione, che
le Quinte nel Liuto vengono scarse di manco d'una Duodecima parte d'un Comma, & di tanto necessariamente uengono superflue le Quarte;& s'affatica à dimostrarlo, cauando dodeci Sesquiterze da cinque Duple; Ilperche auanza una proportione di minor quantità, ch'è la Subsuper. 2847. partiente. 521441. che significa esser piu dodeci Sesquiterze, che le sudette cinque Duple. Et è uero; ilperche si dimostra in questo almeno d'esser stato mio buon Discepolo, quantunque non faccia cosi nell'altre cose; & meglio anco s'haurebbe dimostrato, s'el si hauesse astenuto da quel suo Incirca, ilquale nelle Dimostrationi non è riceuuto. Queste sono le cose ch'egli soppone, & proua nel uoler dare ad intender quello, che si è detto di sopra, per cauar gli Eccessi & Diffetti de gli Interualli del suo Liuto, comparati à quelli, che sono contenuti nella specie Naturale ò Syntona di Tolomeo; accomodando le cose à suo modo, per non sapere (com'ei dimostra in molti luoghi) adoperare alcun'Istrumento atto à Diuidere l'Ottaua in tante parti, come intendea di fare; ne accommodarsi delle Proportioni con numeri ò misure: ilche è stato cagione di fargli dire mille sciocchezze. Hora da queste sue soppositioni pigliate per Principij delle sue Dimostrationi, nascono page 200 molti inconuenienti & false conclusioni; Ilche è il Secondo errore, forse maggior di qual si uoglia altro; sopponendo tutte le Quantità, ch'ei adopera, non terminate, ma incerte & non uere; intorno allequali è da notare; che Quantità terminata dico esser quella, sia poi Rationale ò Irrationale, come si uoglia; che nasce dalla Diuisione d'un'Interuallo rationale, fatto in molte parti determinate, la proportione della quale; se ben con numeri certi rationali & terminati non si può denominare; è però di maniera conosciuta dalla Ragione; quantunque dal Senso alcune fiate non è compresa, che la può distintamente conoscere, & determinare, hauendo rispetto & relatione delle parti al loro Tutto; come quando si facesse (dirò cosi) piu parti proportionali d'uno Interuallo; se bene tali parti non si potessero descriuere con numeri rationali nelle lor proportioni; come in trauiene nella Diuisione del Comma fatto in parti equali & proportionali; potrà la Ragione almeno, pigliandone una, ouer due di esse, con uerità dire, che sia la Settima parte, ò Due settime & altre parti ancora del suo Tutto diuiso. Ma la Quantità incerta & indeterminata non sarà tale; percioche nascerà da un'Interuallo diuiso in più parti, ò composto di più parti equali, di quelle allequali sopr'auanzarà ò mancherà alcuna particella, quantunque minima, per compimento & riempimento del Tutto; Di modo che non diuideranno ò compiranno à pieno & perfettamente quel Tutto, che sarà proposto; & cosi non si potrà sapere alcuna parte di esso Tutto, qual parte ueramente ella sia; rispetto alle parti che lo compongono intieramente, come per essempio: Se dopo l'hauer dimostrato nella 21. del Secondo delle Dimostrationi, che 'l Tuono Sesquiottauo è maggior di noue Comma & minore di dieci, alcun uorrà dire, che l'una di quelle parti ò di quei Comma fusse la Nona ò la Decima parte del Tutto, ouer del Tuono, non dirà bene, quantunque ei potesse dire, che cotal Tuono contenesse Intorno ò Incirca (per usare i termini di questo mio Mathematico moderno) noue ò dieci Comma; essendoche cotali parti ò Comma non sarebbono determinati in numero certo, ch'arriuassero di punto al loro Tutto; ma sarebbono incerte & indeterminate; quantunque ei potesse dire, che l'una di quelle parti ouer Comma fusse la Nona ò Decima incirca di tal Tutto ò Tuono; poiche se 'l si uorrà raddoppiare con quel poco più ò poco meno; ouer con quel Intorno ò Incirca, una delle parti, & non si saprà la quantità per laquale ella sia maggiore ò minore, senza dubio anco non si potrà sapere la quantità determinata, che nascerà da tale raddoppiamento; percioche ouer non arriuerà all'Intiero & sarà (per la 15. Dignità del Primo delle Dimostrationi) meno della metà, ò che lo sopr'auanzerà & (per la Quartadecima) sarà più; secondo quel Più ò Meno, & quello Intorno ò Incirca, che contenerà. Si potrà nondimeno, sapendo la differentia delle noue ò dieci parti, ò Comma del più ò del meno, che sono minori ò maggiori del Tuono, dire; che 'l Comma fusse una nona, ò decima parte di questo auanzo, meno ò più de i detti Comma ò parti; secondo 'l numero di esse; come sarebbe dire, che l'uno de i sudetti noue Comma hauesse maggior proportione d'una Sesquiottantesima, di quello che è la nona parte della proportione, che sopr'auanza la Sesquiottaua ouer il Tuono, ouer l'un de i sudetti dieci Comma hauer minore la proportione di una Sesquiottantesima, quanto importa la Decima parte di quella proportione, per laquale i Dieci Comma superano la proportione del Tuono ouer la Sesquiottaua. Et perche nelle Dimostrationi si ricercano le Premesse ò Principii, che habbiano molte conditioni, come hò dichiarato nel principio del Primo delle Dimostrationi, ne ritrouandosi in alcun di questi suoi Principij alcuna Quantità certa & determinata, ne quelle conditioni, che entrano page 201 in cotali Premesse; però dico, che non si trouerà Mathematico, che usi mai nelle sue dimostrationi Principij di questa maniera, percioche da essi non ne può nascere se non cose incerte & indeterminate, & confuse conclusioni; essendoche le Mathematiche non si sogliono dimostrar con il Senso solamente & à uoluntà, ne come si dice) misurarle con la pertica, come egli fà; che non solamente si serue delle sudette Quantità nelle sue prime diuisioni; ma anco delle Indeterminate, che nascono dalle diuisioni Indeterminate, che è assai peggio. Ma questo sia detto à sufficientia intorno al Secondo errore; ch'ei commette intorno i Principij, nel uoler dimostrar la Distributione de i Tasti del suo Liuto, nel dar contezza della Quantità di quei interualli, che si trouano in esso; percioche tenendo poco conto de i piccioli, uerrò à dimostrare hormai il Terzo, ch'è massimo, dalquale potremo conoscere quanto egli sia buon Geometra.
D'Vna Diuisione fatta della Diapason in Dodeci parti equali & proportionali non essattamente, nella Distributione de i Tasti sopra 'l manico del Liuto. Cap. XXVIII.
Vengo hora à mostrarui il modo, che douete tenere, nel fabricar quello (cioè il Monochordo) ch'Aristosseno chiama diatonico Incitato, & appresso quello del Chromatico Toniaco, co i quali conuien grandemente la Distributione de Tasti del Liuto; ad imitatione de quali sono stati impensatamente distribuiti, & cosi parimente quelli della Viola d'arco, ambedue Moderni Strumenti; ne i quali è diuiso il Tuono in due parti equali; nella cui fabrica è grandemente necessario il Secondo numero Quadrato, ò quello che è à esso Duplo; che è il Diciotto: ma ci seruiremo di questo, per operar con più chiarezza & facilità la sua uirtù, nella ricercata Distributione.O che uanità; ei non s'accorge prima, che 'l modo che ei uuol dimostrare, tanto s'assimiglia all'Incitato diatonico & al Toniaco Chromatico d'Aristosseno, come la Simia al Gallo; ilche potrà ogn'un conoscere, quando haurà ueduto il modo che tiene, & essaminato quello c'hò detto auanti nel Cap. 11. Del Quarto libro in materia delle Diuisioni di questo Filosofo. Dopoi non s'auede, che 'l nominare il Secondo numero Quadrato, ch'è il 9. estremo termine & graue della proportione del Tuono Sesquiottauo, più che un'altro numero, & introdurlo qui, senza dirne il perche, fuori d'ogni proposito; ma solamente uoler dimostrare, ch'egli habbia buona cognitione de i Numeri, è una sua pazzia & uanità espressa; Imperò che hà da far qui più questo numero, di quello c'habbia il 18. suo doppio? se egli non uolesse per caso, non si auedendo; mosso da buona con scientia; render l'honore c'hà leuato senza ragione alcuna à Tolomeo; scoprendosi poco saputo nelle cose Mathematiche; perche pigliando cotal numero 18. per sua guida in questo proposito, ei uiene à confermare la dimostratione, con la quale esso Tolomeo contradice alla Diuisione del Tuono fatta da gli Aristossenici; essendoche misurando in questo modo gli Interualli de i Semituoni, & accommodandoli in co page 202 tal maniera sopra 'l manico del Liuto, uengono tutti ad esser contenuti sotto un' istessa proportione, che è la Sesquidecimasettima, & la minor parte, che nasce
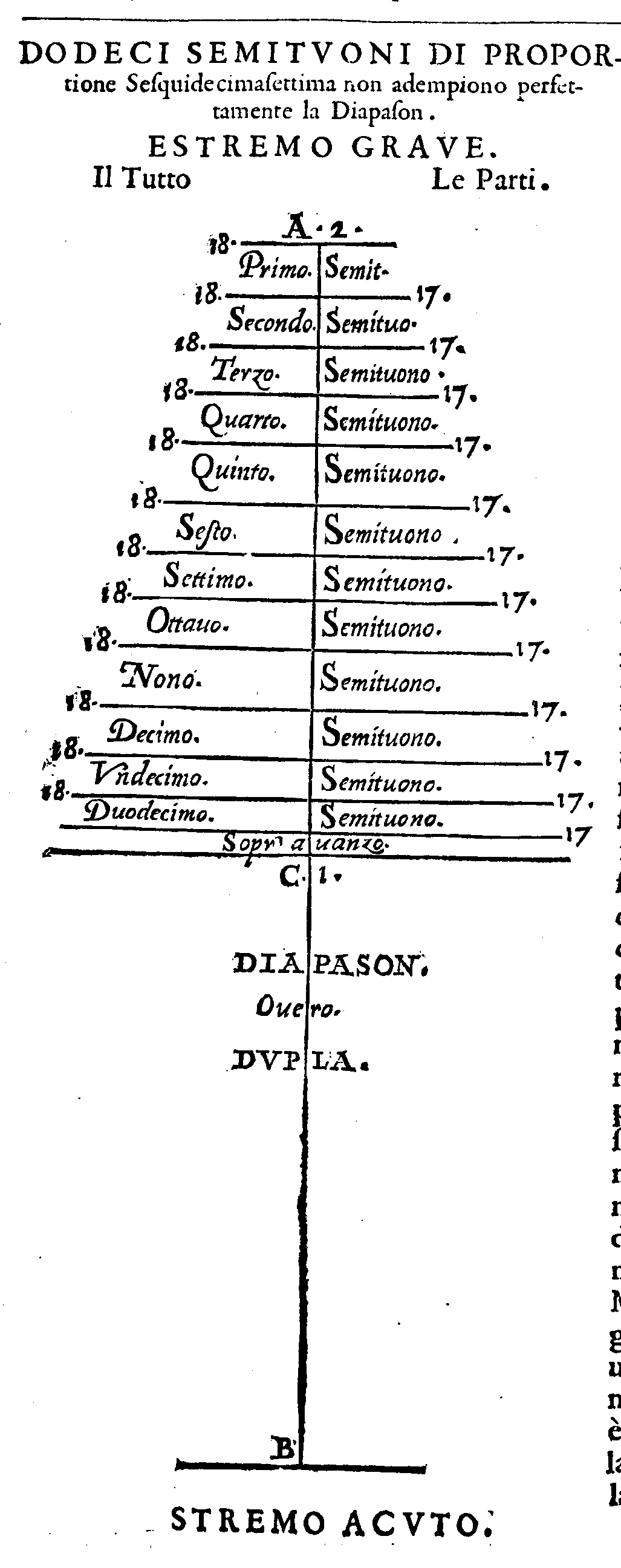
Diuido adunque(dice egli)
tutta la linea AB.(come soppone)
in Diciotto parti; & uerso l'acuto, dal graue partendomi, doue quella prima parte termina, pongo il primo tasto. Parto di nuouo tutto l'auanzo dell'istesso numero de parti; & dalla medesima banda, sotto 'l primo, pongo il secondo tasto: & cosi fatto ordine uò distribuendo sempre lo spacio, che sotto à Tasti mi auanza; sin'al Duodecimo; ilquale mi conduce appunto doue termina la metà di tutta la chorda: la prima & più graue Ottaua, della quale trouo hauer diuiso in Dodici equali Semituoni, & sei Tuoni, cosi detti d'Aristosseno.Et non è uero, secondo il modo, ch'egli insegna; che 'l Duodecimo Tasto lo conduca appunto doue termina la metà di tutta la chorda; & lo dimostra più oltra, come uederemo. Ma prima fà un bellissimo discorso, & da buon Mathematico; accioche alcun non prenda marauiglia, ch'ei habbia più tosto pigliato il numero 18. ch'un' altro in questo fatto onde dice.
Et che per ciò fare, non conuenga altro numero che 'l Diciotto, da questo si manifesta: Al Diciasette prima non conuiene in modo alcuno; perche ci darebbe minor numero de Tasti, ch'al bisogno nostro corre; & minor quantità ne haueremo dal Sedeci & dal Quindeci: Al Dicianoue altresi non conuiene; perche ne haueremo per l'opposito maggior quantità; & ui è più dal Venti & Vent'uno: di maniera che 'l Diciotto è il suo più proprio diuisore d'altro maggiore ò minor numero.O bella ragione; quasi che questo fusse necessario à concludere, che questo Numero diuidesse l'Ottaua in Dodici parti equali, come ueramente non fà, ilche habbiamo potuto uedere nell'essempio disopra, nelquale dopo cauatone Dodici Sesquidecimesettime, auanza quell'Interuallo, ch'è collocato tra l'estremo acuto del Duodecimo Semituono, & l'estremo acuto medesimamente della Diapason, collocato nel punto C. Ma perche ei uedea troppo ben questo suo errore; ò che gran scioccheria; & la falsa conclusione che nasceua in fatto da questa sua fallace dimostratione; però si pensò con una bella argutia & coperta di potersi saluare & iscusare; ilche uolendo fare, d'un'errore ch'ei commette, ne nascono due dalle sue parole che sono le sequenti:
Quantunque à esso;cioè al 18.
ancora auenga l'istesso, che occorre al Compasso, nel uoler misurare in Sei volte appunto la circonferenza del Circolo con l'apertura di esso; ch'è, come sapete, dal centro alla sua circonferenza; per lo che uiene detto Sesto:Et questo è il primo errore; alquale aggiunge immediatamente il secondo; del quale di sopra ne habbiamo ragionato à bastanza, ch'è più graue del primo, quando dice:
Laonde auertisco l'Industrioso agente, che con la sua discretione & diligenza cerchi ouuiare à quella poca disconuenienza, che è tra il Misurante & il Misurato;cosa che non hà saputo mai Archimede, ne qualunque altro Geometra, per eccellentissimo che si fusse, dire; ò che innauertenza, degna di biasimo; ò che gran pazzia. page 204
Che l'essempio del Compasso per iscusar la falsità dis questa sua Distributione, non è al proposito, & non hà luogo nella Mathematica. Cap. XXIX.
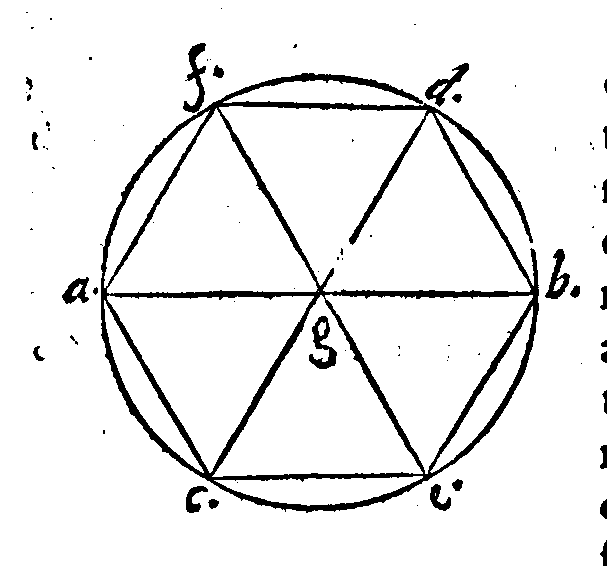 za se non Sei fiate & per il diritto. Ilperche hauendo egli letto nel Cap. 14. della Prima parte dell'Istitutioni quello ch'io scriuo; cioè, che 'l detto Istrumento si chiama anco Sesto; percioche nella figura
circolare, come in essa si comprende, sono contenuti Sei triangoli equilateri, i cui lati sono equali
al Semidiametro del loro circolo; onde per dinotarci la sua perfettione, Sei uolte di punto è misurata la sua circonserenza PER IL DIRITTO,
da quella misura che misura dal centro alla circonferentia istessa; non intendendo quello che importar uolesse il Misurar per il diritto; uuole che ciò non sia uero, & me lo attribuisce ad errore; non auertendo, ch'io non hò detto, che cotale apertura sia la
Sesta parte del Circolo; ma si bene ch'ella misura il Circolo per il diritto Sei
page 205
uolte: Ilche troppo bene gli haurebbe saputo dire il suo Bottaio, se cotal cosa gli
hauesse dimandato; percioche (come si uede) diuiso il Circolo a. e. d. in Sei parti
equali, ne i punti a. c. e. b. d. & f. l'apertura del Compasso ag. la quale è il Semidiametro del Circolo, descriue esso Circolo
& misura Sei fiate per il diritto, & non per
l'obliquo la sua circonferentia di punto; essendoche nel modo ch'ei misura tutti i lati di Sei triangoli ag. cg. eg. bg. dg. & fg. che sono tutti
Semidiametri del circolo, cosi misura anco le lor basi ac. ce, eb. bd. df. & fa. che posano sopra tutta la
za se non Sei fiate & per il diritto. Ilperche hauendo egli letto nel Cap. 14. della Prima parte dell'Istitutioni quello ch'io scriuo; cioè, che 'l detto Istrumento si chiama anco Sesto; percioche nella figura
circolare, come in essa si comprende, sono contenuti Sei triangoli equilateri, i cui lati sono equali
al Semidiametro del loro circolo; onde per dinotarci la sua perfettione, Sei uolte di punto è misurata la sua circonserenza PER IL DIRITTO,
da quella misura che misura dal centro alla circonferentia istessa; non intendendo quello che importar uolesse il Misurar per il diritto; uuole che ciò non sia uero, & me lo attribuisce ad errore; non auertendo, ch'io non hò detto, che cotale apertura sia la
Sesta parte del Circolo; ma si bene ch'ella misura il Circolo per il diritto Sei
page 205
uolte: Ilche troppo bene gli haurebbe saputo dire il suo Bottaio, se cotal cosa gli
hauesse dimandato; percioche (come si uede) diuiso il Circolo a. e. d. in Sei parti
equali, ne i punti a. c. e. b. d. & f. l'apertura del Compasso ag. la quale è il Semidiametro del Circolo, descriue esso Circolo
& misura Sei fiate per il diritto, & non per
l'obliquo la sua circonferentia di punto; essendoche nel modo ch'ei misura tutti i lati di Sei triangoli ag. cg. eg. bg. dg. & fg. che sono tutti
Semidiametri del circolo, cosi misura anco le lor basi ac. ce, eb. bd. df. & fa. che posano sopra tutta la
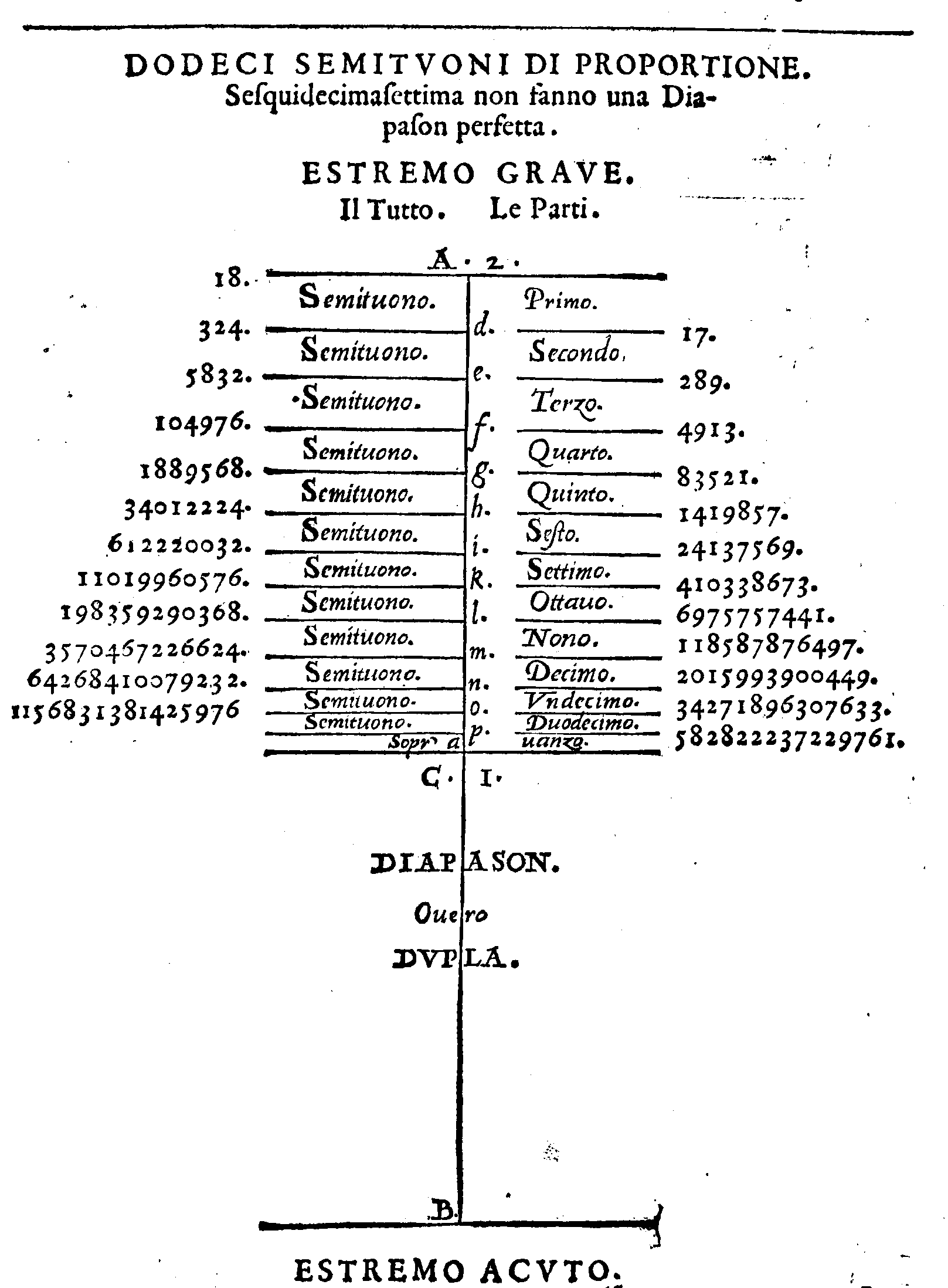
Aggiunti insieme Dodici semituoni nel Liuto, di proportione Sesquidecimasettima; non arriuano alla Diapason, & Tredici la superano.Et perche la forma di questo suo Semituono è la proportione Sesquidecimasettima, & quella della Diapason è la Dupla; però (secondo l'ordine mostrato nella 21. del Secondo delle Dimostrationi) si procederà in questo modo. Sia a. & b. la Diapason consonantia ouer'Ottaua, che la vogliamo dire; & sia a. & c. il Semituono del Liuto di questo mio buon Sonatore, le cui proportioni siano collocate ne i loro termini radicali, ne i luoghi proprij. Sommo primieramente insieme, secondo la dottrina del Cap. 33. del Primo delle Istitutioni, ò secondo la Prima del Primo delle Dimostrationi, Dodeci Semituoni ò Dodeci Sesquidecimesettime proportioni: & ne uiene d. & e. che contengono Dodeci Semituoni, iquali sono di minor quantità, che non è la Diapason df. percioche è maggior la quantità e. della quantità f. Onde (per la 36. del Primo delle Dimostrationi) è maggior la proportione, che si troua tra df. che quella di de. Ilperche essendo de. composto de Dodeci Semituoni del Liuto del mio page 207 Discepolo, & essendo df. Diapason, necessariamente segue; com'anco disopra s'è dimostrato. Ma se di nuouo moltiplicheremo a. in d. & in e. & c. in f.
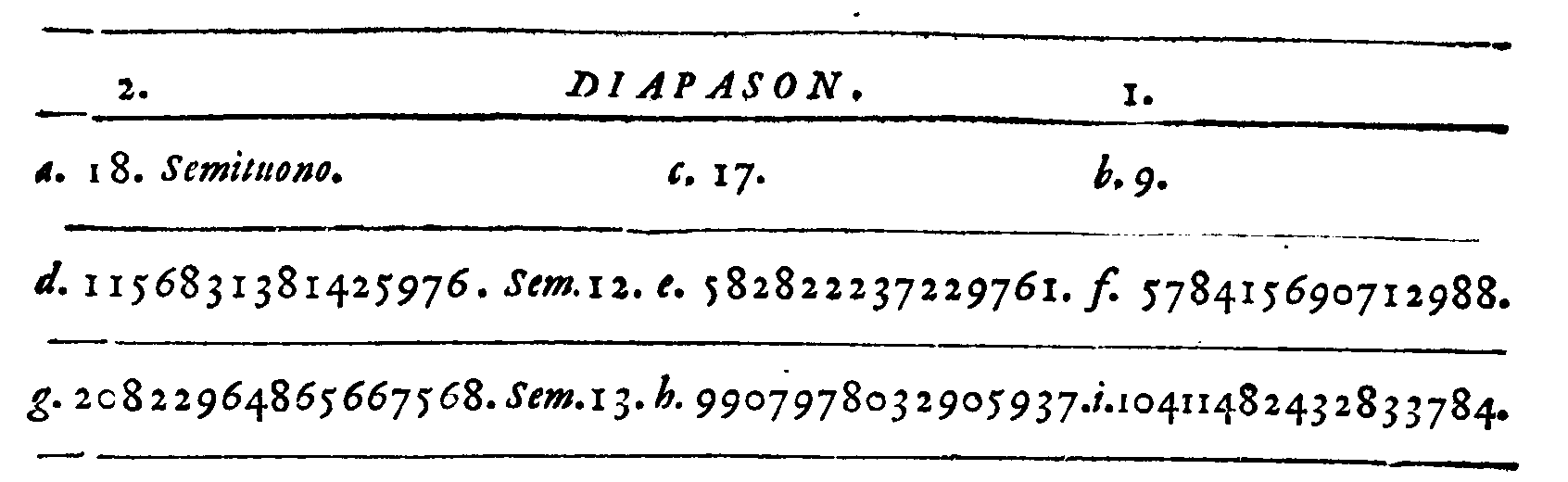
Auertisco l'industrioso agente, che con la sua discretione & diligenza cerchi ouuiare à quella poca disconuenienza ch'è tra 'l Misurante & il Misurato;come hò citato disopra. O beato & felice te Archimede, se ne tuoi tempi hauesti hauuto uno che ti hauesse dato un tal consiglio, & ricordo; & guidato per simile uia; perche con un mezo tale hauresti potuto facilmente & con maggior tua gloria forse, ritrouar la già pianta per morta, come parla sempre Hiperbolicamente il mio Discepolo, Quadratura del Circolo, non ancora d'alcuno ritrouata. Stiamo però di buon animo & che s'attristiamo, ch'io spero un giorno, & forse sarà presto, ch'alcuno Geometra, che non sarà molto scropoloso, come non è anco costui; ma haurà un poco (come si dice) del grosso & del tondo; aiutato da questo buon ricordo, la potrà ritrouare; massimamente quando uorrà porre mente à quelle considerationi, che questo nouo Speculatiuo uà discorrendo; & particolarmente sopra i Vani delle canne de gli Istrumenti musicali, secondo le proportioni delle loro lunghezze & larghezze; lequali considerationi, com'ei dice, potrebbe esser mezo efficace d'aprir la strada à cotale difficile inuentione. page 208
Come si possa dirittamente diuidere la Diapason in Dodici parti ò Semituoni equali & proportionali. Cap. XXX.
 . c.
. c.  . D. b. E. F.
. D. b. E. F.  . G. &
. G. &  . del Diametro Aa. & arriueranno al detto
lato HK. & saranno bI.
. del Diametro Aa. & arriueranno al detto
lato HK. & saranno bI.  M. CN.
M. CN.  O. DP. bQ. ER. FS.
O. DP. bQ. ER. FS.  T. GV. &
T. GV. &  X.
Dopoi hauendo accommodato cotali Linee tra lo Spacio Aa. della Diapason;
tirando da i sudetti punti del Diametro nominato Linee equidistanti, che siano
perpendicolari, & arriuino fin al lato del Liuto ò Quadrato AH. ne i punti medesimamente b.
X.
Dopoi hauendo accommodato cotali Linee tra lo Spacio Aa. della Diapason;
tirando da i sudetti punti del Diametro nominato Linee equidistanti, che siano
perpendicolari, & arriuino fin al lato del Liuto ò Quadrato AH. ne i punti medesimamente b.  . C.
. C.  . D. b. E. F.
. D. b. E. F.  . G. &
. G. &  . per ordine, nel lato già detto;
come si uedono nell'essempio del lato AH. haueremo il nostro proposito: percioche doue saranno i Punti delle congiuntioni delle linee, iui saranno da porre &
segnare i luoghi de i Tasti nel manico del Liuto, che sarà designato nel primo
Parallelogrammo di quelli, che faranno dibisogno in cotal negocio; iquali saranno (per l'istessa Vndecima) l'un dall'altro proportionalmente distanti; & cosi la proposta chorda AH. haurà Dodici Tasti, incominciando dal primo, che
sarà segnato b. & conseguentemente gli altri per ordine, con queste lettere ò caratteri b.
. per ordine, nel lato già detto;
come si uedono nell'essempio del lato AH. haueremo il nostro proposito: percioche doue saranno i Punti delle congiuntioni delle linee, iui saranno da porre &
segnare i luoghi de i Tasti nel manico del Liuto, che sarà designato nel primo
Parallelogrammo di quelli, che faranno dibisogno in cotal negocio; iquali saranno (per l'istessa Vndecima) l'un dall'altro proportionalmente distanti; & cosi la proposta chorda AH. haurà Dodici Tasti, incominciando dal primo, che
sarà segnato b. & conseguentemente gli altri per ordine, con queste lettere ò caratteri b.  . C.
. C.  . D. b. E. F.
. D. b. E. F.  . G.
. G.  & a. sopra la parte Aa. del detto lato AH.
Ma secondo l'uso commune del Liuto, se ne considereranno accommodati sopra
il luogo della Base, Otto solamente; che saranno b.
& a. sopra la parte Aa. del detto lato AH.
Ma secondo l'uso commune del Liuto, se ne considereranno accommodati sopra
il luogo della Base, Otto solamente; che saranno b.  . C.
. C.  . D. b. E. & F. & Otto
simigliantemente sopra quello del Bordone, che è la Seconda chorda più graue
page 209
. D. b. E. & F. & Otto
simigliantemente sopra quello del Bordone, che è la Seconda chorda più graue
page 209
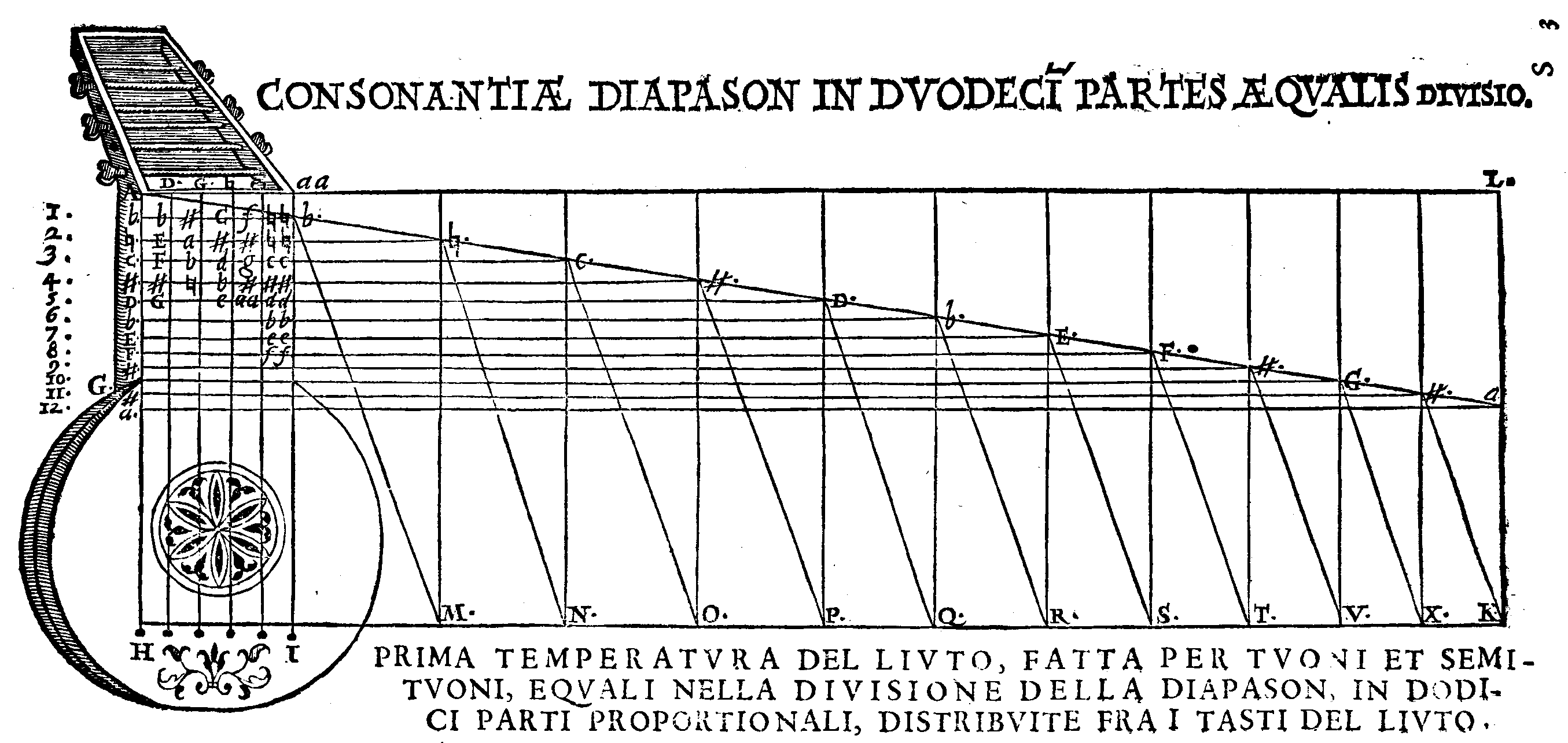
 . G.
. G.  . a. & b.
Cosi il Tenore, ch'è la Terza chorda, che segue il Bordone uerso l'acuto, sarà
notato da.
. a. & b.
Cosi il Tenore, ch'è la Terza chorda, che segue il Bordone uerso l'acuto, sarà
notato da.  . a. b.
. a. b.  . c.
. c.  . d. & b. Per il numero della seguente detta Mezana; ne
sarà anche otto; cioe,
. d. & b. Per il numero della seguente detta Mezana; ne
sarà anche otto; cioe,  . C.
. C.  . d. b. e. f. &
. d. b. e. f. &  . Il simile anco accaderà alla Sottana, che segue la Mezana; essendo che contenerà f.
. Il simile anco accaderà alla Sottana, che segue la Mezana; essendo che contenerà f.  . g.
. g.  . aa. bb.
. aa. bb. 
 . & cc. Il
Canto poi finalmente posto nel più acuto luogo, haurà segnati i suoi Otto con
queste cifere bb.
. & cc. Il
Canto poi finalmente posto nel più acuto luogo, haurà segnati i suoi Otto con
queste cifere bb. 
 . & cc.
. & cc. 
 . dd. bb. ee. & ff. Fatto questo, disteso che si haurà le chorde sopra 'l Liuto, di quella Qualità che ricerca l'Istrumento, s'accorderanno tra loro in questo modo. Prima s'accorderà il Bordone, perfettamenta Vnisono con la chorda DH. che sopr'auanza dal Quinto tasto nella chorda
della Base; dopoi s'accorderà in cotal modo il Tenore, con la chorda GH. che
auanza dal Quinto tasto del Bordone; ma la Mezana s'accorderà nell'istesso
modo unisona con quella, che sopra auanza dal Quarto tasto del Tenore, che
sarà
. dd. bb. ee. & ff. Fatto questo, disteso che si haurà le chorde sopra 'l Liuto, di quella Qualità che ricerca l'Istrumento, s'accorderanno tra loro in questo modo. Prima s'accorderà il Bordone, perfettamenta Vnisono con la chorda DH. che sopr'auanza dal Quinto tasto nella chorda
della Base; dopoi s'accorderà in cotal modo il Tenore, con la chorda GH. che
auanza dal Quinto tasto del Bordone; ma la Mezana s'accorderà nell'istesso
modo unisona con quella, che sopra auanza dal Quarto tasto del Tenore, che
sarà  . H. La Sottana s'accorderà unisona con quella chorda, che sopr'auanza del Quinto tasto della Mezana, che sarà eH. Et finalmente s'accorderà il
Canto unisono con quella parte, che sopr'auanza nella Sottana da Quinto
tasto, che sono aa. H. Et cosi s'haurà accommodato il tutto, & accordato &
temperato il Liuto nelle sue chorde, secondo la Distributione, che si ricerca,
per Tuoni & Semituoni equali & tra loro proportionali. Et la chorda della Base risonerà perfettamente la Disdiapason ò Quintadecima con quella del Canto, & con la Sottana la Diapason diapente ò Duodecima, temperata secondo
la natura di questa Distributione. Si udirà etiandio tra la Base & il Bordone,
tra questo & il Tenore, tra la Mezana & la Sottana, & tra questa & il Canto, la
Diatessaron ò Quarta temperata, secondo la natura di cotale temperamento. Si
trouerà di nuouo tra 'l Tenore & la Mezana il Ditono di quella istessa Quantità,
ch'è quello, che si ode tra 'l terzo tasto della Base, & il secondo del Bordone; &
tra 'l Tenore uuoto & il Quarto tasto di esso; di modo che si trouerà anco le Diapente, le Diatessaron, i Ditoni, i Semiditoni, i Tuoni & i Semituoni, insieme con
ogn'altra Consonanza & Interuallo, tra loro, nella loro Specie, equali & proportionali; & non l'una dell'altra maggiore ò minore ò inequale. Et questo sarà il Primo modo della Diuisione della Diapason in parti simili, equali & proportionali della Distributione de i Tasti nel
Liuto, fatta con l'aiuto del Mesolabio.
. H. La Sottana s'accorderà unisona con quella chorda, che sopr'auanza del Quinto tasto della Mezana, che sarà eH. Et finalmente s'accorderà il
Canto unisono con quella parte, che sopr'auanza nella Sottana da Quinto
tasto, che sono aa. H. Et cosi s'haurà accommodato il tutto, & accordato &
temperato il Liuto nelle sue chorde, secondo la Distributione, che si ricerca,
per Tuoni & Semituoni equali & tra loro proportionali. Et la chorda della Base risonerà perfettamente la Disdiapason ò Quintadecima con quella del Canto, & con la Sottana la Diapason diapente ò Duodecima, temperata secondo
la natura di questa Distributione. Si udirà etiandio tra la Base & il Bordone,
tra questo & il Tenore, tra la Mezana & la Sottana, & tra questa & il Canto, la
Diatessaron ò Quarta temperata, secondo la natura di cotale temperamento. Si
trouerà di nuouo tra 'l Tenore & la Mezana il Ditono di quella istessa Quantità,
ch'è quello, che si ode tra 'l terzo tasto della Base, & il secondo del Bordone; &
tra 'l Tenore uuoto & il Quarto tasto di esso; di modo che si trouerà anco le Diapente, le Diatessaron, i Ditoni, i Semiditoni, i Tuoni & i Semituoni, insieme con
ogn'altra Consonanza & Interuallo, tra loro, nella loro Specie, equali & proportionali; & non l'una dell'altra maggiore ò minore ò inequale. Et questo sarà il Primo modo della Diuisione della Diapason in parti simili, equali & proportionali della Distributione de i Tasti nel
Liuto, fatta con l'aiuto del Mesolabio.
In qual maniera si possa diuidere nel Secondo modo la Diapason in Dodoci parti equali & proportionali. Cap. XXXI.
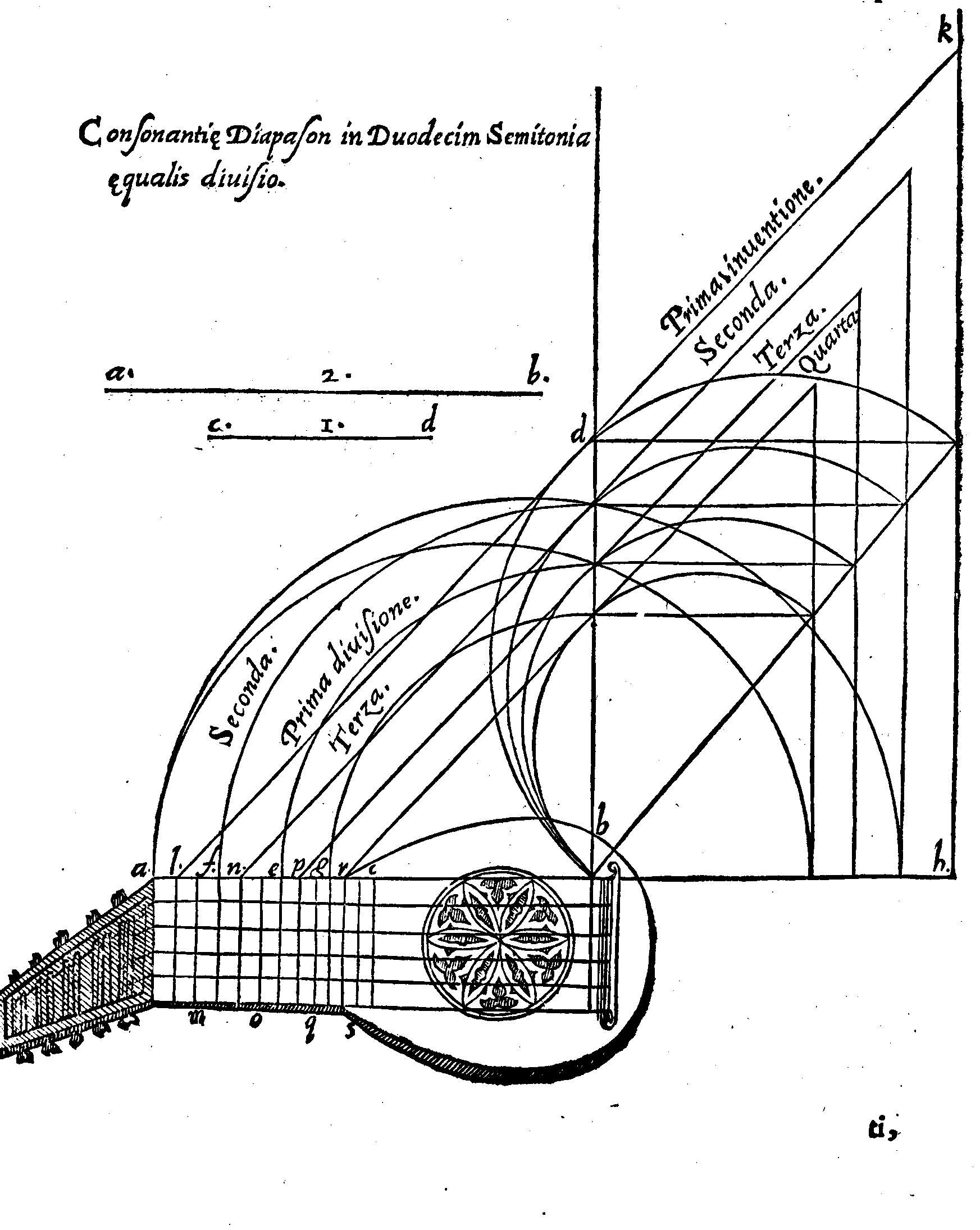
Come si possa anco nel Terzo modo dirittamente diuidere la Diapason in Dodici parti ò Semituoni equali & proportionali. Cap. XXXII.
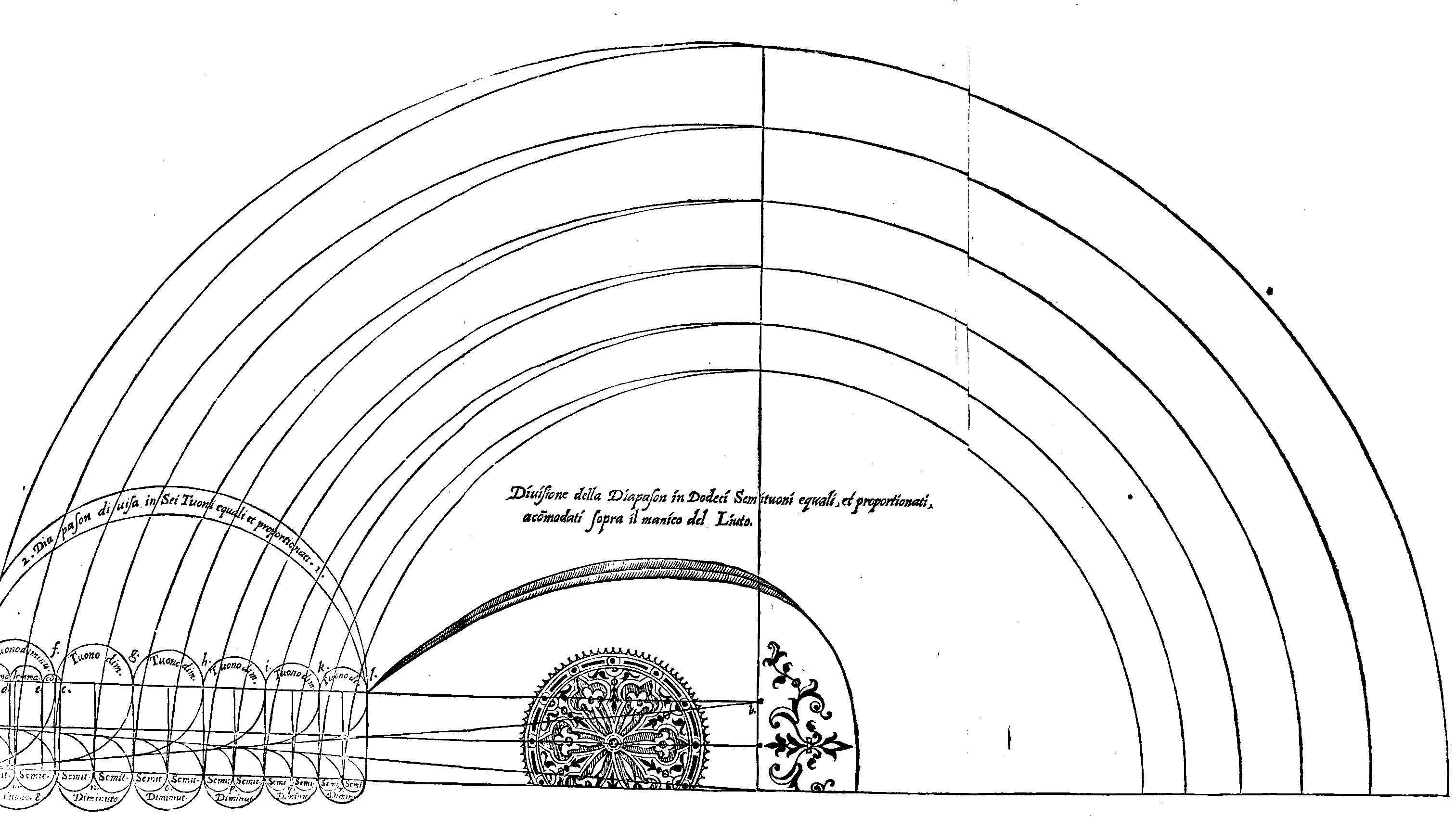
Della Diuisione generale de gli Instrumenti arteficiali in molte Specie, & della loro natura. Cap. XXXIII.
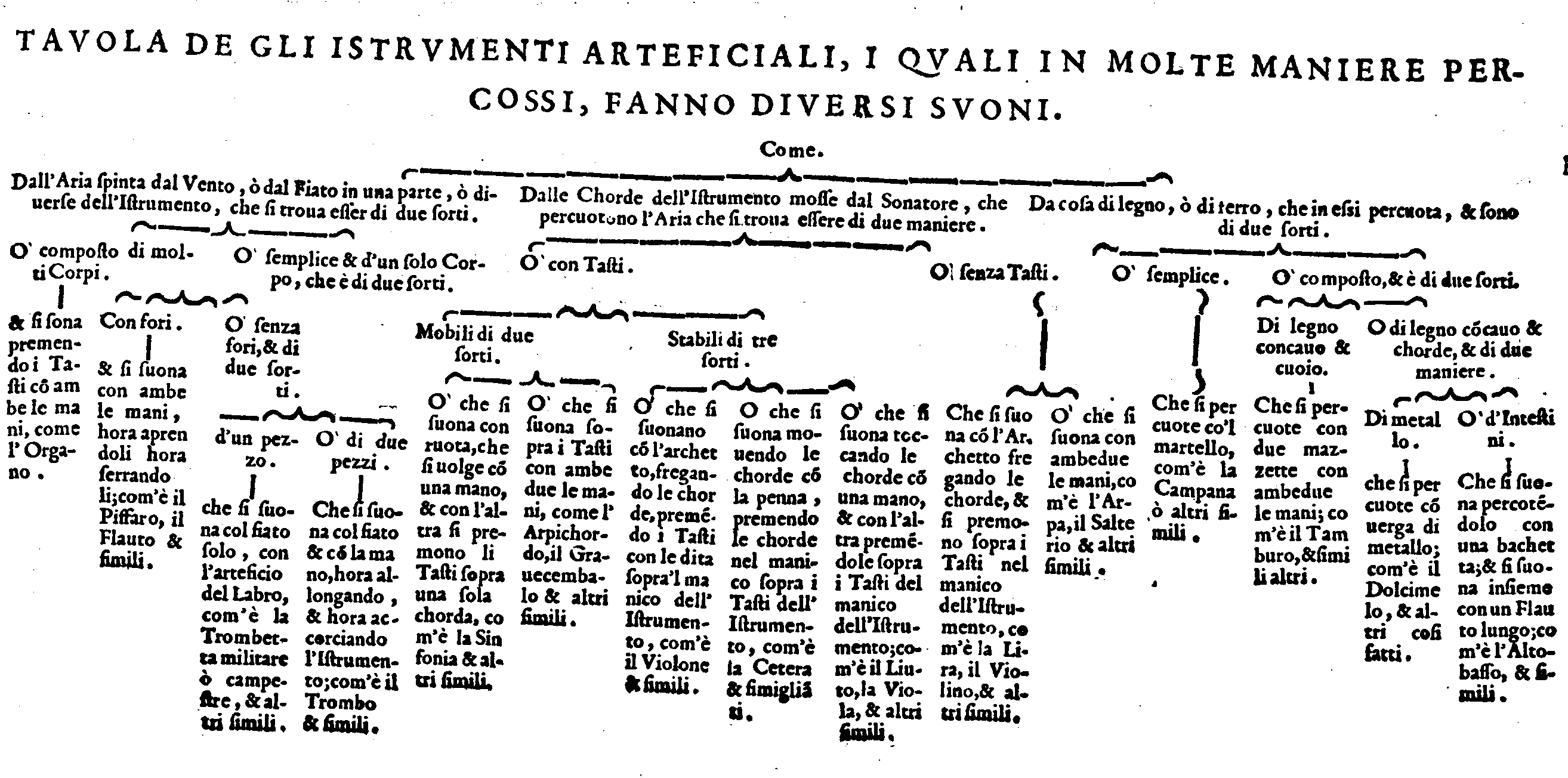
In qual sorte d'Istrumento si possa porre in atto la Specie Naturale ò Syntona diatonica. Cap. XXXIIII.
Che nelle nostre Cantilene usiamo la Specie Naturale ò Syntona di Tolomeo; & che tra le loro Parti si cantano i suoi Interualli nelle lor uere & naturali forme. Cap. XXXV.
Che 'l si canti & suoni la Specie naturale ò Syntona di Tolomeo, si conferma etiandio con l'essempio di due Parti, che cantino insieme. Cap. XXXVI.
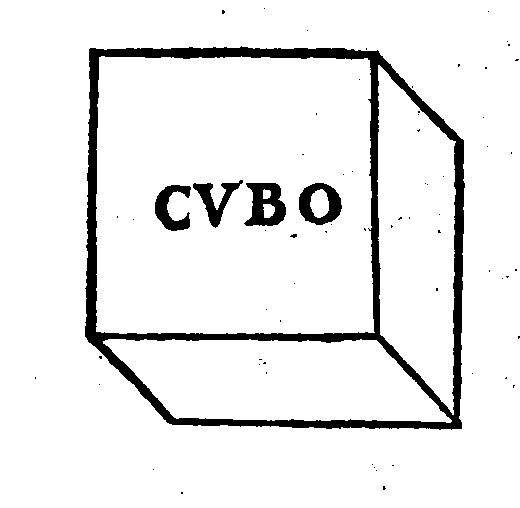
In qual modo si possa & si debba essatamente udire senza alcuno errore, ogni Ordine d'Interualli, distribuiti sotto quelle Ragioni ò proportioni, che si hauranno da ordinare. Cap. XXXVII.
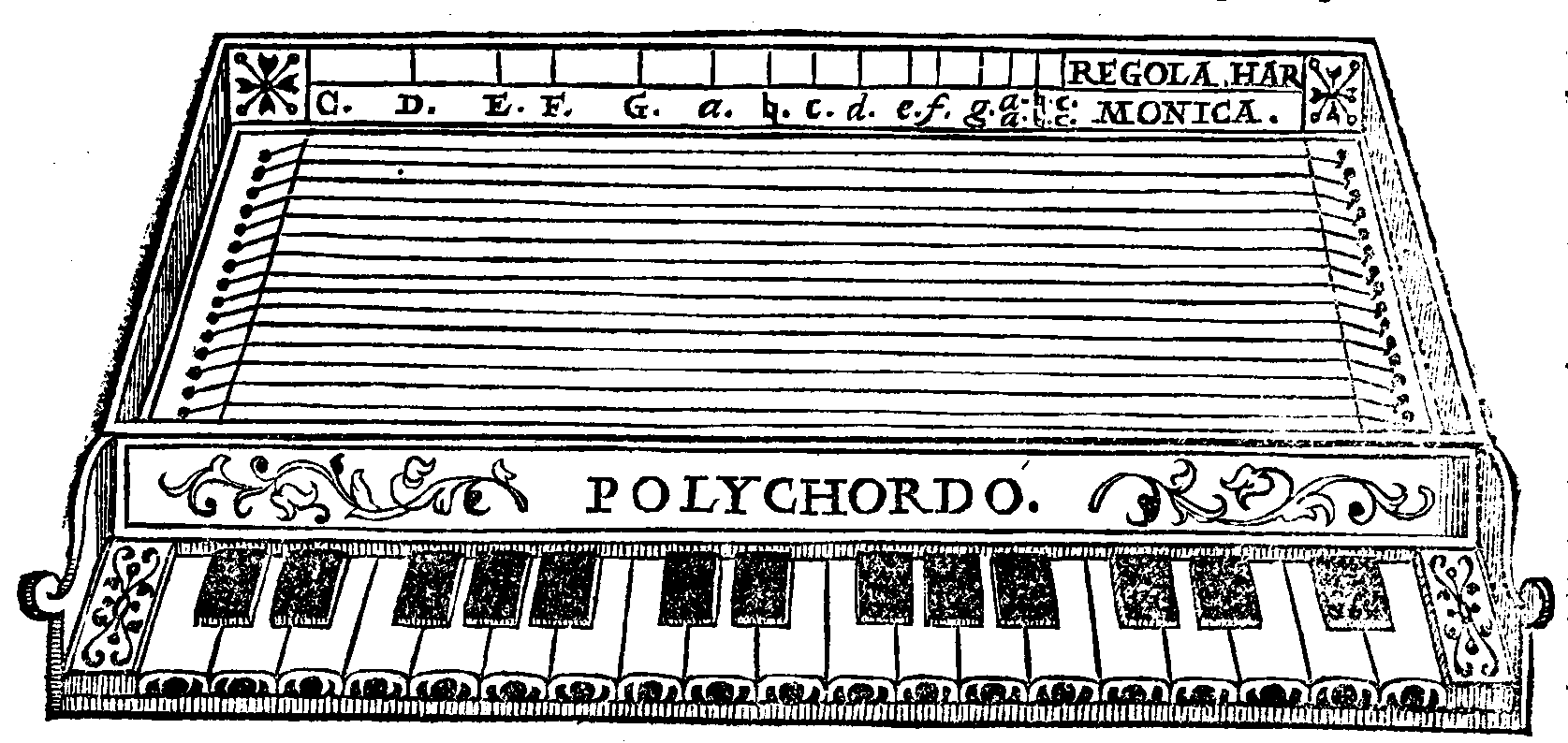
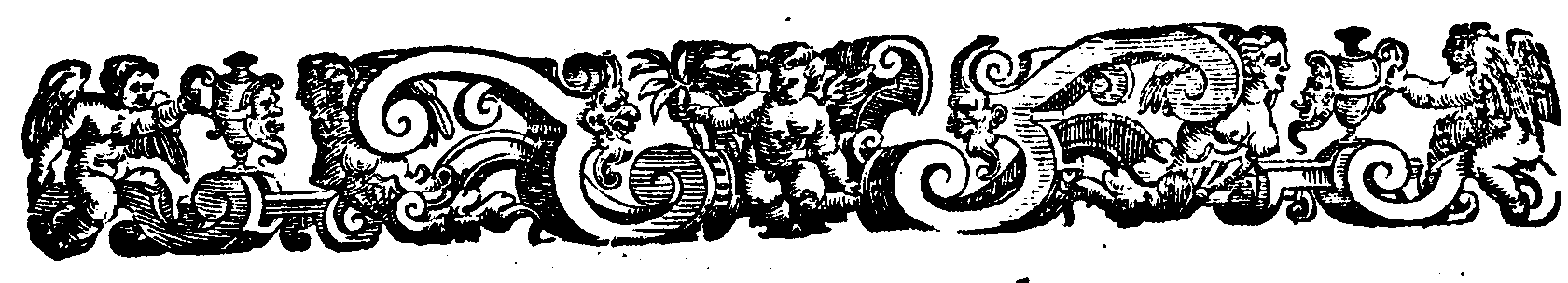
Quinto Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
De i Systemati ò Costitutioni, & delle loro Specie. Cap. I.
Σύστημα δὲ ἐστὶ τὸ ἐκ πλειόνων ἢ ἑνὸς διαστημάτων, συγκείμενον.che uuol dire; Ma la Costitutione è quella, che consta di più d'uno interuallo consonante; & Aristosseno medesimamente dice;
Τὸ δὲ σύστημα σύντετον τε, νοητέον ἐκ πλειόνων, ἢ ἑνὸς διαστημάτωνcioè, Ma la Costitutione s'intenda per un certo composto di più d'uno interuallo. Tolomeo ancora nel Cap. 4. del 2. de gli Harmonici dice; che
Ogni Grandezza costituita de concenti, con semplice uocabulo si suol chiamare Costitutione.Al qual modo anco ogni Grandezza composta di cose consonanti si dice Consonantia; ma essa Costitutione si piglia come Consonantia delle Consonanze. Et si chiama perfetta costitutione quella, che Abbraccia tutti i Concenti insieme con ciascuna delle loro Specie, come uederemo al suo luogo; percioche in tutto si chiama Perfetta quella cosa, che comprende tutte le sue parti. Ilperche nel Cap. 15. della prima parte delle Istitutioni, quando parlai delle Specie de gli Interualli, dissi; che quell'Interuallo ch'è composto di più interualli minori, si chiama da Greci Σύστημα; che anco uuol dire appresso di noi, Congregatione ò Adunanza, onde è scritto nelle Sacre lettere:
Τὰ σύστημα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσσε θαλάσσας;Le congregationi ò Adunanze dell'acque nominò Mari. Sono però molte differentie delle Costitutioni; quantunque (come uuole esso Aristosseno) i più Antichi di lui non facessero di esse mentione alcuna; ma disputassero solamente de gli Heptachordi, i quali chiamauano Harmonie proprie; forse che gli Istrumenti loro erano contenuti dal numero di Sette chorde solamente, come dice Aristotele nel Problema 7. della 19. Parte. Et ancora che alcuni ciò tentassero di fare, tuttauia non poterono ad alcun modo satisfare; come fece Pithagora dal page 231 Zante, & Agenore da Metelino. Ma i più moderni di costoro, di che considerarono la cosa più sottilmente, dissero; cotale Complessione ò Costitutione essere certi ordini nel canto sonoro & in quello senza sonorità, come anco nel parlare auiene, nella compositione delle lettere, percioche la Sillaba non nasce da cotali lettere ò elementi à caso composte, ma poste insieme in ordine certo & determinato: Ilperche di quelle Costitutioni, ch'erano atte al canto ò non atte semplicemente, non ne scrissero parola. Sono adunque Sette le differentie delle Costitutioni, dellequali Quattro sono communi anco à gli Interualli; come quelle che sono differenti per la Grandezza, per il Genere, per il Consonante & Dissonante, & per il Rationale ò esplicabile, & per lo Irrationale ò inesplicabile. E' ben uero, che la Seconda differentia, ch'è posta nell'Interuallo di Costitutione à Costitutione del Genere non si può accommodare; percioche non possono dirsi in qual modo la Costitutione sia composta ò incomposta; come si può mostrare l'Interuallo comporsi, & non si comporre. Sono però tre le Differentie delle Costitutioni; l'una è detta seguitar gli Eccessi; l'altra esser del Congiunto al Separato; & la terza della Mutabilità & della Immutabilità. Ma Tre di esse tutte solamente sono dette proprie; come quelle che sono differenti per l'ordine continuo & seguente, da quelle che non seguono cotale ordine, ma lasciano di mezo qualche cosa, & quelle che sono uarie per la congiuntione & disgiuntione, & ultimamente quelle che non si confanno per la Costitutione Immutabile & mutabile. Per la Grandezza sono differenti le maggiori dalle minori Costitutioni; come la Diapason dalla Diapente, & questa dalla Diatessaron: Per il Genere, come le Diatoniche dalle Chromatiche & Enharmoniche, ouer l'una di queste due dall'altre: Per Consonante & dissonante; come quelle che sono contenute da Suoni tra loro consonanti, da quelle che sono contenute da dissonanti: Onde le Costitutioni Consonanti; secondo gli Antichi erano Sei, nella Costitutione immutabile; cioè, nella Disdiapason; delle quali la minima & prima era la Diatessaron; la seconda, la Diapente; la terza, la Diapason; la quarta, la Diapason diatessaron; riceuuta per consonante da Tolomeo; nel modo però, c'hò dichiarato & dimostrato nella 40. del 2. delle Dimostrationi; la Quinta la Diapason diapente; la Sesta, essa Disdiapason. Ma la Costitutione, che chiamauano Congiunta, procede fino alla quarta Costitutione, Consonante: percioche la prima di esse è la Diatessaron, lasciando da un canto l'altre nominate Costitutioni minori di questa, la Seconda, la Diapente; la Terza, la Diapason; la Quarta, la Diapason con la Diatessaron insieme; la Quinta, la Diapason etiandiapente pure insieme; la Sesta ultimamente, la Disdiapason: percioche s'accresce il luogo della Voce fin'alla Ottaua Costitutione consonante; cioè, fino ad essa Disdiapason insieme con la Diatessaron, & insieme con la Diapente. Ma le Costitutioni dissonanti, parlando secondo gli Antichi, sono tutte quelle, che sono minori della Diatessaron, ouer sono collocate tra le sudette consonanti: onde s'à queste aggiungeremo le Costitutioni del Semiditono, & del Ditono, riceuute da Moderni per consonanti, uinti & superati dal Senso, & sforzati dalla Ragione; allequali si potranno anco aggiunger le Costitutioni del maggiore & del minore Hexachordo; quella della Diapason semiditona, quella della Diapason ditona, quella della Diapason con l'Hexachordo minore, & quella del maggiore; delle quali tutte, da quello che si è dimostrato nel Secondo delle Dimostrationi & nel Terzo delle Istitutioni, si possono conoscer le compositioni & il numero de Tuoni & de Semituoni, che contengono, lequali lascio di dire, per non andare in lungo. Si fanno però le Figure di esse Grandezze composte de gli istessi Interual page 232 li & di numero equali, uariandosi l'ordine loro per alcuna dissimiglianza; percioche quelle Figure, che si compongono d'equali & in tutto simili Interualli, & simigliantemente ad un modo ordinati, non fanno alcuna maniera di Figura. Sono anco differenti le Costitutioni composte d'Interualli rationali, da quelle che sono composte d'irrationali; percioche tutte le Costitutioni rationali si fanno d'Interualli rationali; & quelle che constano d'Interualli irrationali, sono irrationali: essendoche quelle, che si trouano nelle Cantilene uocali, sono composte d'Interualli rationali; & quelle che si trouano ne gli Istrumenti arteficiali, come sono l'Organo il Grauecembalo & altri simili; per la loro temperatura nel modo ch'io dimostrai nella Seconda parte dell'Istitutioni al Cap. 15. & 43. sono ad un certo modo dette irrationali. Sono etiandio differenti le Costitutioni cantate per suoni conseguenti, per ordine & per grado l'uno l'altro; cioè, quelle che procedono per gradi, da quelle che sono cantate per suoni, che non si conseguitano, ma si cantano per salti; & sono quelli, tra i quali se ne troua alcuno di mezo, ilquale cantandosi hà lasciato da un canto; come si uede nel Cap. 17. del 2. Lib. in quella parte che si chiama Euthia, & in quella che nominamo Ploce. Sono etiandio le Costitutioni, che sono composte di Tetrachordi insieme aggiunti, differenti da quelle, che sono fatte da Tetrachordi separati; essendoche la congiuntione è un suono commune di due Tetrachordi conseguenti, & congiunti, non solo secondo l'ordine de i suoni cantati; ma secondo la specie de simili Tetrachordi. Ma la Separatione è la Interpositione del Tuono tra due Tetrachordi, che si con seguitano non solamente secondo l'ordine de i Suoni cantati, ma anco de simili Tetrachordi secondo la Specie. Gli antichi però haueano in somma tre Congiuntioni, l'Acutissima, la Mezana, & la Grauissima. Questa (come si è anco dichiarato nel Cap. 4. del 2. Lib.) era fatta di due Tetrachordi, de i quali l'uno era l'Hypaton & l'altro il Meson; & la Hypate meson suono commune gli aggiungeua insieme. La Mezana era fatta per i Tetrachordi Meson, & Synemennon, che si congiungeuano per il suono commune detto Mese; ma l'Acutissima si facea per i Tetrachordi Diezeugmenon & per l'Hyperboleon, col mezo della chorda ò suono Netediezeugmenon. La Separatione era una sola, ch'era fatta da due Tetrachordi, de i quali il primo era il Meson & l'altro era il Diezeugmenon; iquali erano separati da un Tuono commune, ch'era tra la Mese & la Paramese. Laonde haueano due Costitutioni, che chiamauano Perfette, delle quali l'una era maggiore & l'altra minore. La minore era quella che si faceua per la congiuntione dalla Proslambanomenos alla Netesynemennon, & erano compresi in essa tre Tetrachordi congiunti; cioè l'Hypaton, il Meson, & lo Synemennon, co 'l Tuono compreso da Proslambanomenos & Hypate hypaton; che era la Costitutione fatta della Diapason posta insieme con la Diatessaron, compresa & finita dalla Consonanza Diapason diatessaron, della quale parlaremo al suo luogo; ma la Maggior Costitutione che chiamauano perfetta si faceua per la Separatione dalla Proslambanomenos alla Netehyperboleon, nella quale sono contenuti quattro Tetrachordi; de i quali, due sono separati da gli altri; ma tra loro congiunti; cioè il Tetrachordo Hypaton, il Meson, il Diezeugmenon, & l'Hyperboleon, con due Tuoni, de i quali l'uno è posto tra la Proslambanomenos & la Hypate hypaton; & l'altro tra la Mese & la Paramese; & à questa costitutione conuiene ueramente la Definitione della Consonanza. Et perche nella Costitutione immutabile, che si fà d'una & dell'altera, sono cinque Tetrachordi; però due di questi sono communi all'una & l'altra delle perfette Costitutioni, che sono i Tetrachordi Hypaton & Meson. Ma i proprij della Costitutione page 233 congiunta sono il Tetrachordo Meson & lo Synemennon, & quelli della Separata sono il Diezeugmenon & l'Hyperboleon. Sono etiandio differenti le Costitutioni per il Mutabile & per l'Immutabile, per il quale discordano & sono uarie le Semplici dalle non semplici. Ma le Costitutioni semplici erano quelle, che si accommodauano ad una mezana; & le Doppie quelle; che s'adattauano à due; & le Triple, che si accommodauano à tre; & le Molteplici erano quelle che à più s'accommodauano. Era però nella Media posta la forza del Suono, alquale accadeua nella Separatione d'hauere il Tuono semplice dalla parte acuta, se la Costitutione era immutabile, & il Ditono semplice ò composto dalla parte graue; ma nella Congiuntione à quello, che accascaua essere di tre Tetrachordi congiunti, hauea ò il Tuono acutissimo del mezano Tetrachordo, ouero il grauissimo dell' acutissimo. Et dalla Mese ò Mezana si conosceua le forze de gli altri Tetrachordi: imperoche subito si conosceua in qual modo ciascun Suono hauesse rispetto alla detta Mese. Ma di queste Costitutioni uedasi il Cap. 4. del 2. Libro; nel quale si tratta de i Tetrachordi Congiunti, & Separati minutamente: il che potrà apportare qualche lume, & maggiore intelligentia di quello che detto habbiamo.
Delle Differentie delle Costitutioni ò Specie delle prime Consonanze. Cap. II.
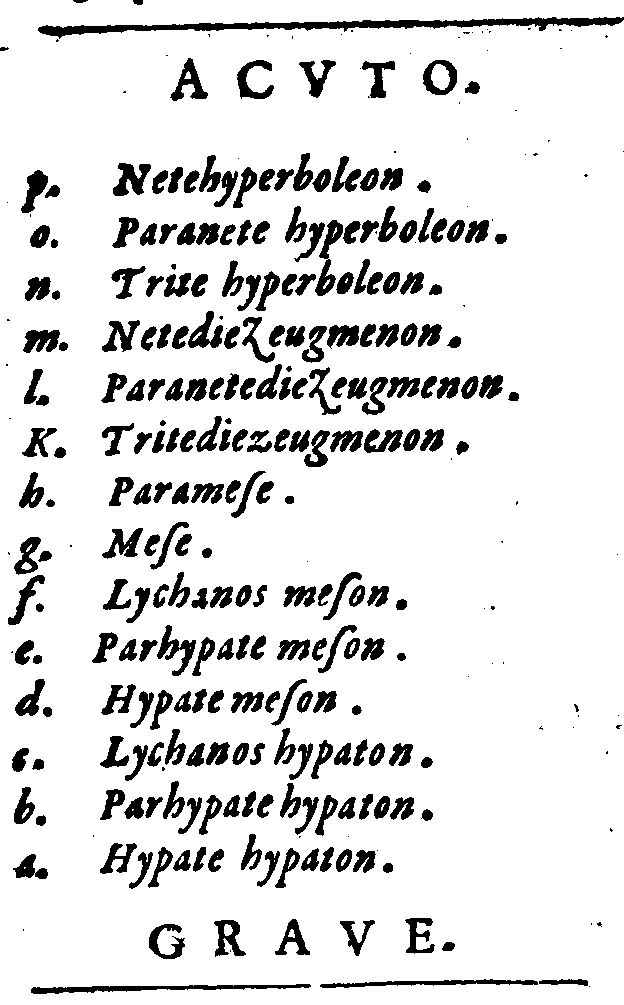
Delle Ragioni ò Proportioni harmoniche, & de i Numeri che comprendono le Costitutioni consonanti. Cap. III.
Che la Diapason solamente sia Complessione ò Costitutione perfetta. Cap. IIII.
In qual modo Tolomeo dimostra, che sia stata riceuuta la Magnitudine della Diapason diatessaron per Costitutione perfetta. Cap. V.
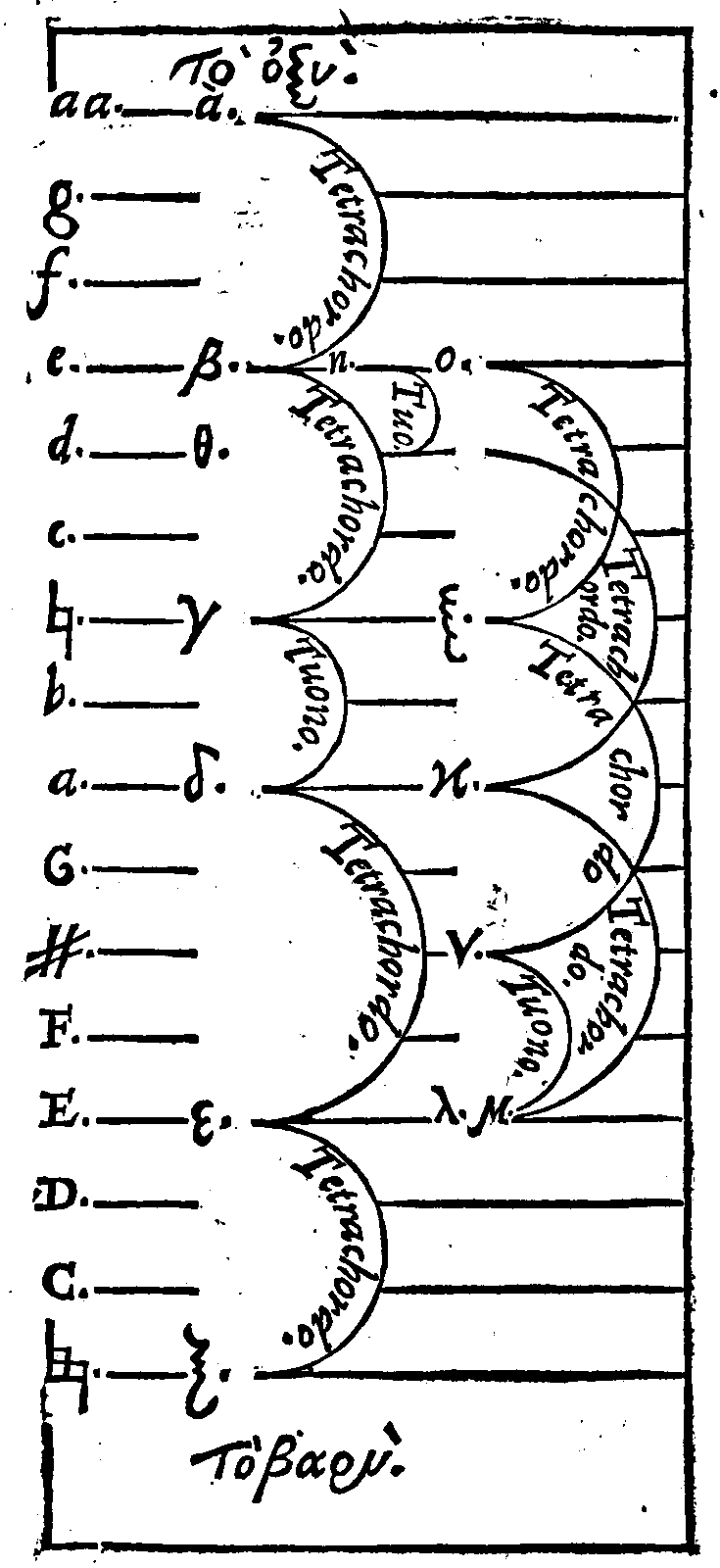
d'hauer saputo da questa dimostratione, che ritrouandosi nelle moderne Compositioni del Systema disgiunto, la chorda Tritesynemennon non sarà altramente diatonica, ne pure chromatica, ne accidentale; come dicono alcuni; & cosi parimente trouando la Paramese in queste Cantilene, che saranno composte per il Congiunto; ma si bene una terza cosa mista.A' questo dico, che prima non essendo la chorda Tritesynemennon posta nelle compositioni del Systema disgiunto nella compositione diatonica, ne pura chromatica, ne accidentale; com'ei dice; non uedo, ne conosco quello che uoglia intendere per questa sua Terza cosa mista; percioche tra il sostantiale & l'accidentale non cade mezo alcuno; il che dico anche della Paramese nelle Cantilene composte per il Congiunto. Ma mettasi questa appresso l'altre cose, ch'ei dice fuori di proposito, & facciamo fine à questo libro; non parlando, ne anco affaticandosi di uoler sapere & intendere quello ch'ei si uoglia dire, quando nomina il Systema disgiunto; cosa non più udita, per quello ch'io mi ricordo, tra quelli, che scriuono & trattano le cose di questa Scienza.

Sesto Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
De i Tuoni & del Numero loro. Cap. I.
Ex Diapason igitur Consonantiae speciebus existunt, qui appellantur Modi; quos eosdem Tropos, uel Tonos uocant. Sunt autem Constitutiones in totis uocum ordinibus, uel grauitate, uel acumine differentes: Constitutio uerò est plenum ueluti modulationis Corpus, ex consonantiarum coniunctiones consistens, quale est Diapason, uel Diapente, & Diatessaron, uel Disdiapason.Laonde per tutto quel Capitolo & ne i tre seguenti chiama il Dorio, il Lydio, il Frigio & gli altri per ordine, Modi, & non Tuoni; forse per schiuar l'equiuocatione del nome Tuono, inteso per quell'Interuallo, ch'è contenuto dalla proportione Sesquiottaua; che noi chiamiamo Tuono maggiore; ilqual rispetto hebbi anch'io; come si uede nel Cap. 1. del Quarto dell'Istitutioni; se ben con più ragione si douerebbono chiamar più tosto Modi, che Tuoni ò Tropi. Ma com'anco dichiarai nel Cap. 11. della Quarta parte delle Istitutioni, era intesa questa Voce Tuono da gli Antichi in quattro maniere; percioche la usurpauano prima per il Suono ò Voce; dopoi, per l'Interuallo; oltra di questo, per il luogo della uoce; & per un Tenore. Prima, per il Suono; quando chiamauano la Lira, ch'era Istrumento di Sette chorde ἑπτατόνον. Di sette Suoni: onde non è marauiglia, s'Aristosseno dice, com'hauemo detto nel Cap. 1. del Quinto Libro che gli Antichi non fecero mentione, se non de gli Heptachordi, che chiamauano Harmonie proprie. Dopoi, lo intesero per l'Interuallo; come quando diceuano della chorda Mese alla Paramese esserui un Tuono. Oltra di ciò, per il luogo della Voce, quando diceuano, Tuono Dorio, ò Frigio, ò Lydio. Vltimamente, per un Tenore; quando diceuano, ch'alcuno hauea Tuono acuto, ò graue, ò mediocre di uoce. Ma lasciando gli altri modi da un canto, ragionando del terzo, diremo con Euclide: che
Τόνος δ'ἐστὶ τόπος τὶς τῆς φωνης δεκτικὸς συστήματος ἀπλατής.cioè, Il Tuono è luogo certo di uoce senza larghezza, capace della Costitutione. Laonde quando dice, che Tuono è luogo certo di uoce; bisogna intender questo luogo nel Systema massimo ò massima Costitutione; per il luogo certo del Tuono; come lo chiamauano gli Antichi, ò modo Dorio; come lo nominano i Moderni, collocato tra un numero certo & terminato di chorde. Et quando dice, che non ha larghezza, bisogna intender della Modulatione di una parte, che uada modulando & cantando nella Cantilena per cotal numero; ilche s'attribuisce principalmente à quella, che nelle nostre Cantilene chiamiamo Tenore, nelquale dalla miglior parte de i Musici è posta la modulatione del Tuono ò Modo, di che è composta la Cantilena: onde tal parte non contiene in sè larghezza alcuna, come la Linea, ilche fù dichiarato nel Cap. 6. del 2. Lib. essendoche s'alcuno (per essempio) darà principio al Tuono nella sua chorda grauissima; uolendosi distendere & andar uerso l'acuto, & di nuouo ritornarsi nel graue, procedendo per uarii interualli; altro non si udirà, che la semplice Modulatione, fatta dal graue all'acuto; ò per il contrario, dall'acuto al graue per cotali interualli & uarie costitutioni & diuerse Aria di canto; & sarà necessario, che incorri in uno de i Tuoni, nelquale haurà incominciato. Ilper page 242 che hauendo usato in esso uarie Modulationi & uarii (come si dice) passaggi, formando uarie Costitutioni; potrà Conoscere, che cotal Tuono sarà capace nella lunghezza, & non nella larghezza della Costitutione; come dice la Definitione. Quanti poi ueramente fussero i Tuoni ò Modi appresso gli Antichi, non è cosa facile da sapere, per le uarie opinioni che sono tra i Scrittori in questa parte, ch'è ueramente Historica; essendoche Euclide nel sudetto Introdottorio dice; ch'Aristosseno uuole, che fussero Tredici; ma altri Aristossenici, come fù Cassiodoro & Martian Capella, uogliono che fussero Quindici; ilche dimostra Alipio con gli essempij, che pone nel suo Introdottorio di Musica, de i Caratteri ò Cifere, che seruiuano à ciascun de i detti Quindeci Tuoni in ciascun Genere: è ben uero, che per essere il Testo d'Alipio guasto, mancano tutte le Cifere ò Caratteri di molti Tuoni, & alcuni sono imperfetti. Ma altri hanno fatto di essi minor numero; come hò dichiarato à lungo nel Cap. 3. della Quarta parte dell'Istitutioni, iquali non starò à replicare. Non è però dubio, per quello c'hò dimostrato nel detto Terzo capitolo, che modernamente ne usiamo Dodeci, siano poi stati quelli de gli Antichi quanti si uogliano; perche se ben Tolomeo nel Cap. 9. del 2. Lib. soppone esserui solamente sette Tuoni; essendoche sette solamente sono le Specie della Diapason, dallequali sono contenuti, com'ei tiene & proua nel Cap. precedente: tuttauia oltra i Sette, nel Cap. 10. del Secondo de gli Harmonici; commemora l'Hipermistolidio, come quello che reputa esser l'istesso con l'Hypodorio; & nel Cap. 16. del Primo commemora l'Ionico, come fà nel Cap. 1. & 16. del Secondo l'Iastioeolico. S'io hauesse atteso solamente all'arteficio di Tolomeo, ch'egli usò nell'accommodare i Tuoni nel modo ch'ei fece molt'altre cose della Musica alle Sphere del cielo, haurei ueramente detto, che i Tuoni non sono più di Sette; ma Plinio nel Cap. 22. del 2. Lib. dell'Historia naturale; parlando della Musica delle Stelle, dopo l'hauer assegnato le distanze c'hanno le Sphere l'una dall'altra; di quelle dico, che sono poste tra la Terza & la Ottaua sphera, nellaquale è il Zodiaco, dice cosi:
Ita septem Tonos effici, quam Diapason harmoniam uocant; hoc est; Vniuersitatem concentus: in ea Saturnum Dorio moueri phtongo, Iouem phrygio, & in reliquis similia; iucunda magis, quàm necessaria subtilitate:cioè, Cosi farsi sette Tuoni, laqual chiamano Diapason harmonia; cioè, uniuersità di concento: In essa Saturno esser mosso col suono Dorio, Gioue col Frigio, & ne gli altri simil cose più tosto esser dette con iucunda, che necessaria utilità. Però (come hò detto altroue) attesi à dimostrar la molteplicità de i Tuoni, accioche non paresse strano à qualcheduno, se ben cotal cosa hauea chiaramente dimostrato, il porre in uso Dodeci Tuoni ò Modi: onde aggiunsi l'Hypermistolidio à i Sette; ilche fece etiandio Boethio. Ne u'aggiunsi à gli Otto l'Ionico, ne l'Iastieolio, ch'ei commemora; percioche lo stimai misto dell'Iastio & dell'Eolio commemorati da Aristosseno. Et quantunque alcun uolesse dire, che i Tuoni ò Modi non fussero più di quelli, c'hanno comemorato i Scrittori di queste cose; credo che s'ingannerrebbe di gran lunga. percioche se i nomi de i Tuoni, come uuol Tolomeo, Boethio, & molti altri; deriuano da i Popoli, i quali di essi si delettauano; non è à bastanza si poco numero, à uolerli numerar tutti: ond' io credo, che i Scrittori habbiano fatto commemoratione solamente di quelli, ch'erano più famosi; com'hanno anco fatto nella Lingua greca; percioche se bene tra i popoli, che la usauano, si ritrouauano molte diuersità di parlari, che chiamano Διάλεκτους, che uuol dire propriamente (oltra gli altri significati) Proprietà di lingua, Modo di parlare, ò Elocutione; onde Aristotele dice; Διάλεκτος ἐστιν ἣ τῆς φωνῆς τοῦ γλώττου διόρθωσις. La Locutione è espositione di uoce, fatta dalla lingua: page 243 tuttauia lasciando eglino da un canto, come in esse non fussero stato scritto cosa alcuna di momento nelle Scientie, che sia peruenuto à i nostri tempi; la Beotia, la Candiota, la Cipriota, la Calcidica, l'Argiua, la Siciliana, la Rhegina, la Tarentina, la Macedonica, la Thessala, la Laconica, la Panfilica, & molte altre; & ne hanno tenuto per se solamente Cinque; che sono, la Commune, l'Attica, la Ionica, la Dorica, & la Eolica; nelle quali si trouano scritte infinite cose da Huomini illustrissimi in tutte le facoltà. Bastaua adunque à Tolomeo, per dimostrar la Musica delle Stelle, solamente applicare alle Sphere de Pianeti, che sono Sette, l'un de i Tuoni, c'habbiamo nominato; lasciando l'Ionico, l'Iastioeolico, & l'Hypermistolidio da un canto, come quelli che non faceuano al suo proposito. Ma sopra di questo si può ueder quello, che dicono alcuni;
che 'l Zarlino uuole, secondo Tolomeo, che i Tuoni fussero Otto; laqual cosa non disse mai Tolomeo, anzi repudiò l'Ottauo.Anzi dico io, che 'l Zarlino uuole hora, che fussero Dieci quelli, che nominò Tolomeo; se bene nel suo ordine non ne uolse porre alcuno de i Tre sudetti: essendoche uedeua, che guastauano il suo disegno nella perfetta Costitutione ò Systema perfetto. Ma che repudiasse ò nò l'Ottauo, cioè l'Hipermistolidio; lo potiamo conoscer dalle sue parole, quando dice quello che segue; hauendo prima parlato de i luoghi de gli altri Tuoni. Οὗ τόνου τὸν διὰ πασῶν ἐσόμενον, ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἀυτὸν ὄντα προσηγόρευσαν, ὑπερμιξολύδιον εἱλημμένον. Τῷ μὲν ὑπὸ καταχρησάμενοι πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ βαρύτερον ἔν δειξιν. Τὼ δὲ ὑπὲρ πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ ὁξὺτερον. cioè, Del qual Tuono douendosi formar la Diapason consonanza; quello che alla parte acuta era ueramente l'istesso Hipermistolydio, dall'accidente, quasi come sopra 'l Mistolydio lo nominarono; usurpando la uoce ὑπὸ, per dinotar la parte più graue; & la ὑπὲρ, per dinotar la più acuta. Et Boethio nel cap. 17. del 4. Lib. rendendo la ragione de i Modi della sua descrittione, dice:
Relinquitur igitur extra h. p. quae, ut totus ordo impleatur, adiecta est: atque hic est Octauus modus, quem Ptolemaeus super annexuit.Hora in questo proposito fanno costoro, come fanno gli Heretici, che quando parlano d'alcuna cosa, pigliano, per concludere in lor fauore, l'autorità della Santa Scrittura, & de S S. Dottori Catholici tronche & imperfette; cioè quella parte, che fà al proposito loro, & si seruono di quella, per la conclusione; essendoche costumano non solamente i sudetti SS. ma ogn'altro Disputante, porre prima i Fondamenti de gli auuersarij, & dopoi impugnarli; & ultimamente dedurre dalla disputa loro una uera, santa, & Catholica conclusione, la qual rasserena le menti di tutti quelli, che desiderano uiuere pietosamente nel Signore: cosi costoro in una loro Annotatione nel margine del Trattato più uolte citato, scriuono queste parole.
Il Zarlino nel Cap 3. della Quarta parte delle sue Istitutioni, dice; che Aristosseno fece Quindeci modi:ma la malignità loro non gli hà lasciato intender quello, c'hò uoluto dire. Scriuono anco, che
Aristosseno (come uuole Cassiodoro & Martiano Cappella) pone Quindeci modi,& altre cose seguenti: Ilperche, se questo m'attribuiscono à errore, sarebbe più tosto stato errore d'attribuire à Cassiodoro & à Martiano, che à me: percioche non hauea à disputare in questa cosa, come historica, se fussero Tredici ò Quindeci; uolendo solamente adunare l'opinioni de Scrittori antichi sopra questo fatto, & pigliar quella parte, che faceua al proposito nella nostra Musica moderna, per dimostrar che non era fuori del caso, ne che paresse ad alcuno strano, ch'appresso di noi si trouasse Dodeci modi; poiche appresso gli Antichi ue n'erano ancora tanti, che passauano cotal numero. Non credo però, che questo si possa attribuire à i detti Autori ad errore, per molte ragioni: prima, perche non si troua appresso Aristosseno, che siano più Quindeci, che Tredeci; page 244 percioche parlando questo Filosofo nel Secondo de gli Elementi harmonici de i Tuoni, non parla secondo la mente propria, ma secondo l'altrui opinione, & ne commemora solamente Sei & non Tredeci, ne Quindeci; come uederemo più oltra. Onde uorrei saper uolontieri da questi nuoui Aristarchi, doue & in qual parte de i Libri c'habbiamo d'Aristosseno; i quali (mercè di quelli, che gli hanno transcritti) sono non solamente imperfetti, ma di quello che resta, tanto incorretti, ch'è un stupore; hanno trouato queste cose: Ilperche è da credere, che Cassiodoro & Martiano habbiano hauuto questo numero, ò dalla coppia antica de i Libri d'Aristosseno, ò da qualche altro Antico scrittore, che gli hauesse ueduti & letto prima di loro. Et se bene Euclide, ilqual seguitò la dottrina d'Aristosseno, in una parte uuole, che siano Tredeci; come fanno anco Aristide Quintiliano & Censorino; parmi che con più ragione possino esser Quindeci, che Tredeci: percioche numerando gli Aristossenici d'accordo Cinque principali modi, Lydio, Iastio, Eolio, Frigio & Dorio; à i quali ue ne attribuiscono separatamente due per uno, che chiamano Collaterali; aggiungono à ciascuno de i nomi de principali queste due particelle ὑπὲρ. cioè, Sopra; & ὑπὸ. che uuol dir Sotto; come si scorge appresso d'Alipio, ilquale in ogni genere d'Harmonia gli aggiunge le sudette due propositioni, & dimostra i Caratteri de Quindeci per ogni genere, & Tre per ogni Modo; di maniera che cosi imperfetto, com'ei si troua, si uedono i Caratteri de Quindeci Tuoni ò Modi nel genere Diatonico, Quindeci nel Chromatico, & Noue ne i Enharmonici; mancandouene quelli dell'Iastio, Hypoiastio, Dorio, Hypodorio, & Hyperdorio, che sono nel numero de Sei; onde trouandosene in essere (ancora che imperfetti & incorretti) al numero di Trentanoue, sarebbono al numero di Quarantacinque, ilche non è sogno; percioche Cassiodoro dice, come hò detto anco nelle Istitutioni, che qual si uoglia modo hà l'Alto & il Basso, significati per le due particelle mostrate di sopra. Per laqual cosa, quando fussero solamente Tredeci, sarebbe necessario, che uno de principali mancasse dell'Alto & del Basso, che sarebbe un'inconueniente; essendoche non ui è maggior ragione, che l'un più che l'altro de i principali habbia d'hauer lo ὑπὲρ & lo ὑπὸ anco; che sono le prepositioni nominate di sopra.
In qual modo i nomi de i Suoni si pigliano, tanto per la loro Positione, quanto per la loro Facoltà ò possanza. Cap. II.
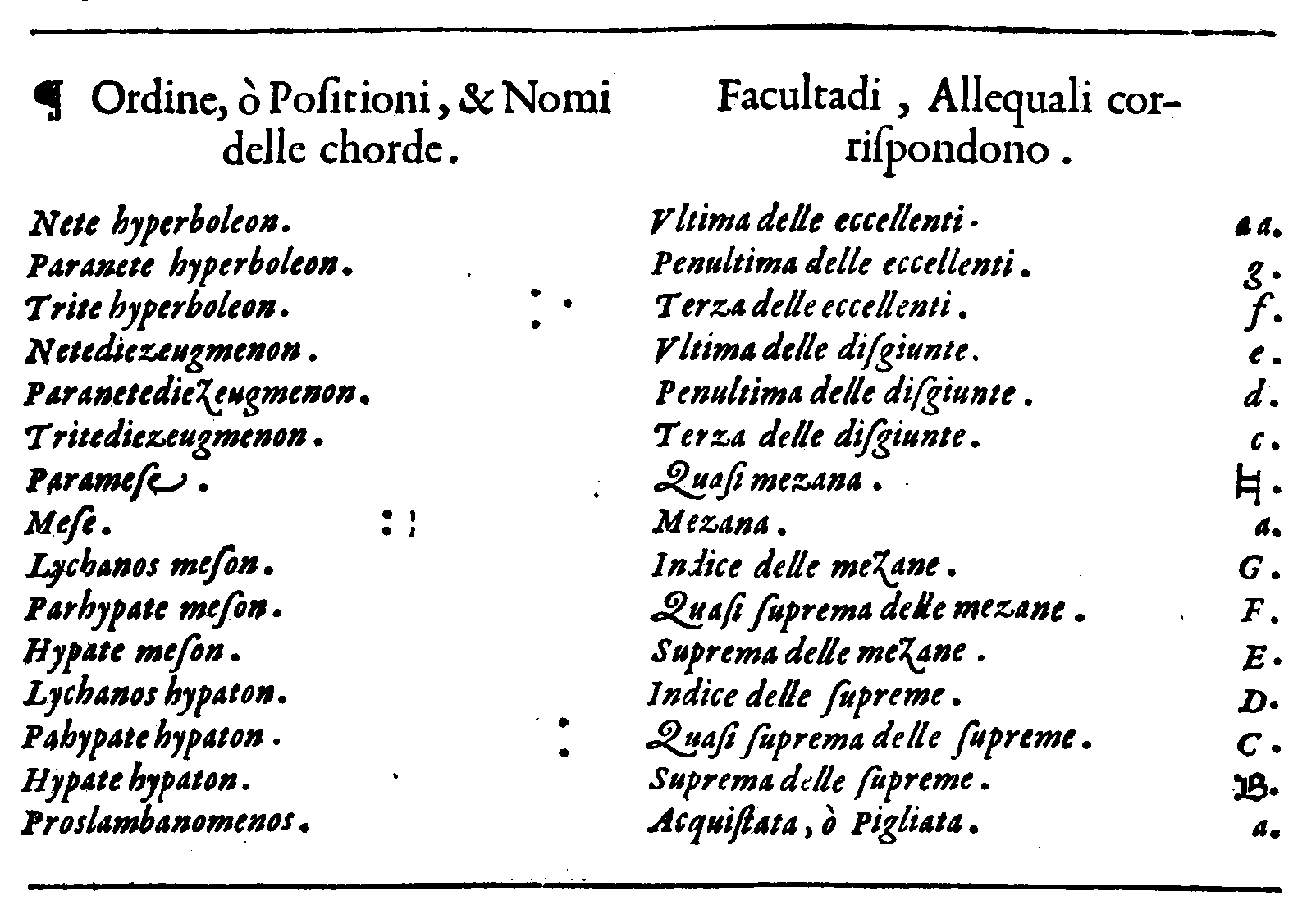
In quali delle Quindeci chorde dell'Istrumento gli Antichi accommodauano ciascun Tuono; & quanto fussero più graui ò più acuti l'un dell'altro & in qual maniera uengano accommodati i nostri Moderni. Cap. III.
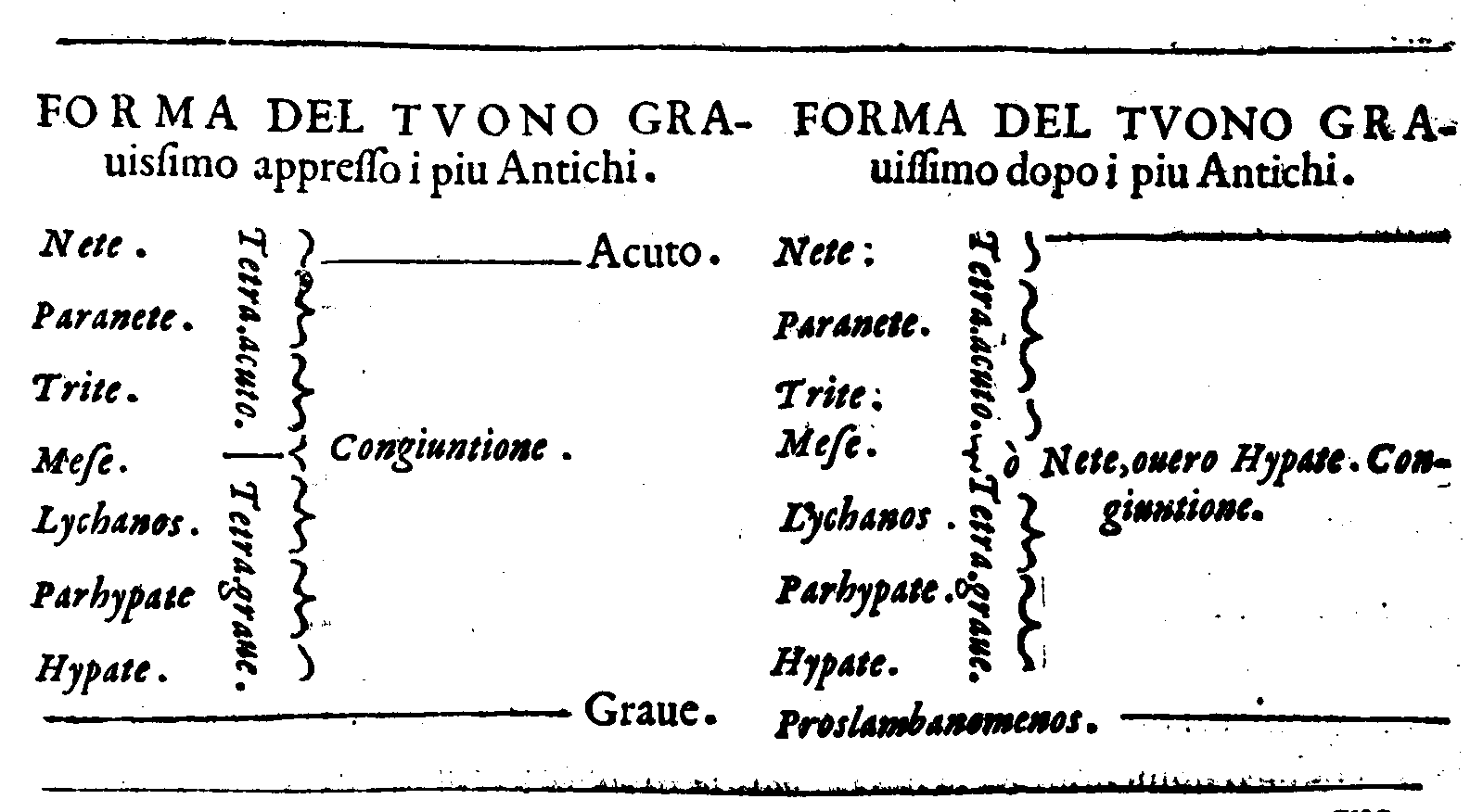
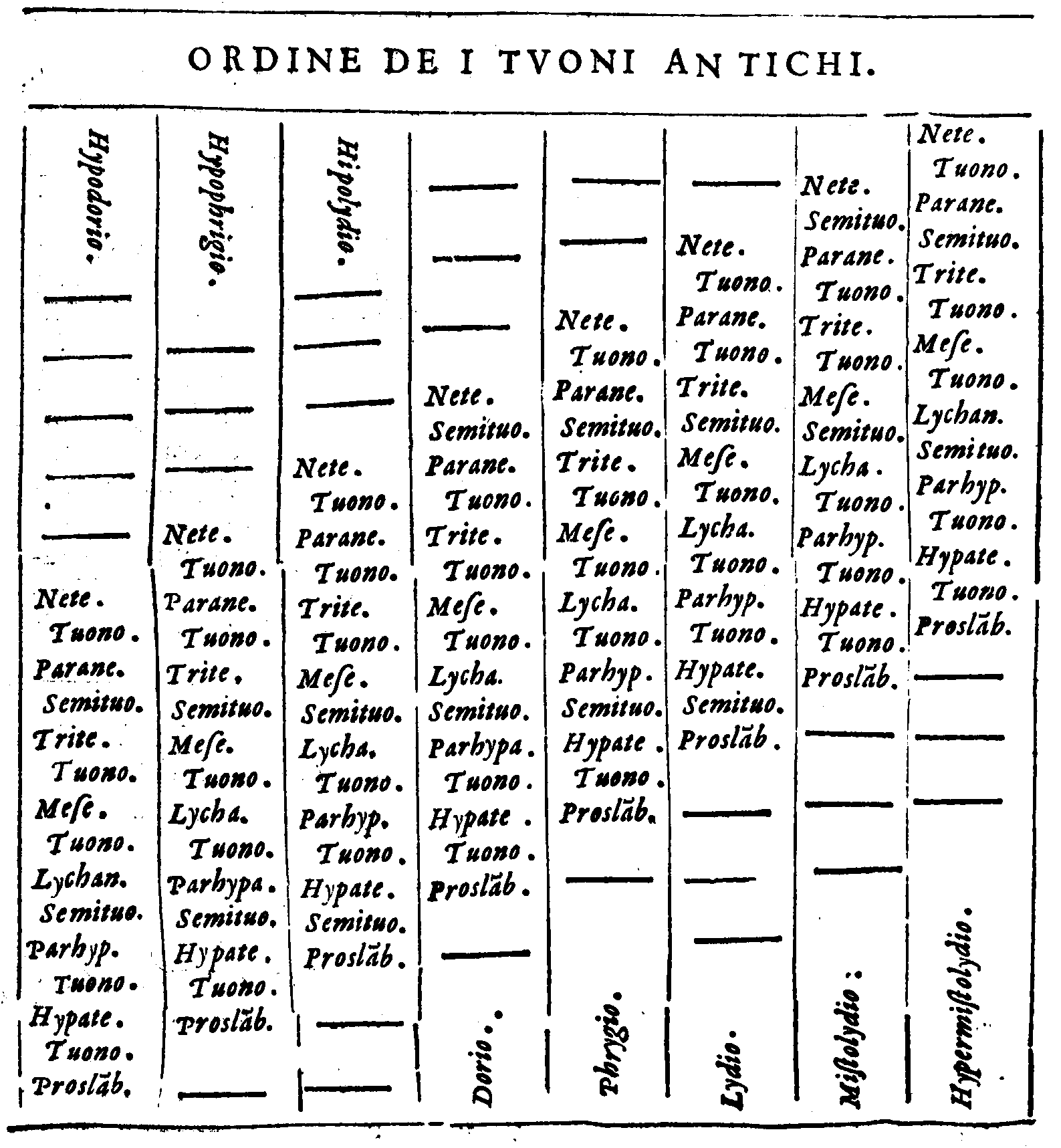
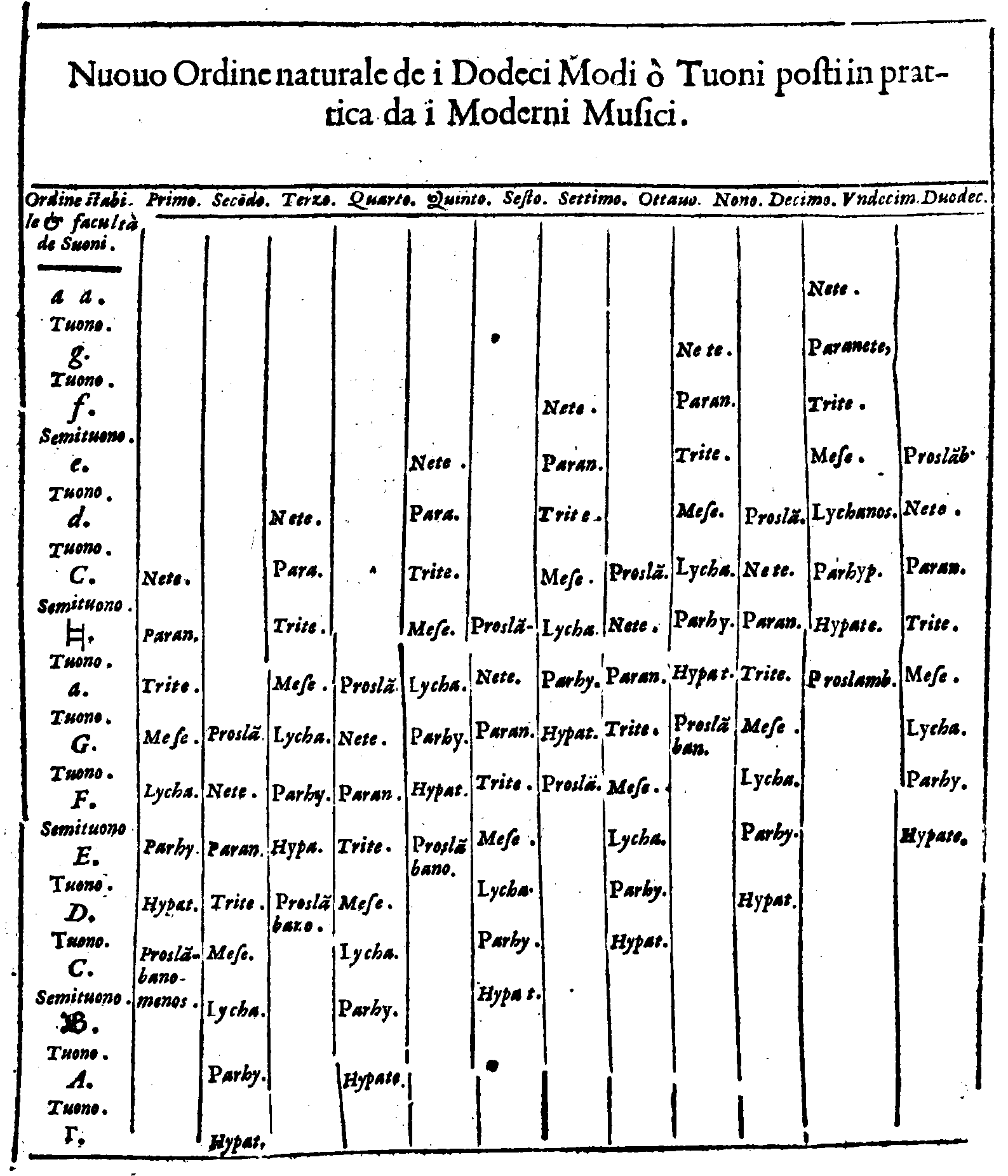
De i Tuoni ò Modi secondo l'opinione d'alcuni Moderni. Cap. IIII.
che 'l Zarlino nel Cap. 3. della Quarta parte dell'Istitutioni uuole, ch'Aristosseno ne facesse Quindeci; & nel Cap. 16. della Seconda disprezza senz'alcuna ragione le sue Distributioni.Et io dico, che quello che dice il Zarlino nel sudetto 16. Cap. ciascuno da se stesso lo potrà uedere, & far quel giudicio che li parerà; & potra conoscere, s'io haurò sprezzato Aristosseno, ò nò. Ma che questo Filosofo & Musico eccellentissimo uoglia più Tredici che Quindeci Tuoni, niun lo potrà conoscer da i suoi Scritti. E ben uero, ch'Aristide Quintiliano, lasciando gli altri da un canto; per hauerne ragionato à sufficientia nel Cap. 3. della Quarta parte sudetta; nomina prima Tredeci Tuoni; dopoi ne commemora Quindeci. Ma nel Secondo libro de gli Elementi musicali d'Aristosseno; se ben'è col primo imperfetto & incorretto, si leggono queste parole.
Πέμπτον δὲ ἐστὶ τῶν μερῶν τὸ περὶ τοῦς τὸνος, ἐφ' ὧν τιθέμενα τὰ συστήματα μελοδεῖται, περὶ ὧ οὐδεὶς οὐδὲν εἴρημεν, οὔτε τίνα τρόπον ληπτέον, οὔτε πρός τι βλέποντα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀποδοτέον. ἀλλὰ πανταλῶς ἔακε τῇ τῶν ἡμερῶ ἀγογῇ τῶν ἁρμονικῶν ἡ περὶ τονὸν ἀποδόσις. οἷον ὅταν κορίνθιοι μὲν δεκάτην ἄγωσιν, ἀθηναῖοι δὲ πέμπτην, ἕτεροι δέ τινες ὀγδόην, οὗτω γὰρ οἱ μὲν τῶν ἁρμονικῶν λέγουσιν βαρύτατον μὲν εἶναι τῶν τονῶν. τῶν ὑποδώριον. ἡμιτονίῳ δὲ ὀξύτερον τούτου τὸν μυξολύδιον, τούτου δὲ ἡμιτονιῳ τὸν δώριον, τοῦ δωρίου δὲ τόνῳ τὸν φρύγιον. ὡσαύτος δὲ καὶ τοῦ φρυγίου τὸν λύδιον ἑτέρῳ τόνῳ. ἕτεροι δὲ τοῖς ειρημένοις τὸν ὑποφρύγιον αυλὸν προστί θεασιν ἐπὶ τὸ βαρὺ. Οἱ δ'ἆν πρὸς τὴν τῶν ἀυλῶν τρίπησιν βλέποντες, τρεῖς μὲν τοῦς βαρυτάτους τριςὶ διέσ σιν ἀπ' ἀλλήλων χωρίζουσι, τόντε ὑποφρύγιον, καὶ τὸν ὑποδωριον, καὶ τὸν δωριον. Τὸν δε φρυγιον, ἀπὸ τοῦ δωρίου τόνῳ, τὸν δὲ λύδιον απὸ τοῦ φρυγίου, πάλιν διέσεις ἀφίστασιν. ὡσαύτος δὲ καὶ τὸν μιξολύδιον τοῦ λυδίου. τί δὲ ἐστι, πρὸς ὁ βλέποντες οὕτω ποιεῖσθαι τὴν διὰστασιν τῶν τόνων προτεθύμιηντα, οὐδὲν εἰρήκασιν.Nelle quali parole non fece alcuna mentione de numero determinato de Tuoni; & cosi dicono. Il
Quinto (capo) è de i Tuoni, ne quali sono cantate le costitute Complessioni; delle quali niun'hà messo fuori cosa alcuna, come s'hanno à pigliare, ne con qual rispetto il suo numero si possa dare; anzi la Sottrattione de i giorni & la Traditione de i Tuoni de gli Harmonici paiono in tutto simili; percioche si come quando i Corinthi veramente fanno il Decimo, & gli Atheniesi fanno il Quinto; cosi alcuni de gli Harmonici dicono, il grauissimo de i Tuoni esser l'Hypodorio, & il Mistolydio esser più di questi acuto per il Semituono; & per questo Semituono anco il Dorio. Ma dicono il Frigio esser lontano dal Dorio nelle parti acute per il Tuono; Et non altramente il Lydio dal Frigio, che per un'altro Tuono. Ma altri, oltra le cose dette, aggiungono nel graue la Tibia Hypofrigia; & altri di nuouo, hauendo riguardo à i fori delle Tibie, distinguono cambieuolmente i tre grauissimi l'un dall'altro, contre Diesis; cioè, l'Hypofrigio, l'Hypodorio, & il Dorio. Distinguono però il Frigio dal Dorio poco meno d'un Tuono, & il Lydio dal Frigio ancora per tre Diesis; & con simil partitione separano il Mistolydio dal Lydio. Ma qual sia quella cosa, dallaquale siano stati persuasi di statuire à i Tuoni cotali interualli, non hanno detto cosa alcuna.Questo è quello, che dice Aristosseno de i Tuoni, nominandone se non Sei, che sono l'Hypodorio, il Mistolydio, il Dorio, il Frigio, il Lydio & l'Hypofrigio, chiamandolo Tibia hypofrigia; non acconsentendo però à questa lor positione; anzi uolendo dimostrare che non stà bene; percioche soggiunge, che quanto la Densatione sia abhorreuole al Canto & al tutto inutile, lo farà manifesto trattandola. Ilperche si uede, che 'l numero del Tredeci ò Quinde page 252 ci modi non è stato assegnato da Aristosseno, ma da quelli c'hanno dimostrato di seguitar troppo la sua dottrina; Ne si troua anco che sia al proposito quello, che dicono costoro; ch'Aristosseno ritrouasse tra il Lydio & il Mistolydio, & tra l'Hypolydio & il Dorio la differentia d'un Semituono minore & Lemma; & che sopra ciò andasse chimerizando quello, che ei mai non si pensò di fare. Hanno oltra di questo ritrouato mille cose, per dimostrar con apparati & uarie figure & essempij, la uarietà de i Tuoni di questo Filosofo da quelli di Tolomeo & di Boethio; nondimeno quando hanno ben detto & detto dimostrano il Systema d'un Tuono, non esser differente da quello d'un'altro se non per il graue & per l'acuto; non intendendo, che questa differentia non è quella, che distingue i Tuoni; ma quella de gli Interualli, che si trouano differenti nella propria Costitutione; & la sua Proslambanomenos, la sua Hypate, la sua Mese, & la sua Nete; con la Proslambanomenos, Hypate, Mese & Nete d'un'altro. Et che ciò sia uero, che non l'intendono, da questo si conosce; ch'in ogni Tuono pongono il Systema massimo composto di cinque Tetrachordi, senza distintione de Interualli; percioche nella dimostratione de i Quindeci Tuoni, de i quali dicono esserne Tredici secondo la mente d'Aristosseno, con due aggiunti nell'acuto da i suoi seguaci; tanto procede il Systema dell'Hypoiastio per quei Tuoni & Semituoni, & cosi ciascun de gli altri per ordine; dal graue all'acuto, & per il contrario; quanto fà l'Hypodorio. Ne si troua la Proslambanomenos dell'Hypoiastio, (per dar'un'essempio) da quella dell'Hypodorio à lor modo, che la sola differentia d'esser l'una più graue ò più acuta dell'altra per un Semituono; come nell'essempio seguente si uede; nelquale, senza uerun proposito assegnano le chorde & li spacij all'uso nostro; ilche quanto stia bene, lascierò il giudicio à coloro, che hanno intelligentia delle cose della Musica. Il simile fanno etiandio di quello di Boethio fuori d'ogni proposito; massimamente non dimostrando altro di quello, che dimostrano. Et forse lo fanno, per dar materia di pascer gli occhi à questo & quello, & impire il libro di molte figure impertinenti al caso: stà bene: ma facea dibisogno almeno, di nominar le Positioni & i luoghi delle chorde con i proprij nomi, impostogli da gli Antichi, & le facultà loro; che forse non haurebbono appresso molti scoperto la sua sciocchezza. Nell'essempio poi ch'adducono secondo la mente di Boethio; parlando de i Modi ò Tuoni; quantunque dimostrino la Specie della Diapason, che serue à gli Otto tuoni, ò Modi in ciascuna delle Sette specie della detta Diapason, senza ueruno errore; tuttauia l'hanno dimostrato con poca intelligentia; essendoche hanno ordinato le chorde de i Tuoni, non secondo la mente di Boethio, ma più tosto secondo che più li tornaua commodo, & secondo il loro capriccio; percioche Boethio dimostrò nel Cap. 16. del 4. Lib. della Musica, che la Mese dell'Hypodorio; come sarebbe dire a. tra le chorde a. b. c. d. dell'altro essempio che segue; è lontana dalla b. ch'è quella dell'Hypofrigio, per un Tuono; quella dell'Hypolydio c. da quella dell'Hypofrigio b. per un'altro tuono; & la Mese di questo esser più graue di quella del Dorio per un Semituono; lasciando di parlare delle Nete, delle Hypate, & delle Proslambanomenos, per esser breui. Di modo che la Nete dell'Hypodorio era lontana da quella del Frigio per un tuono; da quella dell'Hypolidio per un Ditono; & quella del Dorio per una Diatessaron. Laonde si può uedere nella Dimostratione de gli Otto Tuoni secondo Boethio, che pone costoro, che le Nete de i sopradetti quattro Tuoni, ch'ordinano in esso, non sono conformi alla sua mente: percioche se ben la Nete dell'Hypodorio è lontana nell'acuto da quella dell'Hypofrigio per un Tuono, non è però la Nete dell'Hypolydio più acu page 253
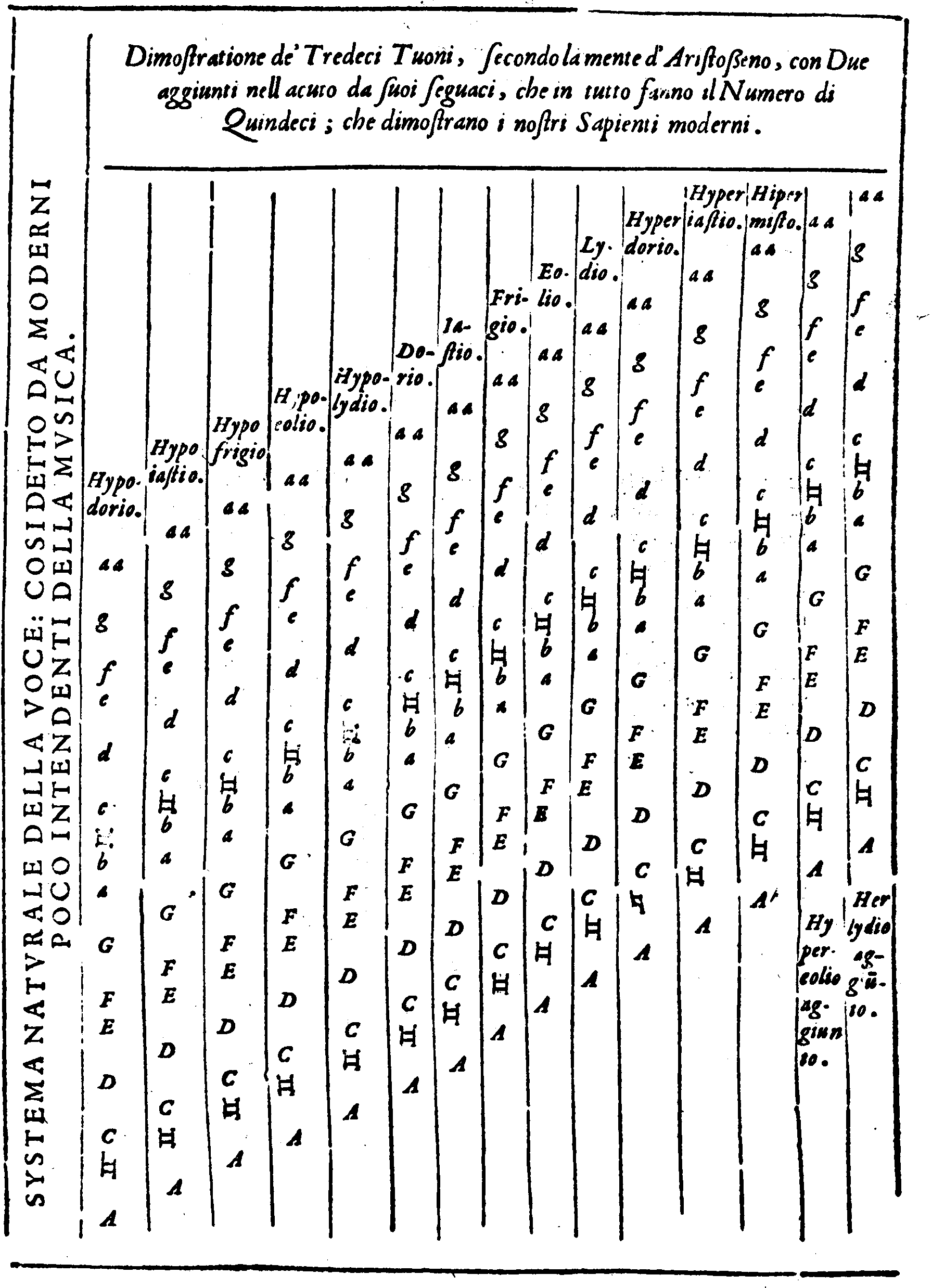
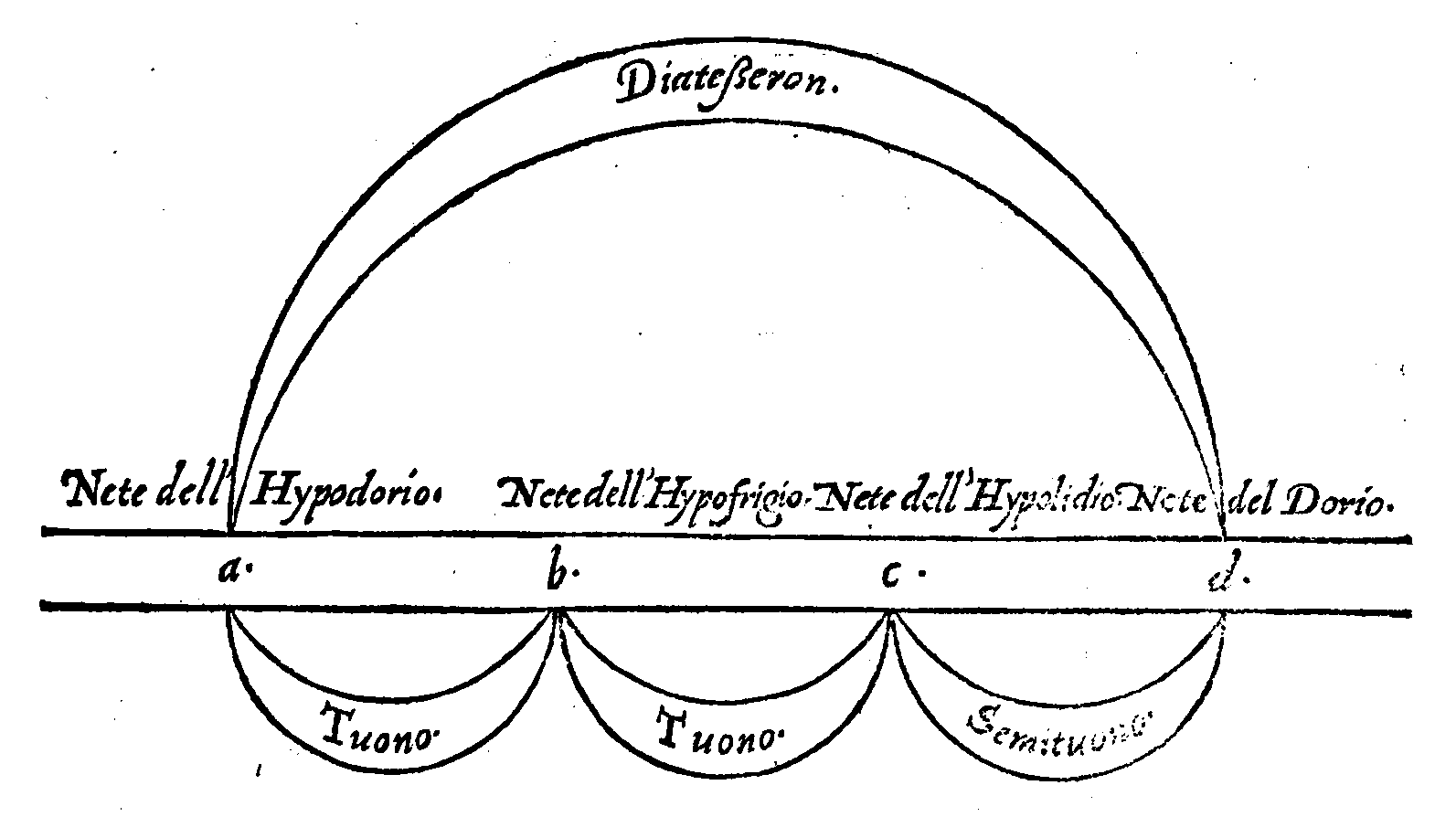
 . duro era stato prima del b. molle; senza hauerne inteso ragione alcuna di cotal fatto & fuori d'ogni proposito si mossono à dire, che
. duro era stato prima del b. molle; senza hauerne inteso ragione alcuna di cotal fatto & fuori d'ogni proposito si mossono à dire, che Si può far argomento, quanto si siano ingannato quelli, che hanno ultimamente mutato senz'alcuna ragione, l'ordine de i Tuoni, & le Specie de i Modi antichi.Ilperche oltra le ragioni c'hò renduto di questo nella Def. 8. del Quinto delle Dimostrationi, lequali non starò qui à replicare; dirò solamente, che non è cosa tanto fuori di ragione, ch'alcun possa pigliar scandolo di cotesta cosa, poscia c'hauendo ordinato le Specie delle Consonanze nel modo ch'io hò fatto; non solamente danno questa utilità, che sono molto facili da apprendere & ritenere nella memoria; ma sono anco ordinate secondo l'ordine della Natura. Et ueramente quanto all'ordine ancora, l'estreme chorde de i tre più graui Tuoni, che chiamano Plagali, & quelle de i tre più graui Autentichi, sono distanti l'una dall'altra per quell'istessi, che sono quelli di Boethio, di Tolomeo & di Briennio, mostrati ne gli essempij posti di sopra. Et se come hò dimostrato nel Cap. 39. della Seconda parte delle Istitutioni, la Diapason ch'è contenuta tra le chorde C. D. E. F. G. a.
 . c. uien diuisa dalla Natura & dall'Arte col mezo della Diuisione harmonica, in Sette interualli ch'ella contiene; & essa Natura & Arte ci dimostra, ch'è Prima considerata nella Scienza; per qual cagione ella non potrà
anco contenere il Primo modo ò Tuono, & per consequente il Primo luogo
nell'ordine de i Modi ò Tuoni? con il douere? essendoche la Mutatione di luogo in cotale ordine, non è cagione che si uaria la facoltà, & la Natura del Tuono; si come non uaria l'Huomo la sostanza & i suoi accidenti, per sedere hora
nel Secondo luogo, hauendo per auanti seduto nel Primo. Quanto poi s'ac
page 255
cordino gli essempij de gli Interualli de i Systemati ò Costitutioni de i Tuoni di
Boethio, con quelli c'hanno dimostrato; si uede in un Testo scritto à mano, ch'io
tengo appresso di me, con quello che corresse il Glareano, che fù stampato in
Basilea; & si conosce da quello che scriue pur Boethio nel sudetto Cap. 14.
del Lib. 5. percioche distinguendosi i Tuoni da i Semituoni con alcune cartelle,
com'ei le chiama; & si uede da per tutto, che quando ue ne sono due seguenti
l'una l'altra, si considera il Semituono; & quando ue ne sia una uacua di mezo,
il Tuono; ilche è cosa chiara da conoscere, che quelli Interualli, che si trouano
in uno de i sudetti Modi ò Tuoni, si trouano in tutti gli altri; come si può chiaramente conoscere in ogni essemplare di Boethio. L'altra cosa è, c'hauendo al
modo loro discorso sopra i Tuoni di questo Scrittore; non possono far, che non
confirmano quel c'hò detto, quando dicono:
. c. uien diuisa dalla Natura & dall'Arte col mezo della Diuisione harmonica, in Sette interualli ch'ella contiene; & essa Natura & Arte ci dimostra, ch'è Prima considerata nella Scienza; per qual cagione ella non potrà
anco contenere il Primo modo ò Tuono, & per consequente il Primo luogo
nell'ordine de i Modi ò Tuoni? con il douere? essendoche la Mutatione di luogo in cotale ordine, non è cagione che si uaria la facoltà, & la Natura del Tuono; si come non uaria l'Huomo la sostanza & i suoi accidenti, per sedere hora
nel Secondo luogo, hauendo per auanti seduto nel Primo. Quanto poi s'ac
page 255
cordino gli essempij de gli Interualli de i Systemati ò Costitutioni de i Tuoni di
Boethio, con quelli c'hanno dimostrato; si uede in un Testo scritto à mano, ch'io
tengo appresso di me, con quello che corresse il Glareano, che fù stampato in
Basilea; & si conosce da quello che scriue pur Boethio nel sudetto Cap. 14.
del Lib. 5. percioche distinguendosi i Tuoni da i Semituoni con alcune cartelle,
com'ei le chiama; & si uede da per tutto, che quando ue ne sono due seguenti
l'una l'altra, si considera il Semituono; & quando ue ne sia una uacua di mezo,
il Tuono; ilche è cosa chiara da conoscere, che quelli Interualli, che si trouano
in uno de i sudetti Modi ò Tuoni, si trouano in tutti gli altri; come si può chiaramente conoscere in ogni essemplare di Boethio. L'altra cosa è, c'hauendo al
modo loro discorso sopra i Tuoni di questo Scrittore; non possono far, che non
confirmano quel c'hò detto, quando dicono: Oltra che la dimostratione, che si troua nel testo di Boethio;cosa ch'ei hà trouato nel Cap. 8. del 4. delle Istitutioni;
non s'accorda in alcune parti circa l'acutezza & grauità de Tuoni, con le parole che le descriuono; la qual cosa dubito grandemente, ch'ella sia stata una delle potenti cagioni, ch'alcuni poco diligenti;ò che modo di parlare poco ciuile;
per non dir giudiciosi; hanno arditamente detto, & forse per commodo loro; che 'l Testo in quel luogo è scorretto, ilche è falso.Et nel margine, uolendo mostrar chi sia quello, che dica questa cosa, pongono queste parole:
Zarlino al Cap. 8. del 4. delle Istitutioni.Ma quanto siano maligni in questo fatto & non molto lontani dall'ignorantia, ogn'un che leggerà cotale Capitolo, lo potrà conoscere: percioche iui non parlo ne di Testo, come si suol dire, ne di Patella; è ben uero, c'hauendo ragionato intorno i Modi, ò Tuoni; & auertito sopra cotal cosa quello, ch'io douea auertire per beneficio de i Studiosi; soggiunsi all'ultimo queste parole:
Questo ho uoluto dire; non già per parlar contra alcuno de gli Antichi, ne de i Moderni Scrittori, à i quali hò sempre portato & porterò somma riuerentia; ma accioche i Lettori siano auuertiti, & considerino bene tal cosa, con ogni diligentia, & possino far giudicio & conoscere sempre il buono dal tristo, & il vero dal falso nelle cose della Musica. Ne credo che sarebbe grande inconueniente, quando alcun uolesse dire; che se bene Boethio è stato dottissimo nelle cose speculatiue della Musica, che poteua essere, che delle cose della prattica non fusse cosi bene intelligente; ilche veramente si può confirmar con quello, che si è detto di sopra, & con quello che hò mostrato nel Cap. 13. della Terza parte; quando ragionai delle quattro Specie della Diapente. Ne di ciò habbiamo da marauigliarsi; percioche ciascuno, inquanto è Huomo, dalla propria opinione può essere ingannato. Ma ricordiamoci quello, che scriue Horatio nella Epistola dell'Arte poetica, quando dice:Questo però c'hò detto, non si potrà dire che non torni in pregiudicio d'alcuno. A questo soggiungono anche con la solita arroganza & usanza solita di dir male, parlando pur del testo di Boethio;Verum opere in longo fas est obrepere somnum.percioche potrà essere ottima escusatione à questo grauissimo autore, & etiandio à ciascun'altro, che scriue molto di lungo.
Ma è bene scorretta e mal concia la Dimostratione, mercè della poca accuratezza; per non dire, come più si conuerrebbe, intelligenza di quelli, ch'in Venetia l'Anno 1491. si pigliarono cura di stamparlo; alqual numero de Tuoni si attenne facilmente Boethio, per consiglito d'Alipio, quantunque non ne faccia mentione; trouando in esso i Caratteri da segnar distintamente le chorde di ciascun di essi otto Modi; oltra al uedere con i sette soli non hauere occupato; come dicono, tutte le Quindeci chorde del Systema.Laonde sopra queste parole si può dir prima; che se quei di Venetia non hebbero quell'accuratezza & intelligentia nel stampar l'Opera di Boethio, come bisognaua; per qual cagione le sue Eccellentie hanno lasciato uscir fuori cotal Dimostratione page 256 de Tuoni, incorretta, & simile à quella del testo scorretto di Boethio, se conosceuano c'hauea dibisogno di correttione? Dopoi, se Boethio si consigliò con Alipio sopra i Caratteri da segnar le Chorde de i Modi, come dicono; per qual cagione, non presero anco il conseglio d'Alipio, nel porre il numero de i Tuoni in tutti i Generi; & non posero i Caratteri ò Cifere proprie à ciascuno di essi, che sono al numero di Quarantacinque, come habbiamo detto di sopra, & come si può uedere in due Testi Greci scritti à mano, che sono appresso di me; l'uno & l'altro de i quali in qualche parte sono imperfetti. Et perche alcuni si potrebbono forse marauigliare, ch'io habbia uoluto pigliar la diffesa d'una cosa tanto leggiera & manifesta à tutti quelli c'hanno cognitione di questi Autori; però dico, che ciò non hò fatto fuori di ragione; essendo che questi Moderni speculatiui, in più luoghi m'hanno citato, come quello che non tenga alcune loro opinioni, le quali mai non hebbi ne per buone, ne per uere; ne anco mai le hò nominate; come si potrà sempre conoscer da i miei Scritti.
De gli errori c'hanno commesso alcuni de Moderni intorno il ragionar de Tuoni. Cap. V.
Aristosseno fù di parere, secondo che racconta Aristide Quintiliano, Briennio & Euclide nell'Introduttorio ch'ei fà di Musica,ilquale Introdottorio pongono in dubio ch'egli sia suo;
che i Modi douessero essere Tredeci & non Sette ouer Otto ò altro numero minore; de i quali auanti lui si hauesse alcuna cognitione; imperoche nel considerar quelle cose, delle quali fecero mentione ne i suoi tempi & auanti molti honorati Scrittori; oltra gli altri Tolomeo & Boethio; trouando dopoi tra il Lydio & il Mistolydio, & tra l'Hypodorio & il Dorio la distantia d'un minor Semituono & Lemma, andò dentro di se stesso cosi discorrendo: Si come dallo inacutire & ingrauire il Systema per un minor Semituono, nasce tra essi Modi sensibile & apparente differentia di affetto; ò almeno più in quello che in questo è la operatione secondo la natura sua efficace; quanto maggiormente lo douerà fare l'intiera metà del Tuono? e trouandosi tal uarietà d'harmonia & d'affetto tra li sudetti Modi; per qual cagione non sarà ancora in qual si uoglia altre chorde distanti l'una dall'altra per un si fatto Interuallo?Questo è ueramente un bellissimo & giocondo discorso degno d'un Filosofo, com'era quel Xanto padrone d'Esopo fauoleggiatore, ma non d'un Aristosseno; alqual discorso aggiungono questo Commento; dicendo:
Et con tali ragioni tra se stesso argomentando, diuise in cinque Tuoni & in due Semituoni minori, che in se contiene(ò bell'auertimento)
la Specie della Diapason, che seruiua al modo Dorio in dodeci parti equali; & à ciascun termine di esse parti, che uengo page 257 no à esser Tredeci, sendo Dodeci gli Interualli, costituì la media di uno di essi Tuoni;nominandogli & disponendogli nella maniera che si uedono nell'essempio posto nel Capitolo precedente. Ma questo che segue, non è men bello & diletteuole di quello c'ha detto, che:
Dalle parole del qual Musico & Filosofo nobilissimo(che non si trouano in alcun luogo, se non nella Idea di questi Speculatiui)
Tolomeo prese occasione di riprenderlo de piu cose; tra lequali ue ne sono tre di qualche consideratione;come sono le due prime, ch'io non replicarò in questo luogo, per hauerle raccontate altroue; ma dirò della Terza & ultima, ch'è intorno à i Tuoni, qualche cosa. Dallequali parole, si può considerar molte cose: prima dicono, ch'Aristide Quintiliano racconta, ch'Aristosseno fù di parere, che i Modi douessero esser Tredeci & non Sette ouer Otto ò altro minor numero; nondimeno Aristide nel Primo libro dice, che secondo Aristosseno sono Tredeci, & secondo 'l parere di più moderni sono Quindeci, de i quali le Proslambanomenos sono aggiunte alla Diapason per un Tuono della Separatione. Ma Emanuel Briennio nella Seconda Settione del 3. Lib. non parla altramente ne de Tredeci ne de Quindeci dell'ordine dell'Istrumento, i quali commemora Aristosseno ma solamente fà mentione de quelli che di sopra hò commemorato; che sono Otto. Pongono dopoi fuor d'ogni proposito difficultà; se l' Introdottorio di Musica nominato di sopra sia d'Euclide ò nò; & questo forse, perche Georgio Valla Piacentino lo tradusse prima dalla Greca nella lingua Latina sotto 'l nome di Cleonida: ma dopoi da Giouanni Pena di natione Francese fù tradotto sotto 'l nome di Euclide: onde l'istessa difficultà si può porre intorno à quello ch'ei fa περὶ τοῦς κατατωμὴ κανόνος; della Settione del Canone ò Regola harmonica posto fuori insieme col sudetto Introdottorio; percioche nel Testo tradotto dal Pena sono citate alcune Proposte, senza che l'autore nel Testo greco dica, Ne 'l tal libro de miei Elementi; ma dice semplicente Nel tal Libro de gli Elementi. Ma questa difficultà è tolta uia da Porfirio ne i Commentarii, ch'ei fà sopra il Cap. 5. del Lib. 1. de gli Harmonici di Tolomeo ; percioche pone questo Tratratello tutto intiero; se ben ui è qualche differentia con quello ch'è stampato in Parigi greco, sotto 'l nome d'Euclide. Vi è anco il testimonio di Proclo ne i Commentarii ch'ei fà sopra il Primo de gli Elementi d'Euclide, ilquale nel Cap. 6. del Primo libro, commemora l'Elementari istitutioni, & il Libro delle Diuisioni, citati di sopra; sotto 'l Titolo di Introdottorio (come credo & tengo per certo) & della Settione sudetta. Et di più, ne in questo Testo, delquale si seruì il Pena; ne anco nella Traduttione del Valla; ne meno in quello di Porfirio, si trouano le sudette citationi. Dicono oltra di questo, ch'
Aristosseno nel considerar quelli Tuoni, de i quali fecero mentione ne i suoi tempi & auanti & anco dopoi molti honorati Scrittori, oltra gli altri di Tolomeo & Boethio; & trouando tra 'l Lydio & il Mistolydio, & tra l'Hypodorio & il Dorio la Distanza d'un minor Semituono & Lemma; andò dentro à se discorrendo con quelle parole si come nell'acutire;& quello che segue, che sono poste di sopra. Ma di gratia uedino & considerino i Lettori questo bello & arguto discorso, ch'attribuiscono ad Aristosseno; & potranno conoscer col loro giudicio quel, che potea esser questo gran Musico & Filosofo, secondo 'l Capriccio di costoro. Quello poi che non è di poco momento, è; che nel porre gli essempij secondo la mente d'Aristosseno, pongono nel Primo ordine (come dicono) il Systema naturale della Voce; come si uede nell'essempio posto nel Capit. precedente; forse non sapendo, che cotale Systema è quell'istesso che pone Tolomeo nel Tuono ò Modo Dorio; & quello ch'è di maggiore importantia, si uede che non ui è differenza alcuna d'un Tuono all'altro, se non il graue & l'acuto; percioche tra la prima & la seconda chorda graue di qual si uoglia Tuono ui è l'inter page 258 uallo del Tuono; & tra la seconda & la terza, quello del Semituono; tra la terza & la quarta, quello del Tuono ancora; & tra la quarta & la quinta simigliantemente il Tuono. Onde si uede tra l'ottaua & la nona di ciascheduno esser un' istesso Interuallo; cosi tra la nona & la decima, come anco tra questa & la undecima; di maniera che dall'Hypodorio all'Hypoiastio ouer Lydio graue non ui è differentia alcuna, se non che l'uno è più acuto ò più graue dell'altro per un Semituono. Et ciò auiene dal poco loro giudicio; perche non sanno, che ogni Tuono (come habbiamo dimostrato) hà la sua Hypate, la sua Mese, & la sua Nete, con la sua Proslambanomenos differenti da quella d'un'altro. Laonde si può comprender da quello c'habbiamo dimostrato di mente di Boethio; che la Hypate dell'Hypodorio (lasciando il primo ordine, cioè questo loro Systema naturale della Voce, nella sua qualità) diuenta la Proslambanomenos dell'Hypodorio, ouer del Lydio graue. Onde tra la prima grauissima chorda di questo & la seconda, si troua l'Interuallo del Tuono; come si troua anco tra la seconda & la terza, che sono l'istessa dell'Hypodorio: Et cosi in questo hanno grandemente errato; percioche al modo che l'intendono, sarebbe quella differentia istessa tra Tuono & Tuono, che si troua tra due che cantano una cosa istessa l'un più acuto ò più graue dell'altro, che si troua anco tra l'Huomo di età matura & un Fanciullo; essendoche tra loro non u'è alcuna differentia, parlando quanto alla Forma dell'Huomo, che la grandezza; quantunque non si possa negare, ch'un istessa Cantilena possa più ò meno muouer l'animo, secondo la qualità della Voce & de gli accenti che la seguitano. Quanto poi alle oppositioni che dicono, che fà Tolomeo à gli Aristossenici; se intendessero le cose per il diritto & come si debbono intendere, ritrouarebbono, che Tolomeo non senza cagione si muoue à riprenderli; come da quello che segue potremmo facilmente comprendere.
Che non faccia dibisogno, che i Tuoni siano acuti l'un più dell'altro per un Semituono. Cap. VI.
Che bisogna, che gli estremi Suoni de Tuoni siano terminati nella Diapason; & quanti siano in numero secondo la mente di Tolomeo. Cap. VII.
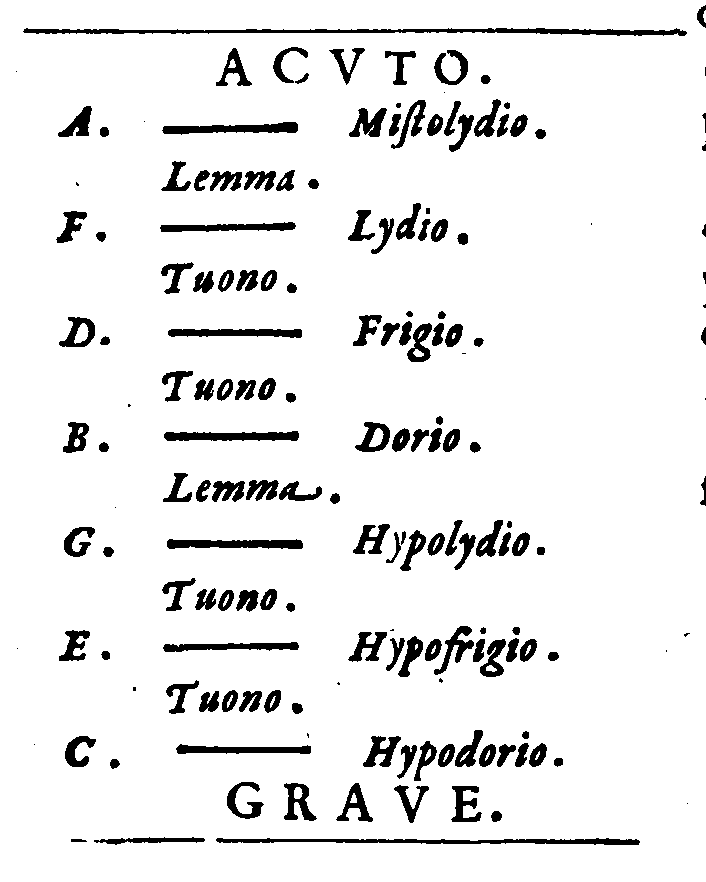
Quello che indusse Tolomeo à dir, che non u'eran più di Sette Tuoni ò Modi. Cap. VIII.
Di quello che discorrono alcuni in materia de i Tuoni, ò Modi. Cap. IX.
Εἶναι δ'αὐτῷ τὰ πρῶτα τῶν ἐναρμονίων τοιαῦτα. τιθέασι γὰρ τούτων πρῶτον τὸν σπονδεῖον, ἐν ᾧ οὐδεμία τῶν διαιρέδεων τὸ ἴδιον ἐμφαίνει, εἰ μήτις εἰς τὸν συντονώτερον σπονδειασμὸν βλέπων αὐτὸ τοῦτο διάτονον εἶναι, ἀπεικάσῃ. δῆλον δ'ὅτι καὶ ψεῦδος καὶ ἐκμελὲς θήσει, ὅτιοῦτο τιθεὶς. Ψεῦδος μὲν ὅτι δισει ἔλαττιόν ἔστι τόνου τοῦ περὶ τόν ἡγεμόνα κειμένου. ἐκμελὲς δὲ, ὅτι καὶ, εἴ τις τῇ ἐν τοῦ τονιαίου δυνάμει τιθείη τὸ τοῦ συντο page 266 νωτέρον σπονδειασμοῦ ἴδιον, συμβαίνοι ἂν δύο ἑξῆς τίθεσθαι διάτονα, τὸ μὲν ἀσύνθετον, τὸ δὲ σύνθετον. τὸ γὰρ ἐν ταῖς μέσαις εναρμόνιον πυκνὸν, ὧ νῦν χρῶνται, οὐ δοκεῖ τοῦ ποιητοῦ εἶναι. ῥᾴδιον δ'ἐστὶ συνιδεῖν ἐάντις ἀρχαϊκῶς τινος αὐλοῦντος ἀκούσῃ, ἀσύνθετον γὰρ βούλεται εἶναι, καὶ τὸ ἐν ταῖς μέσαις ἡμιτονιον. τὰ μὲν οὖν πρῶτα τῶν ἐναρμονίων, τοιαῦτα, ὕστερον δὲ τὸ ἡμιτόνιον διηρέθη, ἓν τε τοῖς λυδίοις καὶ ἐν τοῖς φρυγίοις.Cioè:
In questi veramente pongono nel primo luogo lo spondeo, nel quale non dimostra alcuna cosa di proprio della sua diuisione; se però alcuno, hauendo rispetto à più ristretta vsurpatione dello Spondiasmo, non lo riputasse hauere del Genere diatonico. Ma è manifesto, colui che fà cotesta cosa, che non solamente lo pone falso; ma anco dissonante. Falso dico; percioche è minore del Tuono per un Diesi, ch'è posto nel primo luogo; & Alieno dal Canto; percioche se 'l si porrà nella forza & potestà del Tuono il proprio dello Spondiasmo piu ristretto, nascerà ueramente che due Diatoni continui & perpetui saranno l'un dopo l'altro, l'un composto & l'altro incomposto. Imperoche quello che si dice Denso Enharmonico, ch'è collocato nelle chorde mezane & hoggi è in uso, non par che sia del Poeta; essendoche questo si può facilmente comprendere, s'alcun'udirà alcun cantare ò sonare secondo l'uso antico alla Tibia; percioche vuole anco, che 'l Semituono delle mezane sia incomposto. Et tale furono da principio le cose che usaua il Genere Enharmonico: dopoi, in successo di tempo fù diuiso il semituono ne i Lydij & ne i Frigij.Questo è quello che dice Plutarcho; oue si uede, che la natura de i Generi non consisteua semplicemente nell'Harmonia; ma ne i Piedi posti nella Oratione. Dopoi (lasciandone da un canto qualchedun'altro Antico scrittore) uerremo ad Antonio Lullo, Baleario scrittore moderno, che hauendo hauuto forse riguardo à tal cosa, discorre (se ben fu poco il discorso, nel Cap. 6. del 5. Lib. ch'ei fa della Oratione) sopra i Modi ò Tuoni per tutti tre i Generi; in questa maniera;
Ogni Melodia del modo del parlare detto da Greci Διαλέκτος, è contenuta nello spacio della consonanza Diapente, & anco trappassa più oltra: dopoi che 'l Canto, & il Suono de gli Istrumenti, che cominciano dalla Diapason, cantano per la Diapente, per la Diatessaron, per il Ditono, per lo Semiditono & per la Diesis.Ilperche uolendo egli incominciare à dimostrare il Genere della melodia, ch'è composta (com'altroue dicemmo) d'Oratione, Rhythmo & Harmonia; la differenza de i Modi ò Tuoni, contenuti ne i Versi ò Metri de Poeti; & anco la forza del parlare; cose che non sono lontane dalla Imitatione, dà principio à questo modo.
Non si può dire ò finger cosa che sia men modulata, di quello ch'esclama quella Parturiente di Terentio: And. 3. Act. Sce. 1. & Adelph. 3. Act. Sce. 4.& dice, che s'egli dimostrerà il Genere della melodia, & il modo, & la forza del parlare, che niuno dubiterà più d'una cosa certissima. La onde introduce il Monochordo Pithagorico diuiso secondo i tre Generi di Pithagora: nelquale percuotendo prima la Tritehyperboleon enharmonica, tre fiate ascendendo alla Nete, & di nuouo continuamente ritornando à dietro, cessa nella Netediezeugmenon; & cosi uuole, che la uoce piglia la modulatione Frigia di quello Metro: Iu¯ no¯ Lu¯ ci¯ na ˘. Dopoi quel che segue; Fer ˘. O ˘ pem¯: muoue la Paranete chromatica hyperboleon & la Trite d'esso tetrachordo, facendo fine nella Netediezeugmenon. Il resto, Ser¯ ua¯ me ob¯se ˘ cro ˘. uuol che sia pronunciata diatonicamente & anco nel modo Eolico nel tetrachordo Diezeugmenon; percossa prima tre fiate la Paranete, & dopoi anco la Nete; & ritornando dopo quello all'istessa Paranete, che la uoce uenga à continuare, laquale ultimamente manchi nella Trite ò Terza. Dice però, ch'alcun non si dee marauigliare, se questa intentione di uoce hà superato la Sesquialtera, & concluda il Dialetto tra la consonanza Diapente: imperoche quelle non è se non Chiamore, & non Parlare; & la Femina quanto ella puote alza la uoce. Vuole anco, che niun'altro sia più magnifico, ne tanto uenerando di questo parlare.Iuno Lucina fer opem; serua me obsecro:
Auratus aries Col page 267 chorum;se non perche il concento del Dorio finisce la clausula del Genere diatonico: essendoche nel canto si terminano le forme dal fine di qual si uoglia modo: Ma nella lettura & propria forma del parlare, piu tosto dall' ingresso. Ilperche attribuisce ad Horatio il leuarsi spesse fiate; ancorache non sempre: percioche dicendo;
Moecenas áttauís édite régíbus:uuole che sia uirile & diritto, & che sia incominciato Doricamente; poiche subito più frequentemente ascenda; che discenda, & questo fà hora col Tuono, hora col Semituono, & hora col Ditono: & uuole che lo seguente com'alquanto obliquo & piegato; & quasi Hypolydio:
Lydìà díc pèr ómnes Té dêos ôro. Sybarím cùr próperâs ámándo Pérdere?essendoche subito descende per Ditono, & descende più frequentemente; & abbassa un Tuono col fine Ditono. Tiene anco, che non per altra cagione si troua la Frigia in quello, & in questo la Modulatione:
Scribérís uarió, fórtis & hóstibusVuole simigliantemente, che questo; ilche è proprio del Frigio, ripigli due fiate lo spacio del Semituono; dopoi il Semiditono & tonieo; leuando ouer'alzando l'ultima nel fine. Dice però, che 'l seguitar questo scropolosamente, è troppo faticoso; & non è da negare ogni fatica à i Studiosi. Spiega anco in questo luogo quello, ch'ei intende; con dire, che 'l Canto ò Melodia non si hà da misurar tanto dalla quantità delle Sillabe; come dicemmo altroue; quanto dall'accento: primieramente dalla proprietà della Dittione; dopoi dalla natura delle Vocali; dellequali l'una è maggiormente uocale & sonora dell'altra; ouer per il contrario, più arguta ò forte; & più tenue ò debile; percioche tanto più è fatta acuta, quanto è proferita co 'l sito più angusto & ristretto della bocca; nel modo che la più larga Fistola manda fuori il Suono più graue. A questo aggiunge la separation delle parole, con la qual si schiua la Synalepha: essendoche si suole alzare & far'acuta la uocale seguente, acciò maggiormente habbia luogo: come à dire:
Víctòr Maeónij Cármìnìs alité.
Quàm rém cumque féròx náuìbùs aùt équìs
Míles te dúcè gésserìt.
Authoritate publica ármàtè.Però dice, che accade, che l'istessa lettera succedente è più interiore per l'accento della parola; come dire:
Vario fórtis;& quella che più; & perciò più graue: nondimeno s'alza per la quantità; come in
Variò.Ilperche in questo luogo alle due breui precedenti
Attauis,ancora che l'accento sia collocato nella prima; nondimeno l'ultima si leua longa & stridula; & la prima della seguente dittione, per il proprio accento superò l'intensione della precedente. Aggiunge etiandio, che in queste cose la Locutione hà il suo accento, & che l'interrogatione fà acuta la finale; & li pare che Varrone habbia introdotto; come sarebbe la parola
Obsecratio,fare il circonflesso nelle penultime: lequali innalza; come,
Serua me obsecro.Conclude finalmente, & dice: adunque dall'accento della Dittione, & dalla quantità della Syllaba, dopoi dalla natura delle Vocali argute ò caue, si piglierà non solo dalla separatione dalla Dittione & dalla Figura delle sententie, ogni intensione ò remissione della modulatione. Tiene anco, che dal principio delle sillabe l'una all'altra succedenti, ogni intensione, sia uirile & diritta; per il contrario, quella che discende dal Principio, & dopoi si leua, sia religiosa & lamentabile. Ma la uaria & piegata sia flebile & soaue: Cosi anco scambieuolmente sia l'intensa & rimessa, non circonflessa & furibunda; come,
Mené incéptò desistere uictám?ultimamente piana & moderata. Ma la modulatione graue & moderata dice farsi, quando si tira à poco à poco il primo membro, che ascendi; & che le cose mezane siano piane; cascando l'ultimo al fine: come page 268 incominciò Cicerone nella Miloniana;
Et si uereor Iudices, ne turpe sit pro fortissimo;fin qui ascendendo; ch'à poco à poco fece il Systema Diapente; partendosi di quà, & fermandosi nell'istessa chorda; fuori che nella penultima sillaba di quel membro; laquale abbassò col Semituono, secondo 'l costume Dorico. Et finalmente nella clausula di cinque sillabe fece fine. Vuole anco, che la grauità & l'acutezza di questa Clausula, non consista d'altra parte; perche questa sola abbraccia la generosissima & sopra tutte l'altre harmonia Doria; percioche il fine di questa è posta nel cader continuo de cinque uoci, della quale il Semituono si troua nel penultimo spacio. Questo discorre il Lullo nel luogo citato di sopra: ma nel Cap. 7. del 6. Lib. dice:
La Melodia ò canto Dorio ouero Eolio sarebbe se la Giuntura non gli leuasse lo splendore, quale è:Ma Horatio Flacco imitatore di Pindaro; non hebbe molto timore della austera compositione. Nell'altra la Giuntura, è lieue, ma il Tuono Lydio è più molle, che splendido;O Latonia maximi
Magna progenies Iouis;
Quam mater prope Deliam
Deposuit oliuam,
Montium domina, aut fores.
Syluarumque viuentium.
Quem Deum? cuius recinet iocosa& quello che segue:
Nomen imago.
Aut in vmbrosis Heliconis oris.
Vnde vocalem temerè insequutaEt nel Cap. 16. dice finalmente il Canto ò Melodia mistalydia esser delicata; come,
Orphea sylua.
Passer deliciae meae puellae;fin'à quello che può esser Lydio:
Vestra nunc opera meae puellae;& più florido esser l'Eolio: come da gli essempii posti disopra si può osseruare, & in molti quel Genere chromatico, che si chiama Molle. Dice anco il sudetto Lullo nel fine del Lib. 5. di hauer scritto l'Arte intiera della Musica, laquale, per molta diligentia, ch'io habbia usato di ritrouare, non hò potuto ancora hauerla nelle mani; ne anco hò potuto sapere, s'ella sia in luce. Questa si dee per ogni modo cercare di hauere s'el si puote; percioche leggendola & studiandola bene, potrebbe forse essere di non poco utile in questo negotio, pieno di molte difficultà; & cagione d'hauere più essatta cognitione di quello c'habbiamo di molte cose nella Musica.
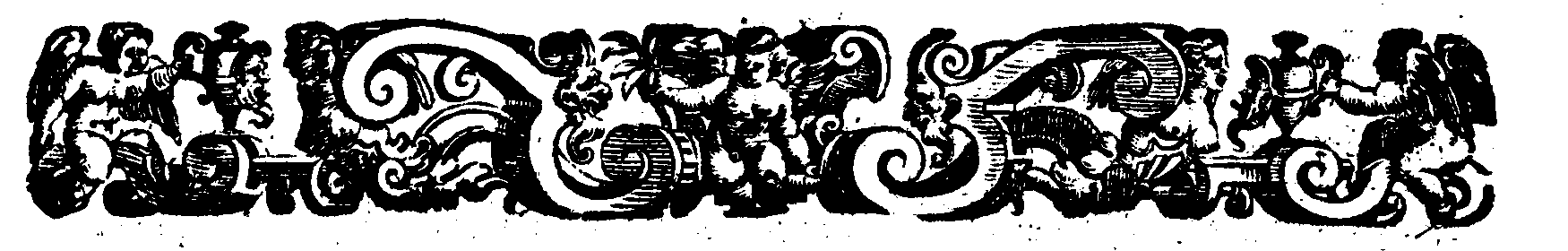
Settimo Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
Della Mutatione & delle sue Specie. Cap. I.
Delle affettioni ò Costumi dell'Animo; & quello che sia ciascuna da per se. Cap. II.
Collis ò HeliconijL'altro
Cultor, Vraniae genus,
Qui rapis teneram ad virum
Virginem, ò Hymenaee Hymen
Hymen, ò Hymenaee:
Vesper adest iuuenes; consurgite: uesper OlimpoEt il terzo.
Expectat diu uix tandem lumina tollit.
O decus eximium, & magnis virtutibus augensi quali sono pieni di tanta soauità & purità; che quanto più costringono l'Huomo à leggerli, tanto piu lo smarriscono nel uolerli imitare. Si troua etiandio quello d'Ausonio Gallo, composto solamente de Versi di Virgilio; ilquale cosi incomincia: page 272
Aemathiae columen Pelaeu.
Accipite haec, Animis laetasque aduertite mentesErano oltra di questi le Nenie, inuentioni de quei popoli, che habitauano la Frigia; & communemente si poneuano tra quel Poema, che si cantauano da quelli che erano pieni di mestitia, & piangeuano la sua trista fortuna. Ma quelle che gli Antichi erano soliti cantare nell'abbrusciare i Corpi de i loro morti, erano ueramente dette Nenie; & quelle, che cantauano sopra i Sepolchri, erano dette Epitaphii. Quelle poi che usauano nell'Essequie, quando faceuano i Sacrificii per i Morti, Epicedii nominarono. Ma il Pontano nostro Italiano Poeta celebratissimo, & d'ingegno eccellentissimo, ridusse questa parola Nenie al canto che fanno le Nutrici, che in Italia si chiamano Nene, quando uogliono far pigliar sonno à i loro fanciulli; lequali (come si può uedere) par che siano simili alle Cantilene di quelle Donne, che sono condotte in molti luoghi dell'Europa, à cantar cose lugubri & lamenteuoli sopra i corpi de Morti, per indurre i circonstanti à piangere. Onde tra quelle del Pontano, che sono molte, ui è la prima, che incomincia cosi:
Ambo animis.
Somne ueni tibi Luciolus blanditur ocellis.Le lamentationi anco, lequali chiamauano Θρήνοι, erano composte, come sono le Lamentationi di Gieremia, nellequali il Santo Profeta deploraua le miserie & le calamità della Santa Città i Gierusalemme. Quello poi che fusse l'Essodio si potrebbe indouinando forse dire, che fusse una compositione fatta in Versi, la quale si usaua cantare ne gli Ingressi dell'Espeditioni ò de i Viaggi; ma non ui essendo cosa alcuna, che dica con certezza quello, che ello si fusse, lasciaremo questa cura ad altri, che lo esplica; ne procederò più oltra à uoler ragionar di lui, & seguitaremo il nostro proposito; bastandoci di dir solamente, che i Musici antichi, i quali erano anco Poeti, & riputati Indouini, in cotal modo considerauano & insieme trattauano le cose della Musica; come etiandio dimostrai ne i Cap 5 & 6. della Seconda parte dell'Istitutioni; ne quali ciascun potrà comprender molte cose, che gli potranno essere di gran giouamento; & potrà essere raguagliato di quelle, intorno lequali forse già potea dubitare. Laonde da quello che si è detto, ogn'uno potra conoscere in qual maniera cotali cose erano da gli Antichi considerate & composte & cantate; con somma grauità sotto diuersi Numeri & Harmonie diuerse; & potrà comprendere, quanto siano differenti da quelle le Cantilene, che compongono alcuni de nostri Compositori moderni, senza Numeri, senza Modi, senza buon'Harmonia, & senza alcuna grauità. Et peggio anco, che in esse non si troua alcuna differenza tra quelle che compongono per seruire al culto Diuino, nel lodare, pregare, & ringratiare Iddio nostro Signore, & à laude & gloria de i Santi cittadini del cielo, & di tutte l'Anime beate; & quelle che seruono ne i Theatri, ne i Giuochi, nelle Feste publiche, ne i Conuiti & ne i Balli: lequali sono piene de Numeri leggieri & di Mouimenti uani & lasciui, aggiunti alle fiate à parole uane, sporche, & piene di lasciuia, che offendono le caste orecchie de gli Vditori. Et si odono tutte le cose loro fatte ad un modo, & in un medesimo stile: percioche quei Numeri & quell'Harmonia che si ode in una Messa, & in uno salmo; che sono cose piene di grauità & santità; si ode anco in una Canzone ò Barzelletta, cosa uana & ridicolosa. Et dirò di più, cosa che mi fà alle fiate arrossire; che sono alcuni tanto temerarij & di tanta sfacciatezza, ch'ardiscono d'accommodare i cantici Euangelici & altre cose simili della Santa Scrittura, piene di santità & religione ad un'Aria d'una Canzone, la qual in se contiene parole lasciue & dishoneste; del che sono ueramente page 273 degni di riprensione & di castigo: percioche dimostrano di esser poco religiosi. Ne uale à dire, che cotali parole non si odino; essendoche troppo bene basta il Numero & il Mouimento che si ode nel suono, à far ricordare quello che in tutto si dourebbe discordare. Però ogn'uno per l'auenire si sforzerà di comporre in tal maniera le sue Cantilene, che habbiano in se quella grauità & quei Numeri & Harmonie, che siano conueneuoli alle Parole, che pigliano ad imitare. Ne speri alcuno col mezo di queste cose contrafatte di acquistarsi il nome di buon Compositore; perciò ch'altro ci uuole; & quando haurà creduto d'hauerselo acquistato, allora conoscerà in fatto, d'hauerlo perso. Attendi adunque ogn'uno al fatto suo, & passiamo più oltra hormai; & ragioniamo piu essattamente della Mutatione, che diceuano gli Antichi farsi per il Tuono.
Delle Mutationi che si dicono farsi per i Tuoni. Cap. III.
 . quadro; dopoi lasciandosi cotale Tetrachordo si passasse per quelle del Synemennon, ò congiunto; che si dice di b. molle; fin'al fine di detta Cantilena; Ilche si fà anco non
solamente in una Cantilena, che sia composta di una sola parte, ma in ciaschedun'altra, che ne contenga due. Laonde questo ueramente si può chiamar più
tosto (com'hò detto ancora) Mutatione di concento che di Tuono; percioche
in quella maniera il Concento non fà mutatione alcuna; onde non apporta à i nostri sensi alcuna alteratione nella facoltà,
per laquale s'habbia à muouere il costume; ma solamente quella, che consiste intorno al più graue ò al più acuto. Ma
in questa Seconda mutando il concento il suo ordine; & non la Tensione, per cagione della Cantilena; si parte dal consueto & aspettato concento, che si fà, come sarebbe dire, nella Diapente consona ne i passaggi; onde fà la uarietà nella
Diatessaron; come già si è mostrato in essempio delle Complessioni ò Costitutioni; percioche il Canto quando passa alla Mese ò Mezana, non secondo 'l solito
nel Tetrachordo diezeugmenon ò del
. quadro; dopoi lasciandosi cotale Tetrachordo si passasse per quelle del Synemennon, ò congiunto; che si dice di b. molle; fin'al fine di detta Cantilena; Ilche si fà anco non
solamente in una Cantilena, che sia composta di una sola parte, ma in ciaschedun'altra, che ne contenga due. Laonde questo ueramente si può chiamar più
tosto (com'hò detto ancora) Mutatione di concento che di Tuono; percioche
in quella maniera il Concento non fà mutatione alcuna; onde non apporta à i nostri sensi alcuna alteratione nella facoltà,
per laquale s'habbia à muouere il costume; ma solamente quella, che consiste intorno al più graue ò al più acuto. Ma
in questa Seconda mutando il concento il suo ordine; & non la Tensione, per cagione della Cantilena; si parte dal consueto & aspettato concento, che si fà, come sarebbe dire, nella Diapente consona ne i passaggi; onde fà la uarietà nella
Diatessaron; come già si è mostrato in essempio delle Complessioni ò Costitutioni; percioche il Canto quando passa alla Mese ò Mezana, non secondo 'l solito
nel Tetrachordo diezeugmenon ò del  . Quadrato passa per la Diapente consonanza; ma quasi ripiegato si porta alla detta Mese del Tetrachordo synemennon ò di b. molle, accioche in luogo della Diapente si oda la Diatessaron in quelle uoci, che precedono la detta Mese. Ilperche se gli fà in opposito & all'incon
page 274
tro la Commutatione, ingannando il Senso, ilquale già aspettaua un'altra cosa.
Onde nel trattar moderatamente cotal cosa, uiene ad essere atto & utile alla
Modulatione; & quando si facesse il contrario, sarebbe utile & anco inetta. Però molto leggiadra & quasi un'istessa si mostra esser quella Mutatione per la facoltà, ch'è simile alla prima; riceuendo (dirò cosi) incrocciamento del Tuono
della Disgiuntione; per il quale è differente la Diapente dalla Diatessaron; non
tanto nel reassumere i Suoni; percioche essendo esso Tuono à i Generi commune, può fare in essa una manifesta mutatione; quanto perche una di quelle due
proportioni ò ragioni de suoni, che sono ne i Tetrachordi, muta la Cantilena.
Oltra di ciò, perche cotal cosa è fatta con moderatione, da quello ch'è statuito primo tra i Suoni; essendoche nel canto non
fanno ne troppo grandi, ne troppo picciole digressioni; l'una & l'altra dellequali porta difficultà all'Vdito, nell'accettarle. Si fanno adunque tre Tetrachordi tra loro cambieuolmente l'uno all'altro corrispondenti; congiunti alla propria ragione
ò proportione di cotal Mutatione;
come quelli che sono nell'essempio posto nel Cap. 5. del 5. Libro: con una certa
mistura particolare di due Complessioni disgiunte, quando tutte le Diatessaron
sono differenti tra loro per un Tuono. Ma perche fin'al tempo di Tolomeo non
era appresso gli Antichi in uso l'augumento de i Tuoni; perciò gli Antichi conobbero solamente il Dorio, il Frigio, & il Lydio
esser differenti tra loro per un Tuono; onde li chiamarono Equitoni; perche non arriuarono dal più acuto al più
graue; ne per il contrario, con l'interuallo della Diatessaron; ne poterono da i
Disgiunti far dopoi tre Tetrachordi; onde compresero sotto 'l nome di Complessione il Synemennon, accioche hauessero in pronto la esposta loro Mutatione. Imperoche in quelli Tuoni, che si eccedono l'un l'altro per lo spacio della
Diatessaron; ouer'in l'uno & l'altro suo Tetrachordo, che uà inanti simile Disgiuntione & più acutamente si congiunge al graue nella parte più acuta; fà nel
più graue tre Tetrachordi congiunti; de i quali, quello ch'è aggiunto, è fatto
acutissimo; ouer de quelli che seguono simile disgiuntione de Tetrachordi, il
più graue si congiunge al più acuto nella parte piu graue, & fà etiandio tre Tetrachordi congiunti, de i quali, quello che fù aggiunto, è il grauissimo; come si uedono nel sudetto essempio. Ilperche potiamo comprendere, che quella Constitutioue ò Complessione, ch'è congiunta & applicata alle perfette Complessioni
disgiunte per la Diatessaron sia superflua; & non conseguisca la natura della perfetta Complessione; com'è manifesto da quello, che si è già detto nel sudetto Cap.
1. La onde di nuouo è da distinguere & definire, che di quelle Mutationi, che si
fanno secondo le Costitutioni, che propriamente chiamano Tuoni; essendo che
acquistano le lor differentie dalla Tensione; è ueramente una moltitudine infinita in potenza; come sono anco i Suoni: percioche in niuna cosa è differente
dal Suono quello, che in tal maniera è chiamato Tuono, che sia composto; comparato con quello ch'è semplice; come la Linea paragonata al Punto: essendoche
nulla impedisce, che possiamo trasferire il Punto, ouer tutta la Linea in luoghi
continui; ma la coppia delle Mutationi comparata al Senso è finita in atto essendo
il numero de Suoni anco finito. Ilperche tre saranno i termini di quelle cose, che
si possono considerare intorno i Tuoni in ciascuna Consonantia: Il Primo, doue
si costituisca la ragione de gli estremi Suoni; il Secondo, doue si costituisca la
moltitudine de i mezani tra gli estremi: il Terzo, doue si dee porre il loro cambieuole eccesso; come se uicini fussero: come per essempio nella Consonanza
Diatessaron prima; che gli estremi suoni danno la proportione Sesquiterza; dopoi, che solamente tre Interualli la compongono tutta; ultimamente, che sia
page 275
no tali le differentie delle proportioni; se non inquanto che ciascuno habbia la
sua cagione particolare di questi termini. Ma ne i Tuoni in due altri termini pendenti da un'istessa ragione, seguono ad un
certo modo il primo; della quale molti,
che non conoscono la consequentia, uariatamente & differentemente espongono
ciascuno de i termini; ponendone alcuni sotto la Diapason, & alcuni tra essa solamente. Ne mancano quelli, che la sopr'auanzano; come soleano fare i Musici nel
tempo di Tolomeo oltra l'inuentioni de gli Antichi d'un certo progresso, che non
conueneua con la natura & la restitutione ò riportamento del Concento, per laquale è necessario che sia definita & terminata sola la Distantia di quelli, che hanno
da essere gli estremi de i Tuoni. Laonde ne di quella Mutatione de i termini, che si
fà secondo la Voce, hà un'istesso termine in potentia, ne anco di quella che si fà
secondo alcun di qual si uoglia de gli Istrumenti, che manda fuori i Suoni: imperoche non si ritroua ueramente la sua Costitutione, che si fà della Mutatione
secondo 'l Tuono, esser fatta per cagione de i più graui ò piu acuti suoni; essendoche l'Intensione ò la Remissione ò Relassatione de gli Istrumenti intieri sia
basteuole; non hauendosi fatto alcuna mutatione nel Canto; quando simigliantemente si fà tutto perfetto, da quelli, che sonano ò più graue ò più acuto. Ma
per questa cagione, quando secondo una istessa uoce, l'istesso Canto alcuna uolta incominciato da luoghi più acuti, & alcuna uolta da luoghi piu graui, fà una
certa conuersione ò mutatione de costumi; ne anco si finiscano nell'uno &
l'altro gli estremi delle Cantilene, & delle Voci, nelle permutationi de i Tuoni;
ma non mai prima finiscano in una delle parti l'estremo dalla uoce della Cantilena, accioche l'accommodata Cantilena della distantia della Voce dal principio,
alcuna uolta si diminuisca nelle Mutationi, & alcuna uolta cresca, & per tal modo
apporti all'orecchie l'imagine d'un'altro costume. Hora questo che fin qui si è detto intorno le Mutationi, che si fanno secondo
i Tuoni, sia detto à bastanza;
percioche fà dibisogno, c'hormai si uenga à ragionare della Melopeia; nellaquale ui concorrono tutte quelle cose, che fin'hora si sono dimostrate; & è il fine
perfetto inteso da tutti quelli, che danno opera alla Musica.
. Quadrato passa per la Diapente consonanza; ma quasi ripiegato si porta alla detta Mese del Tetrachordo synemennon ò di b. molle, accioche in luogo della Diapente si oda la Diatessaron in quelle uoci, che precedono la detta Mese. Ilperche se gli fà in opposito & all'incon
page 274
tro la Commutatione, ingannando il Senso, ilquale già aspettaua un'altra cosa.
Onde nel trattar moderatamente cotal cosa, uiene ad essere atto & utile alla
Modulatione; & quando si facesse il contrario, sarebbe utile & anco inetta. Però molto leggiadra & quasi un'istessa si mostra esser quella Mutatione per la facoltà, ch'è simile alla prima; riceuendo (dirò cosi) incrocciamento del Tuono
della Disgiuntione; per il quale è differente la Diapente dalla Diatessaron; non
tanto nel reassumere i Suoni; percioche essendo esso Tuono à i Generi commune, può fare in essa una manifesta mutatione; quanto perche una di quelle due
proportioni ò ragioni de suoni, che sono ne i Tetrachordi, muta la Cantilena.
Oltra di ciò, perche cotal cosa è fatta con moderatione, da quello ch'è statuito primo tra i Suoni; essendoche nel canto non
fanno ne troppo grandi, ne troppo picciole digressioni; l'una & l'altra dellequali porta difficultà all'Vdito, nell'accettarle. Si fanno adunque tre Tetrachordi tra loro cambieuolmente l'uno all'altro corrispondenti; congiunti alla propria ragione
ò proportione di cotal Mutatione;
come quelli che sono nell'essempio posto nel Cap. 5. del 5. Libro: con una certa
mistura particolare di due Complessioni disgiunte, quando tutte le Diatessaron
sono differenti tra loro per un Tuono. Ma perche fin'al tempo di Tolomeo non
era appresso gli Antichi in uso l'augumento de i Tuoni; perciò gli Antichi conobbero solamente il Dorio, il Frigio, & il Lydio
esser differenti tra loro per un Tuono; onde li chiamarono Equitoni; perche non arriuarono dal più acuto al più
graue; ne per il contrario, con l'interuallo della Diatessaron; ne poterono da i
Disgiunti far dopoi tre Tetrachordi; onde compresero sotto 'l nome di Complessione il Synemennon, accioche hauessero in pronto la esposta loro Mutatione. Imperoche in quelli Tuoni, che si eccedono l'un l'altro per lo spacio della
Diatessaron; ouer'in l'uno & l'altro suo Tetrachordo, che uà inanti simile Disgiuntione & più acutamente si congiunge al graue nella parte più acuta; fà nel
più graue tre Tetrachordi congiunti; de i quali, quello ch'è aggiunto, è fatto
acutissimo; ouer de quelli che seguono simile disgiuntione de Tetrachordi, il
più graue si congiunge al più acuto nella parte piu graue, & fà etiandio tre Tetrachordi congiunti, de i quali, quello che fù aggiunto, è il grauissimo; come si uedono nel sudetto essempio. Ilperche potiamo comprendere, che quella Constitutioue ò Complessione, ch'è congiunta & applicata alle perfette Complessioni
disgiunte per la Diatessaron sia superflua; & non conseguisca la natura della perfetta Complessione; com'è manifesto da quello, che si è già detto nel sudetto Cap.
1. La onde di nuouo è da distinguere & definire, che di quelle Mutationi, che si
fanno secondo le Costitutioni, che propriamente chiamano Tuoni; essendo che
acquistano le lor differentie dalla Tensione; è ueramente una moltitudine infinita in potenza; come sono anco i Suoni: percioche in niuna cosa è differente
dal Suono quello, che in tal maniera è chiamato Tuono, che sia composto; comparato con quello ch'è semplice; come la Linea paragonata al Punto: essendoche
nulla impedisce, che possiamo trasferire il Punto, ouer tutta la Linea in luoghi
continui; ma la coppia delle Mutationi comparata al Senso è finita in atto essendo
il numero de Suoni anco finito. Ilperche tre saranno i termini di quelle cose, che
si possono considerare intorno i Tuoni in ciascuna Consonantia: Il Primo, doue
si costituisca la ragione de gli estremi Suoni; il Secondo, doue si costituisca la
moltitudine de i mezani tra gli estremi: il Terzo, doue si dee porre il loro cambieuole eccesso; come se uicini fussero: come per essempio nella Consonanza
Diatessaron prima; che gli estremi suoni danno la proportione Sesquiterza; dopoi, che solamente tre Interualli la compongono tutta; ultimamente, che sia
page 275
no tali le differentie delle proportioni; se non inquanto che ciascuno habbia la
sua cagione particolare di questi termini. Ma ne i Tuoni in due altri termini pendenti da un'istessa ragione, seguono ad un
certo modo il primo; della quale molti,
che non conoscono la consequentia, uariatamente & differentemente espongono
ciascuno de i termini; ponendone alcuni sotto la Diapason, & alcuni tra essa solamente. Ne mancano quelli, che la sopr'auanzano; come soleano fare i Musici nel
tempo di Tolomeo oltra l'inuentioni de gli Antichi d'un certo progresso, che non
conueneua con la natura & la restitutione ò riportamento del Concento, per laquale è necessario che sia definita & terminata sola la Distantia di quelli, che hanno
da essere gli estremi de i Tuoni. Laonde ne di quella Mutatione de i termini, che si
fà secondo la Voce, hà un'istesso termine in potentia, ne anco di quella che si fà
secondo alcun di qual si uoglia de gli Istrumenti, che manda fuori i Suoni: imperoche non si ritroua ueramente la sua Costitutione, che si fà della Mutatione
secondo 'l Tuono, esser fatta per cagione de i più graui ò piu acuti suoni; essendoche l'Intensione ò la Remissione ò Relassatione de gli Istrumenti intieri sia
basteuole; non hauendosi fatto alcuna mutatione nel Canto; quando simigliantemente si fà tutto perfetto, da quelli, che sonano ò più graue ò più acuto. Ma
per questa cagione, quando secondo una istessa uoce, l'istesso Canto alcuna uolta incominciato da luoghi più acuti, & alcuna uolta da luoghi piu graui, fà una
certa conuersione ò mutatione de costumi; ne anco si finiscano nell'uno &
l'altro gli estremi delle Cantilene, & delle Voci, nelle permutationi de i Tuoni;
ma non mai prima finiscano in una delle parti l'estremo dalla uoce della Cantilena, accioche l'accommodata Cantilena della distantia della Voce dal principio,
alcuna uolta si diminuisca nelle Mutationi, & alcuna uolta cresca, & per tal modo
apporti all'orecchie l'imagine d'un'altro costume. Hora questo che fin qui si è detto intorno le Mutationi, che si fanno secondo
i Tuoni, sia detto à bastanza;
percioche fà dibisogno, c'hormai si uenga à ragionare della Melopeia; nellaquale ui concorrono tutte quelle cose, che fin'hora si sono dimostrate; & è il fine
perfetto inteso da tutti quelli, che danno opera alla Musica.
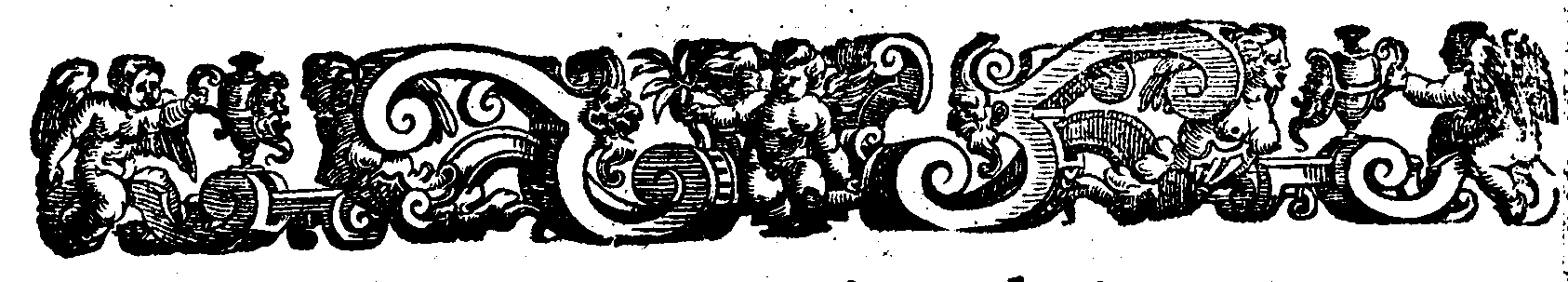
Ottauo Libro de i SOPPLIMENTI MVSICALI DEL REV. M. GIOSEFFO ZARLINO DA CHIOGGIA, Maestro di Cappella della Serenissima Signoria DI VENETIA;
Quello che sia Melopeia; & delli suoi Modi, & delle sue Specie. Cap. I.
Μελοποιΐα ἐστὶ χρῆσις τῶν ὑποκειμένων τῇ ἁρμονικῇ πραγματείᾳ, πρὸς τὸ οἰκεῖον ἑκαστὴ ὑποθέσεως,cioè, la Melopeia è uso delle cose soggette alla trattatione Harmonica, per il decoro del proposto Argomento; che propriamente è la Materia, laquale si dee trattare; come si può conoscere da quello c'hò mostrato nel Cap. 5. del Secondo delle Istitutioni. Si può anco dire, che la Melopeia sia l'uso di quelle cose, c'hanno l'istessa forza, c'hanno quelle, che sono sottoposte à cotal facoltà per il decoro di quelle, lequali si propongono da cantare: ouero ch'è quella forza, che fà la Melodia, laqual forza è ordine di quel Suono detto il Rimanente, dalquale conosciamo cia page 277 scuno de gli altri Suoni, cioè, il Mosso. Laonde non hà dubio alcuno, che colui c'haurà à trattare & porre in uso cotali cose non si habbia à chiamare Melopeo; come Fattore ò compositore della Melodia: laquale si compone (come altroue dichiarai) di Oratione, di Rhythmo, & d'Harmonia: dellequali essendo l'Oratione la parte principale, l'altre due sono come sue serue: Ilperche bisogna dopo l'hauer conosciuto bene il Soggetto che in essa si tratta; che 'l Melopenon sia ignorante del Rhythmo, & dell'Harmonia, che li farà dibisogno. Et accioche egli sappia con ragione Fabricare la sua Cantilena; dopo l'hauer conosciuto questo che ne i precedenti Libri si è narrato; haurà anco ad osseruare quello che segue; che non è di poca importanza; s'egli uorrà far bene il suo officio, & trattar le cose con maestà, & decoro; onde farà dibisogno che sappia molte altre cose, ch'io son per dire. Ma perche è impossibile ch'ei sappia quello, che sia Melopeia, se prima non haurà conosciuto quel che importi questo nome Melos; però acciò facilmente possa intender quello, che siamo per dire; uedremo quello, che significa cotal nome. Μέλος adunque è parola greca, & significa Canto, ò Modulatione. Laonde parlando in uniuersale è composto d'Harmonia, parlando di quella ch'io commemorai nel Cap. 12. del Secondo delle Istitutioni, detta Impropria, di Rhythmo & di parole; tra lequali cose si troua il Graue & l'Acuto, la Velocità & la Tardità, la Lunghezza & la Breuità. Et perche è cosa naturale, che non solamente cantando, ma anche parlando alciamo, & abbassiamo la Voce, secondoche fà bisogno: però questo nome Μέλος si troua essere di due sorti; l'uno che serue al Parlare & è detto Sermocinale & Parlatorio; & l'altro al Canto; detto Musicale ò Cantatorio, dirò cosi. Onde il Primo è quello ch'è fatto intorno il Parlare, & consta de Accenti collocati nell'ordine, delle parole dette da Greci Προσωδία. L'altro è harmonicamente Interuallato; percioche consiste nel Canto, ò Modulatione, che si fà & si compone de Interualli sonori; nelquale fà dibisogno che ui concorri il Moto interuallato della Voce, & molte riposate ancora. Ne solamente fa dibisogno che 'l Canto sia modulabile, & acquisti il suo fine da i Suoni & Interualli; ma etiandio che la sua compositione habbia tal forma & corrispondenza, che sia fatta d'Interualli proportionali, & non posti l'un dopoi l'altro à caso & come uengono fatti, ma pensatamente & con ragione; percio che è pur troppo manifesto, che l'Interuallo fatto de Suoni, è cosa commune al Consonante & bene ordinato & al Dissonante & incomposto. Ilperche essendo cosi; bisogna pensare che la parte principale, & quelle cose che sono di momento nella ben constituita ragione del Canto, ch'ella consista nella Compositione, che habbia in se una sua certa & terminata proprietà, di muouere gli affetti dell'animo. Ma si come è proprietà della Voce nel parlare, che nella Modulatione ò Canto della Parola, ò Dittione, quanto appartiene alla Compositione delle Lettere: ilche habbiamo per natura, che la Voce pone in ciascuna Sillaba un certo primo & secondo de gli Elementi; simigliantemente un terzo & un quarto, & cosi più oltra, costituisca secondo gli altri numeri un'Ordine; di modo che non siano tutte con tutte confuse; ma sia un loro naturale accrescimento della Compositione: cosi osserua la Voce nel Modulare, ò Cantare una certa naturale Compositione, secondo la continuità de Suoni, ò d'Interualli; accommodando non tutto quello che si uuole, con qual si uoglia altro Interuallo, ne anco l'equale con l'inequale, ma l'uno con l'altro, che habbiano proportione & conuenienza. Laonde può esser manifesto il Canto musico ben Composto & industriosamente fatto d'Interualli proportionali, esser diuerso per il Moto della Voce solamente; & l'Incomposto & falso, per la differentia della semplice page 278 Compositione fatta de gli Interualli. Ma diciamo uniuersalmente, che hauendo la Consonanza molte differenze per la compositione de gli Interualli, in ogni Canto ben composto, ui è & si sente un nò sò che di ornamento nella sua facoltà; la quale essendo leuata, è necessario etiandio che sia leuata di mezo essa Consonanza. Hora è necessario che questo Canto, ò Modulatione che uniuersalmente si chiama Μέλος si troui diuiso in Tre parti, percioche pare che in cotanti si possa diuidere: essendoche ogni Canto, ò Modulatione che si uorrà osseruare, ò che sarà Diatonico, ò Chromaricho, ouero Enharmonico: de i quali il Diatonico è antichissimo & primo hauendogli dato la Natura cotal priuilegio, essendo poi dall'Arte consignato il Secondo al Chromatico, & il Terzo all'Enharmonico: al quale apena, & anche col sommo studio il senso, come scriue Aristosseno, si può assuefare. Ma perche il fine di cotal cosa s'acquista dalle positioni & siti de i Tetrachordi, lequali sono Sette: per hauerne à sufficientia trattato nel Cap. 4. del 2. lib. non ne dirò altro. Hora inteso tutto questo, potrà uedere il nostro Melopeo, quanto sia il Μέλος differente dalla Μελωδία, essendoche questa da Platone De Rep. 3. è dichiarata essere una perfetta compositione fatta d'Harmonia, di Rhythmo & di Oratione; onde quelle qualità, che concorrono in essa; com'è l'Acutezza & la Grauità; ouer la Equalità delle uoci, si considera nell'Harmonia; la loro Velocità, la Tardità & il Mouimento, circa il Rhythmo; & la Lunghezza & la Breuità della parola, nel Metro, ouer nella Oratione. Ma è maggiormente il proprio dell'Harmonia, il piegamento ò trappassamento (dirò cosi) dell'acuto al graue & per il contrario, fatto ne i Suoni differenti cantabili per l'abbassamento & l'alzamento loro. Onde nella perfetta Melodia concorrono il Mouimento della Voce, quello del Corpo, & li Tempi; oltra di questo i Rhythmi ò Numeri, che si fanno da questi. Ma per hauer (com'io credo) ragionato à bastanza nel Cap. 8. della Seconda parte dell' Istitutioni, quanto appartiene à questo negotio, non replicherò qui cosa alcuna. Onde per ritornare alla Melopeia, dico; ch'essendo ella (come s'è detto) quella forza, che fà la Melodia; saprà il nostro Melopeo, che si trouaua appresso i Greci esser di tre maniere; l'una detta ὑπατόϊδες; l'altra μεσὸϊδες; & la terza νητόϊδες. La Prima era quella, che si faceua nella parte più graue dell'Istrumento, nellaquale era contenuta la chorda Hypate; la Seconda si essercitaua nelle sue chorde mezane, tra lequali era compresa la chorda Mese; & l'ultima s'adoperaua tra le chorde più acute; percioche tra esse era collocata la chorda Nete. Onde tutta la Melopeia si riduceua sotto 'l Genere di tre Modi; de i quali l'uno era detto Nomico, & si udiua tra le chorde più acute dell'Istrumento; cioè, tra le sudette Netoide, ouero Eccellenti, c'habbiamo nominato; l'altro chiamauano Dithyrambico, ilquale si essercitaua nelle Mesoide ò mezane, & il Terzo era detto Tragico, ch'era trattato nelle chorde più graui & principali, dette Hypatoide. Di questi se ne ritrouano molte specie, lequali, per essempio, erano composte sotto un Genere, che chiamauano Erotico, cioè; Amatorio; & ad esse accommodauano ottimamente gli Epithalamii nominati nel Cap. 1. del Lib. precedente; ch'erano composti in Verso, & anco gli conueniuano gli Encomii. Onde era l'Ε'γκώμϊον fatto in laude d'alcuno, per farlo in questa uita immortale, per hauer conseguito qualche segnalata uittoria; percioche in esso illustremente erano cantate le cose, ch'egli magnificamente hauea fatto, sotto il qual Genere si riduceuano anche gli Hinni, i Peani, & quelli ch'adimandauano Scolii. Et cotali Versi, come scriue Alessandro d'Alessandria nel Lib. 1. Cap. 22. de i Giorni geniali, erano anco chiamati Epicinii; cioè, Premio & Celebrità per la riceuuta uittoria. La page 279 onde si troua appresso di Theocrito un suo picciolo Poema; ilquale titolò Ε'γκώμϊον εἰς πτολεμαῖον; cioè, Laudi di Tolomeo, Philadelpho; Ε'κ Διός ἀρχώμεθα;
Ab Ioue principium;col qual nome si chiama etiandio qual si uoglia Oratione fatta in prosa in laude d'alcuno; come quella di Luciano fatta in lode di Demosthene, & anco quelle due, ch'ei fece l'una in laude della sua Patria & l'altra in laude della Mosca. Tutti questi però si chiamauano Modi; percioche insieme dimostrano in qual maniera il Costume ò l'Affetto ò pur la Forza s'hauesse ad esprimere col mezo della modulatione ò canto, congiunto all'Oratione. Era tuttauia cotal Costume ò Affetto considerato nella Melopeia di tre maniere; essendoche l'uno era detto Diastatico, ò uogliamo dire Interuallare; l'altro Systaltico ò Contratto ò Ristretto; & il terzo chiamauano Hesichastico, cioè, Quieto; de i quali hauendone di sopra nel Cap. 2. del precedente Libro pienamente ragionato, non starò à replicar hora cosa alcuna; ma dirò solamente, ch'appresso gli Antichi tre erano anche (come scriue Psello) le parti di ciascuna delle tre maniere della Melopeià; cioè, delle Hypatoide, delle Mesoide, & delle Netoide: la prima era detta Λῆψις, ouer'Occupatione, ò uogliamo dire Pigliamento, la seconda Μίξις, ò Mescolanza; la terza χρῆσις, che uuol dire Vso. La Prima era, quando accadeua al Musico di ritrouar da un determinato luogo di uoce, cioè, dal Rimanente; da fare il Systema; fusse poi nelle Hypatoide, ò in qual si uoglia dell'altre due: la Seconda era, quando poneua insieme i Suoni ò i luoghi della Voce, ouero i Generi delle modulationi ò i Systema de i Tropi: ma l'Vso era l'essercitio fatto intorno la Modulatione, dellaquale erano Quattro le sue specie, che faceuano perfetta la Melopeia; ritrouandosene tre parti della prima specie, dellequali n'habbiamo ragionato à pieno nel Cap. 17. del 2. Lib. Onde non replicarò qui cosa alcuna; ma dirò solamente, che la Melopeia è molto differente dalla Melodia in questo; che questa è pronuncia del Canto, & quella è habito, che fà il Canto.
Qual fusse appresso gli Antichi l'Harmonia Terza parte della Melodia. Cap. II.
Tibia non, vt nunc aurichalco vincta, TubaequeLequali parole uogliono nella nostra lingua cosi dire:
Aemula, sed tenuis, simplexque, foramine pauco.
Aspirare, & adesse choris erat vtilis; atque
Nondum spissa nimis complere sedilia flatu.
Quò sanè populus numerabilis, ut pote paruus.
Et frugi, castusque uerecundusque coibat.
Postquam capit agros extendere victor, & vrbem
Latior amplecti murus, vinoque diurno.
Placari Genius festis impune diebus:
Accessit numerisque modisque, licentia maior.
Indoctus quid enim saperet, liberque laborum
Rusticus urbano confusus turpis honesto?
Sic priscae motumque & luxuriam addidit arti
Tibicem, traxitque uagus per pulpita vestem.
Sic etiam fidibus voces creuere seueris.
Non era allora il Piffaro, com'hoggiEssendo adunque in tal maniera accresciuta la Musica da quelli che la essercitauano à quei primi tempi; poco importa, c'Horatio parlasse di cotal cosa, intendendo ò del principio della Città di Roma, ò del Popolo Romano, ò pur'anco d'altri popoli; poiche s'incominciò adoperar gli Istrumenti, che seruiuano ad ogni qualità di persone, grandi, piccioli, & mezani; ch'entrauano nelle Tragedie ò Comedie loro; assai maggiori di quelli, che da principio faceuano d'Auena, Stipula, di Stinchi d'Animali ò d'altre cose simili; si comprende da quello, che fece quell'Histrione del quale ne hò scritto nel Cap. 3. del Primo Libro, ripreso da Luciano in quel Trattato, ch'egli fà della Saltatione uerso il fine, per hauerlo ueduto in una Scena troppo affettato partirsi dal decoro nel rapresentare, & con un Piffero percotere sopra 'l capo di uno, che rappresentaua Vlisse di maniera che lo priuò quasi di uita. Ilperche si può conoscere la differentia de i Pifferi, che erano usati nel principio, se Pifferi si poteano nominare, & quelli che si usauano al tempo di Luciano, ne gli Anni di Christo intorno 305. sotto l'Imperio di Diocletiano Imperator de Romani; accioche alcun non credesse, che allora fussero fatti, come si faceuano da principio, quasi nella pueritia (dirò cosi) della Musica, com'hò detto altroue, de Stinchi d'Animali, ò d'altra materia tenue. Et se bene hò detto nel Cap. 31. della Seconda parte dell'Istitutioni, con buon proposito, che l'Harmonia de gli Antichi consisteua nella Modulatione d'una sola parte, ch'usaua il Musico ò Poeta nel recitar le Melodie; non hò uoluto però dire, che in essa Melodia in tal maniera semplicemente usata, non si udisse dopo un principio tanto semplice, qualche anno dapoi alcun concento tra l'Istrumento & la Voce del recitante; percioche troppo ben ui era, come si può con molti essempij dimostrare. Prima da i Caratteri ò Cifere che usauano, come dimostra Boethio nel Cap. 3. del 4. Lib. della Musica, & Alipio nel suo Introdottorio alle cose Musicali; ilquale descriue le Cifere di 32. Modi per tutti tre i Generi della Melodia; essendoche cotali Cifere sono doppie; percioche è opinione di Boethio, che gli uni seruissero nell'esprimer la Modulatione intesa & fatta dal Poeta, c'hauea composta la Cantilena; come di sopra si è mostrato con l'autorità di Platone, & gli altri dell'Istrumento; onde dice queste parole.
Si vede, cinto con cerchio d'Otone,
E' imitator della sonora Tromba;
Ma semplice & sottil con pochi fori
Atto à sonare, & fauorir à i chori,
Empiena d'ogni parte col suo Suono
Le sedie, che non eran molto spesse
L'oue 'l popol, che numerar poteasi.
Perch'era poco, parco, casto & pieno
D'ogni modestia; insieme conuenuano.
Ma poi che 'l Vincitor cominciò stendere
I campi, & con le mura assai più larghe
Cingere la Cittade, & anco senza
Veruna pena ne i festiui giorni
Sacrificar co 'l vin diurno al Genio,
A Numeri & à Modi antichi accrebbe
Ne i Canti & Suoni assai maggior licentia.
Ma che parea veramente sapere
Il Rustico ignorante, & dal lauoro
Poca fà tolto al Cittadino honesto, page 281
E' il Ciuile al Plebeo fatto compagno?
In tal maniera adunque il Sonatore
Aggiunse all'Arte antica il Ballo, & anco
Molte cose souerchie & poco honeste;
E' come vagabondo per la scena
Dietro 'l tirarsi lunga veste, e in oltre
S'aggiunser Voci alle Chorde seuere,
Onde crebbero assai più del douere.
Veteres enim Musici propter compendium scriptionis; ne integra semper nomina necesse esset apponere; excogitauere Notulas quasdam; quibus neruorum vocabula notarentur; easque per Genera, Modosque diuisere; simul etiam hac breuitate captantes; ut si quando Melos aliquod Musicus voluisset ascribere; super versum rhythmica metri compositione distentum, has sonorum notulas ascriberet: ita miro modo reperientes, ut non tantum Carminum verba, quae litteris explicarentur, sed quoque ipsum; quod suis notulis signaretur, in memoriam, posteritatemque duraret:cioè, Ma i Musici uecchi, per abbreuiar la scrittura, accioche non fusse necessario por sempre i nomi intieri, s'imaginarono certe Note, con le quali si notassero i nomi delle chorde, & le diuisero per i Generi & per i Modi insieme etiandio, per breuità; accioche se 'l Musico alle fiate uolesse scriuere ò notare alcun Can page 282 to, potesse notar queste Note de Suoni sopra 'l Verso disteso, & ordinato con numerosa compositione del Metro. Cosi con mirabil modo ritrouando, che non solo le Parole de i Versi fussero esplicate; ma esso Canto ancora, ilquale s'hauesse à segnare ò notare con queste Note; accioche durasse per memoria nella posterità. Segue anco dopoi:
Erunt igitur priores ac superiores notulae, dictionis, id est, Verborum; secundae verò atque inferiores, Percussionis:cioè, Saranno adunque le prime & superiori Note delle Dittioni ò Parole; ma le seconde & inferiori della Percussione. Questo istesso accenna Platone nel 7. delle Leggi, quando parla della Dottrina de i Citharisti; che altro era il Canto & Concento, che rendeuano le chorde, & altro quello del Poeta, che componeua la Melodia. Laonde in questo proposito uolea, che 'l Fanciullo nel termine di tre anni quasi desse opera alle lettere; & questo solamente quando era arriuato all'età di diece anni; & per lo spatio di tre anni ancora, si hauesse simigliantemente ad essercitar nella Musica; & questo dopo che era aggiunto all'età di tredici. Et accioche nella Musica non hauesse à perdere il tempo, ordinò che 'l Maestro & Citarista non douesse insegnare sonare al Discepolo ò Giouane ad altro modo, che πρόσχορδα; cioè, A chorda per chorda; ò pure A chorda à chorda, al modo che fanno anco al presente quelli, che insegnano sonare il Liuto: percioche nell'insegnare, toccando il Maestro nel suo Istrumento quella chorda, che uuole che tocchi anco il Discepolo nel suo; quello ch'essi Maestri sona, sona insieme i Discepoli, pur toccando Chorda per chorda, & non ad altro modo. Et ne dice il diuin Filosofo questa ragione; Che fà dibisogno, poi che ciò non serue, ne consente la breuità del tempo; per maggior chiarezza, aggiungere & usare i Suoni delle chorde della Lira; & che 'l Citharedo & lo Discepolo rappresentino i Suoni πρόσχορδα, ò Chorda per chorda: percioche il porre insieme tutte queste cose; cioè, la diuersità delle Voci, & la uarietà della Lira, facendo ueramente altri concenti le chorde, & altri il Poeta compositor della Melodia, & ultimamente l'accompagnar la densità con la rarità, & la uelocità con la tardità, & l'acutezza con la grauità; simigliantemente l'aggiungere insieme il consono col dissono, & l'accommodare à i Suoni della Lira nell'istesso modo qual si uoglia uarietà de rhythmi ò Numeri, & proporle à quelli, che uogliono conseguire in un Triennio la utilità della Musica, non è cosa conueneuole. Et questo uuol dire Platone sommariamente, & in sostantia; come si può conoscer dalle sue parole registrate nel 7. Lib. delle Leggi. Τούτων τοίνον δεῖ χάριν τοῖς φθόγγοις τῆς λύρας πρωχρῆσθαι σαφηνείας ἕνεκα τῶν χορδῶν, τόντε κιτθαριστὴν καὶ τὸν παιδευόμενον, ἀποδιδόντας πρόσχορδα τὰ φθέγματα τοῖς φθέγμασι. τὴν δ'ἔτειοφωνίαν καὶ ποικιλίαν τῆς λύρας. ἄλλα μὲν μέλη τῶν χορδῶν ἱεισῶν, ἄλλα δὲ τοῦ τὴν μελῳδίαν ξυνθέντος ποιητοῦ. καὶ δὴ καὶ πυκνότητα μανότητι. καὶ τάχος βραδύτητα καὶ ὀξύτητα βαρύτητι, σύμθωνον καὶ ἀντίθωνον παρεχομένους. καὶ τῶν ῥυθμῶν ὡςάυτος παντοδαπὰ ποικίλματα προσαρμόττοντας τοῖος φθόγγοις τῆς λύρας. πάντα οὖν το τοιαῦτα μὴ προσφέρειν τοῖς μέλλουσιν ἐν τρισὶν ἔτεσι τὸ τῆς μουσικῆς χρήσιμον ἐκλήψεσθαι διὰ τάχους. Ma è cosa ueramente da ridere d'alcuni, che si persuadono di sapere ogni cosa; iquali uogliono, che Socrate & Platone in questo fatto auertiscano & commandano à Nobili principalmente, che sonino ò cantino; come dicono; Proschorda & non Sinfone; cioè, all'Vnisono & non in Consonanza; ma la conuenienza c'hanno queste due parole tra loro, dimostra, che non intendono quello, che uoglia dir Platone, se ben da sè è chiaro, & non hà bisogno di commento. Onde soggiungendo dicono & affermano quello che non uorrebbono; ch'anticamente, come al tempo di esso Platone, & più inanti si cantaua in consonanza, & che da questo si conosce espressamente, che fin'al tempo di esso Platone d'alcuni si cantaua & sonaua in cotal modo. Laonde è confermato questo dalle parole di questo diuino Filosofo quando dice: che nella Melodia u'era il Concento del page 283 Poeta & quello dell'Istrumento; ilche è conforme à quello c'habbiamo detto de i Caratteri ò Cifere raddoppiate, dimostrate da Alipio & da Boethio; ancora che Altri habbino uoluto, che 'l raddoppiamento di cotali Cifere uolesse significare che in un'ordine eran poste quelle, che seruiuano alla mano destra, & in un'altro quelle, che s'adoperauano nella sinistra nel toccar le chorde dell'Istrumento; come dimostra il seguente essempio, già sono iti molt'anni tratto da un' antico libro Greco dal Gentilissimo M. Michele Soffianò da Scio, delche me
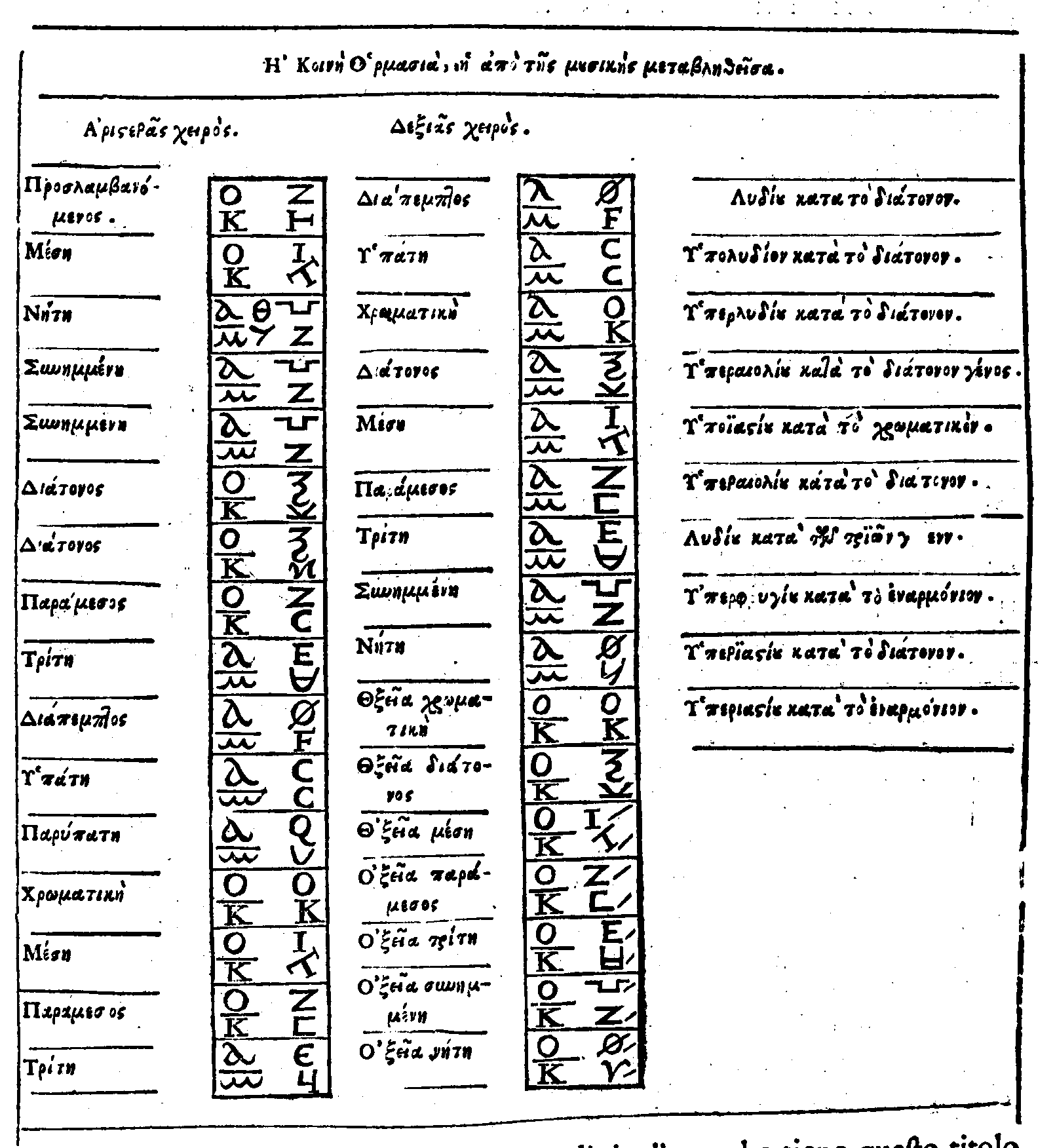

 dico, che senza dubio, nel modo c'hò dimostrato, era
l'Harmonia che si cantaua. Ilperche si uede, di qual maniera ella fosse, quando era parte della Melodia; cosa che
non contradice per alcun modo à quello, c'hò detto altroue; cioè, che l'Harmonia de gli Antichi consisteua più tosto
nella Modulatione d'una parte, ch'altramente; essendoche da
essa solamente si udiua l'Aria della Cantilena & il Modo, nel
quale la cantauano. Onde da questa cosi fatta sorte d'Harmonia hauendo considerato in essa il Modulare, che fa una Parte
sola, che nel Cap. 12. della Seconda parte dell'Istitutioni, hò
nominato Harmonia imperfetta; si potrà non senza ragione
dire Harmonia imperfetta; essendo la Perfetta d'un'altra maniera, come hò dimostrato nel medesimo luogo: poiche quella s'aggiunge insieme & si ode tra le Parti; com'è quella,
che nasce dalle tre poco fà mostrate più graui, Tra lequali si odono la Diapason diuisa nella Diapente, & nella Diatessaron; hò più tosto chiamato harmonica Consonanza, che Harmonia; riseruando il nome d'
Harmonia perfetta; quella che nasce da più parti, che uanno cantando insieme
molte Aria; come s'usa à i nostri giorni nelle Cantilene: percioche questo nome
Harmonia non si piglia cosi semplicemente, come forse alcuno pensa; per quello che conuiene ad una sol cosa, ma à piu cose; come c'insegna il Filosofo;
1. De anima tex. 1.
poscia
che 'l suo primo significato si piglia per la compositione de i Corpi ò Grandezze,
c'habbiano sito & mouimento; come quando due di queste cose si conuengono
in tal maniera insieme nel congiungersi & collocarsi, che niun'altra cosa di qual
genere u'intrauenga di mezo. Onde si dicono esser ben poste insieme & ben'unite; & anco quella compositione & unione, che consiste nell'ordine, si chiama
Harmonia; come quando s'aggiunge legno à legno; ò quando, oltra à qual si uoglia cosa naturale arteficiosamente, sen'aggiunge un'altra. Ilperche da questo
principio il nome d'Harmonia è trasportato per similitudine nell'altre cose; come
sarebbe dire, nella Ragion di quelle ch'insieme si mescolano & confondono:
percioche diciamo quelle cose esser insieme harmonicamente accommodate,
page 285
che si ueggono esser'insieme aggiunte con qualche ragione, di modo che concordeuolmente conuengono in uno & in quello aspirino,
& ugualmente senz'alcuna disparità siano insieme proportionate. Laonde quando le cose in un composto sono aggiunte insieme in qual si uoglia maniera, che stian bene, allora si dicono esser Harmonicamente composte; come diciamo per essempio, il Tenore
allora accordare co 'l Soprano ottimamente & insieme conuenire, quando niuna
proportione si troua di mezo, che si possa far il Concento maggiormente soaue.
Ilperche è da considerare nella Musica, che quel che riduce il graue & l'acuto in
un suono (dirò cosi) conspirato, quello è Harmonia; laquale mentre che perseuera & è in atto, non può far offesa alcuna all'Vdito; poiche l'Harmonia è proportione di Voci ò Suoni, che tra loro acconsentiscono & consonano; & è anche
compositione prouenuta & cagionata dal concorso di più cose & della lor comparatione. Per la qual cosa si uede, che l'Harmonia non è detta semplicemente
quella Ragion de Numeri, come la dice Aristotele, nata dalla buona compositione delle grandezze poste insieme, che sono accompagnate con qualche ragione; ma è detta anco Ragione & Compositione di quelle cose, che insieme si
possono mescolare. Onde essendo cosi, non chiamarò Harmonia quella solamente, che secondo un certo ordine d'Interualli si
uà modulando con la Voce ò si fà
con un'Istrumento ò con la Voce sola al suono di cotale Istrumento, senza udirui alcun concento, come per auentura alcuni potrebbono credere, se non impropriamente; percioche, per finir questo capo, Aristotele
1. Anima. 54.
chiamò Harmonia quel
la concordia, che nasce dalla mescolanza de Suoni ò Voci differenti. Et perche
nelle modulationi di una parte non puo cascare cotale permistione ò commistione; percioche (per dir cosi) è puro ordine de Voci ò suoni solamente; però diremo che l'Harmonia, ch'entra nella compositione della Melodia, non era il
semplice Canto d'una sola Parte ò d'una sola Aria, ma il concento che nasceua
dalla Voce del Recitante, & è prodotta dalle chorde dell'Istrumento insieme
percosse.
dico, che senza dubio, nel modo c'hò dimostrato, era
l'Harmonia che si cantaua. Ilperche si uede, di qual maniera ella fosse, quando era parte della Melodia; cosa che
non contradice per alcun modo à quello, c'hò detto altroue; cioè, che l'Harmonia de gli Antichi consisteua più tosto
nella Modulatione d'una parte, ch'altramente; essendoche da
essa solamente si udiua l'Aria della Cantilena & il Modo, nel
quale la cantauano. Onde da questa cosi fatta sorte d'Harmonia hauendo considerato in essa il Modulare, che fa una Parte
sola, che nel Cap. 12. della Seconda parte dell'Istitutioni, hò
nominato Harmonia imperfetta; si potrà non senza ragione
dire Harmonia imperfetta; essendo la Perfetta d'un'altra maniera, come hò dimostrato nel medesimo luogo: poiche quella s'aggiunge insieme & si ode tra le Parti; com'è quella,
che nasce dalle tre poco fà mostrate più graui, Tra lequali si odono la Diapason diuisa nella Diapente, & nella Diatessaron; hò più tosto chiamato harmonica Consonanza, che Harmonia; riseruando il nome d'
Harmonia perfetta; quella che nasce da più parti, che uanno cantando insieme
molte Aria; come s'usa à i nostri giorni nelle Cantilene: percioche questo nome
Harmonia non si piglia cosi semplicemente, come forse alcuno pensa; per quello che conuiene ad una sol cosa, ma à piu cose; come c'insegna il Filosofo;
1. De anima tex. 1.
poscia
che 'l suo primo significato si piglia per la compositione de i Corpi ò Grandezze,
c'habbiano sito & mouimento; come quando due di queste cose si conuengono
in tal maniera insieme nel congiungersi & collocarsi, che niun'altra cosa di qual
genere u'intrauenga di mezo. Onde si dicono esser ben poste insieme & ben'unite; & anco quella compositione & unione, che consiste nell'ordine, si chiama
Harmonia; come quando s'aggiunge legno à legno; ò quando, oltra à qual si uoglia cosa naturale arteficiosamente, sen'aggiunge un'altra. Ilperche da questo
principio il nome d'Harmonia è trasportato per similitudine nell'altre cose; come
sarebbe dire, nella Ragion di quelle ch'insieme si mescolano & confondono:
percioche diciamo quelle cose esser insieme harmonicamente accommodate,
page 285
che si ueggono esser'insieme aggiunte con qualche ragione, di modo che concordeuolmente conuengono in uno & in quello aspirino,
& ugualmente senz'alcuna disparità siano insieme proportionate. Laonde quando le cose in un composto sono aggiunte insieme in qual si uoglia maniera, che stian bene, allora si dicono esser Harmonicamente composte; come diciamo per essempio, il Tenore
allora accordare co 'l Soprano ottimamente & insieme conuenire, quando niuna
proportione si troua di mezo, che si possa far il Concento maggiormente soaue.
Ilperche è da considerare nella Musica, che quel che riduce il graue & l'acuto in
un suono (dirò cosi) conspirato, quello è Harmonia; laquale mentre che perseuera & è in atto, non può far offesa alcuna all'Vdito; poiche l'Harmonia è proportione di Voci ò Suoni, che tra loro acconsentiscono & consonano; & è anche
compositione prouenuta & cagionata dal concorso di più cose & della lor comparatione. Per la qual cosa si uede, che l'Harmonia non è detta semplicemente
quella Ragion de Numeri, come la dice Aristotele, nata dalla buona compositione delle grandezze poste insieme, che sono accompagnate con qualche ragione; ma è detta anco Ragione & Compositione di quelle cose, che insieme si
possono mescolare. Onde essendo cosi, non chiamarò Harmonia quella solamente, che secondo un certo ordine d'Interualli si
uà modulando con la Voce ò si fà
con un'Istrumento ò con la Voce sola al suono di cotale Istrumento, senza udirui alcun concento, come per auentura alcuni potrebbono credere, se non impropriamente; percioche, per finir questo capo, Aristotele
1. Anima. 54.
chiamò Harmonia quel
la concordia, che nasce dalla mescolanza de Suoni ò Voci differenti. Et perche
nelle modulationi di una parte non puo cascare cotale permistione ò commistione; percioche (per dir cosi) è puro ordine de Voci ò suoni solamente; però diremo che l'Harmonia, ch'entra nella compositione della Melodia, non era il
semplice Canto d'una sola Parte ò d'una sola Aria, ma il concento che nasceua
dalla Voce del Recitante, & è prodotta dalle chorde dell'Istrumento insieme
percosse.
Che gli Antichi sonauano in Consonanza; & se l'Organo nostro Istrumento sia antico ò moderno. Cap. III.
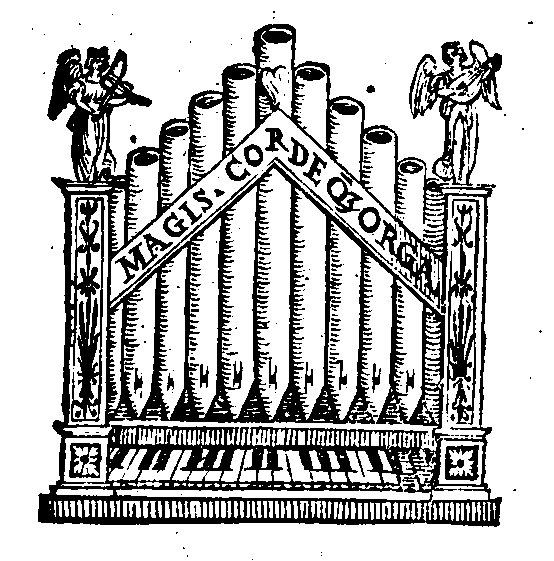
De Hydraulicis autem, quas habeant minores, quàm breuissime proximeque attingere potero, & scriptura consequi non praetermittam. De materia compacta basi, Arca in ea ex aere fabricata collocatur; supra basim eriguntur Regulae dextra, ac sinistra scalari forma compacta; quibus includuntur aerei Modioli fundibulis ambulantibus, ex torno subtiliter subactis; habentibus fixos in medio ferreos Ancones, & Verticulis cum uectibus coniunctos, pellibusque lunatis inuolutos. Idem in summa planitia foramina circiter digitorum ternum; quibus foraminibus proximè in verticulis collocati aerei Delphini, pendentia habentes Catenis Cymbala ex aere infra foramina, Modiolorum chalata intra arcam, quo loci aqua sustinetur. Inest in id genus uti infundibulum inuersum; quod subter Taxili alti circiter digitorum ternum suppositi librant spacium imum: ima inter libra phigaeos, & arcae fundum: supra autem ceruiculam eius coagmentata arcula sustinet caput machinae, quae Graece Κανὼν μουσικὸς appellatur; in cuius longitudine canales; si Tetrachordos est fiunt quatuor; si Exachordos, sex; si Octochordos, octo. Singulis autem canalibus, singula Epistomia sunt inclusa manubrijs ferreis collocata: quae manubria, cum torquentur, ex arca patefaciunt nares in canales. Ex canalibus autem Canon habet ordinata in transuerso foramina respondentia in naribus, quae sunt in Tabula summa; quae Tabula graece πίναξ dicitur. Inter tabulam & canonem regula sunt interpositae ad eundem modum foratae, & oleo subactae, vt faciliter impellantur, & rursus introrsus reducantur; quae obturant ea foramina, pleuritidesque appellantur; quarum itus & reditus altas obturant, alias aperit terebraciones. Hae Regulae habent ferrea choragia fixa, & iuncta cum primis; quarum pinnarum tactus motiones efficit regularum. Continentur supra tabulam foramina, quae ex canalibus habent egressum spiritus. Regulis sunt annuli agglutinati, quibus lingulae, omnium includuntur Organorum. E` modiolis autem fistulae sunt continenter coniunctae ligneis ceruicibus, pertingentesque ad nares, quae sunt in arcula; in quibus axes sunt ex torno subacti, & ibi collocati; qui cum recipit arcula animum, spiritum non patientur obturantes foramina rursus redire. Ita cum uectos extolluntur, ancones deducunt fundos modiolorum ad imum: Delphinique, qui sunt in uerticulis inclusi chalantes in os cymbala, replent spacia modiolorum; atque ancones extollentes fundos intra modiolos uehementi page 287 pulsus crebritate, & obturantes foramina cymbalis superiora, aëra, qui est ibi clausus pressionibus coactum, in fistulas cogunt, per quas in lignea concurrit, & per eius ceruices in arcam: motione uerò uectium uehementiore, spiritus frequens compressus Epistimiorum aperturis influit, & replet anima canales. Itaque cum primae manibus tactae propellunt, & reducunt contnenter regulas, alternis obturando foramina; alternis aperiundo, ex musicis artibus multiplicibus modulorum uarietatibus sonantes excitant uoces. Quantum potui nisi, ut obscura res per scripturam dilucidè pronuntiaretur, contendi. Sed haec non est facilis ratio, neque omnibus expedita ad intelligendum; praeter eos, qui in his generibus habent exercitationem. Quod si qui parum intellexerint è scripturis, cum ipsam rem cognoscent, profectò inuenient curiosè & subtiliter omnia ordinata.Queste sono le parole formali di Vitruuio, che s'interpretano cosi.
Non lasciarò di dire, quanto più breuemente potrò, & appresso conseguir con scrittura quello, che appartiene alla ragion delle machine Hidrauliche. In vna Base fatta di materia ben congiunta insieme, s'accommoda un'Arca di rame; & sopra la base dal canto destro & dal sinistro si dirizzano alcune Regole insieme congiunte à modo di scala; nellequali si inchiudono alcuni Moggetti fatti di rame co i loro cerchietti fatti sottilmente al torno, c'hanno le braccia loro di ferro conficate nel mezo, & i lor fusaiuoli con manichi congiunte & riuoltate in pelli di lana. Ancora nel piano di sopra ui sono fori grandi intorno tre dita; appresso i quali fori sono collocati Delfini di rame ne i loro fusaiuoli, c'hanno Cembali fatti di rame pendenti da catene che calono sotto i fori de i moggetti nell'Arca, doue è sostenuta l'acqua. Et si troua in esso, com'un Tramoglio riuerscio; sotto 'l quale sono certi Tasselletti alti intorno tre dita, i quali stanno à liuello dello spacio posto da basso, tra le labra inferiori del forno & il fondo nell'arca. Ma sopra la sua testa gli è una cassetta ben serrata & congiunta, laquale sostenta il capo della machina, che da Greci è detta Κανὼν Μουσικὸν; cioè, Regola musicale, nella cui lunghezza si fanno quattro canali, s'è Tetrachordo; sè Hexachordo, sei; se Ottochordo, otto: ma in ciascun canale da per sè sono posti i bocchini loro rinchiusi con manichi di ferro; i quali manichi, mentre sono torti, ò quando danno volta, s'aprono le nari dell'arca ne i canali, & da i canali la Regola hà per trauerso i suoi fori ordinati, che s'incontrano nelle nari, che sono nella Tauola posta di sopra; la qual tauola grecamente è detta πίναξ. Tra la Tauola & la Regola sono poste di mezo le Regole, all'istesso modo forate & onte con oglio, accioche più facilmente si possono spingere, & tirar di nuouo dentro; lequali chiudono quei fori, che Coste ò Lati si chiamano; de i quali l'andare & il tornare serra alcune & alcune aprono de quei fori. Hanno simigliantemente queste Regole attaccati & fissi i loro Cerchietti di ferro congiunti con le prime; il toccamento dellequali fanno i mouimenti delle Regole. Sopra i fori della Tauola sono contenuti i Venti ò Fiati, c'hanno l'vscita da i Canali. Alle Regole sono incollati gli annelli, co i quali sono rinchiuse le Linguelle de tutti gli Istrumenti: Ma da i Magliuoli le Canne sono continuamente congiunte à i capi de i legni, che alle nari peruengono, che sono nella cassetta, ne i quali sono l'Animelle tornite & iui poste; iquali riceuendo la Cassella il fiato, otturando i lor fori, non lo lasciano di nuouo ritornare. Cosi quando le stanghe s'alzano, i manichi portano alla parte bassa i fondi de i moglietti; & i Delfini, che sono inchiusi ne i fusaiuoli, calando i Cembali nella bocca; riempiono i Spacij de i moggetti; & i manichi alzando i fondi de i moggetti; per la forza & lo spesso battere, otturando i fori, che sono sopra i Cembali; l'Aria che ui è rinchiuso, costretto dalle pressioni, lo fanno andar per la forza nelle canne; per lequali concorre ne i capi de i legni, & per le sue ceruici nell'arca. Ma per il più uehemente mouimento delle stanghe, il fiato spesso compreso entra per l'aperture de i bocchini, & riempie di uento i canali. Ilperche quando i Tasti sono toccati con le mani, scacciano & riducono continuamente le Regole, serrando cambieuolmente, & cambieuolmente aprendo i fori, eccitano con arti Musicali sonan page 288 do, con molte varietà de moduli de Voci. Mi hò sforzato, quanto hò potuto, che la cosa per scrittura chiaramente si pronunciasse: ma questa non è ragion facile, ne espedita, che possa essere intesa se non da quelli, ch'intorno à questo genere di cose s'affaticano. Per laqual cosa, s'alcuni da questi scritti hauranno inteso poco, quando hauranno cognition della cosa, ritroueranno essere stato il tutto curiosamente & sottilmente ordinato.Questa è la descrittione fatta da Vitruuio dell'Hidraulica machina, laquale, com'ei dice, è molto oscura & difficile; se ben non hà lasciato di discriuerla breuissimamente, con l'accostarsi, narrandola, più al uero che hà potuto. Ma perche è cosa difficile & oscura, ciascuno che uorrà hauer di questa cosa maggiore lume & intelligentia, leggendo quello c'hà scritto sopra questo capo, Daniel Barbaro nobile Venetiano, già Patriarca eletto d'Aquileggia, potrà in parte sodisfare al suo desiderio. Ma la simiglianza, che da questa descrittione si scorge tra l'Hidraulica & l'Organo nostro, mosse l'Illustriss. S. Suor Leonora d'Este, l'Anno 1571. nel mese di Nouembre, à farmi richiedere da Francesco Viola gia mio singolare amico, Se cotale Organo era antico ò pur moderno, & dou'ei prendesse il suo nome; allaquale hauendo prima risposto, mosso da questa richiesta, deliberai di Scriuere i presenti Sopplimenti; non però con quell'ordine c'hò tenuto, ma secondo che mi soccorreuano ò secondo 'l tempo nelquale m'erano richieste le cose, à modo d'una Selua, nellaquale siano piantati molti alberi à caso & senz'ordine alcuno. Et questa fù la Prima dimanda, ch'io scriuessi in questo proposito. Laonde la porrò seguentemente, per satisfare alla curiosità de molti, che desiderano sapere cotal cosa; secondo ch'io la esposi alla sudetta Illustr. Sig. Incominciando adunque dalla Seconda parte della dimanda, dico; che questo nome Organo, non à particolare d'alcuno Istrumento, il quale serue alla Musica; ma conuiene etiandio à tutti quelli Istrumenti materiali, che seruono à qual si uoglia Arte ò Scientia, con l'aiuto de i quali si può condurre in quella alcuna opera al desiderato fine. Quelli anco, che col mezo loro uenimo al possesso d'alcuna cosa, commutandoli in un'altra, si chiamano Organi; essendoche cotal nome è Greco, & si dice Ο῎ργανον. & propriamente uuol dire Istrumento: onde il Martello, che adopera il Fabro nel fare i chiodi, & la Sega, che adopera il Legnaiuolo à segare & fender l'Asse, sono detti Istrumenti. Il Denaro anco, col quale comperiamo le cose necessarie al uiuere humano, è detto Istrumento. Et non pur le cose materiali, c'hanno la forma loro permanente; ma quelle che non hanno cotal forma; com'è la Logica; diciamo Istrumento. Anzi tutta l'Adunanza de i libri, che seruono alla parte Rationale della Filosofia, scritti d'Aristotele, sono detti Ο῎ργανον ὀργάνων; cioè, Istrumento de gli Istrumenti. Et tal parte è detta Istrumento dell'altre Scientie. Per la qual cosa dico, che l'Organo proposto s'acquistò questo nome uniuersale & commune d'Organo proprio & particolare, per una certa eccellenza dalle parti naturali, che formano la Voce, che si chiamano Istrumenti naturali: percioche fù fabricato alla guisa del Corpo humano, corrispondendo le Canne alla Gola, i Mantici al polmone, i Tasti à i Denti, & colui che sona alla Lingua, & cosi l'altre parti di esso à quella che sono nell'Huomo. Ma ueramente l'Organo nostro in quanto ad una parte della forma materiale, non è molto antico, anzi moderno: percioche sono aggiunti ne i Moderni i Mantici, i quali dalla Cassa che conteneua l'Acqua detta hora Sommiero somministrano il Vento, che passa nelle Canne; come nel sudetto luogo dipinge Vitruuio; dal che s'acquistò il nome di Hidraulica; il perche si può uedere, che 'l nostro Organo non è Istrumento moderno, se non in quanto all'alteratione della sua prima forma: percioche il Vento, che hora si fà con i Mantici, è posto in page 289 luogo di quello, che si facea col mezo dell'acqua. Ma l'uso dell'Hidraulica è antichissimo, & da questo si conosce, ch'era posto tra 'l numero di quelli Istrumenti, che si sonauano col fiato ò uento; che chiamauano Ε'μπνευστὰ, & non tra quelli, iquali conteneuano cose distese sopra di loro; come sono chorde, pelli, & altre cose simili, che chiamauano Ε῎ντατα. onde Aristocle appresso di Atheneo nel Cap. 24. del Lib. 4. Dipnosophistòn, hauendo prima ricercato, tra quali si habbia da porre l'Hidraulico, & è dopoi di parere, che ella s'habbia à nominare Εμπνεστὸν. percioche le sue canne riceueuano il fiato dall'acqua; onde dice: Κατεστραμμένοι γὰρ εἰσιν οἱ αὐλοὶ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἀρασσομένου τοῦ ὕδοτος ὑπό τινος νεανίσκεν, ἔτι δὲ δυκνουμένων ἀξινῶν διὰ τοῦ ὀργάνου, ἐμπρνέονται οἱ αὐλοὶ, καὶ ἦχον ἀποτελοῦσι προσηνῆ: cioè, Le canne dalla parte da basso sono uoltate nell'acqua; laquale essendo mossa da un giouane, mouendosi alcune linguele per l'Istrumento, & scorrendo di quà & di là; esse canne si riempiono di spirito ò fiato & rendono suono soaue. Et dimostra poco più auanti, questo Istrumento esser molto antico; se bene Aristosseno non n'habbia di lui fatto mentione; ma dice, che Platone diede un poco di lume del suo arteficio; hauendo fatto un'Horologio notturno, non molto differente dalla forma dell'Hidraulico. Non è però da credere, che quando si troua nella Diuina scrittura in più luoghi questa Voce Organo; come nel Gen. Cap. 4.
Ipse fuit pater canentium Cithara & Organo;& nel Salmo 150.
Laudate eum in chordis & Organo,& in molti altri luoghi; che s'habbia à pigliar per l'Organo, che di sopra habbiamo commemorato, ma per un'altro Istrumento; essendoche quello, che leggiamo nella nostra Volgata Editione di Iubal, c'habbiamo mostrato di sopra; nell'Hebraico si legge.
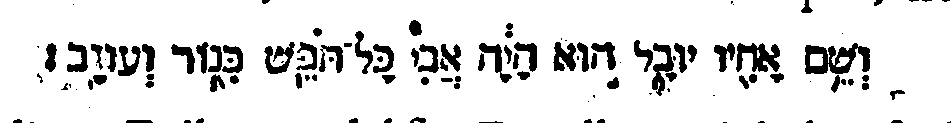
Α'λλοίη ν ὁρόω δονάκων φύσιν. ἦκου ἀπ'ἂλληςCioè;
Χαλκείης τάχα μᾶλλον ἀνεβλάστησαν ἀρούρης,
Α῎τριοι, οὐδ'ἀνέμοισιν ὑφ'ἡμετέροις δονέονται,
Α'λλ'ὑπὸ ταυρείης προθορὼν σπήλλυγγος ἀήτης,
Νέρθεν ἐϋτρήτων καλάμων ὑπὸ ρίζαν ὁδευει.
Καιτις ἀνὴρ ἀγέρωχος ἔχων θοὰ δάκτηλα χειρὸς,
Ι῎σταται ἀμφαφόων κανόνας συμφράδμονας αὐλῶν.
Οἴ δ'ἁπαλὸν σκιρτώντες, ἀποθλίβουσιν ἀοιδὴν.
Vedo diuersa natura de Canne;Et per quello che si uede, non si scorge altra diuersità dal nostro Moderno che nelle Canne, ch'eran fatte di Rame, & rendeuano il suono acutissimo & alquanto aspero; & quello de Moderni sono fatte di Metallo, come di Stagno ò piombo, oueramente di legno rotonde ò quadrate. Dalche si può giudicare, il nostro organo essere Istrumento più tosto antico, che moderno; & esser quasi figliuolo dell'Hidraulico. Alcuni però si sono mossi à dire, che
Non potrebbon più tosto esser'uscite
Da terra, che per caso ferrea fusse?
Aspere sono, & non sono commosse
Da nostri venti: ma 'l Vento mandato
Da spelunca taurina con furore
Si fà la via ne i ben forati Calami
Dalla radice alla parte di sotto.
E' vn Giouane eccellente, che gli artigli
Delle mani tien'agili, si siede
Toccando insieme le concordi Regole
Delle tibie; onde questi in sù salendo
Mandano fuori dolcissimo Canto.
Questo nostro Istrumento fù in uso primieramente nella Grecia, & che de iui per l'Vngheria fusse trasferito nella Germania tra i Bauari;perche
dicono hauerne veduto vno tra gli altri nella Chiesa Cathedrale di Monaco con Canne al bossolo, tutte in vn pezzo, grande & tonde all'ordinario delle nostre fatte di metallo; ilquale nel suo genere & di quella grandezza, è il più antico d'alcun'altro, che si troui non solo in quella prouincia, ma forse in qual si voglia parte del mondo.Ma s'ingannano; percioche ui sono stati Organi più antichi di quello; essendoche, come si può comprendere da un Sommiero d'un'Organo, ch'io tengo appresso di me, ch'era d'una Chiesa di Monache nell'antichissima città di Grado, sede Patriarchale; laqual nell'Anno del Signore 580. fù saccheggiata & destrutta prima da Pepo Patriarca d'Aquilegia di natione Te page 291 desco; come narra Bernardo Giustiniano nobile Venetiano in quello che scriue dell'Origine di Venetia; & dopoi non passò molto tempo, che la Chiesa fù saccheggiata da Fortunato Arriano, & da Lupo Duca del Friul; essendo stata molt'altre fiate saccheggiata la Città solamente. Il qual Sommiero è lungo intorno un braccio, & largo circa una quarta; & per quello ch'in esso si uede, ui sono i luoghi, ne i quali si collocauano solamente Trenta canne, ne ui era alcun Registro; come dal suo Tastame si può conoscere nella seguente figura: percioche erano solamente Quindeci tasti, fatti al modo che in essa si uedono dissegnati; & erano partiti in due ordini, ciascun de i quali ne conteneua Quindeci, se fussero poi di legno ò di metallo, ò fussero questi due ordini accordati insieme all'Vnisono ouer'alla Ottaua, questo non si può sapere. Hauea etiandio i Mantici co fori rotondi, di doue ne usciua il Vento, collocati nella parte di dietro; come si uedono accommodati ne i Regali moderni. Ma nella Chiesa del Santo di Padoa ue
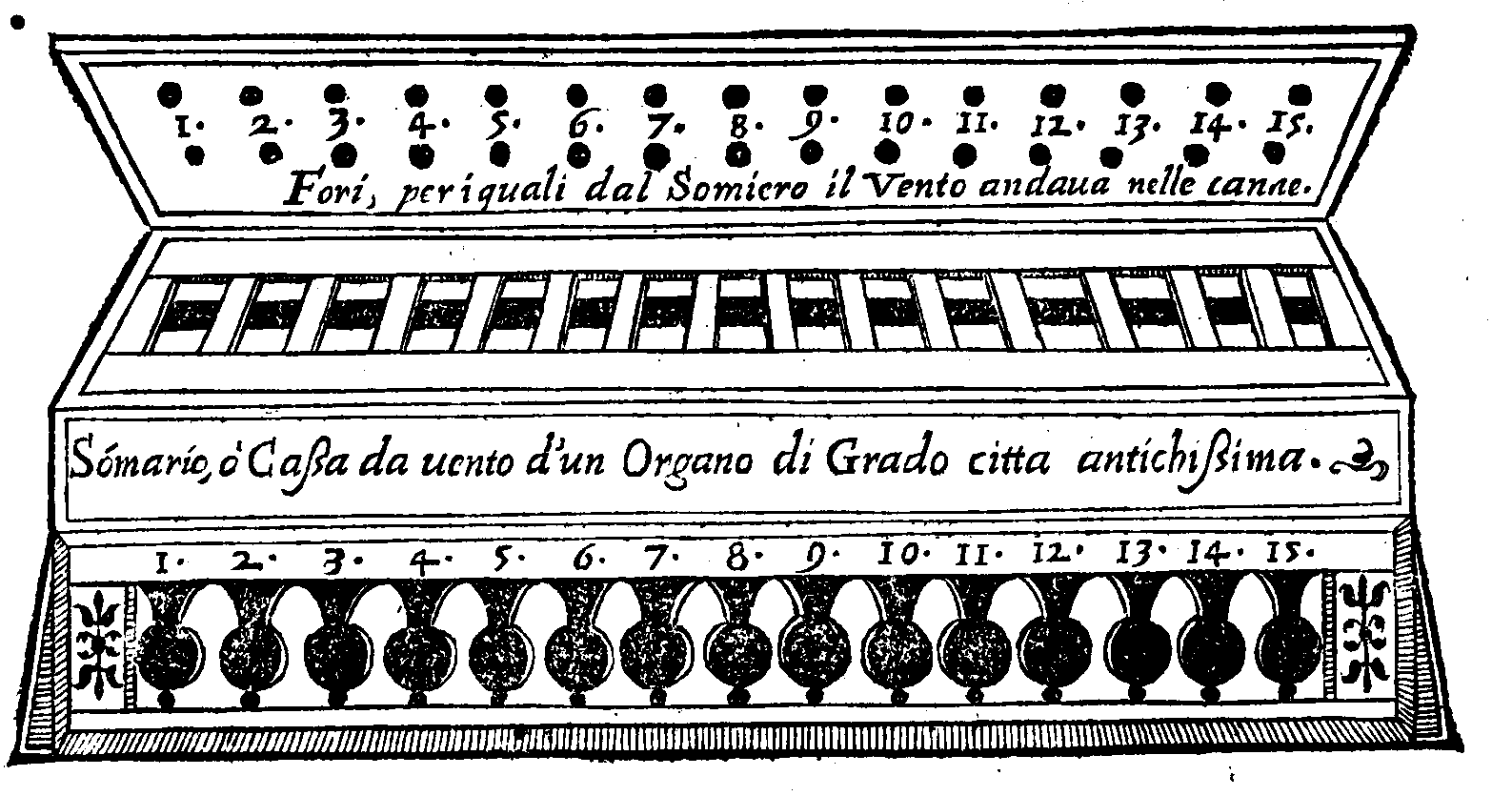
Credono anco, per i molti rincontri,che dicono hauere:
che quell'Organo delquale fà mentione Dante nel fine del Purgatorio, non fusse precisamente come quello che si costuma hoggi; ma si bene in molte cose differente, come nella moltitudine & grandezza delle canne, nella distanza de gli estremi, nella coppia de i Registri, & in molt'altri particolari:Ma uediamo di gratia, il fondamento di questo loro credere, & da che lo cauano; & come l'Organo di Dante non fusse precisamente come quello che si costuma hoggi, ma differente molto per i molti Rincontri che dicono. Questo Poeta celebratissimo nel fine del Cant. 9. del Purgatorio, introducendo un'Angiolo, che gli apre la porta all'entrata del Purgato page 292 rio; scriue il romore che sentì nell'aprirla; imitando Lucano, quando nel Lib. 3. della Guerra Farsalica, scriue di Tarpeia in questa maniera.
Tunc rupes Tarpeia sonat, magnoque reclusascon queste parole:
Testatur stridore fores:
Ma doue si possono conoscere cotali Rincontri? Questo è ben ueramente un loro sogno: percioche Dante altro non fà, ch'assimigliar lo Stridore, che fece la porta del Purgatorio nell'aprirsi, à quello di Tarpeia, che s'apriua di raro; ou'era riposto l'Erario de Romani, quando Cesare aprendola lo spogliò de i Thesori: essendoche entrato ch'ei fù in cotal luogo, ilche è da notare, li parue udir cantare con uoce accompagnata al suono di cotal porta,Non ruggio si, ne si mostrò si acra
Tarpeia, come tolto le fù il buono
Metello, donde poi rimase macra.I mi riuolsi attento al primo tuono,
Et Te Deum laudamus, mi parea
Vdir in voce mista al dolce suono.Tal'Imagine apunto mi rendea
Ciò ch'io udia, qual prender si suole,
Quando cantar con Organi si stea,C'hor si, hor nò s'intendon le parole:
Te Deum laudamus;& se gli rappresentaua uno che cantasse con gli Organi; le cui parole hora s'intendono, & hora nò. Ma cotal nome di Organo è commune; come si è mostrato, ad ogni sorte d'Istrumento, come anco ei lo fà commune alla Cetera, dellaquale parla più abbasso. Ma più mi marauiglio, ch'ei non habbia fatto mentione di quelli, che commemora l'istesso Poeta nel principio del 31. Canto del Purgatorio, quando dice:
Ponendo cotali Organi, per gli istessi, che disopra si è nominato. Ma questo sarebbe stato assai peggio: percioche gli Organi ch'ei qui nomina, non conuengono con li primi in cosa ueruna: poscia che questi sono ueramente Naturali, & quelli Arteficiali. Dirò ancora meglio; dicono cheEra la mia virtù tanto confusa,
Che la Voce si mosse, & pria si spense,
Che da gli Organi suoi fusse dischiusa.
l'Organo, che commemora Suetonio Tranquillo nella Vita di Nerone , & Vitruuio in proposto della machina Hydraulica dell'istesso, & quello di che ragiona Gioseffo nelle Antichità de gli Hebrei di Dauid, non habbia à far cosa alcuna col nostro, eccetto che nel nome.Veramente che questo è ben detto; & non fuor di proposito; ma che hà da fare (di gratia) una Cetera ò Cinnyra con un'Organo? lasciando il parlare dell'Hydraulico. Suetonio parla d'una Cetera, che fù portata à Nerone, & scriue queste parole:
Cithera autem à Iudicibus ad se delatam adorauit, ferrique ad Augusti statuam iussit.Adorò la Cetera (scriue egli) portata à lui da i Giudici, & commandò, che fusse portata alla statua d'Augusto. Et Gioseffo scriue, che solo Dauid cantando ἐν τῇ κεννύρᾳ, nella Cinnira, riduceua il Re Saul nella mente sana. Et s'era Cetera ò Cinnira, ch'io reputo con molti altri Interpreti, che fusse una cosa istessa; che bisognaua dir questa cosa, & introdurla fuori d'ogni proposito & d'ogni uerità? Ma questo basti intorno all'Organo istrumento moderno, conosciuto da ogni prattico delle cose della Musica. page 293
Per Qual cagione si è ridutta la Massima & Perfetta harmonia in Cinque termini; & quello che s'intenda per l'Interuallo diuiso geometricamente in molte parti. Cap. IIII.
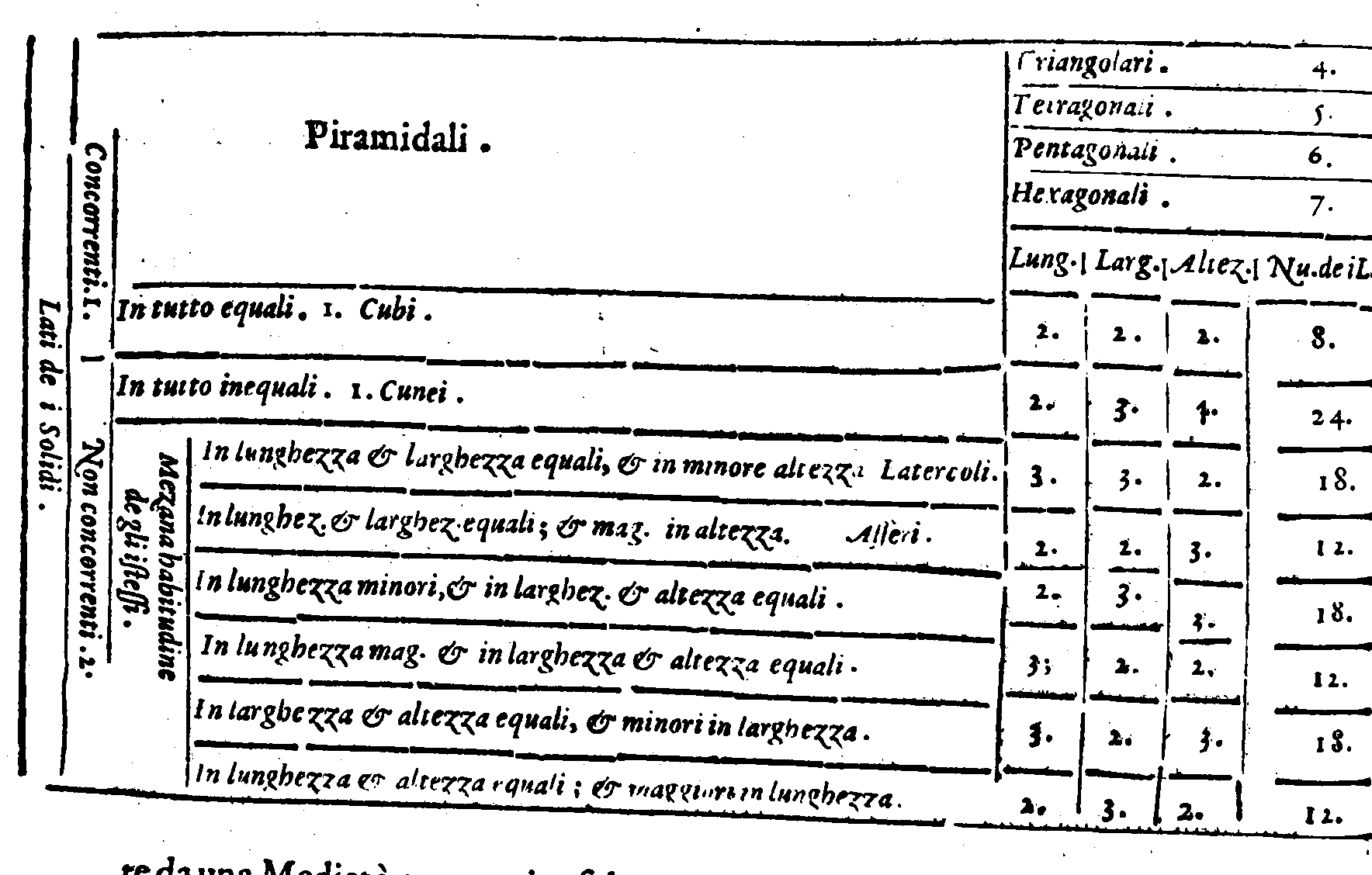
Restat ergo de Maxima, perfectaque harmonia disserere; quae tribus Interuallis constituta, magnam vim obtinet in musici modulaminis temperamentis; & in speculatione naturalium quaestionum. Et enim perfectius huiusmodi medietate nihil poterit inueniri; quae tribus interuallis producta, perfectissimi corporis naturam, substantiamque sortita est. Hoc enim modo Cubum quoque trina dimensione crassatum; plenam Harmoniam esse monstrauimus. Haec autem huiusmodi inuenietur; si duobus terminis constitutis, qui ipsi tribus creuerint interuallis, longitudine, latitudine, & profunditate, duo huiusmodi termini medij fuerint constituti; & ipsi tribus interuallis notatis; qui, vel ab aequalibus per aequales aequaliter sint producti; vel ab inaequalibus ad aequalia aequaliter; uel ab inaequalibus ad aequalia aequaliter; uel quolibet alio modo: atque ita cum Harmonicam proportionem custodiant; alio tamen modo comparati, faciunt Arithmeticam medietatem; hisque Geometrica medietas, quae inter vtrasque versatur, deesse non possit.Et il restante che segue; le quali parole hò uoluto por qui, accioche si conosca, che hauendola alcuni uoluto intendere al modo loro, quanto siano lontani dal uero senso. percioche non solo da gli Antichi, ma ne anco d'alcun de Scrittori de nostri tempi, non pur'è stata detta, ma ne anco accennata & conosciuta per altra. Questa adunque è veramente la Massima & perfetta harmonia, costituita di tre Interualli tra questi quattro Termini ò Numeri solidi. 12. 9. 8. 6. essendoche tra 'l 12. primo & massimo & il secondo 9. si troua prima la Sesquiterza forma della Diatessaron consonantia; come si troua etiandio tra il terzo & l'un de i due mezani 8. & 6. ultimo & minimo. Et nel medesimo modo si troua dopoi la Sesquialtera forma della Diapente tra 'l primo 12. & il sudetta page 296 terzo 8. che si oua anco tra 'l secondo & primo mezano 9. & l'ultimo 6. Ritrouandosi anco la Dupla, ch'è la forma della Diapason tra i due estremi 12. & 6. Ma si troua ultimamente la Sesquiottaua tra 9. & 8. ch'è la forma del Tuono, & la differentia che si uede essere tra la forma della Diapente & quella della Diatessaron. Si ritroua anco la sudetta Massima & perfetta harmonia tra i termini 12. 9. 8. 6. contenenti le tre principali Proportionalità; Arithmetica, Geometrica, & Harmonica: percioche tra 12. 9. 6. si troua l'Arithmetica; essendo le differentie de questi termini equali; poiche il 3. ch'è la differentia che si troua tra 12. & 9. è quella che si troua anco tra 9. & 6. Ma tra 12. 8. 6. è collocata l'Harmonica per la proportione conforme, che si troua tra gli estremi 12. & 6. & quella che è contenuta tra le differentie de i tre dati termini, che sono 4. & 2. essendoche quella, ch'è tra 12. & 8. è 4. & quella, ch'è tra 8. & 6. è 2. che per la relatione c'hanno l'uno all'altro; come 4. al 2. fanno la Dupla. Et l'una & l'altra di queste due Proportionalità si chiama Congiunta, laquale è di tal natura, che l'estremo mezano d'una proportione serue in essa per l'estremo dell'altra seguente; il che non auiene in quella, che si chiama Disgiunta ò separata; laqual si troua spesso in ciascuna delle tre nominate; come dimostra Boethio nel Cap. 30. del 2. Lib. dell'Arithmetica; laquale lascio di dimostrare, per non tornare al propo
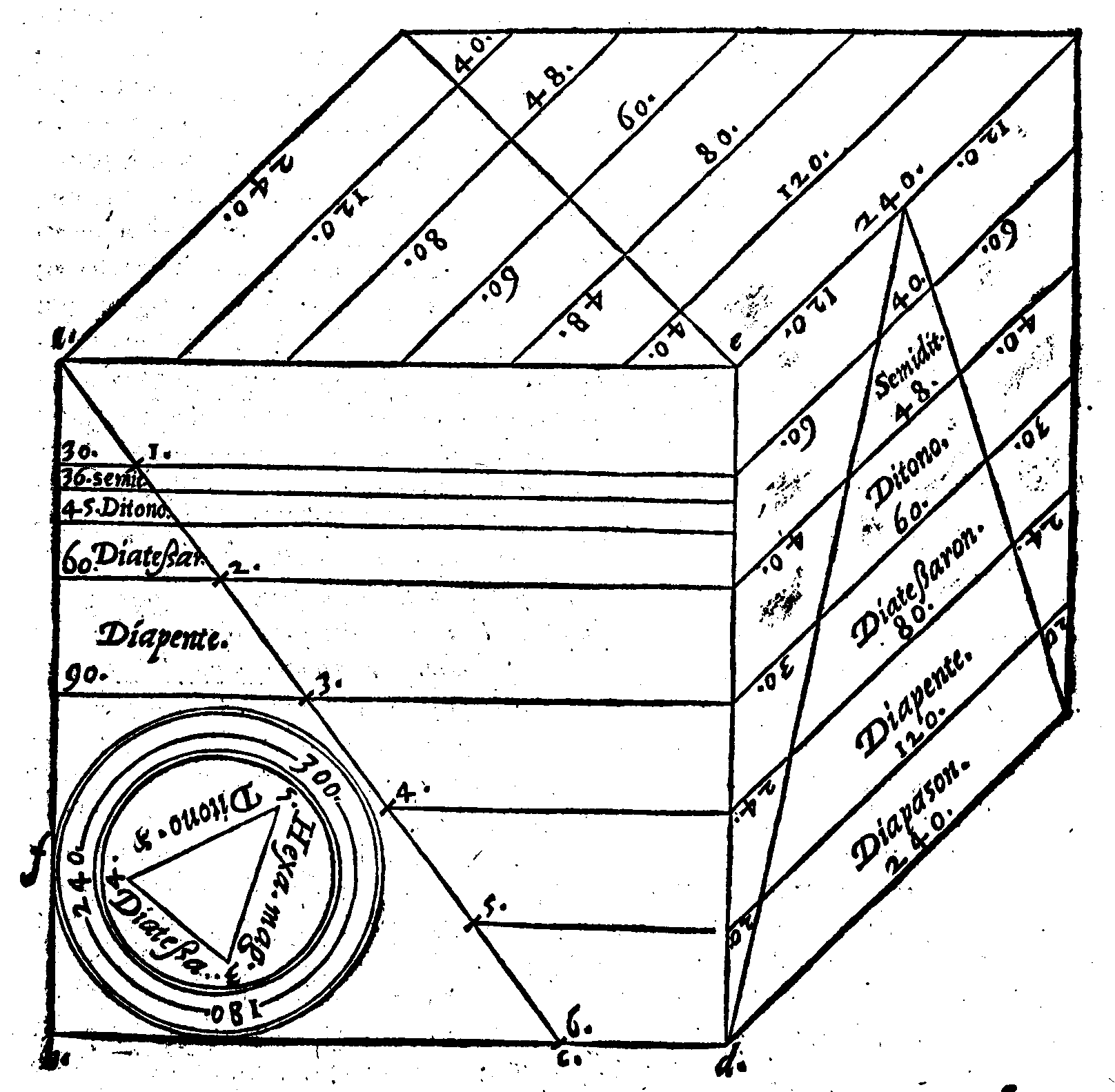
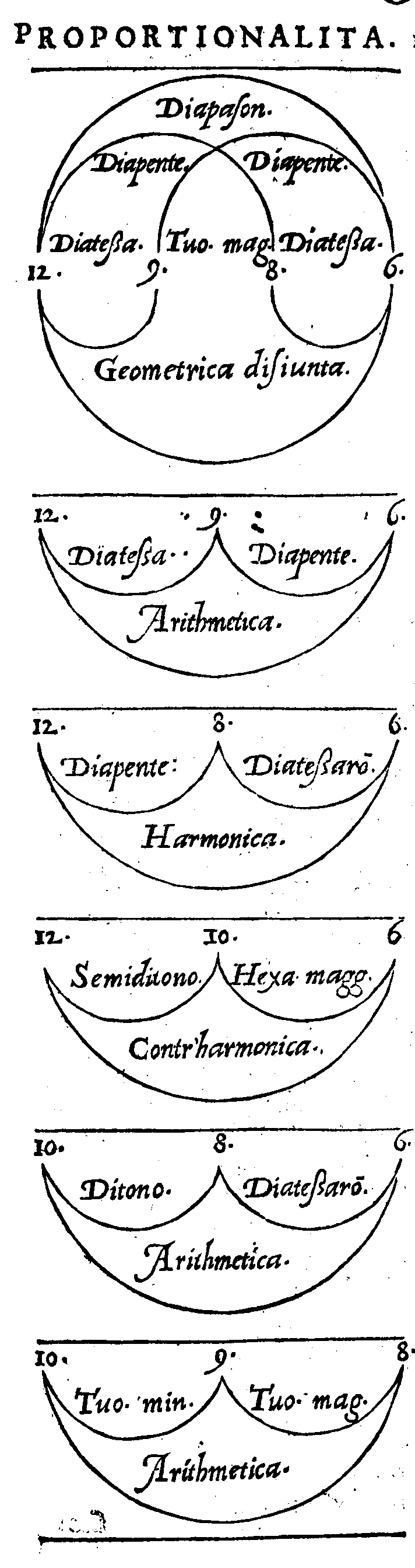
D'Vna noua & insolita Massima harmonia vanamente introdotta d'alcuni Moderni.Cap. V.
Fù opinione de gli Antichi musici, che la Massima harmonia fusse quella Discordante concordia, che virtualmente si troua in qualunque proportionalità, che constasse de cinque numeri, ò termini; iquali fussero tra loro in maniera disposti, che tra le parti di essi ordinatamente si trouasse in potentia la forma di ciascun loro consonante Interuallo, & appresso quello del Tuono, detto Timone delle Harmonie; per esserci col suo mezo hauuto cognitione dell'uno & dell'altro Semituono della diuisione ò separatione de i Tetrachordi, di ciascun'altro Interuallo di esso maggiore ò minore.Ma questa loro dichiaratione non può essere accettata per buona d'alcuno di sano giudicio; essendoche non si troua appresso d'alcun'Autore ne Antico ne Moderno; ne Greco, ne Latino, che faccia di questa lor Massima harmonia alcuna mentione; quantunque questo lor pensiero habbia prima hauuto principio non da altro luogo, che dal Cap. 5. della Prima parte dell'Istitutioni, & dalla 12. Prop. del 2. delle Dimostrationi, & si habbiano poi formato un capriccio al modo loro. Ma se dicessero, d'hauerla ritrouata appresso alcun'autore da me non conosciuto, questo non bastarebbe: percioche bisognaua per dare autorità à questo lor nuouo pensiero, & per mostrar d'hauer ueduto autori, da me non conosciuti, nominarli almeno con qualche strano nome; come fanno molti, per dimostrar d'hauer ueduto Autori da altri non conosciuti: percioche troppo importa page 300 nell'Introduttione de cose noue, lequali non si credono cosi facilmente; l'esser confirmate, ò con uere dimostrationi, ò con l'autorità almeno d'Huomo che sia saputo, & più antico dell'Inuentore. Confessaranno per auentura appresso, d'hauerla presa da me, dalla 12. sudetta Proposta, nella quale medesimamente mi seruo di cinque Termini, come ho dimostrato; & diranno; se fu lecito à te, d'hauere accresciuto il numero de Termini di questa Massima harmonia, perche non dee esser'anche à noi concesso? E` uero, che nella mia Massima & perfettissima harmonia, che cosi la chiamo, senza distrugger quella de gli Antichi, hò aggiunto un Quinto termine, ch'è il 10. com'hò pienamente dichiarato nel Capitolo precedente: essendoche si come gli Antichi ne aggiunsero alla Geometrica harmonia del Cubo, contenuta tra 12. 8. 6. un Quarto, ch'è 9. per hauer tra esso & l'8. la forma del Tuono maggiore, & tra 12. 9. 6. la proportionalità arithmetica; cosi tra i quattro 12. 9. 8. 6. u'aggiunsi l'harmonia del Triangolo orthogonio, contenuto da tre linee rationali. 5. 4. 3. interponendoui il Quinto doppio, ch'è il 10. in questo modo. 12. 10. 9. 8. 6. per far'acquisto del Tuono minore, la cui forma è 10. & 9. & quella del Ditono, ch'è contenuta tra 10. & 8. con quella del Semiditono, che si troua tra 12. & 10. che sono Interualli consonanti, & della proportionalità Contr'harmonica, contenuta tra 6. 5. 3. Ma dicono, che
gli Antichi hebbero opinione, che la Massima harmonia fusse quella Discordante concordia, che virtualmente si troua in qual si voglia proportionalità, che consti de Cinque termini.Veramente non mi ricordo d'hauer mai ritrouato appresso alcuno Scrittore cotal cosa. Mi souien bene, ch'Empedocle pose insieme la Lite & l'Amicitia, delle quali si generano (secondo 'l suo parere) tutte le cose; & questo chiamai nel Cap. 5. della Prima parte delle Istitutioni, Harmonia; & dissi, ch'era una Discordante concordia; cioè, Concordia de uarie cose, che si possono aggiungere insieme. Delche sen'hanno questi Galant'huomini gentilmente accommodato; & non mi dispiace. Dicono anco, che uniuersalmente si troua in qualunque proportionalità che contenga cotali numeri, & ne fanno entrare cinque nella compositione della lor Massima harmonia, che sono 24. 12. 9. 8. 6. tra iquali non si troua ne la Contr'harmonica, ne il Ditono, ne meno il Semiditono; se ben dicono, che tra questi Numeri si trouano in atto (com'è uero in fatto) tutte le forme di quelle Consonanze ouer Interualli, che nominano. Ma non bisognaua (se cosi è) che dicessero, che tali Numeri fussero tra loro in maniera disposti, che tra le parti di essi ordinatamente si trouasse in potentia la Forma di ciascun'Interuallo consonante, se non aggiungeuano, appresso de gli Antichi, anco dicessero che 'l Tuono era il Timone della loro harmonia. Aggiungono anco, quando parlano de gli Accidenti, che
Gli Antichi considerarono in ciascuna delle diuisioni Arithmetica, Geometrica & Harmonica; che l'Interuallo, dell'Arithmetico diuisore separato, conteneua tra i suoi termini maggiori la maggiore, & sempre nel graue la minor parte di esso.Quanto à queste non credo, che gli Antichi mai dicessero, che considerassero l'Interuallo contenuto tra i termini maggiori della Diuisione sempre nel graue, & la minor parte anco di esse; percioche questa consideratione è tratta dal Cap 40. uerso il fine della Prima parte delle Istitutioni, oue con nuouo modo & bel discorso, con due essempij fò uedere la simiglianza & la differenza delle Proportioni, che nascono dalla Diuisione arithmetica & dalla Harmonica; & il diuerso modo, che si debba intendere nel loro procedere. Ma forse eglino, per non dire, che questa nuoua consideratione uenga da me, l'attribuiscono à gli Antichi; ò che espressa malignità. E` ben cosa ueramente da ridere, c'hauendo anco parlato intorno le proprietà della proportionalità Geometrica, in confor page 301 mità di quello c'hò mostrato di sopra, dicono:
Et in tal maniera si possono diuidere tutti gli Interualli composti di due parti equali; contenuti però da numeri cogniti & rationali: com'è il Ditono, la Semidiapente, & il minore Heptachordo dell'antico Diatono, & altri: ma però tutti dissonanti, da quello che consta di più Ottaue in fuori.Et questa è ueramente una bellissima Regola & un'auenimento molto sottile, & una dottrina molto reale; da tenerla cara; se bene è da Mathematico poco dotto & di poca conscienza, & di grosso ingegno; oltra la quale, secondo l'occasione, n'andrò dimostrando dell'altre, che sono scaturite da un'istesso fonte in tal maniera grandi & grossi, che non potrebbono uscir fuori della porta Flaminia, ò del Popolo in Roma; quantunque ella sia alta & ben larga. Chi è quel tanto grosso huomo nel mondo, che non sappia, che un'Interuallo composto di due parti equali, & anco inequali (c'haurà ueduto la Seconda dignità del Primo delle Dimostrationi) si può anco in quelle istesse parti diuidere? Soggiungono ancora:
Contenute da Numeri cogniti & rationali;cosa che saprebbe anche dire il Cauallo del Gonella. A queste aggiungono anc'un'altra impertinentia, con l'essempio del Ditono, della Semidiapente & del minore Heptachordo; quando uogliono che siano quelli dell'antico Diatono, & che siano dissonanti: quasi che se fussero Consonanti, ciò non si potesse far per alcun modo. Et per dar maggior credito à questa loro Massima harmonia, aggiungono; che
Molto accommodatamente si sarebbe in prattica trouato tra le quattro chorde della Lira di Mercurio; seguendo l'opinione di Boethio, & non quella (come più vera) di Emanuel Briennio; se sotto la più graue di esse si fusse aggiunta una chorda, che l'estrema acuta hauesse risposto in Quadrupla proportione.Et questo è troppo; uoler ch'à loro sia lecito il far giudicio, qual di due cose sia la migliore, per poterla accomodare al loro proposito, & introdurre una in solita & nuoua cosa fundata nell'Aria; senza addurre pur una ragione ò autorità; &, non dirò lasciar da un canto, ma in tutto & per tutto distrugger quello, ch'è stato approuato da tanti & tanti huomini Antichi & Moderni dotti & di sommo ualore nelle Scientie; de i quali non ui è numero: come si scorge da queste loro parole:
HANNO ancora ueduto & credono alcuni; che tra Quattro chorde tese secondo la proportione della Lira, si troui la Massima harmonia, con ciascuna delle narrate conditioni: la quale opinione si può con diuerse ragioni confutare.Et tutto questo sarebbe uero, quando le conditioni, ch'essi pongono nel loro nuouo trouato, s'hauessero da osseruare in questa, & non secondo c'hanno definito gli Antichi; ma la cosa uà altramente; percioche ogn'un di mediocre ingegno & di mediocre intelligenza delle cose musicali conosce; che percuotendosi insieme Quattro chorde tirate sotto la ragion de i Numeri della Lira di Boethio, non rendono buona Consonanza; anzi discordano, non che facciano la Massima harmonia. Et cosi scriuono quelli, che uogliono trattar quelle cose, che non intendono. Et che questo sia uero, si uede espressamente, che per saluar la loro ignorantia, commettono un'altro fallo maggiore, quando dicono;
Questi tali mostrano, non hauere osseruato & auertito quello, che particolarmente Boethio dice di essa Massima harmonia in proposito, nel cap. 12. 13. & 14. del 2. Lib. della Musica; oltre à quello che ne hauea detto prima nell'Vltimo Cap. de i libri, ch'egli scriue dell'Arithmetica.Et se credono che Boethio fauorisca questa loro nuoua chimera & nuouo sogno. Eglino ueramente & non quelli ch'accusano di cotale ignoranza, non hanno inteso quest'Autore, ilqual parla di cotesta cosa tanto chiaramente, quanto dir si possa: essendoche nella Musica dichiara & dà ad intender quello, che sia Proportionalità arithmetica, geometrica, & harmonica, &qual page 302 sia la Continua & la Disgiunta: & ne i libri dell'Arithmetica dimostra chiaramente quello, ch'intenderebbe ogni poco poco istrutto Abachista; cioè, quello che sia la Massima harmonia costituita tra quattro termini, posti apunto nella sudetta Lira; che sono 12. 9. 8. 6. co i quali anch'io la segnai nel Cap 1. della Seconda parte dell'Istitutioni. Non uoglio anco lasciar di dire, che parlando eglino pur della Massima harmonia & della Proportionalità geometrica, che si troua in essa, dicono; che
Non si troua anco la diuisione geometrica, con le circonstanze che conuengono alla natura & qualità sua; tra lequali manca, che l'operatione del suo Diuisore sia da esser fatta da un termine ò numero, & non da due; & quello ch'importa più; il uoler trarre da un Tutto due parti, dellequali non è ueramente capace: & in oltre, le Differentie non contengono quell'istesso Interuallo che contiene l'un de mezi, considerato per Diuisore, con l'estrema più remota; nelle quali è paruto il tutto; come al suo decoro contiene.Dallequali parole si può comprender quello, che possono intendere di questa cosa, & come habbiamo bene inteso il Testo con l'essempio di Boethio; & quello c'hò narrato nella 12. del 2. delle Dimostrationi. Non contenti di questo procedono più oltra, riprendendo quello che non intendono, & lo mostrano tanto chiaramente, che non fà dibisogno perder tempo nel recitar le loro parole; essendoche basta solamente sapere, che uogliono dimostrare, che questa loro Massima harmonia si può considerare anco tra la chorda Proslambanomenos nel Systema delle Quindeci chorde, con applicargli il numero 24. & alla Mese il 12. alla Paranetediezeugmenon il 9. alla Netediezeugmenon l'8. & alla Netehyperboleon il 16.
Ne per altro s'acquistò tal Systema(dicono)
nome di Massimo & perfetto appresso gli Antichi Musici; se non perche in esso si trouaua ciascuna loro Consonanza; & l'istesso occorse à quella Progressione de numeri di sopra mostrata, per virtualmente contenerla.Ma questo è poco, rispetto à quel, che segue; quando audacemente dicono, ch'
Altri d'ignorantia & presuntione ornati dissero, esser la Massima harmonia de gli Antichi la ottaua, con la Quinta, & la Terza in mezo;ò che sfacciatezza: dalche si scopre il poco intendimento di quello, che questi Ignoranti (come presumono) hanno uoluto dire: percioche non hò trouato mai alcuno, per quello ch'io mi ricordo, c'habbia detto questa cosa: E' ben uero, che io dissi & dichiarai essere Harmonia, ouero Harmoniosa consonanza quel Composto, che si fà del Ditono & del Semiditono, i cui estremi sono contenuti dalla Diapente; come si può uedere nel Cap. 39. della Prima, & nel 12. della Seconda parte delle Istitutioni; ma ciò non potea tornare al loro proposito, di modo che lo potessero biasimare.
Con quanta poca cognitione habbiano costoro introdotta questo lor nuoua Massima harmonia.Cap. VI.
In musicis duplex poni solet harmonia maior, vt pote, & minor. Maxima harmonia est; quoties Quatuor solidorum Numerorum in Geometrica medietate constitutorum; inter maximum, unum mediorum & minimum, medietas Arithmetica concluditur: itemque inter maximum & alterum medium, page 303 nec non & minimum, medietas continetur Harmonica.Che uuol dire:
Nelle cose Musicali si suol porre una doppia Harmonia; come la Maggiore & la Minore. La Massima harmonia si troua tante fiate, che di quattro Numeri solidi costituiti in medietà Geometrica, tra 'l massimo, uno de i mezani, & il minimo, si rinchiude la medietà Arithmetica, & anco tra 'l Massimo & l'altro Mezano, & simigliantemente il minimo, si contiene l'Harmonica.Et segue più oltra.
Minor harmonia est, quotiescunque in solidorum dispositione, duae duntaxat sumuntur medietates; ut Arithmetica & Geometrica, aut denique Arithmetica & Harmonica;cioè,
La minore harmonia è quella, tutte le uolte che nella dispositione & ordinanza de i Solidi solamente, si pigliano due Medietà; come l'Arithmetica & la Geometrica, ouer la Geometrica & l'Harmonica, ouero l'Arithmetica & l'Harmonica.Ma per il Quinto Solido aggiunto potremo anco insieme porre con queste la Contr'harmonica & l'Arithmetica, la Geometrica con essa Contr'harmonica, & anco questa con l'Harmonica, & haueremo Sei minori harmonie; percioche in Sei modi solamente & non più si possono accompagnare; come appar ne i seguenti essempii. Et perche si può comprendere hormai quel
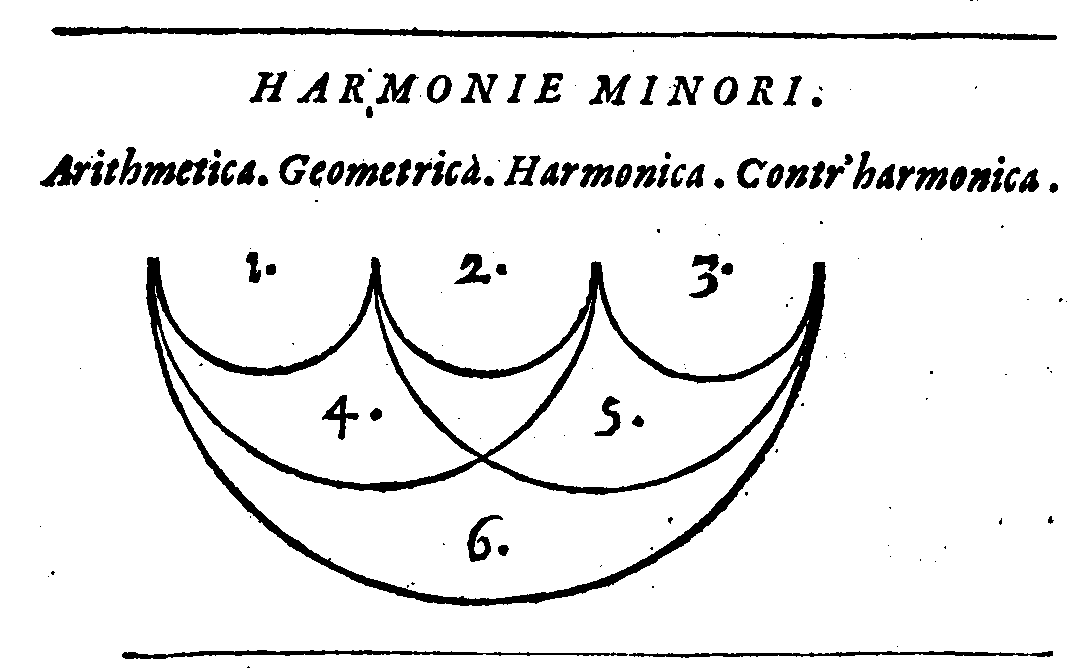
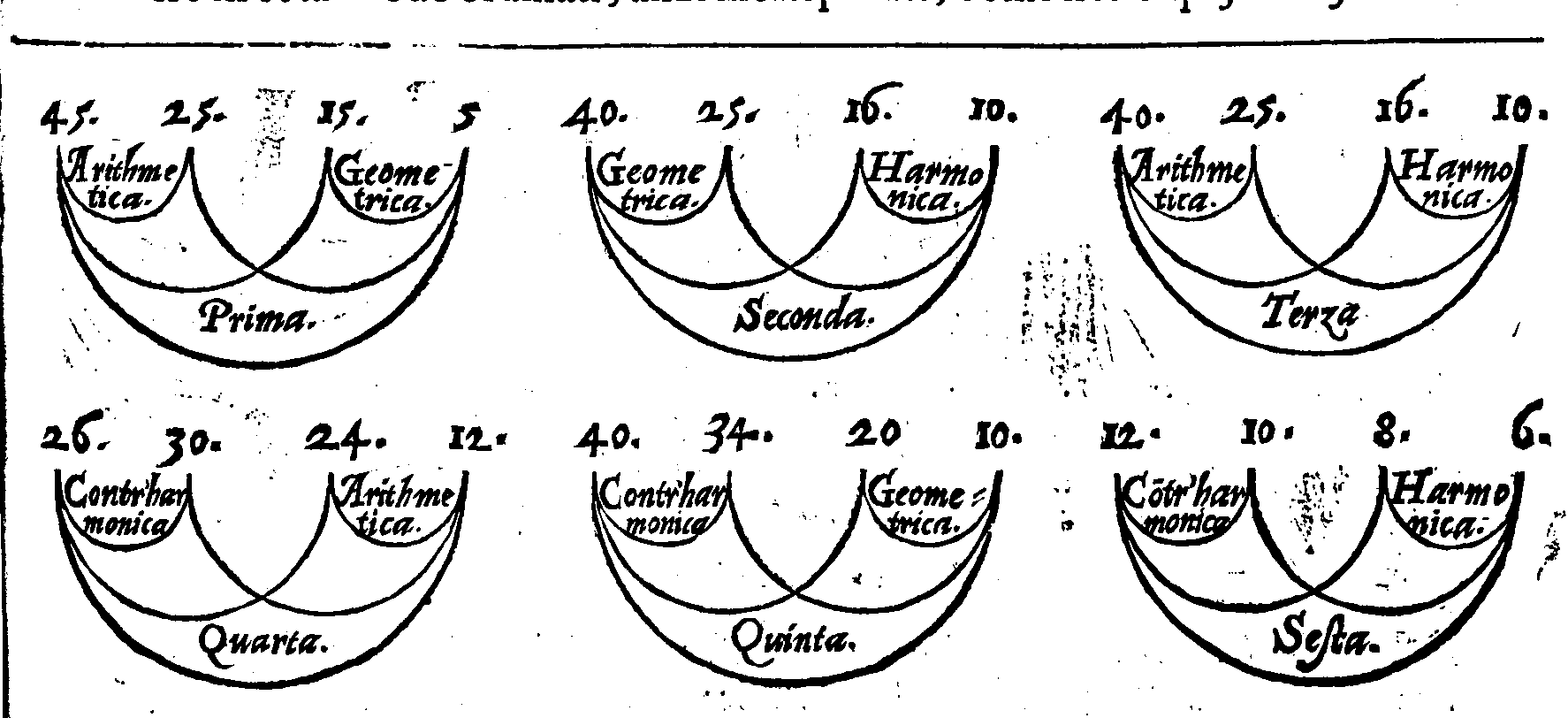
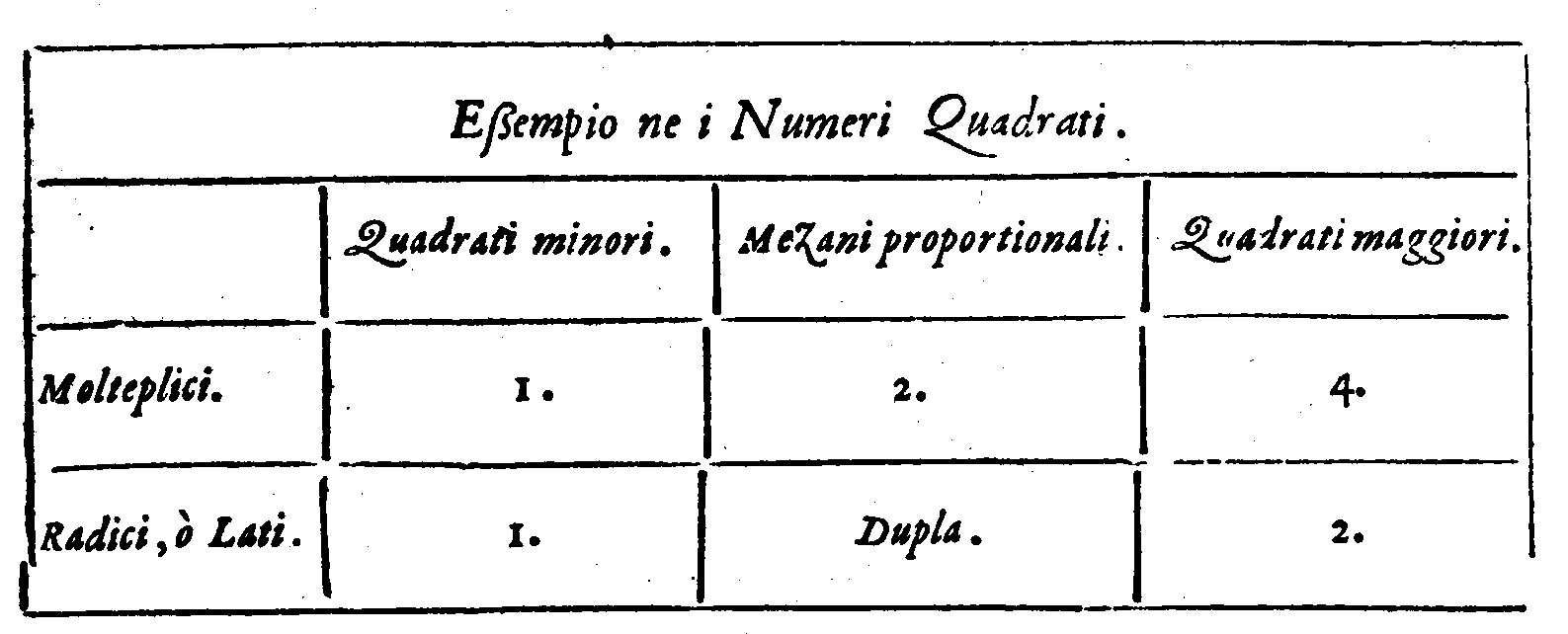
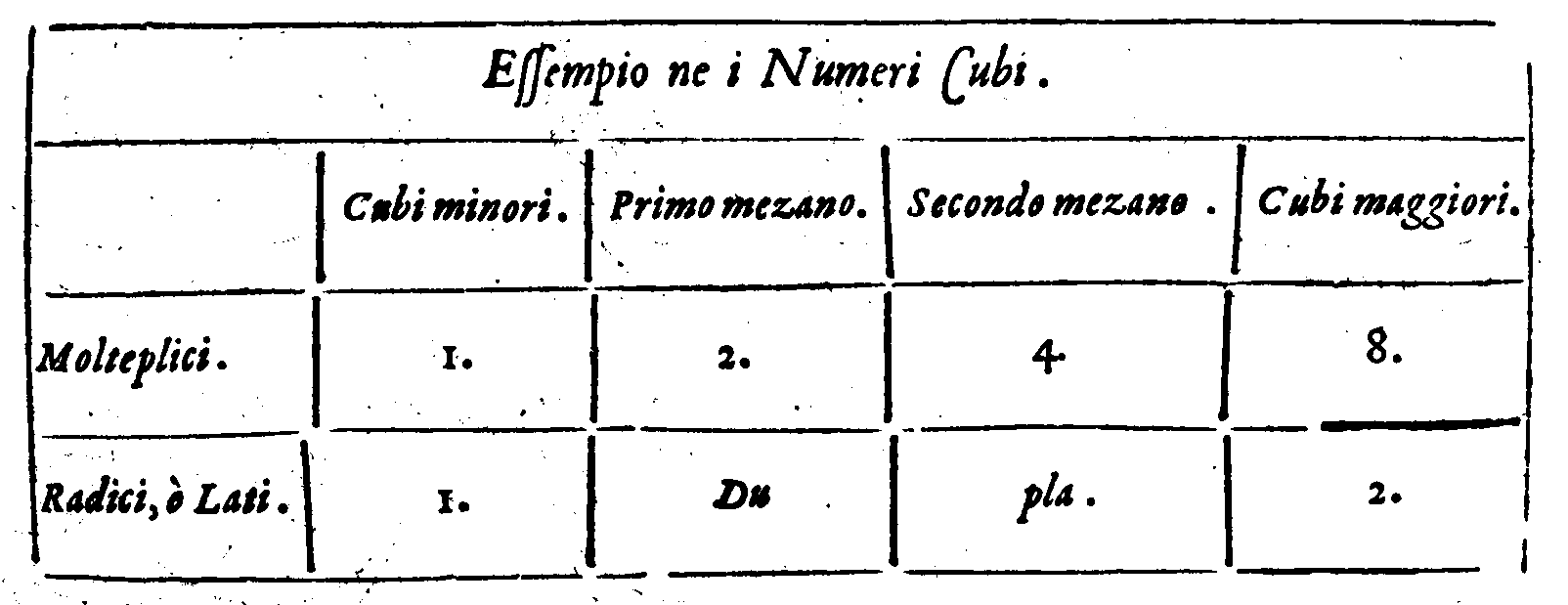
Se 'l Cantare in consonanza sia cosa impertinente; & delle Cagioni che attribuiscono alla Musica moderna, che non partorisca alcuno effetto.Cap. VII.
I Prattici d'hoggi vogliono, che la Musica de gli Antichi à comparatione della loro, fusse vna baia, da ridersene; & lo stupore, che col mezo suo cagionarono ne gli animi & menti de gli Huomini, non da altro nascesse ò deriuasse, che dall'esser grossi & rozi:onde chiamano cotali Prattici temerarij; che si ridono de gli effetti, che facea una cosa, laqual non sanno (come dicono) quello che si fusse, ne conoscono la sua natura & proprietà, ne come potesse ciò operare. Procedendo dopoi con poca honestà, & fuori d'ogni proposito mordendosi, dicono insieme col mio ualoroso, ben nato, ben creato, fortunato & dotto Discepolo; in lode de i Compositori moderni; che
Se da Cent'anni ò poco più che la Musica è stata essercitata, come si essercita al presente da Genti, che per l'ordinario sono di nullo o poco ualore(ò che imprudentia, ò che temerità)
non sanno per modo di dire, doue & de chi nati; non hanno beni della fortuna à pochi; ne anco sanno à pena leggere; è venuta in quel colmo d'eccellen page 306 za, che essi dicono; quanto maggiormente douea essere stupenda & marauigliosa quella appresso gli Greci, & i Latini; doue ella durò tanti & tanti secoli in mano del continuo à huomini i più sauij, i più scientiati, i più giudiciosi, i più ricchi, valorosi, regij & maggior Capitani, c'hauesse mai hauuto il mondo?Et soggiungono anco, che
dall'essempio di Temistocle, & da quello, che ne dice Polibio, si può comprendere, ch'era cosa vergognosissima & da ignorante à qual si voglia Nobile, di qual si voglia grado, senza quella sorte di musica conueniente à loro: & che quelli, che non sonauano la Lira, non erano ignoranti della Tibia: onde nacque il Prouerbio: Se non Citharedo, almen Auledo.A questo si può dir prima, che per quello ch'io mi ricordo, non ho mai trouato Scrittore, ne udito dire ad alcuno di buona qualità; che faccia professione di questa Scienza, che la Musica de gli Antichi fusse una baia da ridersene à comparatione della Moderna; come dicono; ma si bene hò udito lodar quella con somma marauiglia, per gli effetti che si leggono, ch'ella cagionaua & faceua ne gli animi humani; & quanto alla parte dell'Harmonia intorno all'uso, preporre la Moderna all'Antica: essendo per il uero l'una dall'altra molto differenti. Si può dir dopoi, che mi par uedere, che questi nuoui Censori non habbiano dato molto opera allo Studio delle cose morali; percioche si partono dall'utile & dall'honesto; poiche non è lecito ad alcuno, per grande ch'egli sia, di uscir fuori de termini contra la Giustitia, 1.ff. De Instit. & Iure. laquale consiste nel Viuere honesto, nel Non offendere il Prossimo, & nel Dare ad ogn'uno quello, ch'è suo: dellequali cose quanto questi siano stati osseruatori; da quello che dicono sfacciatamente, con poca ragione, & senz'alcuna uergogna, ciascun lo può conoscere. Ma per uenire à i Miracoli, che predicano della Musica antica & de i Musici; quale è quello Studioso che non sappia, di che qualità erano quelli, ch'anticamente la trattauano? essendoche se ue ne fu uno dotto & di uita modesta, ue n'era infiniti di uita sordida & ignoranti; com'hò discorso nel primo Libro del nostro Melopeio ò Musico perfetto. Diranno che Timotheo incitò Alessandro à pigliar l'Arme, un'altro conseruò per un gran tempo la pudicitia di Clitennestra, & Demodoco sospinse Vlisse à piangere & molt'altre cose; com'hò narrato nelle Istitutioni. Et forse preponeranno anco Hesiodo, Homero, Thamira, & altri più antichi ad ogn'altro: Stà bene; ma non erano però questi semplici Musici, ma Poeti celebratissimi; come ne fan fede gli antichi, & moderni Scrittori, tanto historici, quanto Poeti: Et furono anco una gran parte di loro huomini illustri, dotti, & di uita incontaminata. Ma di gratia, che si potrebbe dire di Homero lasciandone da un canto molt'altri; poi che nella sua uecchiezza; come recita Plutarcho nella sua uita; ei morì in gran miseria & calamità, se 'l si hà d'hauer riguardo alla pouertà? per laquale costoro biasimano i Moderni professori della Musica; bisognerebbe secondo la loro opinione porlo in filza, come si dice, co i Moderni, dalla dottrina in fuori, se bene fu Homero. Et se consideraremo quello che si legge d'Hesiodo appresso di Pausania, ei non fù Musico, ma semplice Poeta; perche non sapea sonar la Lira, ne la Cetera: onde recitaua i suoi Poemi al fischiare d'una Verga di Lauro, con laquale percuoteua l'Aria uelocemente: essendoche come dice un Scholio sopra la prima Rapsodia dell'Illiade d'Homero cotal Verga era cosi detta non, ἀπὸ τοῦ ῥάπτειν καὶ ὠδῆ: cioè dal Porre insieme la Cantilena; ma ἀπὸ τοῦ ῥάβδου καὶ ὠδῆ: cioè, dalla Verga fatta di Lauro, & da essa Cantilena; poiche i Poeti portauano seco cotal Verga, & alla percussione dell' Aria fatta con quella, cantauano in Verso le Laudi de i loro Heroi. Onde bisognerebbe porre Hesiodo nel numero de gli Ignoranti: percioche dicono, che anticamente il non saper sonare la Lira, la Cetera, & breuemente il non esser Per page 307 fetto nella Musica, era uergogna appresso i grand'Huomini d'honore. A questo rispondo, che non era men uergogna l'essere allora troppo eccellente, di quello che era il non saperne: ilche si conosce prima da quello che fece Filippo Re di Macedonia padre del Magno Alessandro; c'hauendo udito una fiata cantare & sonare soauemente Alessandro, lo riprese tacitamente, dicendogli: Non ti uergogni Alessandro, di saper cantare cosi bene? & dopoi da quello che si legge d'Antisthene, intorno quello che dicono d'esser Auledo; che hauendo egli udito nominare uno Hismenia, che era tenuto ottimo Sonatore di Piffaro de suoi tempi, disse: Veramente costui è huomo tristo; percioche se fusse huomo da bene & accostumato, non sarebbe Sonator di Piffaro. Onde appresso i Greci si canta à questo proposito; come si legge in Celio Rodigino, nel cap. 7. del 9. lib. Delle Antiche lettioni:
Α'νδρὶ μὲν αὐλητῆρι θεοὶ νόον οὐκ ἐνέφυσαν.Cioè;
Α'λλ ἅμα τῷ φυσᾶν χ'ὡ νόος ἐκπέτατε;
Nell'Huomo della Tibia sonatoreLaonde per il lor poco ceruello auenne, che i Musici furono poco stimati, & da gli Antichi riputati Huomini di poco relieuo & di uil conditione. Ilperche leggemo non solamente appresso di Gellio; ma di Tito Liuio anco; & più coppiosamente nel 6. Lib. de i Fasti d'Ouidio, la sordida uita, & l'ingordigia de quei Sonatori, che seruiuano ne i sacrificii in Roma, iquali partitosi per un sdegno c'hebbero contra il Consule, & andati tutti insieme (come si dice) & in frotta à guisa di Stornelli à stantiare à Tiuoli, i Romani non si potero mai persuadere, ne con preghiere, ne con minaccie, di ritornarui; ne ui sarebbono mai ritornati, se col mezo dell'Astutia & della Crapula, presi dal sonno, per hauer troppo mangiato & beuuto, non fussero stati uilissimamente posti sopra i carri, & condotti à guisa d'animali brutti à Roma. Ma che si può aggiunger di più alla modestia di quella Donna honesta, sonatrice di Piffaro, chiamata da Eliano Agiaide figliuola d'un Megacle; laquale in una cena mangiaua Dodeci mine di carne, & tanto pane, quanto mangiauano quattro huomini; & si beeua un concio di Vino; robba, che non l'haurebbe portato un'Asino sopra 'l dorso. Et forse che questi nostri Moderni scrittori si marauiglieranno, quando dirò, ch'anticamente il Sonar di Piffero era essercitio dishonorato & da persone uili & sordide, & non da ciuili & honorate, & che tale Arte era anco tenuta uile & sordida; & era pur cosi; poich'era essercitata allora se non da Serui, genti uile; de i quali la maggior parte erano Arabi; di doue nacque il prouerbio; Α῎ραβος ἀυλητῆς; perche dopoi, se bene incominciò à piacere à nobili, di modo ch'era tenuto indotto colui, che non ne sapea, durò poco tempo, che fù fino tanto ch'Alcibiade; come dicono alcuni; ò com'altri uogliono; Minerua; gettò il Piffero, come cosa sordida; hauendosi ueduto un giorno nello Specchio, quando sonaua, col uolto difforme. Grande honore ueramente fece anco alla Musica Conna sonator di cotale Istrumento; del qual si legge, che ne i conuiti staua coronato, & continuamente tragugiaua il Vino con stupor d'ogn'uno. Et di questi tali se ne trouano à nostri tempi, quasi infiniti, de i quali non è cosa ciuile, ne meno porta la spesa farne mentione alcuna. Ma se 'l si porrà in conto dal tempo, che s'incominciò à scriuere le cose, che dicono essersi marauigliosamente accadute; che fù (poniam caso) dal tempo di Homero, & più inanti anco un pezzo, fin'al tempo di Giulio Cesare; si potrà dire, che ui sia maggiore spacio d'Anni 1000. nondimeno page 308 si leggono pochissimi effetti, c'habbia partorito la Musica, rispetto al tempo, ch'è longhissimo; & pur sono i Scrittori greci uerbosi & molto loquaci, & scrittori molto amplificatori d'ogni minima cosa, & forse anco buggiardi; come si uede, che Pausania, se ben è Scrittore di grande autorità, non hebbe per inconueniente di commemorare un fico, che nacque appresso una porta d'una Città della Grecia, facendone gran marauiglia. Ma perche non solo scriuono le cose uere, ma di più anco le false, & Fauolose simigliantemente per uere; però Horatio non senza ragione disse una fiata:
Non posero la mente i Dei; ma insieme
Mentre 'l Piffaro gonfia ella si parte.
Graecia mendax;cioè, chiamò la Grecia mendace, & buggiarda; dellequali cose molte se ne potrebbe numerar, che si lasciano per breuità. Non uoglio però restar di dire solamente, quello che scriue Clemente Alessandrino In orat. adhortat. ad Graecos. & anco Strabone, come cosa marauigliosa, di Eunomo Citharedo; alquale fù dirizzato una statua, che teneua una Cetera, sopra laquale riposaua una Cicala: perche contendendo costui nel certame musico (come scriuono) con Aristone Musico regale, se gli ruppe una chorda nella Cetera; onde uolò sopra di essa una Cicala, che sopplì con la sua uoce à quello, che la chorda non potea far col suono: Laonde da quello che si è detto, si può creder, che non sia tutto uero quello, che scriuono. Et se i Scritti di molti huomini Illustri & degni d'autorità, & quelle ragioni c'hò detto nel Secondo dell'Istitutioni, non ci persuadessero à creder molte cose; Credo ch'apena si crederebbe quello, che scriuono di questi cosi fatti miracoli operati dalla Musica, non già ne gli Huomini grossi & rozi; come costoro attribuiscono l'hauer cosi detto à i Nostri prattici; percioche di questi se ne tiene dal mondo poco conto; ma in Soggetti alti & honorati. Et se i nostri Scrittori Latini ha uessero pigliato l'impresa di narrare ogni minima cosa, com'hanno fatto i Greci, io recitarei alcuni miracoli, parte à me narrati da Huomini di qualche autorità, che gli hanno ueduti, & parte de i quali hò ueduto io: ma non uoglio entrare in cotesta cosa, poiche non hò autore, ch'in publico ne faccia testimonio. Chi uorrà però sapere & conoscer le cagioni di cotali miracoli, leggerà nel luogo sudetto delle Istitutioni: percioche iui ne hò trattato copiosamente; se bene questi nostri Ingegni speculatiui moderni fuggono di narrarle; & mostrano di non hauerle mai lette, ne anco sentito narrare; come s'io non le hauesse mai scritte. Essendoche s'auedono, che se le hauessero palesati, non haurebbono forse di queste cose fatto tanti romori & tanti strepiti: perche s'haurebbe conosciuto, qual fusse la parte migliore de i Musici antichi, de i quali lasciai da un canto la peggiore. Ne ueramente haurei di questo fatto alcuna mentione, s'io non ne hauesse hauuto occasione. Aggiungono etiandio à questo, parlando con ironia: che
Con tutto il colmo dell'eccellenza della musica prattica de i moderni, fatta à più uoci:percioche non uogliono c'habbia proprietà alcuna;
non si uede ò pur non si ode vn minimo segno di quelli, che facea l'antica:onde primieramente attribuiscono questo alle Regole diuerse, ch'usano i Moderni Contrapuntisti nel collocare nelle loro compositioni le Consonanze, & questa è la prima cagione, che gli attribuscono. page 309
Altra cagione ch'attribuiscono & adducono, perche la Musica non faccia più miracoli. Cap. VIII.
Altro esser la natura del suono graue, & altro quella dell'acuto, & dell'una & dell'altra di queste esser diuersa la natura di quella di mezo.Cosi parimente dicono dopoi,
hauere altra proprietà il Moto ueloce, & altra il tardo; & da questa & quella esser lontano il mediocre: & che essendo ueri questi due principij, che sono uerissimi;come dicono;
si può facilmente da essi raccorre, che 'l Cantare in consonanza nella maniera, che i primi Prattici moderni usano, è una impertinenza:Et di più aggiungono, dicendo:
Il Zarlino nelle Istitutioni al Cap. 1. & 16. & nel 49. della 2. Parte, per l'opposito dice; che senza essa, è l'harmonia imperfetta:percioche dicono costoro,
la Consonanza non esser'altro, che mistura di suono graue & acuto, la qual senza offesa, ò con diletto, ò soauissimamente ferisce l'Vdito: & che se tal contrarietà d'effetto si troua tra gli estremi suoni delle semplici Consonanze; quanto uie più hauranno tal diuersa natura le Replicate & Composte, mediante la lontananza maggiore de gli estremi, & più di queste quelle, che più uolte Composte ò Replicate sono? le quali per esser più lontane dalla sua origine, sono men pure, dal senso men comprese, & meno intese dall'Intelletto. Et à gli impedimenti che cagionano la diuersità de Suoni & la varietà delle Voci, aggiungono quelli, che nascono dalla inequalità del moto delle parti; come non meno de i primi importanti.Quanto al dire, ch'altra sia la natura del Suono graue, & altra quella dell'acuto, & quella di mezana qualità esser diuersa: & cosi quanto alla diuersa proprietà de i Moti ueloci & tardi & de i mezani; si può dire, che tutto questo è manifesto ad ogn'uno, ch'è studioso delle cose naturali: ma tutte queste cose si trouano nelle Compositioni di più Voci; & di più, che ui è l'Harmonia propria, nellaquale si ode alle fiate dolcezza & soauità, & alle uolte asprezza & durezza; & tra questi due oppositi una cosa mezana, che ritiene la natura dell'una & dell'altra; che fanno effetti mirabili, secondo il buono & il bello stile, c'hà il Compositore nel Comporre, che non si può in fatto insegnare; perche uiene dalla Natura. Onde meglior'effetto fanno ne gli animi l'Harmonie, che non fanno le semplici Modulationi. Ma intendiamoci di gratia; credo d'hauer'à sufficientia insegnato nelle Istitutioni & narrato le cagioni, che possono muouer gli Affetti in un Soggetto; che sono l'Harmonia & il Numero ò Rhythmo, serui della Oratione; onde si fà troppo quello che bisogna fare, da quello che leggono quel c'hò detto, nel muouere gli affetti: Ilperche si uede ogni giorno, che cotal forza nasce dall'accompagnamento di queste tre cose posti insieme: percioche noi ascoltiamo uolentieri & con piacere un Musico, ch'al suono della Lira recita qualche bel Soggetto & honorato; non dico però un de canti moderni, come quelli che chiamano con nome Barbaro Motetti ò Madrigali; ma qualche bello Episodio, dirò cosi; nel quale udendosi recitare dal Musico con bella Attione alcuna cosa lagrimeuole, sono sforzati gli Vditori di uenir spesse fiate alle lagrime; & se per il contrario odono qualche facetia, di ridere qualche fiata squaccheratamente. Et se al suono dell'Organo ò d'altro Istrumento musicale s'udirà alcuno cantare semplicemente alcun canto, che contenga parole graui; come sarebbe il dimostrar l'amore, che porta Iddio alla sua Creatura; commemorando i beneficii che di con page 310 tinuo fà à quella; non è dubio, che cotali cose retenerà l'ascoltante ben disposto in tale dispositione, che sentirà grande soauità & dolcezza nell'animo, & qualche fiata, per souerchia letitia, si uedrà mutar nel uolto di modo, che parerà che non si possa contenere, di non accompagnare qualche segno, che faccia fede del piacere che sente di cotal cosa. Et questo non si può negare: percioche spesse fiate accade; & si può allora dire, che quella Cantilena sia composta nel modo Dorio, quando l'Huomo è da lei disposto di dentro, nel modo c'hò detto; & quella nel Lydio, quando si uede à piangere, come quando si uedesse à troppo ridere, & per la furia far qualche pazzia; ch'ella fusse composta nel Frigio. Laonde essendo uero quello, che ueramente è, che la nostra Musica sia composta de Consonanze, de Moti, & de Voci diuerse, & che operi quel c'hò detto; è anco uero, ch'ella hà tanta forza, quanta hauea l'Antica, & anco più; perche con maggior diletto ascoltiamo le cose composte, che le semplici, quando sono ben proportionate. Ilperche non bisogna attribuire alla Musica de nostri tempi impotenza alcuna, & dire che non si uede, ne che non si ode; ma à i Musici, che non la fanno udire, se non in quel modo confuso, che si comprende & uede à giorni nostri, in un gran numero de parti, accompagnata da molti Istrumenti, uarii anco di specie. Ma pigliasi qual si uoglia Cantilena composta al modo nostro, & facciasi recitare al suono di qual si uoglia semplice Istrumento; purche à cotal suono ui canti alcuno, con bel garbo & soaue uoce, con belli passaggi fatti al proposito, à tempo & luogo, & con giudicio; sempre ella operarà qualche effetto segnalato; essendo però il Soggetto ben disposto à riceuer quella passione, che potrà cagionare cotal Cantilena. Percioche se ben si uede, che questa nostra Musica non fà sempre quelli effetti, che si desiderano, per la diuersità del modo che si tiene à porla in uso; cosi non si legge anco, che l'Antica cagionasse sempre cotali effetti, quando si recitaua; se ben'era posta in opera da un solo Musico. Ma di gratia legga il Lettore studioso, non dirò i Capitoli, ma più tosto Trattati 4. 5. 6. 7. 8. & 9. della Seconda Parte dell'Istitutioni, ch'ei trouera in questo proposito cose, che li saranno di gran gusto, & uedrà, come questi nostri Censori la intendino; considerando, che se ben nell'Harmonia della Cantilena ui si trouano uarietà de Moti, ueloci, tardi & mezani; diuersità de Voci ò Suoni graui, acuti, & quelli di mezo tra queste due sorti; non però fà, che nella Modulatione ò cantare d'una parte al suono d'un'Istrumento, si generi alcuna confusione; come ciascun'intendente può senza dubio conoscere. Percioche se la Consonanza, come dicono, è mistura di suono graue & acuto; laquale senza offesa, ò con diletto, & soauissimamente peruenire all'Vdito, & quella ferisce; come potrà mai essere, che l'Vditore odi cosa cotanto amica con dispiacere? Ma per rispondere alla Seconda loro proposta, che dice; che 'l Zarlino tiene l'opposito di quello che affermano, dico; che è uero, che ueramente il Cantare senza consonanza è cosa imperfetta; percioche imperfetta si può dir quella cosa, che oltra quello che contiene, se ne può desiderar molt'altre; come per il contrario quella si può dir Perfetta, nellaquale, oltra quello ch'ella contiene in quel Genere non si può desiderar cosa alcuna. Ilperche s'oltra il Cantare una sola parte senza Consonanza, si può desiderar la Consonanza; & nel cantar molte parti insieme in Consonanza, altro non si desidera; seguita, che 'l primo modo sia imperfetto & impertinente, & non il secondo, & che questo non faccia impertinentia alcuna. Et perche hanno detto, ch'io in particolare nel Cap. 1. & nel 16. & nel 49. della Seconda parte dell'Istitutioni, dico l'opposito; però, lasciando di replicar quello c'hò detto di sopra; soggiungo solamente prima, che page 311 nel sudetto Primo capitolo non parlo altramente di cotesta cosa; ma dimostro la pouertà (dirò cosi) ò semplicità, che dalla sua origine hauea la Musica nella parte dell'Harmonia; & ciò faccio con l'autorità d'Apuleio, citando anco quella autorità d'Horatio, c'hò citato anco di sopra nel Cap. 1. hauendo detto, che
I Musici de i primi tempi non usarono la musica con tante sorti uariate d'Istrumenti; lasciando da un canto quelli, che nelle Comedie & ne gli esserciti loro adoperauano; ne anco le lor Cantilene erano composte de tante parti, ne con tante voci faceuano i lor concenti, come facciamo hora; ma la essercitauano di maniera, che al suono d'un solo Istrumento, come d'un Piffero, Cetera ò Lira, il Musico semplicemente accompagnaua la sua Voce, & porgea in tal modo grato piacere à se & à gli ascoltanti.Questo scriuo io, dalle quali parole, & anco da tutto quello ch'è contenuto in questo Capitolo, non credo ch'alcun di sano giudicio possa dire, che 'l Zarlino tenga l'opposito di quello, ch'essi scriuono, cioè che 'l cantare in Consonanza sia impertinenza; ne meno ch'ei dica, che senza 'l Cantare in cotal modo l'Harmonia sia imperfetta. Ma ueramente quest'è un bellissimo tiro; da ridersene; che non si partendo eglino dal loro ordinario; citano per testimonio di questa loro Proposta il sudetto Cap. 16. che niente fà al loro proposito; se però non uolessero dire, che quelle parole, che sono poste nel principio del sudetto Capo, che contengono questo nome Harmonia; aiutassero questo loro errore; ma ciascuno c'haurà patienza di ueder questo luogo, potrà conoscere quanto siano reali in referir l'altrui opinioni. A questo s'aggiunge, che nel nominato Cap. 49. scriuo; che
Considerati i Generi secondo l'uso dimoderni, con l'acquisto de tutte le Consonanze, & la perfettione dell'Harmonia, non si hà più d'una Specie per ciascuno di loro; essendo impossibile, che da altri numeri ò proportioni, & da altro ordine, che dal mostrato ne i capitoli antecedenti, possiamo hauere il desiderato fine.Laonde sopra queste parole male intese potrebbono perauentura hauer fatto nascere questo lor falso pensiero. Non dico però in questo luogo, che senza esso Cantare in consonanza l'Harmonia sia imperfetta; quantunque sia pur uero, che cosi sia; essendoche l'Harmonia propria (come dichiarai nel Cap. 12. delle sudette Istitutioni) si compone di molte Consonanze, che sono tra loro diuerse, & di molte Harmonie non proprie. Ilperche eglino non hauendo conosciuto cotal cosa, hanno detto, che 'l Cantare in consonanza sia una impertinentia. Ma quali siano le Regole ch'usano i Prattici contrapuntisti nelle loro compositioni, lo uedremo più oltra: percioche hora aggiungeremo un'altra ragione di questo loro pensiero, quando dicono; che
Essendo conosciute queste cose dal Diuin Platone; commandò nelle Leggi espressamente, che si cantasse & sonasse Proschorda, & non Symphone; cioè, all'Vnisono, & non in consonanza:& dicono, che
Si vede espressamente, che fin'al tempo di quel Diuin Filosofo si costumaua per alcuni, di Cantare & Sonare in Consonanza;ilche quanto faccia al proposito loro quello, che scriue questo Diuin Filosofo; lasciando da un canto, ch'egli non habbia fatto mai mentione in cotal luogo ne di Symphone, ne di Paraphone, perche non fanno al caso apunto; da quello c'hò scritto nel Cap. 2. di questo Libro ciascuno che lo leggerà, lo potrà ottimamente conoscere; & conoscerà anco leggendo il Cap. 41. della Seconda parte dell'Istitutioni, ch'io non confuto il precetto di Platone, come essi dicono. page 312
In qual maniera sia stato introdotto il modo del Cantare & del Sonare in Consonanza, & di comporre più Aria insieme, secondo l'opinione d'alcuni Moderni. Cap. IX.
Essendo in essi tesa quella quantità di chorde, nella maniera & dispositione che dimostrano; i Citharisti de quei tempi; ò per eccedere in qualche parte i Citharedi, ò per fuggire l'obligo d'hauer continuamente appresso un Musico cantore, per la perfettione della Melodia; che insieme la Voce di questo, & l'Istrumento di quello faceuano; cominciarono andare inuestigando un modo, col quale potessero senza il suo aiuto dilettare in qualche maniera, col semplice suono dell'Istrumento il senso dell'Vdito;& dicono, che
per colorir questo loro disegno, giudicarono essere efficace mezo gli Vditori; & veramente con dilettatione onerosa. Ilperche noi pensiamo, che questo essercitio non sta di huomo libero; ma ciò accade farsi per uili & sordidi: Imperoche il fine, per ilquale operano, non è buono. Onde si vede, ch'Aristotele non biasima la Musica arteficiale & l'opera in se, come cosa trista; ma la biasima, come posta in atto per il fine, che non è nobile. Ne per altro si puo dire, che la Musica arteficiale fusse sprezzata da nobili; se pur la sprezzauano: che per la perdita del tempo, che si facea nel porui studio in essa: & perciò giudicaua Platone, che fusse bene à non ui dare opera ad essa, se non per lo spacio di tre anni.Questo dicono i nostri Aristarchi: ma che quei Musici hauessero uoluto superare i più antichi di loro nel suono & nel canto, questo può star benissimo; essendo questo proprio d'ogn'uno, che desidera sopr'auanzar gli altri in una facoltà; & anco che cercassero diuersità di consonanze & d'accordi; per dilettar col suono semplice dell'Istrumento il senso dell'Vdito; ma che la Consonanza hauesse facoltà di scordar gli animi ben composti de gli Vditori, come dicono, questo è un bel sogno. Percioche questo più tosto s'attribusce à i Numeri ò Rhythmi & alla Oratione, che alla Consonanza: però s'ingannano di gran lunga, ne hanno inteso quello, c'hò scritto nella Seconda parte dell'Istitutioni: essendo che la Consonanza da se non può hauer cotale forza, ma la piglia dal Rhythmo & dall'Oratione, come potiamo comprender dal moto ueloce ò tardo, che si scorge in quello; ilquale cagiona nell'Vditore grande alteratione, che si conosce nel mouimento tardo ò ueloce della sola percussione, fatta nell'Aria con una uerga, che quando è fatta tardamente & equalmente; come si scorge ne i tempi contenuti nello Spondeo; in altra maniera muoue l'Vdito, di quel che fà, quando è fatta uelocemente & equalmente; come sono i Mouimenti fatti nel Pirrhichio, & ad altro modo, quando è percosso inequalmente; come auiene ne i tempi conteuuti dal Trocheo, & dall'Iambo, & ciò conosciamo dalla semplice percussione fatta dalle dita d'alcuna fanciulla in quell'Istrumento che chiamiamo qui in Venetia Cembalo, fatto in forma rotonda, sopra 'l quale ui è disteso una Pergamena; & ui sono attaccati molti sonagli, & alcune lamette d'ottone, ò d'altro metallo; ò nel Tamburo, che è coperto di pelle assai grossa, che fà romore & strepito grande, senza udirui consonanza alcuna. Da i quali Istrumenti s'odono cotali Piedi; & massimamente quando al suono del detto Cembalo una fanciul page 313 la fà danzare l'altre. Ilperche si può dir con uerità, che non ui essendo alcuna Consonanza; dalla percussione & dal mouimento di cotale Istrumento fatto secondo il Rhythmo ò Numero, sono sforzate ballare & saltare con allegrezza. Però adunque, quando dicono, che la Consonanza hauea facoltà di scordar gli animi ben composti de gli Auditori, non dicono bene: essendoche la Consonanza, mentre è consona non può far tristo effetto; ma ciò può auenire solamente dalla Oratione, ch'esprima uarii costumi & uarie imitationi. Laonde da questo si può uedere, per qual cagione Platonenon ammetteua nella sua Republica ogni sorte di Poema; ma solamente quelli, che poteano indurne gli animi de gli Ascoltanti buoni costumi. Et se non uolse, che si tenesse & leggesse l'opere del grande Homero, non lo fece senza cagione; poiche conteneuano molte cose piene di lasciuia, fauolosamente recitate de i loro falsi Dei; com'è l'Adulterio di Marte & di Venere, scoperto d'Apollo, con altri simili. Et fece da uero Filosofo: essendoche (come dice il S. Apostolo Paolo) φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὀμίλια κακαί: I tristi ragionamenti corrompono i buoni costumi. Laonde quando si dice, che l'Harmonia hà possanza d'indurre in chi ascolta uarie Passioni, si dee intender nel modo ch'io hò dichiarato nel sudetto luogo nelle Istitutioni. In quanto poi dicono, che i Musici de quei tempi facessero questo per leuarsi quell'obligo dalle spalle, d'hauer sempre appresso loro un Musico cantore, per la perfettione della Melodia, che faceuano insieme con la Voce di questo & l'Istrumento di quello; non sò ueder quello, che si uogliano dire; poiche la Melodia da per tutto si uede appresso i Scrittori esser essercitata da un solo al suono d'un'Istrumento; come fà Demodoco & Femio appresso d'Homero, Ioppa appresso di Virgilio, & Teutrate appresso di Silio Italico, ilche dimostrai nelle Istitutioni. Onde la cagione del sonare & cantare in Consonanza, che allegano, non hà del uerisimile; percioche si può dire, che più tosto si cantaua & sonaua in cotal modo, auanti che si trouasse i due sopranominati Istrumenti Simico & Epigonio che dopo. Et è ragioneuole, che col mezo de Istrumenti tali ò simili, incominciassero i Musici à largare i Confini della Musica, & fuori di quella stretezza, nella quale era posta. Ma questo sia detto à sufficienza, anzi più tosto in sopr'abondanza di quello, che dir si douea in cosa di poca importanza, & che non hà punto di fondamento.
Per qual cagione alcuni biasimano il Sonare & Cantare in Consonanza, & per conseguente il modo di Comporre, facendo cantar molte Parti ò Aria insieme. Cap. X.
Nunc saliare Numae carmen, qui laudat, & illudChe dicono:
Quod mecum ignorat, solus uult ipse uideri:
Ingenijs non ille fauet, plauditque sepultis;
Nostra sed impugnat: nos, nostraque liuidus odit.
Chi loda hora quel Verso saliareIlperche pare, che sia cosa fatale, che tutti quelli c'hanno hauuto & hanno ancora in sè qualche cosa di buono, concessagli dal Sommo Iddio, la Fortuna & il Mondo gli siano contrarii; come si può anco conoscere di Giosquino de Pris, ilqual teneua à i suoi tempi nella Musica il primo luogo; se ben non è da paragonare ne con Horatio, ne anche con altro Poeta eccellente antico ne Greco, ne Latino; che si dolea & si lamentaua spesse fiate con i suoi amici della sua trista fortuna; & specialmente con il Serafino Acquilano Poeta nominato in quei tempi, alquale, cercando egli di consolarlo, come amico, cosi scriue. Sonetto. 51.
Di Numa, & quel che meco non conosce,
Vuol esser riputato singolare:
Non però fauorisce egli ne applaude
Alli sepolti ingegni; ma impugnare
Cerca le cose nostre prima; & noi
Con queste insieme l'Inuido odia poi.
Il perche per tornar al nostro proposito, dico; che questi nostri Censori per coprir la loro ignorantia & questo loro disegno, sprezzano come cose impertinenti, tutte le buone Regole, che indricciano il Compositore nella buona Melopeia; cioè, nella Fabrica del Canto, lequali non staro à commemorare, per esser breue; ma dirò solamente, che prima biasimando eglino la cura, che si pone in questa Fabrica, nel porre le Consonanze di maniera concatenate l'una con l'altra ne gli affronti delle Parti, che non se ne desideri di udir'in essa alcuna, che faccia alla perfettione dell'Harmonia non propria; com'è la Terza & la Quinta; ouer in luogo di questa la Sesta ò l'una delle Replicate di queste; lodano dopoi cotal Compositione, per il diletto ch'apportano le Consonanze all'Vdito; & le chia page 315 mano Bonissime & Necessarie; ma le dicono Pestifere, per l'espressione de i Concenti. Et più oltra dicono con biasimo de i Compositori; cheGiosquin non dir che 'l ciel sia crudo & empio,
Che t'adornò de si soblime ingegno:
Et s'alcun ueste ben, lascia lo sdegno;
Che di ciò gode alcun Buffone, ò Sempio.Da quel ch'io ti dirò prendi l'essempio;
L'Argento & l'Or, che da se stess'è degno,
Si mostra nudo, è sol si veste il Legno,
Quando s'adorna alcun Theatro ò Tempio:Il fauor di costor uien presto manco,
E mille volte il dì, sia pur giocondo,
Si muta il stato lor di nero in bianco.Ma chi hà virtù, gira à suo modo il mondo;
Com'Huom che nuota & hà la zucca al fianco,
Metti 'l sott'acqua pur, non teme il fondo.
Tirati dall' ambitione, per la troppo osseruanza che usano nelle Imitationi delle Fughe; cagionamo molte uolte, ch'alla Parte graue, cantando quattro parti insieme; manchi hora la Terza & alcuna volta la Quinta ò la Sesta, ò alcuna delle replicate;ò che incostantia, ò che leggierezza; poi che uogliono hora quello, che prima non uoleano. Et quando anco soggiungono, che
I Compositori, per ciò osseruare, hanno introdotto la diuersità delle Pause;Et da questo fanno nascere questa ridicolosa consequenza:
Non è uero adunque quello, che 'l Zarlino al Cap. 53. della Terza parte dell'Istitutioni dice in tal proposito.O che pazzia manifesta; quando à questa lor falsa consequenza soggiungono una falsa allegatione intorno la Regola del non porre due Consonanze perfette l'una dopo l'altra ne i Contrapunti, che siano d'un'istessa proportione, col dire arrogantemente; che
I Prattici sonatori, per il contrario, ne concedono; come meno semplici & più uariabili; due ò tre delle Imperfette; non per la differenza del Tuono maggiore ò minore, che si troua tra esse, com'ardiscono dire alcuni;notando il Cap. 2. della Terza parte dell'Istitutioni; O' che arroganza;
Ma per la varietà de gli estremi loro, i quali non cosi bene uniscono in questa parte, come fanno le Perfette.Ilche quanto al proposito allegano questo luogo, il Lettore leggendolo potrà conoscere & sapere, s'io parlo della Differenza del Tuono maggiore ò minore, ouer della Natura de gli Interualli, c'hanno, quando ne sono aggiunti due insieme, che siano d'un'istessa proportionee; quasi anco che la uarietà de i loro estremi non nascesse dalla differenza della loro grandezza. Conoscerà ancora, leggendo il Cap. 15. della Prima parte, se la cagione del non consonar bene sia la uarietà de gli estremi delle Consonanze imperfette ò altra cagione; & leggendo il 32. della Terza parte, potrà uedere, com'io dimostro il modo di por due ò più Consonanze imperfette, contenute sotto un'istessa forma; con qual ragione si possono porre immediatamente l'una dopo l'altra; & come mi sforzo di mostrar delle due Imperfette differenti, come si pongono l'una dopo l'altra, secondo la ragione della diuersità de i Mouimenti di Tuono maggiore, & di minore. Ma che ne posso io se non intendono? Ilperche si uede, che si come i Prattici (come dicono) hanno hauuto sempre la mira di condur la Musica all'ultimo esterminio, nelquale ella si troua; cosi tutto questo si uerifica in loro, poiche non intendono per il diritto le cose della Musica, & cercano di roinare & porre à terra tutto quello, che di buono & di bello fin'hora è stato ritrouato da gli Huomini periti & di giudicio. Per laqual cosa si può ben dire, che spiacendoli & biasimando, come dimostrano, la Musica arteficiosa; che più tosto siano come quelli, che maggiormente amano una Compositione fatta d'alcuni Poeti bassi (dirò cosi) & molto inferiori al sudetto Serafino, al Tibaldeo, & all'Olimpo da Sassoferrato; ouer d'altro simile; nellaquale se bene qualche fiata il soggetto si troua più che mediocremente bello, lo uestono poi con parole tanto indegne, che è un stupore; ponendo in essa quello che li uiene in bocca: che qual si uoglia, che sia fatta dal Petrarcha ò dal Sannazaro ò dall'Ariosto, ouer d'altro Poeta celeberrimo; nellaquale ciascuno di loro s'habbia affaticato, & posto ogni loro studio & ogni diligenza & ogni artificio, accioche riuscisca bene. Ma che si può fare à questo? Veramente parmi, che ciò sia naturale à tutti quelli, che sono ignoranti d'una cosa; che non la sapendo, la biasimano; come uediamo d'alcuno, che essendo priuo della Musica; & dilettandosi dello Studio delle lettere humane; maggiormente ama d'intender le parole contenute in una Cantilena; quantunque siano poco eleganti, che udir la sua Harmonia; forse per non hauer l'Vdito ad essa accommo page 316 dato; & per non intender l'arteficio, che da buoni & periti Musici in essa con ogni arte & diligenza fù posta. Onde non la può gustar con diletto, ne cauare di lei alcun spasso. Et io ne posso far fede di due eccellenti & nobili Filosofi & Mathematici insieme; il cui nome lascierò di palesare, per qualche rispetto; de i quali il primo si lasciò uscir di bocca, che non conosceua la differenza che è tra la Consonanza & Dissonanza, quantunque ei hauesse trattato le cose della Musica in alcuni suoi Commentarii. L'altro una fiata mi giurò, ch'altro Suono non li parea conoscere, ne gli piaceua, che quello dell'Istrumento Sinfonia ò Zampogna, delquale ragionai nel Cap. 79. della Terza parte delle Istitutioni; & tutti gli altri (per dir cosi) gli puzzauano; & con tutto ciò ragionaua delle cose della Musica tanto bene, & sauiamente quanto si può dire; quantunque anco non conoscesse quello, che fusse una Diapason, ò una Diapente, & altro Interuallo in atto tra le Voci ò Suoni.
Dell'Imitatione, che si può far nel comporre & recitar la Musica ò Melopeia. Cap. XI.
Quando per loro diporto (i Moderni prattici) vanno alle Tragedie & alle Comedie, che recitano i Zanni; lascino alcuna volta da parte l'immoderate risa; & in lor vece osseruino, di gratia, in qual maniera parlano; con qual voce, circa l'acutezza & grauità; con che qualità di suono; & con qual quantità; con qual sorte d'accenti & de gesti; come proferite, quanto alla velocità & tardità del moto, l'uno con l'altro quieto Gentil'huomo. Attendino un poco la differenza, che occorre tra tutte quelle cose; quando un di essi parla con vn suo seruo, ouer l'un con l'altro di questi; considerino quando ciò accade al Principe, discorrendo con vn suo suddito & vasallo; quando al supplicante nel raccommandarsi, come ciò fà l'infuriato ò concitato; come la Donna maritata; come la Fanciulla; com'el semplice Putto; come l'astuta Meretrice; come l'Innamorato nel parlar con la sua amata, mentre cerca disporla alle sue voglie; come quelli che si lamentano; come quelli che gridano; come il timoroso; & come quello ch'esulta d'allegrezza. Da quali diuersi accidenti, essendo da essi con intentione auertiti & con diligentia essaminati, potranno pigliar nome di quello, che conuenga, per l'espressione di qual si uoglia altro concetto, che uenir gli potesse tra mano.O bel discorso veramente degno da grande Huomo, com'egli si reputa; dal quale si può ben comprendere, che ei uuole in fatto ridur la Musica in gran dignità & reputatione; quando essorta che si uada ad ascoltar nelle Comedie & nelle Tragedie i Zanni, & si diuenti in tutto & per tutto Histrioni ò Buffoni, per poter'imitare ogn'uno; ma che hà da fare il Musico con quelli che recitano Tragedie ò Comedie? Di più, contra quelli, che non attendono à cotali cose scriue da Filosofo naturale questo mio suegliato Discepolo, queste parole.
Ciascun de Bruti hà naturale facoltà, di poter à quelli almeno della sua specie, communicare con la sua voce il piacere & il dolore del corpo & dell'animo: ne per altro è stato data loro dalla natura; e tra i ragioneuoli ue ne sono di cosi stupidi; che per non saper ciò mettere in prattica; merce della dapocagine loro; & valersene all'occasioni; credono d'esserne naturalmente priui.Di maniera che secondo l'opinione di costui è uergogna il non hauer più della Bestia che dell'Huomo; ò almeno più del Buffone, che del Modesto; accioche à tempo & luogo le Canzoni & le Cantilene che cantano, possino muouere al riso gli Ascoltanti. Et non s'accorge, che queste Imitationi più tosto appartengono all'Oratore, che al Musico; & che quando il Cantore usasse cotali termini, più tosto se gli potrebbe dire Histrione ò Buffone, che Cantore. Chi non sà, che l'Oratore, che uuole muouere gli affetti, bisogna che gli impari, imitando non solo questa, ma etiandio altre sorti di persone, che li possa condurre à questo fine? Questo fece il Grande oratore Cicerone, ilquale pratticaua di continuo con Roscio histrione, & con Archita poeta: ma in questo caso, quello che stà bene all'Oratore, non conuiene al Cantore. Più oltra anco discorrendo uuol dimostrar quello, ch'osseruauano i Musici antichi; se bene non adduce autorità, onde dice;
Nel cantare l'antico Musico qual si voglia Poema, essaminaua prima diligentissimamente le qualità della persona che parlaua, l'età; il sesso, conchi, & quello che per tal mezo cercaua operare; iquali concetti uestiti prima dal Poeta di scielte parole, à bisogno tale oportune; gli esprimeua poscia il Musico in quel Tuono; con quelli accenti, & gesti; con quella quantità & qualità di suono; & con quel Rhythmo che conuenia in quella attione à tal personaggio.Et di Timotheo dice; se bene non nomina l'Autore;
Si legge, che quando prouocò Alessandro à combattere con gli inimici esserciti; che non solo ne i Rhythmi, nelle parole, & ne i concetti di tutta la Canzone, si scorgeuano le circonstanze dette, conforme al desiderio di lui; & che l'habito, l'effigie del volto, & ciascun particolare suo gesto & membro douea almeno parere in quello affare, che ardesse di desiderio di combatte page 318 re, & di superare & vincere l'inimico.Di maniera che questo suo Timotheo douea, se non essere, almen parere un perfettissimo Zanne ò Buffone. Ma chi udì mai i più belli & dolci discorsi di questi, fondati nell'Aria? Però lasciando hora i Zanni, i Zannini, & i Zannoli da un canto, parliamo in questo proposito, come si dee parlare della Imitatione, fatta col mezo della Musica; & ricordianci di quello che dice il Filosofo nel luogo citato; alche aggiongeremo anco quello che ci seguira dicendo; che
Altri sono poi, che fanno l'Imitatione col suono, & col strepito della Voce; ilche auiene anco nell'Arti nominate di sopra; che tutte fanno l'Imitatione col Rhythmo; col parlare & con l'Harmonia. Et perche alcuni che sono istrutti nell'arte del Saltare, imitano col Rhythmo istesso separato dall'Harmonia; & che l'Epopeia si serue solamente della Locutione ò Parlare; sta poi sciolto dalle misure de i Versi, ò pur congiunto con tali misure.Dice poi finalmente, che
sono alcune delle dette Arti, che si seruono di tutte le cose già dette; cioè, del Rhythmo, dell'Harmonia, & del Verso; come sono la Poesia de i Dithyramhi, & quella che canta & contiene le Leggi, & oltra di questo la Tragedia & la Comedia; doue si uede, che tanto nell'Epopeia, ò Poema heroico, quanto nella Poesia della Tragedia ò Comedia, & de i Dithyrambi, si facea l'Imitationi; ilche anco facea l'Arte del citharizare, & del sonare i Flauti ò Pifferi, & altri simili.Laonde io domandarei à costui che uole, che i Moderni Musici imparino l'Imitatione da i Zanni, che recitano le Comedie; sotto qual capo di queste cose, che si sono nominate, uoglia che si troui la nostra Musica moderna; & se in quello, ch'ei dimostrasse & intrauenesse tutte quelle parti, che si è nominato; non potrà egli mai dire, ch'ella sia sottoposta alle quattro prime nominate; ne anco sotto le seguenti; poi ch'ella è quella parte, che solamente da i Musici è detta Melopeia; che uuol dir (com'hò detto ancora) Fattione, Fabrica, ò Fattura di Canto, laqual si tratta in questo Libro; che non passa fuori della consideratione di quelle cose, che tendono alla contemplatione & consideratione de gli Ordini de Suoni & de i Tuoni. Di modo che 'l Musico moderno non hà se non da considerare quell'Harmonia, laquale, secondo che gli è concesso dalla sua Arte, uada imitando co i Suoni & Voci quelle parole, ch'egli uuole esprimere col Canto. Ilperche non cade sotto alcuna specie delle Quattro prime nominate; ne men sotto l'Arte del Sonar Flauti ò altre sorti d'Istrumenti; stando sopra la Compositione del Canto, che si fà intorno à qualche Poesia; percioche quella fattura di Canto, che si fà solamente per sonare; dal Rhythmo in fuori, ch'ella può hauere; come si conosce ne i Balli moderni; è ad un certo modo lontana dalla Imitatione, che non accade parlarui. Onde bisogna dire, che sia una cosa da sè, per la qual cosa nel recitare & esprimer le Parole della Melopeia, ritrouarono i Nostri Moderni un nuouo modo d'Imitatione, fatta parte col mouimento della Modulatione, & parte con l'Harmonia che si trouano nella Cantilena: forse perche uidero, & conobbero, che nel recirar le loro Compositioni, non poteuano uestirsi della persona del Poeta, nel recitar le sue Poesie; ne meno di quella dell'Oratore, nel recitar le sue Orationi: percioche quello nel recitare al suono della Lira, usando quella sorte d'Harmonia, che richiede alla qualità del Poema; non può usar quelle Attioni, che usa l'Oratore nelle sue Ringhe; ilquale stando nella sua grauità, può bene & ottimamente usar quelle Imitationi col mezo dell'Attione, che conuien nell'esprimere le materie, non solo con quelle qualità de uoci & parole, che le conuiene; ma etiandio accompagnandoui i Gesti del corpo, con mouimenti atti & conueneuoli à cotal cosa: i quali accompagnati alle parole, di modo che stiano bene, hanno gran forza di commouer l'Animo de gli Ascoltanti, & di pregar l'animo de i Giudici in alcuna causa. page 319 Questa parte fù troppo ben intesa & conosciuta dal grande Oratore M. Tullio Cicerone, fonte d'Eloquentia; ilquale (come ho detto di sopra) fù molto amico di Roscio eccellentissimo Histrione & Recitatore di Comedie: perche di continuo l'udiua uolentieri, per imparare i gesti & le imitationi di esso Roscio; per poter nelle sue Ringhe adoperarle con maiestà; il che faceua necessariamente, come Oratore, alquale apparteneua la buona Attione, che consiste principalmente ne i Mouimenti del corpo, & in quelli della Voce. Ma i Musici non hanno dibisogno di simili Attioni; percioche li basta solo quelle Imitationi, che si possono far con la Voce & udire col Senso; accioche le sue Compositioni non manchino di quelle cose, che da essi imitare si possono; poiche ne alla guisa de Poeti, ne à quella de Oratori non lo possono fare: onde ritrouarono da esprimerle con quel modo che si uedono espresse nelle lor Compositioni; dalle quali, se bene alle fiate si uedono alcune Imitationi strane, sgarbate, & senz'alcun decoro, & senz'alcun sale di buona Harmonia; ciò non si dee attribuire all'Arte, ma all'Artefice, come poco perito, & poco intendente di simil cose; com'anco s'attribuisce all'Oratore, poco atto al parlare con maiestà, difetto; quando manca delle sudette Attioni; quantunque questi nostri Censori moderni biasimino alle fiate quello, che non sanno fare, ne meno intendono. Non debbono però per questo i Compositori, restar di cercare di usar quei modi conuenienti, che ricerca la materia, con quella maggior gratia & grauità, che si può fare; & non sarà inconueniente, ne errore alcuno, come questi poco istrutti non intendono: percioche si come all'Oratore, nel recitar è concesso, secondo le materie che tratta tallora, non dirò palare; ma con alta uoce & horribile, gridando & esclamando, esprimere il suo concetto; & questo quando parla di cose, con lequali egli uoglia indur spauento & terrore; & tallor con uoce sommessa & bassa; quando uuole indur commiseratione, cosi non è cosa disconueneuole al Musico, d'usar simili attioni, nell'acuto & nel graue, hora con uoce alta, & hora con uoce sommessa, recitando le sue Compositioni. Diranno forse questi nostri Sapienti, ch'altra cosa è il Cantare & altra è l'Orare ò Ringare, & che non stà bene al Musico nel cantare, ch'ei usi quei modi, che usa l'Oratore nella sua Oratione: Stà bene; questo hò detto anch'io di sopra; onde non dico, che 'l Cantore cantando debba ne gridare, ne far strepito: percioche non è cosa c'habbia ne proportione, ne decoro; ma dico che à lui è concesso, come recitatore in quell'atto, quello che si concide à i Recitatori delle Tragedie & Comedie: i quali, se bene alle fiate non uanno discorrendo con altri, ma parlano soli & da loro stessi di qualche loro pensiero, ilquale non bisognarebbe ch'alcuno lo udisse; come quelli che parlano in secreto; tuttauia questo gli è concesso fuori del uerisimile; accioche i Spettatori, tanto quelli che sono lontani dalla Scena, quanto quelli che sono da presso, possino udir quello, che dicono & intendere la cosa perfetta. Percioche si come à questi si puo dir, che non sia concesso in tutto la uera Imitatione; come sarebbe dire; che parlando alcuno in Scena da se stesso; & non uolendo essere udito d'alcun de gli altri; pare inconueniente; com'è ueramente; ch'ei parli con uoce alta; come s'egli parlasse con un sordo; tanto più essendoli non più che due passa lontano colui, che non uuol che oda: cosi se questo si permette al Recitante per il commodo de gli Ascoltanti; si permetterà anco al Cantore alcune attioni nel Cantare; che uolendo star su 'l rigore della Imitatione, à patto alcuno non potrebbono passare. Et perche ogni Arte & ogni Scientia si chiama meno imperfetta, allaquale mancano meno cose: però conoscendo i Musici moderni, che per caminar uerso cotale cosa, li mancaua quest'attione nell'imitar con l'Harmonia & co i mouimenti (come con cose page 320 à loro proprie) le soggette Parole hanno uoluto aggiunger'all'Arte quella sorte d'Imitatione, che usano; per dimostrar quanto arteficio possano usar nelle loro compositioni. Ma se i Cantori uolessero nel cantar loro, usar quelle attioni, ch'usano i zanni recitatori de Comedie; non sò uedere, come quelli che li udissero & uedessero, si potessero tanto contenere, che non ridessero. Passarò anche à dire più oltra che se Timotheo sia stato qual si uoglia, hauesse usato quelle attioni, che costoro descriuono che faceua; egli haurebbe potuto ben recitare ad Alessandro la Legge Orthia, ò qual si uoglia altra cosa, che più tosto non l'hauesse indutto à ridere, che spinto (come dicono con Amplificatione) à combattere con gli nemici esserciti. Et perche non è à bastanza per quello che credono d'indurre alle uarie Passioni dell'animo, quel c'hò detto nel Cap. 7. della Seconda parte delle Istitutioni; però dicono, ch'io son di proprio parere nel sudetto Capitolo; che 'l Suono semplice dell'Istrumento arteficiale, non hauesse uirtù d'operare alcuno effetto nell'Auditore. Onde non intendendo forse quello, c'habbia uoluto dire, ò forse anco per malignità, hanno detto questa pazzia; che 'l Suono dell'Istrumento fatto dall'Arte, senza l'uso delle parole, hauea natura d'Imitare il costume, & d'hauerlo in sè, & grandissima facoltà d'operare ne gli animi de gli Vditori gran parte de gli affetti, che al perito Sonatore piaceuano. Ma s'intendono dell'Harmonia, che si scorge ne i Balli, non dico alcuna cosa: percioche se bene allegano Aristotele; non per questo contradico ad Aristotele; ma più tosto uengo à dichiararlo; se ben eglino non l'hanno inteso: ma s'intendono d'altra Harmonia, à questo non consento. Ma per confirmar questo lor pensiero, adducono l'essempio di Pithagora, ch'era Greco; ilquale commandò à quella Tibicine, che ragioneuolmente douea esser Greca, che mutasse il Modo, dicendo in Lingua latina; O bel tiro;
Muta modum;cosa ueramente da un zanni; il che fà grandemente al nostro proposito; percioche mutando (secondo che le fù commandato) il Rhythmo del ueloce Dattilo; come soggiungono, che prima era nel tardo Spondeo, e 'l Tuono d'acuto in graue, & il molto in poco suono, placò l'infuriato Giouane taurominitano, ch'egli non abbrusciò la casa della Meretrice, contra laquale era grandemente sdegnato. Laonde si uede, che (non s'accorgendo) danno la possanza alla Oratione, co i Rhythmi ò Numeri; nellaquale si conosce ogni sorte de Piedi, sia Dattilo, ò Spondeo, ò Anapesto, ouer'altro simile qual si uoglia; la cognitione de i quali dourebbe hauere ogni Musico & ogni Melopeio, ouer Compositore, acciò non fusse ignorante di quella cosa, laquale è sommamente necessaria alla perfettione della sua Arte.
DE i Poeti detti Melopei, & qual fussero. Cap. XII.
Σίγα, σίγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύληςpoiche le tre prime Dittioni si proferiscono con un suono istesso di uoce, senza differenza alcuna d'accento acuto ò graue; & ne la quarta si fanno acute le due ultime sillabe; abenche una Dittione debba hauer solamente un'accento acuto. Et all'istesso modo nelle Dittioni τιθεῖτε, & κτυπεῖτε, non hauendo altro riguardo al circonflesso, si fanno acute le due posteriori. Cosi anco in questo; ἀπὸ προβατ' ἐκεῖς, si perde l'accento acuto, & si trasporta & riduce nel Quarto. Molte cose simili si odono anco ne i nostri Tempii, nel cantar gli Hinni; che quantunque noi alcune fiate oscuriamo, ò uogliamo dire, ascondiamo la quantità & l'accento delle sillabe nel parlare; tuttauia non lo corrompiamo in tutto; ancora che si faccia alcune fiate anco senza il canto; & con la sola specie della pronuncia: & quantunque non si leui cosa alcuna alla quantità delle sillabe; si uiene però à mutare la ragione del Verso: & (com'ei dice) l'istesso Verso heroico trappassa, & & si muta nel Sotadeo; & per il Contrario, questo in quello: come nella seguente Oratione; ὡς ὅ πρόσθ'ύππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθείς. se 'l si misura prima tre Molossi, hauendo risolto la prima del quarto. Onde auenne de quì, & non senza cagione Demosthene grande Oratore diede le prime & le seconde parti alla Pronuncia. Et se bene si considera; ch'altro è ueramente quello, appresso di Senofonte che pensa Socrate, il Parlare farsi più soaue, aggiunto alla Tibia, che la Cantilena? & quello etiandio che pensò Platone ne i libri delle Leggi; che fussero da i Poeti & da i Musici pronunciati i Numeri & gli Accenti de gli Huomini forti & temperati, non altri; accioche gli animi giouenili alle grandosi udendo cotali cose; s'assuefacessero ad obedire alle Leggi? Et dice, potersi ueramente osseruare alcun Canto nel parlare, prouocato dalla Lira. Ma i Musici hauendo tolto ad imprestido; dirò; cosi dalle cose naturali la Dimostratione; collocarono ogni Canto in quattro cose: come quello, delle quali come da Principii & come da page 322 Soggetto & da materia habbia il suo essere: & sono queste; il Suono la Resonantia, la Voce & il Moto. Chiamano Suono tutto quello, che muoue l'Vdito; & Resonantia quella, quando essendo percosso l'Aria, il Suono si uiene à continuare; com'è quello, ch'alle fiate esperimentiamo nell'Orecchia percossa. Ma la Voce dicono esser cosa propria dell'Animale, laquale risuonando uariamente si ode hora nel graue, & hora nell'acuto, è chiamata Canto; altramente ouero ch'è il Parlare, ò che è Chiamore. Vltimamente il Moto (ilquale ogn' uno confessa esser principio della Modulatione) in tanto si considera, che ne il Suono si fà senza esso; ne la Ragione ò Quantità de Suoni d'altra parte consiste, che dalla Celerità ò tardità de i Moti. Ma il Canto diletta per la proportione che si troua tra i Suoni. Et si come si dice, l'Harmonia essere ordine, per la Voce contemperata nell'acuto & nel graue, & il Rhythmo esser nel Moto, cosi il Canto si dice esser una certa soauità d'Harmonia insieme & di Rhythmo, portata à gli orecchi de gli Ascoltanti; la quale soauità; si come essendo senza Harmonia non hà l'essere; cosi debbe parere al senso una certa forma grata & diletteuole; della quale i Generi & le Parti, tanto con i Suoni, quanto con le Voci possino esser dimostrati, & con ragion mathematica l'uno dall'altro separati. Et questo è quello che in somma dice il Lullo.
Τιθεῖτε. μὴ κτυπείτε
Α'πὸ προβατ'ἐκεῖς, ἀπ'πρόμοι κοίτας.
De Tre sorti d'Accento, Grammatico, Rhetorico, & Musico. Cap. XIII.
Ar¯ma ˘. vi ˘. rum ¯ que ˘. ca ˘. no ¯ma in lor uece hanno gli Accenti musici; mostrati con alcune loro Cifere ò segni. Ilperche per tutti i luoghi, doue in una Dittione uedono segnato alcuna sillaba con alcun carattere, musicale; sanno che iui hà luogo l'accento Grammatico, con l'accento Musico: essendoche in qual si uoglia luogo nella Dittione non si può ritrouar questo accento, che non ui si troui anco il Grammatico; eccetto che in pochi luoghi della Santa Scrittura. Laonde gli è à bastanza quando l'esprimono con una uirgoletta leuata in alto segnata ò disopra ò di sotto cotale Dittione; se non u'aggiungessero la Cantilena fatta da i Cantori. Et di questi Accenti scriuono alcuni, che 'l Rhetorico, è un'arteficioso ritenimento dello Spirito, che prattica intorno le Dittioni per cagione d'ornamento & soauità: essendo in questo utile, acciò si sappia quali sillabe si habbiano da proferir lunghe ò breui: percioche non è dubbio, che 'l Numero oratorio consta di questi due tempi, ò lungo ò breue; & è insieme misurato dal tempo & dal Rhythmo: Ma l'accento Rhetorico in questo è differente dal Grammatico; che questo segue il tempo lungo & breue nella quantità delle sillabe, & quello si serue del tempo, senza offesa dell'Vdito; & senza fare udire alcun barbarismo nella pronuncia delle Parole; come habbiamo detto, che fanno i Poeti Melopei, nel Capitolo precedente; se ben non lascia udir la sillaba Lunga & la Breue in atto; come se recitando il mostrato Mezo uerso in un'istesso suono, si pronunciasse in questo modo:
Arma uírumque cáno:doue non si sente la pronuncia d'alcuna sillaba, ch'offenda il senso; come farebbe quando si dicesse:
Armà uirúmque canò;percioche il Rhetore attende più alla soauità del parlare, ch'ad altra cosa. Ma dell'accento Musico, dicono, che Mosè amico di Dio & Scrittore antichissimo fù quello, ch'insegnò ridur la conceputa allegrezza della mente sotto certi articoli & membri con suoni non uani; accioche alcuno de mortali; dopo l'hauer considerato i beneficij, & le grandezze di Dio, & essendo pieno d'allegrezza; adunati tutti i Sensi insieme; come da un fonte copiosissimo prorumpendo ne i mouimenti del Corpo col Canto della Voce, & con l'arteficioso moto della lingua insieme ne i quali consiste ueramente la Musica; distintamente potesse & abondantemente lodar la Maestà, l'Onnipotenza, la Sapienza, & la Bontà del Sommo Fattore: & ciò dimostrò dopo il passaggio del Mare rosso col Cantico ch'ei compose: Exod. 15. [Hebrew]; cioè, Cantarò al Signore. Dalche impararono i Posteri (ilche è comprobato anco da quelli de i nostri tempi) di ornare i Sacrificij, ne i quali si loda il sommo Iddio con orationi, contenute ne gli Hinni & Versi di più sorti: percioche al tempo d'Orfeo, Lino, & Museo, tutte le cose diuine erano fatte di maniera, che si cantauano sotto diuersi Rhythmi: essendo che pensarono, che niuna cosa più che la Musica fusse grata à Dio, ilquale hauea fabricato l'Opera sua secondo l'Harmonia; come Pithagora, Archita Tarentino, & Platone, con molti altri Filosofi affermano. Non uoglio lasciar di dire; accioche 'l Musico habbia etiandio qualche scintilla di cognitione di questa cosa; che quantunque i Greci & i Latini habbiano diuerse maniere di Versi ò Metri; tuttauia gli Hebrei con altra ragione scriuono i loro che non fanno gli altri popoli & Genti; essendoche non sanno quello che sia ne Dattilo, ne Spondeo, ne Trocheo, ne Iambo, ne altra sorte de Piedi; ma hanno alcune lor parole, le quali significano quelle parti, ch'entrano ne i loro Ver page 324 si: come sarebbe (lasciandone molte altre da un canto) il [Hebrew] Daleth, che significa Porta; ilquale pigliano per la Prima parte del Verso: & ancora il [Hebrew] Segor: che uuol dire Clausura ò Serraglia; che pigliano per l'altra parte del Metro: ma col [Hebrew] Bajit, cioè, Stanza ò Casa, dallaquale denominano tutta la Compositione; rinchiudono le due nominate parti: come si può conoscere ne i due seguenti Versi, posti da Elia Leuita Germano nella Profatione del Libro ch'ei chiamò Massoreth.
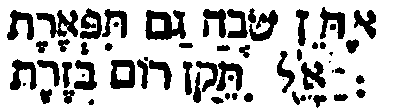
Daro laudi & gloria à Dio,ouer diremo & forse più propriamente.
Che le cose alte & soblime
Fabricò con le sue mani.
Darò à Dio gloria & bellezza,Et credo ueramente, che da questo i nostri Poeti Italiani chiamassero le loro Ottaue rime STANZE. Si puo però dire; ancora che non conoscano tali Piedi, che questi Versi siano composti, come i nostri percioche hanno il piede Iambo nella parola [Hebrew] Leda, ouer [Hebrew]; Semor nella parola [Hebrew] Iather, che uuol dir Chiodo, nel qual piede usano la similitudine di esso Chiodo, che nel principio è acuto, & nel fine ottuso: onde pigliano l'acutezza per il tempo ò sillaba breue, & la ottusità, per il tempo ò sillaba lunga. Et quando à queste due sillabe uen'aggiungono un'altra; com'in questa parola [Hebrew] Melachim; dicono, tal Compositione esser composta del [Hebrew] Iather & del [Hebrew] Tenuah; cioè del Chiodo & del Moto; onde nasce una Dittione composta, che i Latini chiamano insieme con i Greci Bacchio. Et se ben sono molte appresso di questa gente le maniere de Versi & Metri, ch'arriuano al numero di Diciotto; come appresso nel sudetto Thesbite & molt'altri si può uedere, ne i quali si comprendono molti esser composti de; uarii Piedi; come sono Spondei & Iambi diuersamente; tuttauia in essi (com'hò detto ancora) dou'è l'Accento Musico, bisogna che ui sia l'accento Grammatico. Et per dar qualche lume di quello che si è detto à i nostri Musici, pigliaremo nella nostra lingua Latina da Virgilio in prestanza queste parole:
che creato han l'Altezz'in
La misura della mane.
Ma¯ne¯t a¯lta¯ me¯nte˘ re˘po¯stu¯m Iu¯di˘ci˘u¯m P˘ari˘di¯s;nellequali (senza dubio) l'accento Grammatico è in qual si uoglia dittione di questo membro ò periodo; ma l'accento Musico domina solamente nelle dittioni, Alta , & Páridis , & nelle loro Prime sillabe; di modo che 'l Verso risonerà in questo modo:
Mànet áltà mènte repòstum Iudìcium Páridis.L'Accento adunque haurà il precedente accento graue nel uerbo Manet; ilquale da gli Hebrei sarà detto suo ministro, alla guisa di quelli, che come ministeriali nella Pompa precedono prima il Prencipe; seguendo poi i suoi Gentil'huomini; onde la dittione Álta ha due ministri ad un certo modo: l'uno ueramente detto ministro, precedente nel uerbo Mànet; l'altro seguente nella parola Mènte. Et quantunque essi Hebrei habbiano molte sorti de Versi ò Metri, com'hò detto; tuttauia il Santiss. & Dottiss. Hieronimo de gli Hexametri loro dice queste parole.
Fateor ego in hac causa ignorantiam meam: non potui hactenus de tota Biblia treis sui similes Hexametros expiscari, qui una ratione decurrerent. Oratorium vero numerum deprehendo, qui & breuibus constat & longis, ac simul tempore mensuratur & rhythmo.Et nel Proemio del Libro di Giobbe dice;
Porrò à verbis Iob, in quibus ait: Pereat dies in qua natus sum, & nox in qua dictum est: Conceptus est Homo; usque ad eum locum, ubi page 325 ante finem uoluminis scriptum est: Iccirco me reprehendo, & ago poenitentiam in fauilla & cinere: Hexametri versus sunt, Dactylo, Spondeoque currentes: & propter linguae idioma, crebro recipientes & alios pedes; non earundem syllabarum; sed eorundem temporum. Interdum quoque Rhythmus ipse dulcis & tinnulus fertur numeris pedum solutis, quod metrici magis, quàm simplex lector intelligat. A supradicto autem uersu, usque ad finem libri, paruum Comma quod remanet, prosa oratione contexitur.Questo dice il Santiss. Dottore; del che è cosa difficile, il uolerne essattamente ragionare: essendoche in questo tempo sono smarrite le uere pronuncie, i ueri accenti, & i ueri modi musicali d'ogni lingua. Et se ben questo è uero, non hò uoluto mancar di dar questo poco di lume al Melopeio, ò Compositore, & à quelli che si dilettano della Musica, & sono studiosi delle buone lettere; per infiammarli nel cercare quelle cose, che fin'hora non sono state trouate; & anco porli auanti gli occhi molti luoghi, da i quali potranno hauer qualche lume, che li potrà guidare alla cognitione de cose di maggiore importanza. Facendolo auertito di questo, che nelle sue Compositioni debbe sempre seguire l'accento Rhetorico; nella materia del Tempo; & non il Grammatico: percioche non è al proposito: Ma quanto all'accento Musico, egli haurà da ritrouarlo, che ritenga in sè quella grauità, che se le conuiene. Percioche tutto questo si fà intorno l'Aria, de che si compone la Cantilena. Et credo ueramente che non per altro, che per la poca cognitione, c'hanno i Compositori di Musica de i nostri tempi del Rhythmo, de gli Accenti, & della buona Harmonia; lasciando star da un canto quello, ch'è di maggior importanza, ch'è l'intelligentia dell'Oratione, la Musica habbia perso una gran parte della sua grauità & del splendore, ch'anticamente appresso i Greci & Latini reteneua: Essendoche il Rhythmo & l'Harmonia commouono grandemente l'animo; come si scorge ne i Balli: ma dall'Oratione accompagnata à coteste cose, prendono maggior forza: com'hò dichiarato nella Seconda parte dell'Istitutioni. Ma parmi che la cosa sia ita tanto innanti, che alcuni si reputino uergogna l'imitare gli Antichi, nel fare udir la Melodia insieme col Rhythmo che sia proportionato con l'Harmonia conueniente alla Oratione: & quello ch'è peggio; ch'ogn'uno (ilche auiene dalla poca intelligentia dell'Arte & della Scientia) insieme habbia in odio & non possa udire una buona Compositione, fatta in quella maniera di comporre, che già arteficiosamente si componeua con mille belle corrispondenze, che faceano tra loro le parti della Cantilena, che uolgarmente chiamano Consequenze ò Fughe; per non hauer dato opera come bisognaua, all' assuefarsi alla Intelligentia ò Ragione, & alla Cognitione di quest'Arte per la uia del Senso; cose che sono sommamente bisognose; secondo la dottrina d'Aristosseno, & di Tolomeo; come nel Cap. 13. del Primo libro si è discorso. Ilperche la dapocagine & l'ignoranza l'hanno ridotto in questo termine; che compongono le cose loro senza giudicio & senza ueruna ragione, non si curando d'altro i Compositori moderni, che di dimostrar, che siano presti & pronti nell'infilzare (dirò come si dice) Note: onde auuiene, che non ui è cosa, che più presto satia il Senso de gli ascoltanti, & che duri meno nella loro memoria, & che più tosto inuecchiano, che cotali compositioni. Però fà dibisogno che considerino molto bene le cose, & che non pongano in opera in un tratto tutto quello, che li souiene, & per ispedir la cosa, tutto quello che li torna commodo. Onde fan dibisogno, che questi ch'imbrattano in tal maniera le carte si ricordino di quello, che si legge d'Euripide poeta tragico famosissimo, che ritrouandosi una sera à trebbo in una compagnia d'Huomini molto honorati & dell'istessa professio page 326 ne; tra i quali ue n'era uno chiamato Alcestide: ilquale uedendo stare Euripide molto sospeso & sopra di sè, gli dimandò per qual cagione ei staua cosi maninconico: Allora disse Euripide; sono alquanti giorni, ch'io feci tre Versi, & di continuo uò pensando à quelli, ne fin'hora li hò potuti ridurre à tal segno, che mi satisfacciano. O` Euripide; rispose Alcestide, tu non sai una cosa che ti uoglio dire, che herisera in poco tempo, ne fà un numero, che passano Trecento. A questo subito gli disse Euripide; uoglio che tu sappia Alcestide; che tal differentia si troua tra i miei & i tuoi Versi, che i miei dureranno lungo tempo, & li tuoi non arriuaranno à tre giorni; Et cosi fù, percioche non solamente di loro; ma quello ch'è peggio, apena di lui se ne fà mentione alcuna. A questo antico fatto, ne uoglio aggiungere anco un moderno, che accascò nell'Anno di nostra Salute 1541. il Primo ch'io uenni ad habitar Venetia, & nel Quinto giorno di Decembre, nel tempio di S. Giouanni Elemosinario in Rialto; nelqual giorno douendosi cantare un Vespero solenne per la festa di S. Nicolò; ad una Fraterna de Cimatori da panni; non erano ancora ridotti tutti quei Cantori che faceano dibisogno à cotale opera: Laonde uno de quelli, che si trouauano presenti, uolendo udire una sua Compositione assai ben prolissa; fatta in due parti à cinque uoci; pregò una parte de quei Cantori ch'erano presenti, che fussero contenti di compiacerlo; ilche fecero gratiosamente; replicandolo anco una fiata. Hora essendosi compiaciuto pienamente, uoltatosi con uolto allegro uerso il Parabosco, ch'era presente, gli disse: ditemi, di gratia, M. Girolamo; quanto tempo sarebbe stato M. Adriano à comporre un Canto simile? Rispose il Parabosco; ueramente M. Alberto (che cosi hauea nome il Compositore) che à fare un canto di tanta lunghezza, non sarebbe stato men di due mesi. Rise allora il Compositore, & disse: E' possibile, ch'ei stesse tanto? sapete, che herisera mi posi à sedere, & non mi leuai, ch'io gli hebbi dato fine. A' fè M. Alberto, disse subito il Parabosco, ch'io ue lo credo & mi marauiglio, che in tanto tempo non ne habbiate fatto dieci di questa sorte; Et non ui marauigliate perch'io parli in questo modo; percioche M. Adriano, quando egli compone, mette ogni suo studio & ogni sua industria; & pensa & studia molto bene quello, c'habbia da fare, auanti che dia fine, & mandi in luce una sua compositione: ilperche non per altro, che per questo è riputato il Primo de nostri tempi. Questo hò uoluto dire, accioche alcuni Guastamistieri de nostri tempi; habbiano la sua lettione; & imparino à non esser tanto precipitosi nel comporre; se uogliono che duri la sua memoria appresso quelli, che sono amatori, & intendenti della buona musica: essendoche se bene non è impossibile, è almeno difficile, il far presto alcuna cosa, che habbia in sè qualche perfettione.
Che non bisogna essere precipitosi nel giudicare alcuna cosa, auanti l'hauerla bene essaminata. Cap. XIIII.
Hormai mi resta sol di bramare la vostra arteficiosa Apologia; che mi persuado, anzi, son certo, che sarà non men utile che diletteuole à tutti i Musici Cantori, & Mathematici famosi; accompagnandola con queste mie lettere, sendo cotesta città industriosa & coppiosa di Stampe. Ilche ui verrà facile à fare, & io ue ne prego infinitamente: auisandoui anco, che di queste lettere da molti Amici, che l'han uiste, si son fatte Coppie, ch'io non hò potuto ciò negarli.Questo è quello che contiene & conclude la sudetta Lettera; nellaquale ei hà uoluto rispondere ad alcune cose, & poteua far di meno, perche molte sono fuori di proposito; & questo è ueramente quello, ch'è stato cagione, che di essa habbia qui nel fine fatto mentione; sopra la quale non hò uoluto dir cosa alcuna per non gettare uia il tempo; essendoche sono proposte, che la maggior parte non contengono il uero, & sono intorno à cose tanto leggieri & basse, ch'io m'arrossisco à ricordarmene solamente: & marauigliomi che quelli che propongono cotali cose, non si uergognano à far tanto poco conto del loro honore, come fanno; percioche senza considerar cosa alcuna, dicono quello, che li uiene in bocca. Et ancora quelle risposte, le quali sono aggiunte alle Proposte, se bene sono fatte in mio fauore, sono tanto seche, aride, & fuori di proposito, che mi fanno stupire; perche non risoluono cosa alcuna. Ilperche niuno si marauiglierà s'io hò lasciata la cura ad altri di risponderli, quando però li paresse di uoler pigliare cotale impresa; dopo che cotal Lettera gli sarà capitata nelle mani: percioche da quello c'hauranno letto ne i miei Scritti, potranno facilmente cauar le Risposte, che saranno conueneuoli; & dimostrar quanto quelli, c'hanno uoluto contradire à quello c'hò scritto, sia page 328 no lontani dalla dritta uia; & come l'intendino poco: ancora che se fussero stati intendenti, quello c'hò detto in più luoghi delle cose della Scientia, li potea dare à conoscere il uero; & li potea scoprire la loro ignoranza & ch'erano maligni; onde si sarebbono ritenuti di commettere tanti errori, com'hanno commesso. Ma in trauiene à cotal sorte di persone quello, che intrauenne già sono iti molti anni auanti un Tribunal de Giudici qui in Venetia, ad un Causidico ò Auocato; che difendendo la Causa d'un suo Clientulo, seppe tanto ben dire; che dopo c'hebbe finito di parlare, il suo Auersario non uolse replicar, ne dire cosa alcuna in difesa: ma uoltatosi à i Giudici, disse solamente queste parole. E superfluo Clarissimi Giudici, à quello che con lungo parlare hà detto questo mio aduersario, il uolere rispondere; essendoche (come hanno potuto udire V. M. Clarissime) tutto quello ch'egli hà detto è in mio fauore; però solamente le uoglio supplicare à contentarsi di questa mia breue risposta; & considerata molto bene la causa, à far buona Giustitia. Laonde essendosi retirati i Giudici, & considerata la cosa; diedero la Sentenza in fauore di quello, che non uolse replicare, ne dir cosa alcuna; hauendo il primo detto à sufficienza le sue ragioni, & quelle del suo auersario. Ilperche dico, che dopo ch'alcuno haurà ueduto & essaminato la sudetta Lettera, se mai gli peruenirà alle mani, senza ch'io ne dica altro; potrà fare Giustitia, & dar la Vittoria, à chi ne sarà meriteuole. Et accioche si ueda più facilmente quanto bene intendino le cose, quelli che cercano di tassare quello, che hò scritto nelle Istitutioni & nelle Dimostrationi; proponerò un dubbio proposto nella sudetta Lettera, con la sua risposta & Risolutione; che sarà il Primo; delquale ciascun potrà conoscere, come possino esser gli altri, & come siano stati ben risolti; & conosca, come si dice in Prouerbio, dall'Vngia il Leone. In cotal modo adunque il mio Amico scriue nella sua Lettera del dubio che gli fù proposto, & della risposta che gli diede.
Perche nella Diapente diQuanto alla Proposta dico, che la sudetta Diapente con la nominata Diatessaron fà conueneuole congiuntione; percioche la prima contiene in se due Tuoni maggiori A. re, con. quadro primo, cominciando in A. re, non era conueneuole congiuntione con la Diatessaron Mi. fa. sol. la, di natura prima nel Monochordo, e nel Cimbalo: Io gli dissi acciò m'intendesse subito la differenza per Commi; cioè che tal Diapente haue Trenta Commi, per li due Tuoni minori Re mi, & sol la. oue son Re mi, che 'l giusto intiero debbe hauerne Trentauno; et al Diatessaron di natura prima Mi. fa. sol. la, haue Ventitre Commi, e haue due Tuoni maggiori Fa. sol. la. che debbe hauerne Ventidue, che fanno la Diatessaron intiera & giusta: che il Semituono di queste due proprietadi sempre è maggiore, & hà cinque Commi, che nasce dalla proportione sopraquintadecima 16/15. et però bisogna che s'accordino per giudicio d'orecchie, aggiungendo, e diminuendo, fin che concordino bene insieme; che Sonatori uecchi e Maestri, che fan Monochordi, stan confusi in questo accordo.
 . mi per dire come dicono, & C. fa ut,
con D. sol re: & un minore D. sol. re, con E. la mi. & il maggior Semituono
. mi per dire come dicono, & C. fa ut,
con D. sol re: & un minore D. sol. re, con E. la mi. & il maggior Semituono
 . mi, con C. fa ut. & la seconda contiene un Semituono maggiore E. la mi,
con F. fa ut; & un Tuono maggiore F. fa ut, con G. sol re ut, & un minore G. sol re
ut, con A. la mi re: ilperche questi due Interualli tra loro contengono Tre tuoni
maggiori, due minori, con due maggiori Semituoni nelle loro uere forme; come
per la 39. Prop. del 2. delle Dimostrationi etiandio contiene la Diapason, che tallora si diuide, & tallora si compone di queste due Consonanze semplici: siano
poi udite tra le Voci, ò tra i Suoni di qual si uoglia Istrumento arteficiale. Ma
cotale congiuntione, che di sopra habbiano nominato, non nasce tra le chorde
contenute in questa parte, ma si bene in quelle che passano più oltra, in altra,
page 329
Cioè nella Diapason piu acuta. Come leggendo il modo di temperare l'Istrumento da chorde con i Tasti si potrà conoscere, laquale non è stata intesa; onde è stata malamente proposta. Ma nella Risposta ò Risolutione si trouano
due cose degne di riprensione: la Prima è, che non si può risoluere cotal Dimanda con la quantita de i Comma; percioche essendone posti tanti insieme,
com'ei dice, non fanno un Tutto intiero, ne danno alcun buono accordo;
come si puo comprendere dalla 21. 22. 23. & 24. del Secondo delle Dimostrationi, & dal Cap. 46. della Seconda parte delle Istitutioni. La Seconda è, che la nominata Diapente non può hauere due Tuoni minori; ne la Diatessaron non ne può
hauere due maggiori, se l'una & l'altra contengono il Semituono maggiore di proportione Sesquiquintadecima, & non Soprasesquiquintadecima,
com'ei scriue.
A questo s'aggiunge, che mentre che era in tale ragionamento, com'ei scriue;
ecco uenire à lui una persona di nobile aspetto, ch'al primo saluto la conobbe di
che natione era; questa dopo molte parole & ceremonie, hauendogli dimandato quello che gli parea de i miei Libri; udito c'hebbe la risposta, gli disse per conclusione; Ch'in Fiorenza staua una persona ingegnosissima, & dottissima in Theorica, & Prattica di Musica, c'hauea fatto molte
Annotationi contra i miei Scritti;
delle quali gli ne disse alquante, che sono di pochissimo rilieuo, che si trouano
scritte in cotal Lettera: ma lasciando tutte l'altre da un canto, per non perder
tempo; questa fù una tra l'altre delche ei mi riprendeua, ch'io douea prima fare il Libro delle Dimostrationi, e poi dell'Istitutioni; & adduce questa bella ragione,
. mi, con C. fa ut. & la seconda contiene un Semituono maggiore E. la mi,
con F. fa ut; & un Tuono maggiore F. fa ut, con G. sol re ut, & un minore G. sol re
ut, con A. la mi re: ilperche questi due Interualli tra loro contengono Tre tuoni
maggiori, due minori, con due maggiori Semituoni nelle loro uere forme; come
per la 39. Prop. del 2. delle Dimostrationi etiandio contiene la Diapason, che tallora si diuide, & tallora si compone di queste due Consonanze semplici: siano
poi udite tra le Voci, ò tra i Suoni di qual si uoglia Istrumento arteficiale. Ma
cotale congiuntione, che di sopra habbiano nominato, non nasce tra le chorde
contenute in questa parte, ma si bene in quelle che passano più oltra, in altra,
page 329
Cioè nella Diapason piu acuta. Come leggendo il modo di temperare l'Istrumento da chorde con i Tasti si potrà conoscere, laquale non è stata intesa; onde è stata malamente proposta. Ma nella Risposta ò Risolutione si trouano
due cose degne di riprensione: la Prima è, che non si può risoluere cotal Dimanda con la quantita de i Comma; percioche essendone posti tanti insieme,
com'ei dice, non fanno un Tutto intiero, ne danno alcun buono accordo;
come si puo comprendere dalla 21. 22. 23. & 24. del Secondo delle Dimostrationi, & dal Cap. 46. della Seconda parte delle Istitutioni. La Seconda è, che la nominata Diapente non può hauere due Tuoni minori; ne la Diatessaron non ne può
hauere due maggiori, se l'una & l'altra contengono il Semituono maggiore di proportione Sesquiquintadecima, & non Soprasesquiquintadecima,
com'ei scriue.
A questo s'aggiunge, che mentre che era in tale ragionamento, com'ei scriue;
ecco uenire à lui una persona di nobile aspetto, ch'al primo saluto la conobbe di
che natione era; questa dopo molte parole & ceremonie, hauendogli dimandato quello che gli parea de i miei Libri; udito c'hebbe la risposta, gli disse per conclusione; Ch'in Fiorenza staua una persona ingegnosissima, & dottissima in Theorica, & Prattica di Musica, c'hauea fatto molte
Annotationi contra i miei Scritti;
delle quali gli ne disse alquante, che sono di pochissimo rilieuo, che si trouano
scritte in cotal Lettera: ma lasciando tutte l'altre da un canto, per non perder
tempo; questa fù una tra l'altre delche ei mi riprendeua, ch'io douea prima fare il Libro delle Dimostrationi, e poi dell'Istitutioni; & adduce questa bella ragione, Quia Praxis est Theoricae finis:non si accorgendo, che quando posi in luce l'Istitutioni, posi insieme la Contemplatiua ò Theorica, con la Prattica; questa nelle due Parti ultime, & quella nelle due prime; doue si dimostra di hauer male studiato le mie Opere; quando non conosce & discerne le Prime parti dalle Seconde. Ma forse che egli non sà, che niuna cosa può esser nell'Intelletto, come dice il Filosofo, se prima non è compresa da i Sensi; & che la Prattica sempre fù prima della Speculatiua, ò Scienza; & che tutto quello che si scriue in questa Seconda, si caua da quella; ch'è sempre Prima: nella quale si genera la Scienza da molti esperimenti; com'hò dimostrato nel Cap. 7. del Primo libro: onde s'egli sapea questo, non si douea marauigliare; essendoche la Marauiglia nasce da Ignorantia. Et s'egli hauesse saputo, che quello c'hò scritto, l'hò scritto come cosa quasi noua; percioche bisogna ch'ogn'uno sappia (ilche anco non potrà mai negare il mio diligente Discepolo) ch'auanti ch'io scriuessi le cose della Musica, ogn'uno teneua, che si usasse i Numeri & le Proportioni, che sono Forme delle Consonanze, scritte da Boethio: laonde hauendo ritrouato non esser cosi, bisognò prima far molte esperienze, per ritrouar la uerità; dellequali certificato, dimostrai che non si usaua nella Musica la specie diatonica detta Diatona, ma si bene la Naturale & Syntona, l'una della specie che dimostra Tolomeo; & dopoi scriuerla, riducendo il tutto nella Theorica, ò Speculatiua. Laonde non è stato inconueniente, se le cose ch'io ritrouai prima con la prattica, le dimostrassi dopoi, & le riducessi sotto la Scienza contemplatiua. Quanto poi ch'ei mi riprende, ch'io sia stato troppo lungo, troppo affettato in dottrine, e troppo mescolato d'altre Scienze fuor di materia nel Scriuere; & più presto per ostentatione: percioche qual si uoglia che legge non si ricorda nel fine quello, ch'ei habbia letto: Dico, che per essere stato troppo lungo nel scriuere, non mi potrò mai pentire; essendoche chi porrà mente alle cose chio hò trattato, conoscerà che non sono dette fuori di proposito, com'ei dice; perche potranno sempre seruire per un'istrumento all'Inuentione d'altre cose, che si desiderano nella Mu page 330 sica: essendo gran pazzia il tener per certo, che non ui sia altro da imparare; onde si uede in quante cose nella Musica, m'habbia seruito della Geometria, ch'erano necessarie; alla Dimostratione delle quali non ui è alcuno che ne habbi parlato; seruendomi della Quantità dimensiua, & de i Corpi sonori, che sono Quantità continua; perilche da questo son persuaso, & da molte & molt'altre cose, le quali hò trattate ne i miei Scritti, che la Musica più tosto sia sottoposta alla Geometria, che alla Arithmetica; & che più tosto ella habbia per suo uero & principale Soggetto il Corpo sonoro proportionato, che il Numero sonoro; come forse dimostrerò un'altra fiata più in lungo. Et se questo è troppo affettatione di dottrina; da ogn'Animo uirtuoso sarò iscusato; che s'io hauessi potuto far di meno, l'haurei fatto; onde appresso di costui non m'haurei acquistato questo nome, di Troppo affettato in dottrine, Troppo mescolato d'altre Scientie fuor di materia; se ben non senza grande occasione hò detto molte cose, che saranno di gran giouamento in questa Scientia, & che questo ch'io hò fatto, dica, ch'io l'habbia fatto per ostentatione. Ma di gratia, che colpa è la mia, s'alcun che haurà letto i miei Scritti, al fine di quel Capo c'haurà studiato, non si ricordarà quello c'haurà letto: & che ne posso io fare, se egli ha poca memoria, & se non si ricorda; & forse che questa è la cagione, per non hauere inteso quello c'hà letto; ma la colpa non è mia; ma della sua crassa Minerua, che non lo serue, come gli bisognarebbe. Ma poniamo hormai fine à coteste cose, & diciamo; che chi uolesse rispondere à tutte l'oggettioni, che sono fatte da gli Ignoranti & Maligni, troppo tempo ui andarebbe; ne anco si potrebbe satisfare ad ogn'uno; ne si potrebbe far tanto, ch'alcuno dopoi non uolesse ancor dire & malignare. Ilperche hauendo parlato hora à sofficienza dell'Vltima parte delle cose che considera in uniuersale & in particolare la Musica, & della Melopeia, un'altra fiata uederemo quelle cose che appartengono al MELOPEO, ò MVSICO PERFETTO. Laonde rendendo gratie immortali à quello che habita col suo Figliuolo nostro Redentore, & con lo Spirito santo nel Celeste Regno; di hauermi concesso tanta gratia, ch'io habbia posto in luce queste mie fatiche, oltra gli altri doni riceuuti da sua Maestà, spero che di nuouo mi sarà da lei concesso ch'io potrò satisfare al debito, che gia molto tempo hò contratto con ciascheduno Studioso, ponendo in luce hormai i promessi Venticinque Libri DE RE MVSICA, fatti in lingua Latina; con quello ch'io nomino MELOPEO, ò MVSICO PERFETTO.

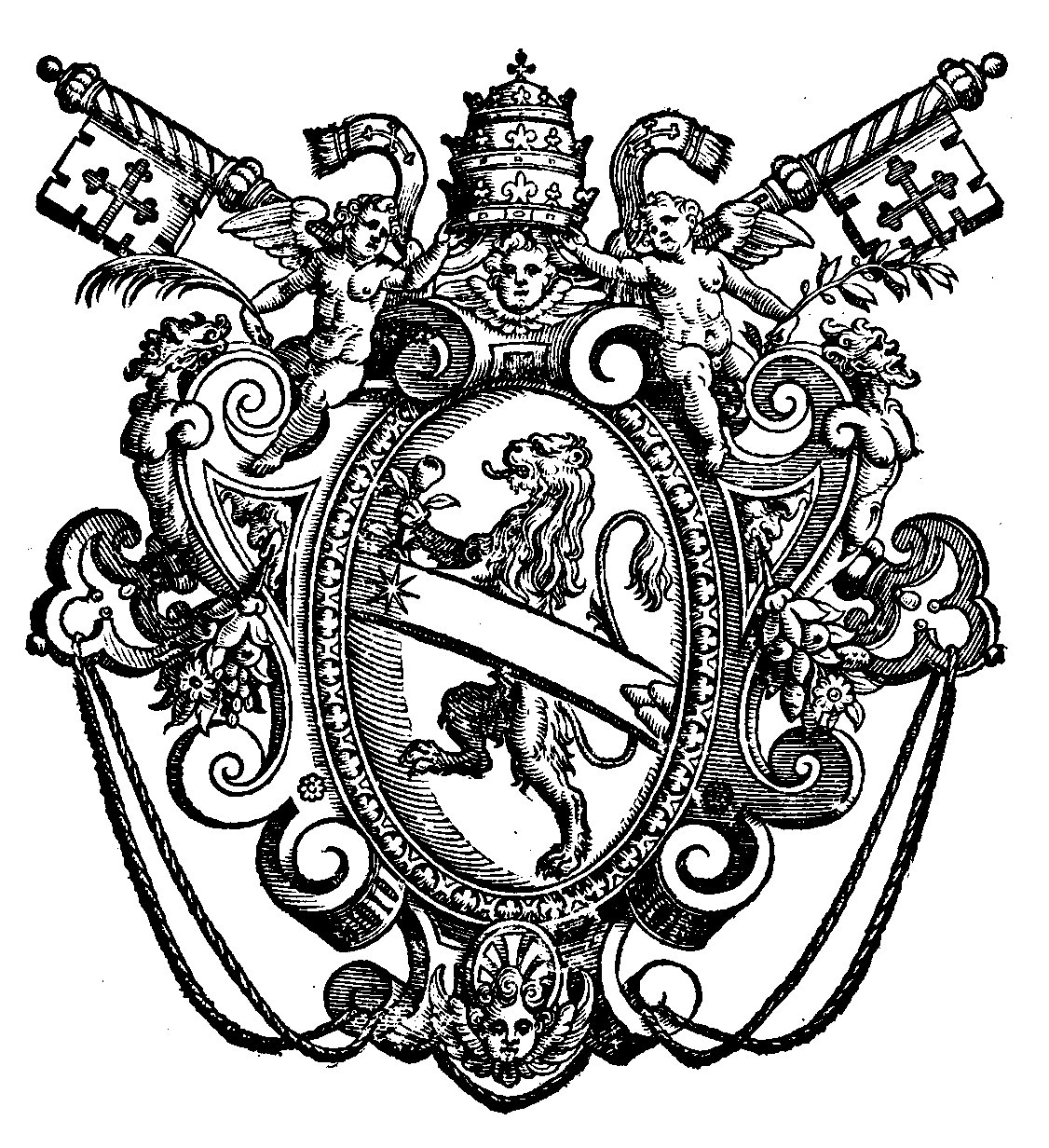
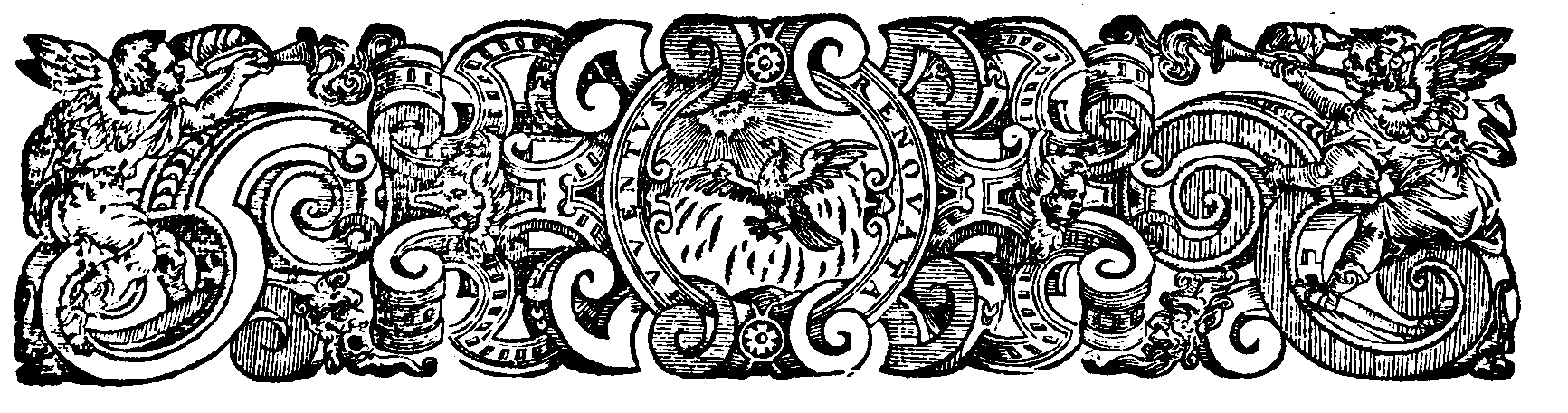
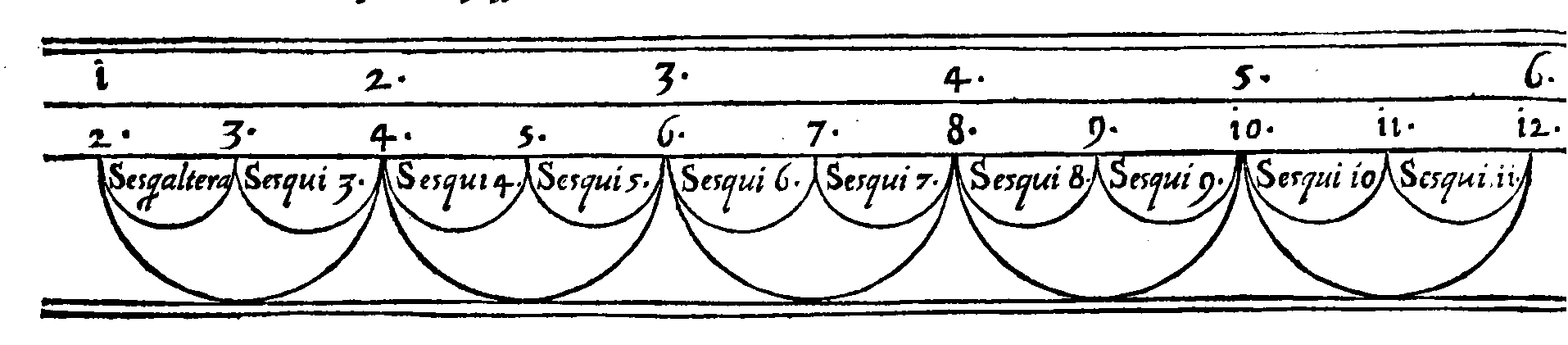
![Diapente. 3.
Acqua. 2.
[line]
Vino. 1.
Diapason. 2.
Acqua. 1.
[line]
Vino. 1.
Diatessaron. 4.
Acqua. 3.
[line]
Vino. 1.](../../zarsop/ill/308_5.gif)